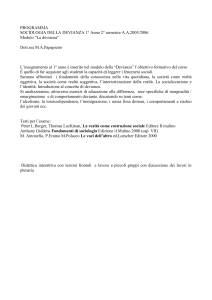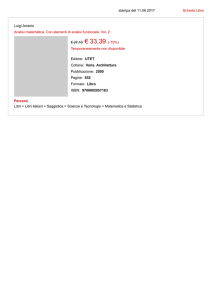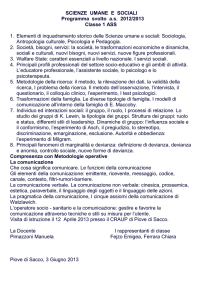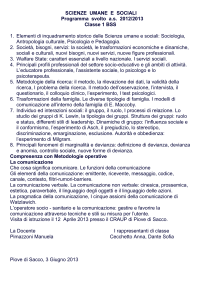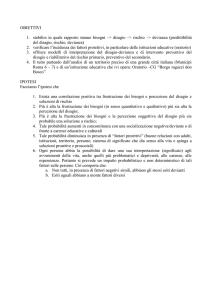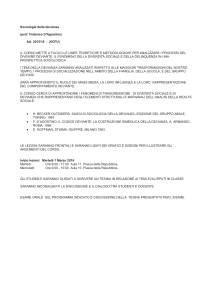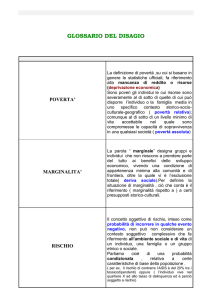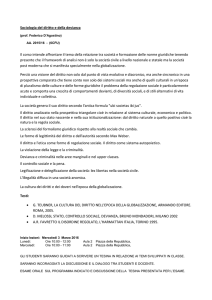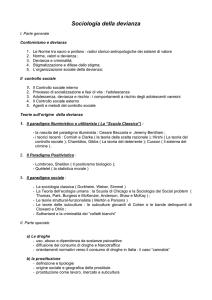PER UNA BREVE STORIA CRITICA DELLA PREVENZIONE IN AMBITO GIOVANILE
Dalla dissuasione scientifica alla teoria del disagio.
Prendiamo ad esempio in analisi alcuni modelli di prevenzione. Un modello tuttora
prevalente ritiene che le persone debbano essere informate ed in maniera il più possibile
scientifica e neutrale riguardo ai rischi che corrono ed alle misure da prendere per evitare
tali rischi. Secondo tale ipotesi è necessario e sufficiente informare le persone dei rischi
della droga, del fumo, delle cattive abitudini alimentari per ottenere i cambiamenti sperati e
scoraggiare le condotte dannose. Molti credono ancora che tale modello di per sé funzioni.
Esso ha certamente una sua validità relativa in molte situazioni ed in senso generale è
certamente meglio e bene che le persone posseggano conoscenze scientifiche adeguate.
Tuttavia tale pratica in moltissimi casi si è rivelata inutile, insufficente o addirittura
controproducente anche perché ogni informazione spesso veicola un giudizio morale.
Recentemente sono stati pubblicati i risultati assolutamente sconsolanti (result : no effect,
(Lynam D, Milich R. et al., 1999) dell’importante e molto propagandato progetto D.A.R.E.
(Drug Abuse Resistance Education) statunitense che aveva visto un impegno massiccio di
fondi e di coinvolgimento di vari esperti (poliziotti, studiosi etc). La consapevolezza del
limite di tali approcci si è sempre più rivelata in ampi settori dell’intervento sociale
stimolando - ad esempio nel caso della droga – interventi che evitassero di parlare di
sostanze. Il dato paradossale è che, se per taluni parlare di sostanze appare necessario e
sufficiente, per altri sarebbe da evitare e controproducente.
In questo dibattito
curiosamente elementi importanti quali :il chi (parla),il dove (parla), a chi (parla), il perché
(parla) e di cosa (parla) ( le famose cinque W dell’ inglese why, who,where,whom, what)
sono passati in secondo ordine così come il “come” se ne parla. Certo è che era
necessario un paradigma diverso che permettesse di realizzare politiche di intervento
preventivo. Ed è in questa fase che è stato coniato l’infelicissimo concetto di disagio che
tanto successo poi avrà. Infelicissimo per varie ragioni e da non ultimo per il fatto di
indurre taluni a pensare che, essendo l’agio l’opposto del disagio, compito della
prevenzione sarebbe portare o mantenere le persone nell’agio. Piuttosto possiamo
pensare come fattore predittivo sia non il permanere nell’agio ma la capacità di soffrire e di
reggere l’insicurezza. Il cambio di prospettiva tuttavia è stato notevole ed ha prodotto
interventi ed attenzioni più ampie ed articolate portando ad adottare politiche di intervento
preventivo che, mettendo tra parentesi la presenza o meno di sostanze, giocassero nel
produrre forme di svago e di realizzazione che di per se potessero fungere da fattori di
protezione dall’uso di sostanze. In ultima analisi il paradigma che sorregge tale ipotesi
parte dalla premessa che una persona che usa sostanze lo farebbe per rispondere ad un
bisogno di sofferenza e di disagio. La prevenzione pertanto consisterebbe nel fare in modo
di evitare che le persone si trovino a disagio o meglio nel favorire le condizioni di agio. Ma
siccome la definizione stessa di disagio risulta di difficile cittadinanza in territorio
scientifico, il problema che si è venuto a determinare è stato che, pur concordando - la
maggior parte delle persone dotate di buon senso- sul fatto che qualsiasi intervento,
progetto, iniziativa che “lavori in positivo” favorendo la partecipazione ed il protagonismo
da parte dei giovani debba essere vista con simpatia e supportata, molto difficile se non
impossibile sarebbe invece riuscire a delimitare il confine o la connessione tra una
determinata azione e la prevenzione o meno di sostanze stupefacenti. In altre parole, se
qualsiasi politica nei confronti dei giovani avrebbe comunque una intenzione preventiva,
risulta difficile se non impossibile discriminare tra azioni maggiormente efficaci, inefficaci
o controproducenti. Questa logica ha di fatto alimentato uno scetticismo scientifico dello
stesso segno nei confronti delle politiche di prevenzione: per cui, se qualsiasi cosa è
potenzialmente positiva, qualsiasi cosa è - se non potenzialmente negativa -quantomeno
potenzialmente inutile .
Il riconoscimento e l’intervento sugli indicatori precoci di disagio e di devianza.
Se prevenzione è arrivare prima che “le cose arrivino” oppure che i guai diventino troppo
grossi (vedasi ad esempio il concetto di prevenzione secondaria) è evidente l’importanza
che possono assumere gli indicatori di rischio in modo da intervenire il più precocemente
possibile. Ma il disagio giovanile non lo si prende attraverso germi o virus precisi come
molte malattie. E la storia di molti interventi cosiddetti “precoci” sui soggetti a rischio ha
segnalato come talvolta l’intervenire prima abbia di fatto favorito in molti casi la possibilità
di chiudere dei percorsi anziché di aprirli. Tale fatto è noto in molti interventi precoci di
tipo individuale ove “l’individuazione” di chi potrà avere un determinato problema talvolta
anziché scongiurare o limitare il problema stesso, innesca il cosiddetto meccanismo della
profezia che si autodetermina. Tale meccanismo è stato ben dimostrato da una ricerca
condotta nelle scuole primarie americane (Rosenthal R., Jacobson L, 1972 ) dove 5OO
bambini furono sottoposti a test di intelligenza i cui risultati furono comunicati agli
insegnanti con degli errori intenzionali. Vennero cioè comunicati i nominativi di bambini
ritenuti intellettualmente iperdotati quando in realtà non lo erano ma semplicemente erano
stati scelti a caso. Il test fu ripetuto a sei mesi ed ad un anno e si riscontrò un progresso
intellettuale in tali bambini a differenza degli altri. Cosa ci insegna tale esperimento? Era
accaduta una cosa molto singolare e cioè che l’aspettativa e l’idea - degli insegnanti - di
avere a che fare con bambini molto dotati aveva di fatto funzionato come catalizzatore per
lo sviluppo intellettuale di questi bambini. E ciò avvenne nonostante il tempo dedicato a
questi bambini non fosse superiore a quello dedicato per gli altri bambini. Comprensibili
ragioni di tipo etico impediscono di ripetere tale esperimento selezionando a caso bambini
o adolescenti ritenuti a rischio di qualsiasi problema, e quindi verificare se il fatto di
osservarli e relazionarci con loro con l’idea che essi presentino quel determinato
problema, possa prevenire tale problema oppure (come tale esperimento sembrerebbe
indicare) funga da catalizzatore per l’instaurarsi o l’aggravarsi del problema. Certamente
tale ricerca dovrebbe mettere maggiormente in guardia dal rischio di interventismo
precoce se questo risulta selettivo per i soggetti a rischio e crea percorsi, identità, spazi
(anche solo mentali) “speciali e separati”. Riguardo sempre ai fattori di rischio in
particolare riguardo il disagio e la devianza minorile, in molti operatori è avvenuto un
passaggio da ipotesi di lombrosiano (la causa sta nell’individuo) influsso ( e riflusso dato il
ritorno di letture biologiche ed individualistiche) verso l’idea che i fattori di rischio fossero
ricercabili e ben visibili, ben strutturati, ben chiari in precisi parametri sociali : il quartiere, la
carenza di servizi, le carenze familiari, e in questi ambiti andassero sviluppati interventi per
situazioni a rischio rispetto alle quali si potesse fare una azione di prevenzione della
devianza. Tuttavia come nota De Leo (1995) “Da molto tempo gli studiosi hanno detto ai
politici, anche se non sempre i politici hanno ascoltato questo discorso, che se avessero
voluto intervenire per migliorare la qualità dei quartieri o per la qualità della vita delle
famiglie sarebbe stato molto importante, ma che non lo facessero per prevenire la
devianza, perché questo cambia la natura dell’intervento. “Dovrebbe essere fatto per la
qualità della vita, poiché questo è un diritto di tutti “ e non solo dei giovani o peggio ancora
dei giovani devianti “ e questo forse farà anche prevenzione alla devianza, ma se si
inserisce questo lavoro in un programma di prevenzione della devianza, succederà un
qualcosa che strutturerà in maniera rigida questi interventi in modo tale che si andranno a
pescare certe persone prima che queste siano entrate in una “carriera” e forse come è
successo tante volte nella storia si faciliterà l’ingresso in questa “carriera”. Perché
un’attenzione selettiva ai fattori di rischio della devianza può produrre un irrigidimento di
questo genere. Questo per quanto concerne il territorio, la scuola , le politiche per la
famiglia. E’ molto importante fare interventi in questi ambiti per migliorare la qualità del
servizio in questi ambiti. C’è un’enormità di cose da fare per la scuola, ma è diverso farlo
per la qualità della scuola o per prevenire la devianza”. Disgraziatamente avviene che gli
interventi per la scuola non trovano finanziamenti mentre quelli per la devianza, trovano
immediatamente finanziamenti. C’è una sorta di stupidità sociale strutturata in questa
direzione: la gente è disposta a spendere soldi per la paura della droga , ma non è
disposta a spendere soldi per la scuola o per le famiglie: è troppo generico. Ci deve
essere una minaccia perché si spendano dei soldi. Ma proprio quando si spendono soldi
per dare una risposta alla minaccia il risultato è molto diverso”. (De Leo, ibidem)
L’individuazione delle categorie a rischio: il caso dell’AIDS.
Esito ancora peggiore hanno avuto le politiche di individuazione di categorie a rischio nel
caso dell’AIDS
ove l’individuazione di categorie a rischio (gli omosessuali, i
tossicodipendenti etc) ha causato notevoli guai. I principali sono stati l’avere favorito nei
confronti di tali “categorie” processi di esclusione e l’aver associato a tale malattia (anche
nei confronti di chi l’aveva contratta in maniera diversa) uno stigma sociale. In secondo
luogo l’idea che il problema fosse legato a categorie e non a comportamenti a rischio ha
portato molti di coloro che si riconoscevano parte di tali gruppi ad un sentimento
generalizzato ed indistinto di pericolo talvolta da negare anche attraverso atteggiamenti
fatalistici. Ma il dato più paradossale è stato il rinforzare la percezione - in chi non si
sentiva parte di “tali categorie” - che la cosa non li riguardasse. Il risultato è che
nonostante le innumerevoli campagne e gli innumerevoli sforzi in tale direzione ci si è resi
conto che la diffusione dell’AIDS ha ora tranquillamente traghettato “dalle categorie a
rischio” ad altri strati di popolazione.
E allora la prevenzione?
Il fatto che la prevenzione sia una scienza piuttosto “complessa e debole” per cui le facili e
forti certezze si scontrano con le evidenze e le complessità del reale (che non è mai un
laboratorio ma la quotidianità e lo spazio vitale di tutti noi) non deve tuttavia portare a
pensare che allora sia meglio non fare nulla ed investire il denaro pubblico in altri settori. Il
rischio che attualmente si sta correndo è infatti che la prevenzione sempre meno interessi
il dibattito tecnico -scientifico e politico (soprattutto in ambito sanitario) concentrato su
altre problematiche vuoi più semplici o che presentano più evidenti segni di leggibilità , di
correlabilità e di visibilità tra “ ciò che vi era, ciò che è stato fatto “. Di fatto l’ offrire
modelli e azioni di carattere preventivo soprattutto in ambito giovanile pone problemi
metodologici ed applicativi di non facile soluzione. Da un punto di vista teorico i modelli si
presentano spesso o come troppo complessi o come troppo generici, e difficilmente
risultano applicabili in contesti diversi. Non raramente si chiedono soluzioni a problemi di
un target i cui appartenenti - non raramente - hanno una diversa definizione della realtà e
dei propri bisogni. Ad esempio i ragazzi si ritengono estranei alla definizione di problema
che viene attribuita a loro atteggiamenti o comportamenti, oppure non si ritrovano nelle
soluzioni e negli interventi che vengono loro proposti. A loro volta gli insegnanti possono
interpretare le richieste degli operatori sanitari (volte ad esempio ad acquisire maggiori
elementi per comprendere la realtà ; a porsi in appoggio agli insegnanti evitando interventi
diretti ; a collocare le singole azioni in un quadro progettuale maggiormente articolato etc.),
come tentativi di non coinvolgersi e delegare agli insegnanti la soluzione di problemi cui
non hanno competenza tecnico-professionale alimentando un sentimento di
emarginazione. Gli operatori possono pensare a loro volta che la scuola sia un terreno
dove si giocano questioni molto importanti che riguardano la salute ed i percorsi di molte
persone in formazione (altrimenti difficilmente intercettabili da parte dei servizi sociosanitari), ma anche “un luogo” che pone domande e chiede soluzioni a problematiche
troppo complesse per le risorse a disposizione , oppure ancora che non pone domande o
contrappone elementi di rigidità istituzionale (Croce M, Vassura M, 1998).
In questa fase storica , che vede la scuola confrontarsi con la realtà dell’autonomia e la
sanità pubblica con una organizzazione di tipo aziendale si nota come la prima stia
sforzandosi di ‘aprire i cancelli’ per offrire ed incontrare spaccati di società, mentre la
sanità pubblica sempre più appaia interessata ad incontrare nuovi target e nuovi contesti
di intervento. Tuttavia l’interazione tra “mondo della scuola” e “mondo della sanità e dei
servizi psicosociali “ non raramente rischia di produrre ad uno o più degli attori coinvolti
sentimenti di incomprensione e di impotenza oppure aspettative deluse, percezioni distorte
e fantasie di manipolazione. Da qualche tempo inoltre si stanno facendo più frequenti le
richieste da parte del mondo della scuola (dirigenti, insegnanti o studenti per il tramite
degli insegnanti) di interventi rapidi e incisivi, sulla base di domande/bisogni a volte
generici ( “vorremmo capire che cosa interessa i giovani”), altri oltremodo specifici ( “in
quella classe c’è un clima conflittuale”), e a volte anche precisi e vincolanti (“i ragazzi sono
interessati a capire il significato del rischio per gli adolescenti”). Gli operatori si ritrovano
con un risicato bagaglio di un ‘paio d’ore’, aspettative elevate e tempi strettissimi per
mettere a punto un intervento con un capo ed una coda. Se è facile ed opportuno in molti
casi simili decidere di non intervenire, è anche vero come in molte situazioni sia opportuno
avere a disposizione uno strumento agile di analisi ed intervento che permetta di penetrare
in universi ed attori comunque importanti con i quali aprire canali comunicativi e costruire
ipotesi di analisi partecipata, di coinvolgimento e di alleanza.. Ma uno degli elementi
spesso fonte di inquinamento in ambito scolastico è probabilmente costituito dalla ‘difesa’
nei confronti di attività per le quali i ragazzi non sono minimamente stati coinvolti. Se è
vero che in genere non è l’operatore diretto responsabile della situazione, è altrettanto
innegabile che un suo approccio corretto alla questione può, almeno in parte, ovviare alle
difficoltà iniziali. Si è pertanto posta una forte attenzione alla situazione di partenza,
all’imprinting dell’intervento, attraverso la messa in crisi degli assunti iniziali ed usando una
metafora sportiva si può pensare che la filosofia di base dell’approccio sia quella di
‘ributtare la palla nel campo avversario’ anche per vedere quale gioco vuole, sa e gli è
concesso di giocare : se lo si vuole giocare insieme e con quali regole. Ciò significa che ,
avversari a parte, dal momento iniziale il gruppo è chiamato a ridiscutere le opzioni di
avvio ed eventualmente proporne di nuove all’interno di una cornice chiara e condivisa.
L’obiettivo è quindi quello di chiamare in causa direttamente i soggetti (a volte oggetti?
Non dimentichiamoci che il tanto ab-usato termine target significa bersaglio!)
dell’intervento, rendendoli realmente partecipi e corresponsabili del percorso che si
intende attivare. (Croce M, Vassura M, 1999).
Dall’intervento sul target alla peer-education
Quando alcuni anni fa ci ritrovammo un piccolo gruppo di operatori e l’associazione
contorno viola per pensare e realizzare un programma di prevenzione dall’AIDS non
sapevamo bene come muoverci. Da tempo eravamo impegnati e coinvolti “ nel problema”
e con le persone sieropositive in vario modo ed in vari luoghi (l’ospedale, il carcere,
l’ambulatorio, il gruppo di auto-aiuto, la casa, etc). Sentivamo importante entrare anche nel
mondo della scuola ed incontrare i giovani ma volevamo evitare tutti gli errori ed i rischi
che seppur in misura sbrigativa e parziale ho cercato di esporre. Inoltre ci sembrava (se
non rischioso e controproducente ) quantomeno discutibile entrare in aula con un tema
così denso di implicazioni calandolo dall’alto. Certamente la cosa si poteva risolvere
restando su un “piano tecnico ed asettico” tuttavia non era quello che volevamo.
Gli strumenti (economici, umani, teorici) a disposizione erano quelli che erano ma
sapevamo che tale tema si poteva affrontare solo se si riusciva a collegare ad altri temi
che non era giusto né possibile decidere a priori. Ma soprattutto era importante che i
ragazzi fossero parte progettuale e realizzativa del progetto. Non so a chi (purtroppo credo
che non fui io) venne l’idea della peer-education. E’ curioso come le parole riescano a
costruire nei gruppi, nuovi significati che magari non sono chiari a tutti ma certamente
catalizzano intorno ad una idea. Poi quando non si sa bene spiegare cosa si vuole fare
funziona molto dire magari in inglese un qualcosa. Ed in quel caso suonava bene dire a
chi chiedeva cosa si stava facendo che si stava facendo della “peer education”. Ognuno a
modo suo poteva avere i riferimenti teorici che potevano essere utili a “giustificare o
razionalizzare” l’idea della peer education, ed il fatto che siano stati diversi tra loro è
probabilmente importante. Nel mio caso i riferimenti erano (e sono almeno quelli di cui
vorrei essere consapevole) a Kurt Lewin, alla teoria delle minoranze attive di Moscovici,
all’intervento di rete ed all’empowerment sociale. Certamente i riferimenti teorici sono
importanti ma talvolta sono un pretesto per fare comunque quello che si crede sorretti da
teorie. Altre volte ahimè fungono a sorreggere la mancanza di idee e di la non vogliacapacità di confronto dietro una cortina fumogena di teorie. Spero nel nostro caso che
valga la prima ipotesi.
Lewin , le reti, le minoranze attive e l’empowerment.
Di Lewin mi affascinava (oltrechè l’action-research) l’idea del cambiamento nei gruppi ed
in particolare il metodo di lavoro nei gruppi sapendo che una azione esercitata per
modificare le norme produce la comparsa di forze che neutralizzeranno l’effetto di questa
pressione ed aumenta l’equilibrio quasi stazionario. Secondo Lewin sarebbe più
“economico” ed efficace cercare di ridurre l’intensità delle forze che si oppongono alla
modificazione delle norme di un gruppo, piuttosto che esercitare una modificazione
crescente che imporrà all’individuo tensioni conflittuali : cosa che tra parentesi viene
spesso proposta in molti interventi. Lewin giunse a tali concetti dalla sua esperienza sulla
modifica delle abitudini alimentari negli Stati Uniti ove era necessario per problemi di
economia bellica “convincere” vasti strati di popolazione al consumo di frattaglie che
risultavano oggetto di avversione alla maggior parte delle casalinghe. Tali studi hanno
non solo spiegato il perché dell’inefficacia di metodi stile conferenza,ma hanno soprattutto
dimostrato i meccanismi attraverso i quali avvengono i cambiamenti nei gruppi. Tali
meccanismi non risiedono nella “semplice” organizzazione di un setting di apprendimento
attivo, quanto nella comprensione di come l’elemento di conformità al gruppo sia uno
degli elementi di maggiore resistenza al cambiamento e sia quindi necessario riorientare
questa forza per ottenere un cambiamento. Ma se si agisce rafforzando le forze che
spingono nella direzione desiderata dal conduttore, si determina nel gruppo uno stato di
tensione elevato (aggressività, fuga, abbassamento del livello della azione costruttiva,
resistenze etc) mentre l’agire sulle forze opposte favorisce il cambiamento attraverso le
fasi di a) scongelamento (unfreezing);b) cambiamento (moving);c) cristallizzazione
(freezing). Ma anche la ricerca di Berkam e Syme (1979) sulle reti sociali (l’insieme delle
persone che si conoscono, si frequentano, fanno parte della nostra storia), ed i successivi
sviluppi ed attenzione che ha avuto questo concetto (Speck, Attneave,1976, Amerio,
Croce,2000 ) credo possa essere un riferimento importante. La ricerca di Berkam e Syme
ha infatti dimostrato l’importanza di come il grado di estensione delle reti , il grado di
integrazione ed i contatti sociali abbiano delle connessioni significative con lo stato di
salute individuale , al punto di influenzare lo stato di sopravvivenza. La ricerca è stata
condotta su 7.OOO soggetti dei quali sono stati raccolti dati relativi allo stile di vita, allo
stato di salute ed alle modalità di relazione interpersonale con una osservazione
longitudinale e protratta per nove anni (!) riguardo l’estensione delle reti sociali. In altre
parole di ogni persona sono state raccolte notizie sullo stato civile, il numero di amici,
parenti e conoscenti, la frequenza degli incontri con loro e l’appartenenza ed il ruolo svolto
in gruppi ed associazioni. Sono stati anche quindi analizzati i dati relativi alla mortalità ed
alla morbilità ed è stata notata una correlazione molto alta tra questi dati e le variabili
inerenti le reti sociali. In particolare gli individui con scarsi legami hanno presentato una
frequenza di morte da due a cinque volte più alta delle persone con una rete sociale più
estesa. Questa differenza si è dimostrata indipendente dai noti fattori di rischio quali
obesità, fumo ed uso di alcol. Detto questo come è possibile coniugare tali ipotesi e
risultati in un progetto di prevenzione e di peer-education? Altri elementi teorici – ma non
solo – sono necessari. Nel mio caso tra quelli teorici citerei ancora la teoria delle
minoranze attive di Moscovici (1981) e cioè la spiegazione teorica (anche se
apparentemente paradossale) di come “una minoranza di soggetti (il nostro gruppo? I peer
educators?) può influenzare i soggetti a rivedere le basi profonde del suo giudizio, mentre
invece una maggioranza può portare la maggior parte delle persone ad accettare il proprio
punto di vista, se è unanime, senza però raggiungere il sistema cognitivo soggiacente. In
altri termini l’influenza maggioritaria opera in superficie mentre quella minoritaria ha effetti
profondi”.( Amerio,1995, pag.254). Un ultimo punto che vorrei riferire – scusandomi allo
stesso tempo per l’eccessiva prolissità e sinteticità ! – interessa l’empowermet ovvero “il
processo attraverso il quale le persone sono aiutate ad assumersi ruoli e responsabilità
attraverso lo sviluppo di capacità che danno accesso ad opportunità prima impensate, e
che consentono il godimento dei risultati associati al sentimento di dominio sugli eventi e
di appropriazione delle situazioni”. (Amerio, Piccardo, 2OOO).
Conclusioni
Tra le tentazioni che talvolta ci hanno attraversati - ma io mi riferisco soprattutto alle prime
fasi del progetto che meglio ho potuto seguire ed esserne parte organica - tra un “fare
senza pensare” ( riferendosi o delegando a rassicuranti modelli) ed “un pensare senza
fare” (in attesa di costruire e realizzare modelli) credo che l’idea forte (che poi sarebbe
diventata anche un modello) sia stata quella di un fare-pensando. Un fare-pensando che
vive della cosiddetta capacità negativa. “Un agire cioè che rende vulnerabili al dubbio
”senza volere a tutti i costi e rapidamente pervenire a fatti o a motivi certi”. Certamente
può apparire inattuale o anacronistico dedicare attenzione a questa qualità in ambienti
socio-culturali che premiano la prestazione specialistica, l’orientamento al risultato,(…), la
conformità a norme e a modelli canonici di comportamento, e l’acquisizione di certezze,
rinforzando così l’Incapacità Positiva - quel particolare tipo di incompetenza che si
accompagna all’eccessiva competenza”. (Lanzara ,1993, pag.13).
Il bello ed il triste di tante cose è che quando i gruppi partono sorretti da passione,
desiderio di mettersi in gioco etc. talvolta i conflitti, i confini, le implicazioni e le aspettative
diventano sempre più forti ed il continuo navigare tra certezze acquisite e ricerca di
elementi critici diventa talvolta anche faticoso. Ma tali gruppi si trasformano nel tempo e
nuove forze entrano in gioco. Indipendentemente dall’utilità o meno di tante teorie ciò che
ha permesso di andare avanti è stato l’accettare collettivamente una sfida. Credo senza
facile retorica che in questo caso la forza principale e più importante sia ora quella dei
peer-educators. Tali ragazzi sono certamente diventati una risorsa. Il circuito tradizionale
tra chj forma, in-segna e chi è formato e in-segnato probabilmente si è modificato. Ora
però si tratta di accettare una nuova sfida. Ma l’adulto spesso non sa apprendere
attraverso la sfida: scappa o interviene troppo rapidamente. Può però anch’egli imparare.
Amerio P., Fondamenti di psicologia sociale, Il Mulino, Bologna, 1995l
Amerio P., Piccardo C, (2000), L’empowerment tra individuo ed organizzazione, in , Piero
Amerio, Psicologia di Comunità, Il Mulino, Bologna.
Amerio P.,Croce M.,(2000), Le reti sociali, in Piero Amerio, Psicologia di Comunità, Il
Mulino, Bologna.
Berkman L.F.,Syme S.L.( 1979),”Social metworks, host resistance and mortality, a nineyear follow-up studiey of Alameda country residents”, American Journal of Epidemiology,
109 (2), 196.
Croce M., Vassura M,(1998),”Verso un modello sperimentale di intervento in ambito
scolastico”, in “Le comunità possibili”, atti del Convegno, Biella, 20.11.98
Croce M., Vassura M,(1999). “Il gusto di ricercare”, in Animazione Sociale nr 11.
Lanzara G.F.,(1993), “Capacità Negativa. Competenza progettuale e modelli di intervento
nelle organizzazioni”. Il Mulino, Bologna.
De Leo G,(1995), La sfida alla devianza minorile, Comune di Mantova.
Ghittoni E, Croce M., (1998), Dall’informazione verticale alla partecipazione tra pari nella
prevenzione: il progetto “la tavola rotonda”, atti 3a Conferenza Europea degli operatori
dele tossicodipendenze. Bologna, pp 227-228.
Lewin K., (1943), “Behind Food Habits and Methods of Change”, in Bullettin of the
Research Council, 108.
Lewin K., (1947)“Frontiers in Group Dynamics”, in Human Relations,pp 2-38.
Lewin K, (1948), trad it. 1972, “I conflitti sociali”,F.Angeli, Milano.
Lynam D.R, Milich R., et al.,(1999), “Project Dare: no effects at 10-year follow-up”, Journal
of Consulting and Clinical Psychology, August.
Moscovici S., (1981); Psicologia delle minoranze attiva, Boringhieri, Torino,
Rosenthal R, Jacobson L, (1972), Pigmalione in classe, Franco ANGELI, Milano.
Santinello M., (1996), “La prevenzione primaria delle tossicodipendenze nella scuola:
verifica dell’efficacia usando la meta-analisi”, in (a cura di) Arcidiacono C., Gelli B., Putton
A.., ”Empowerment sociale”, Angeli, Milano, pp219-227.
Speck R., Attneave C.,(1976), La terapia di rete,Astrolabio, Roma.