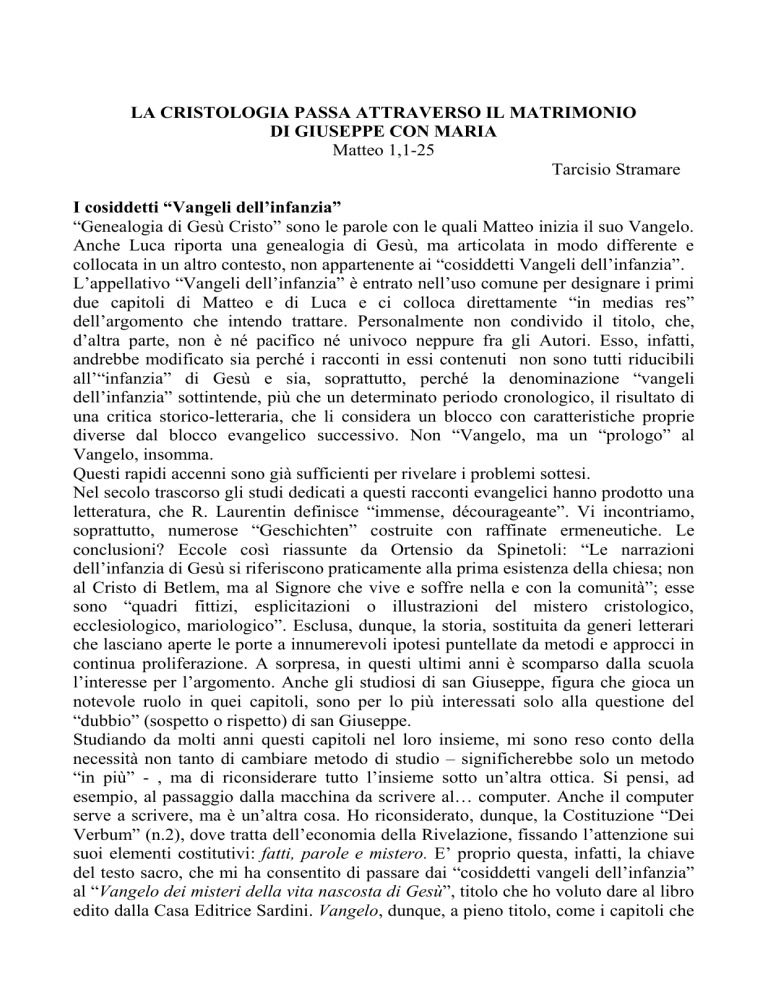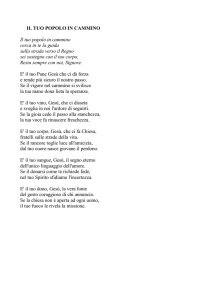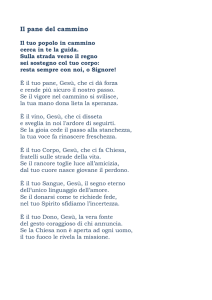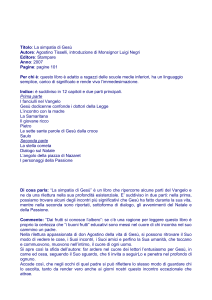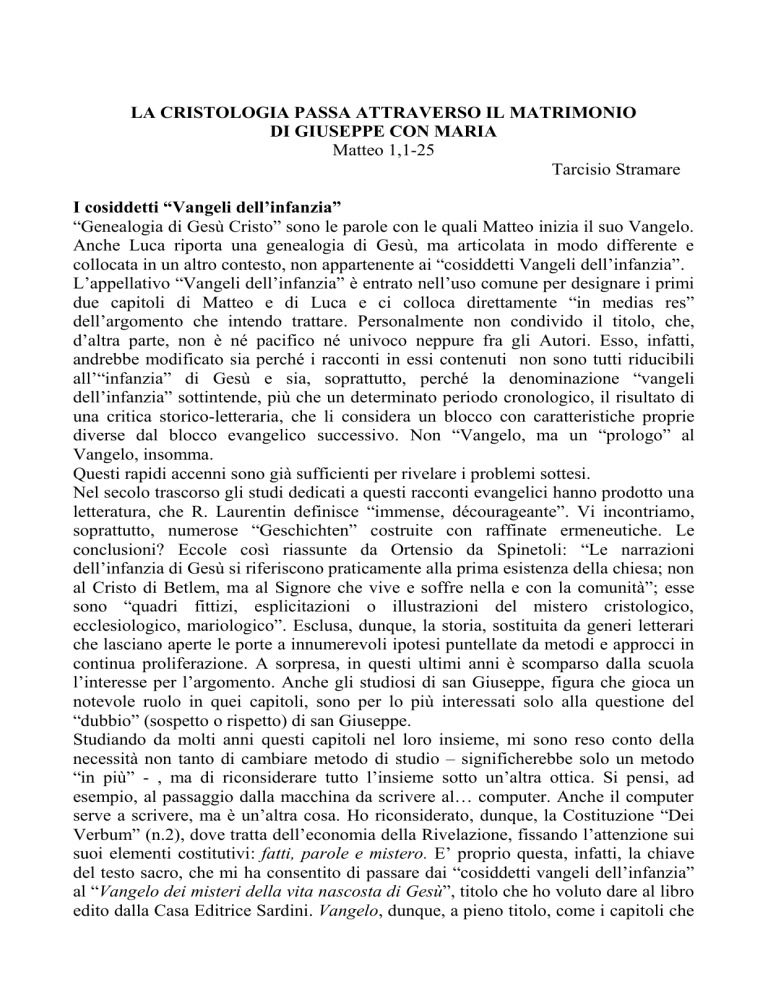
LA CRISTOLOGIA PASSA ATTRAVERSO IL MATRIMONIO
DI GIUSEPPE CON MARIA
Matteo 1,1-25
Tarcisio Stramare
I cosiddetti “Vangeli dell’infanzia”
“Genealogia di Gesù Cristo” sono le parole con le quali Matteo inizia il suo Vangelo.
Anche Luca riporta una genealogia di Gesù, ma articolata in modo differente e
collocata in un altro contesto, non appartenente ai “cosiddetti Vangeli dell’infanzia”.
L’appellativo “Vangeli dell’infanzia” è entrato nell’uso comune per designare i primi
due capitoli di Matteo e di Luca e ci colloca direttamente “in medias res”
dell’argomento che intendo trattare. Personalmente non condivido il titolo, che,
d’altra parte, non è né pacifico né univoco neppure fra gli Autori. Esso, infatti,
andrebbe modificato sia perché i racconti in essi contenuti non sono tutti riducibili
all’“infanzia” di Gesù e sia, soprattutto, perché la denominazione “vangeli
dell’infanzia” sottintende, più che un determinato periodo cronologico, il risultato di
una critica storico-letteraria, che li considera un blocco con caratteristiche proprie
diverse dal blocco evangelico successivo. Non “Vangelo, ma un “prologo” al
Vangelo, insomma.
Questi rapidi accenni sono già sufficienti per rivelare i problemi sottesi.
Nel secolo trascorso gli studi dedicati a questi racconti evangelici hanno prodotto una
letteratura, che R. Laurentin definisce “immense, décourageante”. Vi incontriamo,
soprattutto, numerose “Geschichten” costruite con raffinate ermeneutiche. Le
conclusioni? Eccole così riassunte da Ortensio da Spinetoli: “Le narrazioni
dell’infanzia di Gesù si riferiscono praticamente alla prima esistenza della chiesa; non
al Cristo di Betlem, ma al Signore che vive e soffre nella e con la comunità”; esse
sono “quadri fittizi, esplicitazioni o illustrazioni del mistero cristologico,
ecclesiologico, mariologico”. Esclusa, dunque, la storia, sostituita da generi letterari
che lasciano aperte le porte a innumerevoli ipotesi puntellate da metodi e approcci in
continua proliferazione. A sorpresa, in questi ultimi anni è scomparso dalla scuola
l’interesse per l’argomento. Anche gli studiosi di san Giuseppe, figura che gioca un
notevole ruolo in quei capitoli, sono per lo più interessati solo alla questione del
“dubbio” (sospetto o rispetto) di san Giuseppe.
Studiando da molti anni questi capitoli nel loro insieme, mi sono reso conto della
necessità non tanto di cambiare metodo di studio – significherebbe solo un metodo
“in più” - , ma di riconsiderare tutto l’insieme sotto un’altra ottica. Si pensi, ad
esempio, al passaggio dalla macchina da scrivere al… computer. Anche il computer
serve a scrivere, ma è un’altra cosa. Ho riconsiderato, dunque, la Costituzione “Dei
Verbum” (n.2), dove tratta dell’economia della Rivelazione, fissando l’attenzione sui
suoi elementi costitutivi: fatti, parole e mistero. E’ proprio questa, infatti, la chiave
del testo sacro, che mi ha consentito di passare dai “cosiddetti vangeli dell’infanzia”
al “Vangelo dei misteri della vita nascosta di Gesù”, titolo che ho voluto dare al libro
edito dalla Casa Editrice Sardini. Vangelo, dunque, a pieno titolo, come i capitoli che
seguono; dei Misteri, perché questi sono l’oggetto della predicazione apostolica
messa per iscritto; della Vita nascosta di Gesù, perché questo è il periodo storico in
essi considerato. Sui tre elementi indicati dalla Dei Verbum – fatti, parole e Mistero non ci debbono essere né “se” né “ma”; rifiutare questi punti fermi, significa voler
rimanere nell’esegesi “secondo me”.
“Una rivoluzione copernicana”, ha scritto un recensore della mia pubblicazione. Io
direi più semplicemente: una questione di logica, di semplice coerenza con il testo
conciliare.
Perché Matteo ha iniziato ex abrupto il suo vangelo con una genealogia?
Non si tratta di una semplice curiosità, perché proprio questa domanda mette il dito
nell’esigenza della… storicità, il primo elemento dell’economia della Rivelazione.
Non dimentichiamo che il Cristianesimo è una religione “storica”. Siamo soliti
concludere le nostre preghiere liturgiche con la formula: “Per il nostro Signore Gesù
Cristo…”, ma non riflettiamo forse abbastanza sul grande peso di questi tre Nomi e
sul loro diverso significato, usandoli spesso come termini interscambiabili. In realtà,
Gesù si riferisce all’umanità del “figlio di Giuseppe da Nazaret”; Cristo al titolo
messianico inerente ad una particolare missione; Signore, infine, all’identità della
Persona divina. Tre realtà molto differenti, dunque. C’è da aggiungere la qualifica di
“figlio di Davide”, necessaria per il riconoscimento della messianicità. Non è stato
facile per la Chiesa apostolica fare confluire questi differenti nomi nella stessa
persona, come non è stato facile per la Chiesa postapostolica trovare le espressioni
adatte per definire i dogmi cristologici.
Dobbiamo riconoscere che nella Chiesa apostolica l’approfondimento della fede
tendente a illuminare la vita terrena di Gesù si è operato con un procedimento a
ritroso, ossia a partire dal mistero pasquale. E’ alla luce della Pentecoste che Pietro
può proclamare: “Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso” (At 2,36).
Ebbene, è appunto in questo procedimento a ritroso, durante il quale la comunità si è
interrogata sull’inserimento del Verbo di Dio nella carne, ossia sul modo concreto
dell’incarnazione, che è emersa la verità del concepimento verginale, intesa non come
esaltazione mariana, ma vista come esigenza cristologica, che tuttavia veniva a
compromettere l’“attesa umana” del Messia, considerato appunto come “figlio di
Davide”. Il punto centrale del primo capitolo di Matteo è proprio lì, dove è scritto
riguardo alla maternità di Maria: “inventa est in utero habens de Spiritu Sancto”
(1,18). Il testo latino, che userò ancora in qualche caso, ha il vantaggio di essere più
esplicito delle versioni.
E’ facile ammettere come ogni nuova “verità” su Gesù venisse a metterne in
discussione un’altra. Il titolo di “figlio di Davide” costituiva un serio problema sul
fronte della divinità oltre che della storicità. Si veda Matteo 22,41-46 (ma anche Mc
12,35ss.; Lc 20,41-44), dove Gesù stesso chiede ai farisei di chi Cristo è figlio. La
risposta è unanime: “di Davide”. Gesù non la discute, ma intanto rimanda i suoi
interlocutori al Salmo 110,1, dove Davide chiama il Cristo “Signore”.
“Figlio di Davide” non equivale a Messia, e Messia non è lo stesso che Figlio di Dio.
Si tratta di realtà diverse, che tuttavia nel disegno di Dio si concentrano in Gesù. Di
qui la necessità di distinguerle, ma anche di non separarle. Poiché nel piano di Dio il
Messia viene scelto nella casa di Davide, ecco che la davidicità diventa la “condicio
sine qua non” della sua messianicità. Ed è questa messianicità che appunto sembra
compromessa, se Matteo si sente costretto ad affrontarla sin dall’inizio del suo libro.
Tra gli evangelisti, infatti, il titolo di “figlio di Davide” è caratteristico di Matteo.
Mentre negli altri evangelisti si incontra solo in Mc 10,47s. e Lc 18,38s., in Matteo lo
incontriamo disseminato un po’ ovunque (1,1; 9,27; 12,23; 15,22; 20,30.31; 21,9;
21,15).
Che Matteo dovesse produrre una genealogia “davidica” va dato per scontato
Nessuno mette in discussione che Matteo scrive il suo Vangelo con il pensiero rivolto
soprattutto agli ebrei. Il problema della messianicità di Gesù non può essere eluso; la
messianicità include a sua volta la davidicità di Gesù. Paolo ne fa oggetto della sua
predicazione nella sinagoga di Antiochia di Pisidia; dopo aver tratteggiato la storia di
Israele fino a Saul, l’apostolo puntualizza: “Et amoto illo, suscitavit illis David in
regem… Huius Deus ex semine secundun promissionem eduxit Israel salvatorem
Iesum” (At 13,22s.). Trattando del vangelo di Dio, promesso nelle Scritture e
riguardante suo Figlio, lo stesso Paolo lo definisce “factus ex semine David secundum
carnem” (Rm 1,3; cf. 2Tm 2,8). In altri testi l’origine davidica di Gesù è data come
“nota a tutti” (Eb 7,14). L’eco si ripercuote fino all’Apocalisse: “leo ex tribu Iudae,
radix David” (5,5; cf. 22,16). Si tratta di una tradizione risalente a 2 Samuele 7 (cf.
1Cr 17), dove si ha la profezia più importante dell’A.T. sulla stabilità della dinastia di
David. Questa promessa si farà sempre più esplicita e verrà tradotta in preghiera,
garantendone in tal modo la trasmissione e soprattutto il ricordo frequente. Si pensi al
Salmo 89,20-38, dove si insiste sulla stabilità della dinastia e si ricorda a Dio il suo
giuramento (v.50); il Salmo 132 ricorda il giuramento da cui Dio non si ritrarrà: “Il
frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono!” (v.11). Anche Luca, che scrive il suo
Vangelo per i pagani, non trascura il riferimento a Davide. L’angelo è mandato “a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe… il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre” (1,27.32); Zaccaria lo conferma: il
Dio d’Israele “ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide suo
servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo” (2,69s.).
Dopo quanto abbiamo scritto sull’attesa discendenza davidica del Messia, appare
scontato che Matteo dovesse produrre alla sua comunità una genealogia. D’altra
parte, la genealogia davidica di Giuseppe, benché complessa, non doveva essere
impossibile. Ogni individuo custodiva gelosamente le proprie origini, controllate
ovviamente anche dalla propria tribù e comunità. Secondo Luca, Giuseppe sa
esattamente che per il censimento deve recarsi “in Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide” (2,4).
La discendenza davidica di Giuseppe, nonostante il suo umile mestiere, doveva essere
abbastanza solida e indiscussa, se gli evangelisti Matteo e Luca possono produrre due
genealogie non ricalcate l’una sull’altra, senza preoccuparsi di concordarle e senza
reazioni da parte della comunità.
Mentre Luca aveva narrato diffusamente il concepimento verginale di Gesù e aveva
inserito la genealogia di Gesù dopo la descrizione della teofania avvenuta in
occasione del suo battesimo (3,21-38), evitando di “scontrarsi” con il problema
davidico, Matteo, invece, affronta direttamente la questione, risolvendola
giuridicamente “secundum legem”. Arrivato a Giuseppe, infatti, egli interrompe la
serie dei “generò”, sostituendo il verbo con il titolo giuridico alla paternità: “lo sposo
di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo” (1,16). L’anomalia è voluta e ben
visibile; Matteo ne darà la spiegazione subito dopo.
Il “test della ragionevolezza” al servizio di un’esegesi “funzionale”
Contro le esegesi del “theologumenon” e simili, allergiche alla storia, A. Ory ha
sottoposto all’esegesi “funzionale” il fatto del concepimento verginale, da intendersi
in senso biologico-fisico. L’esegesi “funzionale” è definita come “un metodo di
critica letteraria interna, applicabile al Vangelo, che con l’aiuto di un ‘test di
ragionevolezza’ cerca la funzione esatta di una frase, di una pericope o di un insieme
di racconti appartenenti allo stesso genere letterario”. Essa si fonda sull’ipotesi che
l’uomo agisca in modo ragionevole e che questo suo modo di agire lo si debba
trovare dopo secoli nelle sue opere, ad esempio nei suoi scritti. La porta del
ragionamento è la “funzione” del racconto: “A che cosa serve?”. “Se si può
rispondere: ‘A fare apologetica, a difendersi dagli attacchi degli avversari accaniti’, la
storicità vi deve essere inclusa. I cristiani si trovavano nella necessità di legittimare la
loro scelta di essere discepoli di un condannato a morte; devono fornire delle prove a
scribi, specialisti nello studio delle profezie; il migliore, anzi, l’unico argomento è
l’adempimento delle profezie. Solo un argomento storico possiede sufficiente valore
portante”. “Perché compilare una genealogia? Non è difficile la risposta. Gli
avversari, gli scribi, esigevano che il vero Messia, delineato dai profeti, fosse
discendente di Davide (Mt 22,42). In assenza di tale prerogativa, Gesù non ha
possibilità serie di venire accettato come Messia”. “Gli scribi esigono una
discendenza davidica, ma non hanno alcuna esigenza quanto alla maternità
verginale”. “Il test di ragionevolezza nella genealogia si ricava appunto da questo: si
deve fornire la prova che Gesù discenda da Davide a degli studiosi che esigono una
discendenza davidica, senza alcun interesse per una vergine-madre”. “La genealogia
ha senso solo se sottolinea la pretesa di Gesù di fronte all’attesa messianica. Se vi
riesce, la pretesa di Gesù è salva; diversamente è l’insuccesso. Dato il contesto, una
falsificazione è non solo possibile, ma probabile, quasi inevitabile. Nella sua
genealogia Matteo non indica solo qualche anello, ma tutta la catena… Occorre che
nelle vene di Gesù scorra sangue reale. Matteo offre una dimostrazione molto
fragile”. “Che cosa c’è di speciale nell’ultima frase della genealogia? Niente, a prima
vista, e perciò essa forse nasconde un ‘test di ragionevolezza’… Il lettore attento deve
essere colpito da questa eccezione, che suggerisce chiaramente che Giuseppe non è il
padre di Gesù… Senza affermare la paternità di Giuseppe, l’ha suggerita, benché
faccia notare al lettore attento che Giuseppe non è totalmente il padre di Gesù. Perché
questa ambiguità? Matteo aveva bisogno della paternità di Giuseppe per illustrare la
discendenza davidica di Gesù. Da lui e solo da lui può avere sangue reale nelle vene.
Di Giuseppe dice che è figlio di Davide, ma non che è il padre di Gesù. Ai lettori
critici come gli scribi non ha fornito una prova convincente. La genealogia di Matteo
non dà la prova richiesta: ‘Gesù figlio di Davide’. Se Giuseppe non è che lo sposo
della madre di Gesù, questi è discendente ‘legale’ di Davide e non un vero figlio.
Perché Matteo si accontenta di una genealogia così debole? Non dimentichiamo che
gli scribi non pretendono né il figlio di una vergine né il figlio di Dio, ma
semplicemente il figlio di Davide. Se Giuseppe è il padre naturale, perché Matteo non
l’ha detto nella sua genealogia? E’ la prova silenziosa, ma molto convincente, della
verginità fisica di Maria. Matteo avrebbe potuto falsificare la realtà. Essendo un
autore impegnato, avrebbe potuto fare di Giuseppe un padre naturale invece di un
padre putativo. Non avrebbe mai potuto fare di Giuseppe un padre putativo, se fosse
stato un padre naturale. Ugualmente, avrebbe potuto presentare Maria come una
madre normale, se era una vergine-madre; non avrebbe mai potuto fare di lei una
vergine-madre, se in realtà era una madre naturale. In questo contesto, Matteo
avrebbe potuto inventare tutto, salvo un padre putativo e una vergine-madre.
L’ipotesi di stupro o di un amante è talmente priva di senso della realtà, che non ne
teniamo conto. Nella sua genealogia Matteo non parla della verginità di Maria.
Questa non è che il rovescio della medaglia. Chi dice paternità naturale di Giuseppe,
implica la verginità fisica di Maria che, a sua volta, è necessaria per onorare la
divinità di Gesù. Il lettore non intravede che questi tre punti: Giuseppe padre
putativo, Maria vergine-madre, Gesù uomo-Dio; o tutti e tre sono inventati, o tutti e
tre sono reali. Il test di ragionevolezza fondato sul dubbio non è più un test
condizionato, perché, grazie al risultato fornito dal test della genealogia, è stata
trovata la condizione richiesta (ossia che Giuseppe non era il padre naturale di Gesù).
Se Giuseppe non è il padre di Gesù, anche il suo dubbio è un fatto storico, perché
necessario, ed è storica la pericope di Matteo 1,18-25 sul dubbio. Il Giuseppe che
dubita (1,19) è lo stesso della genealogia (1,16). Se Giuseppe non è il padre di Gesù,
deve pensare di separarsi segretamente da Maria. In conclusione, questi due racconti
dell’infanzia si dimostrano storici; Giuseppe non è il padre naturale di Gesù; è storico
il dubbio provato da Giuseppe; Maria è madre, pur rimanendo vergine”.
Il racconto del dubbio di Giuseppe non è separabile dalla genealogia, ne costituisce il
naturale complemento. Possiamo paragonarlo al “codicillo” di un testamento,
indispensabile chiave di lettura del testamento stesso. L’importanza del racconto
merita una trattazione a parte; accontentiamoci per il momento di averne segnalato
l’importanza in rapporto alla genealogia, dalla quale non può essere disgiunto, perché
sigilla la paternità di san Giuseppe. Il racconto termina, infatti, con le parole:
“Giuseppe prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce
un figlio ed egli lo chiamò Gesù” (1,25). La frase conclusiva del “codicillo” è
fondamentale per la genealogia; è proprio imponendo il nome al Bambino, che
Giuseppe conferma la sua paternità e convalida tutta la genealogia, iniziata appunto
con il nome “Gesù”.
Giuseppe, una presenza indispensabile
Il racconto di Matteo sulla “nascita” di Gesù (1,18-25) ha sollevato un’infinità di
questioni, sufficienti per comporre un grosso volume, come è sotto gli occhi di tutti.
Riproporre qui uno “status quaestionis” risulterebbe, dunque, un lavoro tanto facile
quanto inutile. Ecco allora la necessità di concentrare l’attenzione sul vero problema
di Matteo, che abbiamo identificato nella messianicità di Gesù, eliminando quanto
non direttamente pertinente.
Per semplice coerenza, dunque, se l’interesse del racconto è rivolto alla discendenza
davidica, non dobbiamo lasciarci preoccupare dalla verginità di Maria e dal
conseguente concepimento verginale. Le due realtà, infatti, non hanno bisogno di
essere “provate”, perché, al contrario, sono all’origine del problema che Matteo deve
risolvere. Non esistono due fronti di combattimento. Mentre per noi oggi la verginità
di Maria, vista come un’esigenza dell’incarnazione, è collocata in evidenza, per la
comunità giudeo-cristiana, invece, che attendeva semplicemente “un figlio di
Davide” e non “il Figlio di Dio”, il primo posto era occupato dalla “messianicità”. La
comunità di Matteo, infatti, non era certamente interessata a creare la “verginità” di
Maria e tanto meno a “difenderla”. Doveva semplicemente “metabolizzarla”, come
Matteo cercherà di fare nel suo racconto attraverso un non facile argomento
scritturistico.
Tutto il racconto è focalizzato, dunque, attorno al figlio generato da Giacobbe (1,16),
ossia Giuseppe, riconosciuto e confermato dall’angelo come “figlio di Davide (v.20).
Da lui dipende, infatti, la legittimazione del figlio di Maria, al quale egli imporrà il
nome: “senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò
Gesù” (v.25). E’ appunto imponendo il nome che a Giuseppe viene riconosciuta la
paternità e conseguentemente la discendenza davidica a Gesù .
Il contesto matrimoniale del concepimento
Matteo entra subito nel vivo dell’argomento e inizia il suo racconto partendo dallo
stato civile della madre di Gesù: “sua madre Maria, essendo [promessa] sposa di
Giuseppe” (1,18). Sorvoliamo su “promessa”, introdotta dal traduttore con
l’intenzione di garantire l’integrità della sposa. Maria, di fatto, a prescindere dalle
modalità del matrimonio - suddiviso in due tappe, insignificanti, tuttavia, per il nostro
assunto - , è “sposata”, ossia “coniunx”, come viene designata in seguito (vv.20.24), e
Giuseppe “sposo”, ossia “vir” (v.19). Solo nel contesto di un vero matrimonio hanno
senso le decisioni di Giuseppe (“pensò di ripudiarla, v.19, e “prese con sé”, v.24),
come pure l’ordine dell’angelo (“prendere con te Maria, tua sposa”, v.20). Lo stato
matrimoniale di Maria e Giuseppe è un punto di partenza necessario per la paternità
di Giuseppe, come chiaramente affermato da Giovanni Paolo II nella scia di
sant’Agostino e di san Tommaso: “La paternità di Giuseppe – una relazione che lo
colloca il più vicino possibile a Cristo, termine di ogni elezione e predestinazione
(cfr. Rm 8,28-29) – passa attraverso il matrimonio con Maria, cioè attraverso la
famiglia. Gli evangelisti, pur affermando chiaramente che Gesù è stato concepito per
opera dello Spirito Santo e che in quel matrimonio è stata osservata la verginità (cfr.
Mt 1,18-25; Lc 1,26-38), chiamano Giuseppe sposo di Maria e Maria sposa di
Giuseppe (cfr. Mt 1,16.18-20.24; Lc 1,27; 2,5). Ed anche per la Chiesa, se è
importante professare il concepimento verginale di Gesù, non è meno importante
difendere il matrimonio di Maria con Giuseppe, perché giuridicamente è da esso che
dipende la paternità di Giuseppe. Di qui si comprende perché le generazioni sono
state elencate secondo la genealogia di Giuseppe. ‘Perché – si chiede sant’Agostino –
non lo dovevano essere attraverso Giuseppe? Non era forse Giuseppe il marito di
Maria? (…) La Scrittura afferma, per mezzo dell’autorità angelica, che egli era il
marito. Non temere, dice, di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo. Gli viene ordinato di imporre il nome al
bambino, benché non nato dal suo seme. Ella, dice, partorirà un figlio, e tu lo
chiamerai Gesù. La Scrittura sa che Gesù non è nato dal seme di Giuseppe, poiché a
lui preoccupato circa l’origine della gravidanza di lei è detto: viene dallo Spirito
Santo. E tuttavia non gli viene tolta l’autorità paterna, dal momento che gli è ordinato
di imporre il nome al bambino. Infine, anche la stessa Vergine Maria, ben
consapevole di non aver concepito Cristo dall’unione sessuale con lui, lo chiama
tuttavia padre di Cristo’” (Redemptoris Custos, n.7). San Tommaso, da parte sua,
nella IIIa parte della sua Summa, dove tratta dei misteri della vita di Cristo,
avvertendo la necessità del matrimonio della Madre di Dio, si introduce subito con
due questioni: 1. Cristo doveva nascere da una donna sposata?; 2. Il matrimonio tra la
Madre del Signore e Giuseppe fu vero matrimonio?
Tutto il racconto di Matteo si svolge, dunque, all’interno del matrimonio, che ne
costituisce il perno.
Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo
Con l’affermazione “Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo” (1,18),
Matteo non denuncia semplicemente un incidente di percorso, bisognoso di una
complessa spiegazione, ma rivela, proprio in apertura del suo racconto, il mistero
cristiano dell’Incarnazione, origine della modifica della genealogia. Teniamolo
presente. Succede, invece, che lungo la storia dell’esegesi l’attenzione si sia riversata
piuttosto sulla verginità di Maria, suscitando dei dubbi, che la comunità apostolica,
invece, non aveva.
L’affermazione unitaria di Matteo (1,18) viene da alcuni suddivisa in due parti,
considerando la seconda parte (“per opera dello Spirito Santo”) come una “prolessi”,
ossia una precauzionale spiegazione “anticipata” della realtà, allo scopo di prevenire
eventuali dubbi nel lettore circa l’onestà di Maria, dubbi da imporre, piuttosto, a san
Giuseppe. Quale la conseguenza? Invece di illuminare con l’appoggio della citazione
del profeta la “mirabile maternità di Maria” - come si esprime la “Redemptoris
custos” (n.3) - tutto il messaggio angelico avrà come scopo quello di tranquillizzare
l’animo angustiato di Giuseppe, rivelandogli appunto la verginità di Maria. La
differenza delle due interpretazioni non è da poco; esse sono conosciute come la tesi
del “rispetto” e la tesi del “sospetto”.
Conseguentemente anche l’interpretazione del titolo “giusto”, riconosciuto dallo
stesso Spirito Santo (Autore del testo ispirato) al santo personaggio, oscillerà tra due
estremi: quello di san Bernardo di Chiaravalle (+1153), che lo considera una lode
(“cuius laus est in Evangelio”), e quella opposta, secondo la quale il dubbio di
Giuseppe “non è solo un dramma personale, ma è quello di tutta l’umanità, la
difficoltà di accettare quello che è al dà della ragione umana, l’incarnazione di Dio”.
La congiura del silenzio
La tesi del “sospetto” parte dalla convinzione che san Giuseppe non conoscesse
l’origine della maternità di Maria, ossia l’opera dello Spirito Santo. Maria, infatti, si
sarebbe chiusa nel “silenzio”. Quali gli argomenti? Maria temeva che Giuseppe non
le avrebbe creduto e si sarebbe addirittura adirato; Maria non avrebbe potuto sperare
di essere capita da Giuseppe; Maria si sarebbe rimessa completamente a Dio
lasciando a lui di completare l’opera iniziata; Maria avrebbe taciuto per umiltà e
modestia; infine, Maria deve aver taciuto – e siamo da capo! - , altrimenti non si
capirebbe la rivelazione dell’angelo (v.20) e cadrebbe tutto il pathos del racconto.
Queste spiegazioni sono molto diffuse.
A questo punto entra il “test” della ragionevolezza. Senza rinunciare alla diretta
testimonianza di Maria, sulla quale ci soffermeremo in seguito, la conoscenza della
“mirabile” maternità di Maria poteva essere giunta alla conoscenza di Giuseppe da
altre fonti, come, ad esempio, il “naturale” tramite della madre della giovanissima
Maria, certamente preoccupata dell’onore della figlia. Notiamo, tuttavia, che è il
Vangelo stesso ad interessarsi di informare Giuseppe sull’origine della gravidanza
della sposa. Non rivela forse l’angelo Gabriele a Maria la miracolosa maternità di
Elisabetta (Lc 1,36) a riprova della potenza di Dio? I commentatori motivano la
“fretta” di Maria (v.39) di andare a farle visita con il suo desiderio di esercitare la
carità verso l’anziana; ma perché non viene prima loro in mente l’esercizio della
carità verso il marito, invitandolo a controllare il “segno”? Di questo, infatti, si tratta:
Elisabetta benedice il frutto del grembo di Maria; la saluta come “madre del mio
Signore”; la dichiara “beata” per aver creduto nell’adempimento di ciò che il Signore
le aveva detto; oltre a tutto questo, Giuseppe ascolta il “Magnificat” di Maria. Chi più
di lui poteva capirne il significato? Che dire poi degli avvenimenti accorsi in
occasione della nascita di Giovanni, ai quali Giuseppe “ragionevolmente” è ancora
interessato? Nasce, infatti, veramente un “maschietto” (viene circonciso!), come
predetto dall’angelo (cf. Lc 1,36); Zaccaria, inoltre, “profetizza” che il Dio d’Israele
ha suscitato un Salvatore “nella casa di Davide” (Lc 1,69). Chi avrebbe potuto capire
meglio di san Giuseppe?
Il “ragionevole” comportamento di Maria
San Giovanni Crisostomo nelle sue Omelie sul Vangelo di Giovanni commenta così
la vocazione di Andrea: “Andrea, dopo essere restato con Gesù e aver imparato tutto
ciò che Gesù gli aveva insegnato, non tenne chiuso in sé il tesoro, ma si affrettò a
correre da suo fratello per comunicargli la ricchezza che aveva ricevuto. Ascolta che
cosa gli disse: ‘Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)’ (Gv 1,41). Quella
di Andrea è la parola di uno che aspettava con ansia la venuta del Messia, che ne
attendeva la discesa dal cielo, che trasalì di gioia quando lo vide arrivare, e che si
affrettò a comunicare agli altri la grande notizia. Dicendo subito al fratello ciò che
aveva saputo, mostra quanto gli volesse bene, come fosse affezionato ai suoi cari,
quanto sinceramente fosse premuroso di porgere loro la mano nel cammino
spirituale”. Riguardo a Pietro, lo stesso Crisostomo commenta: “Nessuno certo
condannerà la facile condiscendenza di Pietro nell’accogliere la parola del fratello,
senza aver prima esaminato a lungo le cose. E’ probabile infatti che il fratello gli
abbia narrato i fatti con maggior precisione e più a lungo, mentre gli evangelisti
compendiano ogni loro racconto preoccupandosi della brevità. D’altra parte non è
detto nemmeno che abbia creduto senza porre domande” (Om. 19,1: PG 59, 120121).
Che dire, allora, di Maria? Maria è la prima creatura in terra alla quale è stato dato
l’annuncio della salvezza dell’umanità. La pietà dei fedeli ha espresso questo
privilegio, definendo Maria l’“Annunziata”. Non è, dunque, naturale pensare che
Maria, l’Annunziata, sia stata anche la prima annunciatrice della “Buona Novella”
(questo è il Vangelo!) e ne abbia reso partecipe per primo la persona più amata, ossia
san Giuseppe, il quale, oltre tutto, essendo il suo vero sposo, è la persona non solo più
interessata, ma anche la più coinvolta nel mistero della sua maternità? E’ spontaneo
chiedersi come l’interpretazione del racconto di Matteo 1,18-25, che impone a Maria
il silenzio, costringendo Giuseppe ad arrivare faticosamente alla conoscenza del
mistero dopo tormentosi sospetti, sia conciliabile con l’emergente personificazione di
Maria come “Figlia di Sion”, invitata dall’angelo alla “gioia” (“Rallegrati, piena di
grazia”, Lc 1,28) per la venuta del tanto atteso Redentore. Come avrebbe potuto
proprio lei, l’Annunziata, di fronte ad un avvenimento che richiede la sua immediata
proclamazione, chiudersi in un muto silenzio?
Non togliamo a Maria la gioia e la gloria di essere stata la prima evangelizzatrice e
non togliamo a Giuseppe il diritto e il privilegio di essere stato il primo
evangelizzato! Giovanni Paolo II afferma chiaramente nell’Esortazione apostolica
“Redemptoris Custos”: “Di questo mistero divino Giuseppe è insieme con Maria il
primo depositario. Insieme con Maria – ed anche in relazione a Maria – egli
partecipa a questa fase culminante dell’autorivelazione di Dio in Cristo, e vi
partecipa fin dal primo inizio. Tenendo sotto gli occhi il testo di entrambi gli
evangelisti Matteo e Luca, si può anche dire che Giuseppe è il primo a partecipare
alla fede della Madre di Dio, e che, così facendo, sostiene la sua sposa nella fede
della divina annunciazione” (n.5). Come già Mosè anche Giuseppe sa bene di trovarsi
di fronte al “roveto ardente”: “Non avvicinarti oltre!” (Es 3,5).
Il messaggio angelico
Dopo la decisione di Giuseppe di separarsi da Maria, comunque la si voglia
interpretare, Matteo inserisce l’apparizione di un angelo in sogno. Il contenuto del
messaggio è chiaro: Giuseppe deve trattenere con sé Maria, sua sposa; il bambino
viene dallo Spirito Santo; Giuseppe, tuttavia, gli deve imporre il nome, ossia
riconoscere in tal modo la sua paternità. Del bambino è rivelata contemporaneamente
la “missione”, contenuta nel nome stesso di “Gesù” (“salverà il suo popolo dai suoi
peccati”), e l’“identità” divina, esplicitata nella traduzione di “Emmanuele” (“che
significa Dio con noi”).
Ogni punto meriterebbe di essere commentato. Limitiamoci alla citazione matteana
dell’Antico Testamento (Isaia 7,14), oggetto da sempre di tanti commenti e
discussioni: “Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal
Signore per mezzo del profeta: ‘Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio;
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi’” (1,22-23). Il testo
di Isaia (almeno fino al tempo del Concilio Vaticano II) era ritenuto altamente
“profetico”; la chiara espressione “vergine” era vista dagli avversari come una
“forzatura” o esplicitazione arbitraria della traduzione greca, utilizzata da Matteo. La
contesa, molto accesa nel passato, si è andata talmente spegnendo, da far passare
quasi inosservato l’autorevole intervento di Giovanni Paolo II, che ha disinnescato la
bomba: “Tale profezia nel testo ebraico non enuncia esplicitamente la nascita
verginale dell’Emmanuele: il vocabolo usato (almah), infatti, significa
semplicemente ‘una giovane donna’, non necessariamente una vergine. Inoltre, è noto
che la tradizione giudaica non proponeva l’ideale della verginità perpetua, né aveva
mai espresso l’idea di una maternità verginale” (Allocuzione del 31 gennaio1996). Si
tratta, perciò, nel caso della citazione di Matteo, non tanto di una “prova” scritturale a
dimostrazione della realizzazione di un “fatto” previsto e annunciato, quanto piuttosto
di mostrare che quanto di nuovo e strabiliante è accaduto ora nel Nuovo Testamento è
la continuazione o sviluppo dell’unico progetto di Dio. Eccoci, allora, trasferiti nella
questione dell’unità dei “due Testamenti” e del loro rapporto, già presente in san
Paolo (“figure, ombre”) e sintetizzato da san Tommaso come “sviluppo
dall’imperfetto al sua perfezione”.
Giuseppe lo chiamò Gesù
Riassumendo e concludendo. Matteo inizia il suo Vangelo con le parole “Genealogia
di Gesù figlio di Davide” (1,1). Abbiamo chiarito quanto questa genealogia fosse
necessaria per la messianicità di Gesù e come Matteo fosse consapevole della sua
fragilità “fisica”, da lui chiaramente ammessa con la sostituzione dell’ultimo
“generò” con la qualifica di “sposo di Maria” (1,16). Di qui, appunto, la necessità del
“codicillo” del quale ci stiamo occupando. Il procedimento stilistico usato da Matteo
è quello dell’“inclusione”, che consiste nella ripresa, alla fine di una pericope e di una
sezione, di un termine o di una formula usata all’inizio. Nel nostro racconto essa è
formata dal nome di Gesù, con il quale si apre (v.18) e si chiude (v.25) la pericope.
Conseguentemente è del tutto ingiustificata l’omissione nei Lezionari liturgici proprio
delle parole conclusive: “ed egli lo chiamò Gesù” (v.25), che richiamano la parola
iniziale del capitolo (1,1), ossia “GESU”, del quale si vuole, appunto, dimostrare il
diritto al titolo di CRISTO, legittimo perché “figlio di DAVIDE”. E questo per mezzo
del “figlio di Davide”, il giusto Giuseppe, che ha riconosciuto come suo,
imponendogli il nome, il figlio dato alla luce dalla sua “sposa” Maria. Si tratta di
un’unica catena, nella quale “ogni anello” è essenziale; un anello rotto o mancante,
spezza l’intera catena.
Per chi desideri “attualizzare” la Sacra Scrittura, niente più di questa pericope
richiama all’uomo la dignità della famiglia, all’interno della quale Dio ha voluto
inserire l’Incarnazione, nonostante la trascendenza dell’evento. In questo incontro del
“divino con l’umano” si comprende l’importanza dell’istituzione del matrimonio, che
Dio non solo vuole che sia rispettato, ma che egli stesso sceglie per l’inserimento
onorato di suo Figlio nella famiglia umana. Di qui ancora la funzione indispensabile
della paternità in esso, che si traduce nel rispetto della madre (“non ha voluto
ripudiarla, v.19) e in onore per il figlio, la cui legittimità va riconosciuta (vv.21.25).
Giustamente i commentatori vedono in questo capitolo la “vocazione di Giuseppe”,
“chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante
l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei
tempi al grande mistero della redenzione ed è veramente ‘ministro della salvezza’”
(Redemptoris custos, n.8).