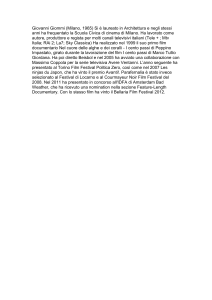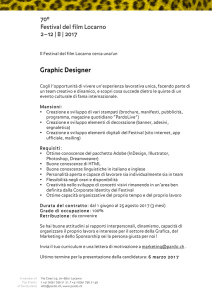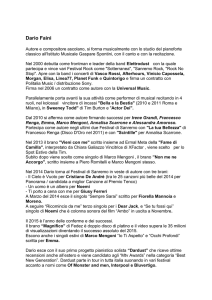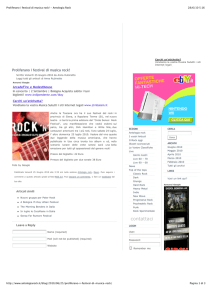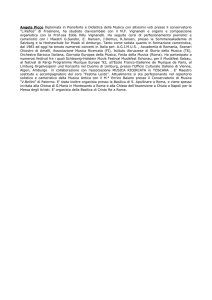N.8
ARTE NOMADE
Rivista di musica arti multimediali e viaggi
LAVOCEDELPROFETA
Molto spesso, ora più che mai, l’approfondimento culturale passa attraverso studi accademici, televisioni e internet. La ricerca
viene fatta principalmente seduti ad una scrivania o comodi nel divano di casa. Il materiale a disposizione è talmente vasto che
il grosso del lavoro si riduce ad un processo di “copia e incolla” e conseguentemente perde di quell’esperienza personale fatta
“sul campo”. Giuseppe Tucci, il nostro vate, ai suoi allievi consigliava vivamente il metodo della ricerca diretta, alle origini
delle fonti. Lui stesso, percorrendo a piedi i vasti territori himalayani, raccolse una messe infinita di dati e documenti che poi
filtrò attraverso la sua esperienza diretta tra i popoli e i territori attraversati. Questa premessa serve a spiegare i contenuti di
questo numero che ha come trait d’union dei vari articoli proprio il viaggio personale, fatto spesso in condizioni estreme e
rischiose. Ad esempio quello organizzato da Arte Nomade nei territori dell’Humla in Nepal. Venti giorni di trekking sopra i
4000 metri d’altitudine con temperature che hanno spesso raggiunto i 10° sotto zero per documentare popoli e villaggi rimasti
per secoli lontani dal mondo tecnologizzato. O quello in Etiopia, appoggiatosi alla Missione dei Frati Cappuccini, avente
intenti documentativi e umanitari. E ancora quelli europei fatti nelle Fiandre e a Barcellona in cerca di una poetica che le
grandi città riservano ormai solo agli animi più sensibili e curiosi, a coloro che sanno cercare e cogliere le vere peculiarità
metropolitane al di là del potente ed evidente impatto globalizzante. Anche il supporto fonografico allegato, il doppio CD Iang
Pipol, nasce dall’esperienza diretta dei curatori dell’omonima trasmissione televisiva dopo 5 anni di lavoro per il settimanale
della Redazione Regionale della Rai 3 Marche. 5 anni in cui la troupe, con l’intento di documentare i fermenti culturali della
regione, si è ritrovata con un materiale audio che rappresenta la sintesi del buon lavoro svolto nel lungo viaggio tra rassegne,
festivals, sale prove e sale d’incisioni delle Marche. In definitiva, sempre più, stanno emergendo i punti filosofici
fondamentali di Arte Nomade con la speranza che gli abbonati, e non solo, colgano e condividano la nostra proposta
alternativa di vita e si uniscano alla “grande famiglia” sia nelle iniziative che nelle proposte. A tal proposito un caro saluto va a
Giuseppe Matteucci, il compilatore dell’articolo su Cecco d’Ascoli, abbonato e lettore e da ora nostro collaboratore.
“...la nostra vita è ancora in preda alla sua pura esistenzialità. È vero: tende a non esserlo: cioè a perdere la casualità; gli
uomini tendono sempre più a considerare ciò che succede loro come del tutto previsto e normale; la civiltà tecnica e la
produzione in serie determinano milioni di destini tutti uguali, e quindi privi di quello stupore del succedere che è il senso
del romanzo.”
PIER PAOLO PASOLINI
PRECISAZIONE: i saggi NEL LIMBO DEI METICCI e ZITTIRE I CAMPANELLI di Sergio Quinzio, presentati nel
numero 7 di Arte Nomade sono già comparsi sulle pagine della Stampa di Torino.
SPECIALE
IANG PIPOL
di Alessandro Bolli
La storia di Iang Pipol ha radici lontane. Parte da Strada Statale 16, un telefilm che Rai3 Marche produsse nel 1981: tre
storie intrecciate che si snodavano lungo il litorale adriatico marchigiano e finivano tutte malissimo. Fu presentato a non so
quale festival di telefilm e reportage realizzati da tutte le sedi regionali Rai e arrivò buon ultimo con, mi pare di ricordare,
una qualche nota di demerito. Segno che era molto buono, insomma. La regia era di Giuseppe Camilletti, che insieme a
Tony Prenna e Massimo Rogati, ne scrisse anche la sceneggiatura. Le riprese erano di Carlo Bragoni, che con Daria
Beni cura oggi Iang Pipol, per l’appunto. Per la scelta delle musiche mi diedero carta bianca e non mi parve vero di ficcarci
dentro -nel 1981- PIL, Devo, i Teenage Jesus & The Jerks di Lydia Lunch, DAF, il Bowie berlinese, Gaznevada, Adam
+ Ants, Kraftwerk, la Yellow Magic Orchestra di Sakamoto e un sacco di altra gente che ora non ricordo ma che sortì,
nello spettatore medio ma non solo, quell’effetto urticante che volevamo(?) avesse. Le comparse le rastrellammo tra i vari
giri di amici e concerti coinvolgendo un paio di gruppi punk locali. Rivisto oggi (è stato festeggiato al Civitanova Film
Festival di due anni fa), nonostante diverse ingenuità, dà ancora diversi giri di pista a tanta roba gggiovane che viene
prodotta con ben altro impiego di mezzi e di soldi. Forse perché già eravamo più sei piedi sotto terra che tre metri sopra il
cielo. Più o meno tre anni dopo per il mensile Frigidaire, che realizzò una mappatura dei gruppi italiani in diverse puntate,
curai le schede di Marche e Umbria, giusto per toccare con mano, poiché cercar di fissare un mondo così magmatico è
come spalare l’acqua del mare coi bastoncini per il sushi. Problema ancor più grosso oggi che il rock tira, e per le sole
Marche le band attive sembrano essere 1.500, ossia una ogni 1.000 abitanti, più o meno un musicista ogni 250. Come dire
che Iang Pipol può essere solo la vetrina parziale di un fenomeno, forse meno scapicollato, ma senz’altro più vasto che in
passato. Tornando alla storia, nel 1998, Carlo e Daria, raccogliendo un suggerimento della dirigenza regionale Rai di dare
vita a un progetto che parlasse dei giovani, realizzarono un’inchiesta intitolata Marche Rock, dove in una manciata di
puntate raccontammo quello che fu il percorso di questa musica, dagli inizi a oggi, qui da noi e, soprattutto, furono presentati
anche diversi nuovi gruppi a illustrare la realtà che si stava vivendo in quella fine di millennio. Erano, in nuce, delle preview
di Iang Pipol. Una volta varata, la rubrica ha visto crescere di continuo il numero di spettatori negli anni e attualmente la
redazione è subissata da richieste di ragazzi che fanno musica ma che si occupano anche di arte a vari livelli e che cercano in
quel piccolo spazio del giovedì un minimo di visibilità, com’è giusto che sia. Un segno tangibile che, se si vuole, qualcosa di
buono si riesce a fare anche con la televisione.Con il doppio cd omonimo, Carlo e Daria hanno voluto semplicemente dare
vita a un progetto che riuscisse a documentare quattro anni di attività di Iang Pipol (non della regione in sé, che ancora
molto ha da raccontare), pescando tra i gruppi che sono intervenuti e che dimostrano quanto il suono sia indirizzato a 360°,
dal recupero del folk all’electropop, dal metal allo ska, dal blues al reggae, dalla musica cantautoriale al caro vecchio
rock’n’roll. Niente male per una regione dove, come sarà capitato anche a voi di sentir dire da chi proviene dal resto d’Italia,
“sembra che non succeda mai niente”.
DENTRO IANG PIPOL COMPILATION
Le compilation, specie quelle che non vanno per argomento, o ci vanno per sommi capi (la musica etnica, sempre che
qualcuno mi spieghi che significa, o la disco in senso lato, dove le Ritchie Family, James Brown e l’LCD Soundsystem
potrebbero stare strettissimi insieme), per quanto ben congegnate come possono essere, ad es, quelle di Les Inrockuptibles o
di Wire, stridono sempre un po’ quando si passa da atmosfera ad atmosfera (evito appositamente la parola genere). Figurarsi
una come Iang Pipol, dove il massimo comun denominatore non è una stessa linea sonora ma i cartelli indicatori che ci
racchiudono a nord di Pesaro e a sud di Ascoli Piceno. Eppure, a forza di ascoltarla, prima per selezionare i brani (molti,
invero, già indicati dalle band), poi per cercare di dare un’armonia alla scaletta, il tutto iniziava ad avere un suo senso,
ovvero i vari modi di assorbire una stessa terra e di risputarla sotto forma di emozioni le più diverse. Così, se gli alfieri di
sempre, i Gang, hanno compiuto un viaggio a ritroso che dalla Londra di Strummer li ha riportati a casa con un bel
bagaglio umano e armonico (bringin’ it all back home, no?), i Polyetnik Muzak sparano la musica popolare e dialettale
nello spazio siderpunk. Se i Cheap Wine alle bandiere blu un po’ chiquitose del nostro mare preferiscono le polverose
strade blu americane, i Luxluna guardano con amarezza e ironia alle sgangherate orchestrine balcane. Se Zap si muove
(distorcendo) con maestria tra il Bowie più luccicante e lo Zappa più rocchettaro, gli Elettrodust (affiancati da Ivan
Cattaneo, una delle migliori menti del nostro pop quando non si procura il pane quotidiano in revival sixtosi e reality
catodici. O forse anche lì) infilano un gioiellino electropop difficile da togliere dalla testa. Cos’altro abbiamo qui? I
F.L.A.G. che sono cresciuti mostruosamente dai tempi d(e)i Re-azione tanto che è stato difficile selezionare un brano dalla
loro ultima fatica; i Kurnacchioni che, da brava band di culto di migliaia di giovani marchigiani, hanno offerto la sigla della
rubrica del TgR intorno a cui tutto questo si è mosso; il gran talento tecnico di Dogma e Metronhomme (un concept-album
ricco di fantasia, il loro); i sorprendenti Perfect Guardaroba a cavallo tra le vecchie zampate dei Jam e il rombare dei
BRMC; i Pincers, personalissimi e con un album molto interessante; gli Oginoknaus (gran nome) della cui Monster der
Gesellschaft mi innamorai già quando la inserii in una passata compilation di Anomolo; il recupero del folk sia in
interessanti adattamenti modernizzati (Vincanto) che filologici (Bùsqueda) che demenziali (Mortimer Mc Grave:
Farewell To Garbatella vince il titolo di... miglior titolo della raccolta); Paolo F. Bragaglia che con una Monica Demuru
in splendida forma presenta una versione in inglese (e modernizzata) di Doppler Fx; la sbandata pornopunkfunk, già
ostaggio di qualche dj, di aarctic_hysteria, la chanson ibrido folk-blues-reggae dei rodati Radio Noè; lo stralunato
(rhythm&)blues-gospel-rock dei Varechina Loredana; il potente post-core dei My Cherry-Flavored Grave che si impone
un po’ di più ad ogni nuovo ascolto, la torturata ballad dei sempre più maturi Drunken Butterfly (in arrivo il loro terzo
album); il boogie perfetto e vitalissimo del santone Joe Galullo; le atmosfere rilassate/nti degli Ogam e la lunga ballata folk
rock dei ben noti Oloferne; il (post?)rock intimista dei M.A.Z.C.A. che ricorda certi acquerelli di Mr. Vini Reilly; la fiesta
ska dei sempre più lanciati Radio Babylon, qui coadiuvati da Roy Paci; il rock dei Nadesico, altro gruppo
compositivamente molto cresciuto in poco tempo e capace di riff azzeccati che invitano al coro; il beat psichedelico e sporco
dei John Doh di un altro veterano della scena, Leonardo Terenzi; il pop d’autore dei Lanafina e, last but not least, le
atmosfere cantautoriali dei Per Presa Visione i cui (alti) riferimenti sono evidenti. Per una visione più completa della
musica della regione, oltre ai cataloghi di Bloody Sound e di Arte Nomade, occorre nominare altre importanti compilation,
come quelle natalizie di Anomolo (i gruppi per lo più sono a livello nazionale ma compaiono anche molte formazioni
marchigiane), March(e)ingegno Sonoro, curate da Kathodik (Macerata), una delle più vecchie e seguite webzine italiane e
dalle folli raccolte dei folli geniacci di Lupinaria (Recanati). Il tutto, consapevoli che già altri nomi, vecchi e nuovi
pressano: Versailles, Gallina, Guinea Pigs, Lleroy, Sedia, Helena Verter, Anima Equal, Edible Woman, Vel, Lush
Rimbaud, Hi-Risk Cafè, Planeatnon, Ex Pistols, Le Bruit Du Monde, Rain, Rota Cupa e Res Nullis, Dadamatto,
Chewing Gum, Fabio Camilletti, Specially Mild, Firesons, Almanacer, Total Revenge, Voibbuska, etc etc etc etc etc
etc etc etc etc etc etc etc etc.
Naturalmente, non ho dimenticato quelle gran belle persone che sono i Malavida, che qui eseguono il loro anthem Grazie,
che contiene una delle frasi più belle mai messe in una canzone: “grazie per i giorni mai vissuti”.
Grazie a tutti. Con quel che segue.
Cd1 Track 1
VOLEMO ANDÀ AL FESTIVALBAR
I Kurnalcool nascono nel 1986 e nel giro di pochi mesi riescono ad imporsi all’attenzione del pubblico locale sia per la musica suonata che per i temi
trattati nelle loro canzoni. I Kurnalcool sono gli inventori del VI’ METAL, cioè hard rock con testi che raccontano storielline alcoliche capitate ai
componenti del gruppo ed ai loro amici usando un linguaggio giovanile corrente, che quindi comprende anche espressioni colorite. Tra il 1986 ed 1990 il
gruppo incide 4 demo tapes. Nel 1991 il gruppo si scioglie ma 6 anni dopo, pressati dalle richieste dei vecchi fans ormai cresciuti e dai loro fratelli minori,
e soprattutto sorpresi dal fatto che il nome Kurnalcool era tutt’altro che morto, i 7 curnacchioni decidono di ritornare sulla scena per alcune serate
commemorative. Il calore dei fans li convince a continuare. A breve esce Bumba Atomika, loro primo lavoro ufficiale che in 8 mesi vende 1000 copie
solo nelle Marche. A due anni di distanza dal primo cd le kurnakkie ci riprovano con un nuovo lavoro, Stand By Vi’, musicalmente più vario del primo
album ma ugualmente tagliente e provocante. Il terzo lavoro dei Cavalieri della Bumba è un live e si intitola Fuckin’ Giubilive. Nel 2002 il gruppo si
smembra ed entrano forze nuove e motivate che ridanno grinta anche ai reduci dell’86. Esce Takki A Beve, quarto lavoro dell’instancabile band
falconarese.
www.unofficialkurnalcool.com
Cd1 Track 2
ALIBI
La band nasce all’inizio del 2002, fondata da elementi ben conosciuti nel panorama underground. Tra loro il chitarrista Fulvio Ilari, ex lonely boys,
rumdum, re-azione (finalista Indipendenti) e Luigi Gattafoni già front-man dei re-azione (finalista indipendenti e Rock targato Italia). Due chitarre,
basso, batteria: il quartetto propone un rock ruvido e melodico allo stesso tempo, con venature pop soprattutto nel cantato in italiano. Presenti al Meeting
delle Etichette Indipendenti di Faenza, 2005 e 2006, i F.L.A.G. hanno partecipato all’ AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL 2006 quale vincitore
delle finali Arezzo Wave Marche. Nel marzo 2007 hanno vinto le selezioni di Rock targato Italia 2007 e parteciperanno alla finale nazionale di Milano.
Dopo l’autoproduzione 100% e diversi promo attualmente il gruppo, con il nuovo chitarrista Fabio Quintozzi, ha ultimato le registrazioni del nuovo CD
con etichetta indipendente. Ospite Caterina Trucchia alias Helena Verter (cori).
www.flagelettropop.it
Cd1 Track 3
TIME FOR ACTION
I Cheap Wine cominciano a suonare per sfuggire alla desolazione che attanaglia l’Italia negli anni Ottanta. La scintilla parte da Marco Diamantini: “I
Cheap Wine erano nati alla fine degli anni Ottanta, ma suonavano solo in un vecchio garage. Io sono l’unico reduce da quella preistoria. Quando ho
deciso che volevo fare qualcosa di serio, sono rimasto solo, perché i compagni di allora cominciavano ad avere altri programmi: famiglia, carriera, ecc.
Nel frattempo, Michele, Alessandro e Francesco avevano un loro gruppo, ma anche questo si stava sfaldando. Così abbiamo deciso di metterci insieme e
di conservare il nome Cheap Wine”. I quattro cominciano a seguire le strade del rock americano, che dalle nostre parti non sono certo le più frequentate. Si
riconoscono nel rock, ne assimilano la forza e ne concretizzano lo stile, le tematiche, l’etica all’interno della propria esperienza. Questa coerenza è la linfa
di cui si nutrono producendo dischi anomali per il panorama italiano. L’impianto sonoro-narrativo è trapiantato dal rock americano e coltivato in una terra
come quella italiana, che per tradizione è ostica ad una materia poco melodica, per nulla accomodante e affatto nostalgica.
www.cheapwine.net
Cd1 Track 4
STRANGE WORLD
La band si foma nel 2002 dal soladizio artistico di Lorenzo Paoloni, Luca Ditullio, Niko Giubelli, muovendo i primi passi verso un rock grezzo con una
formazione essenziale, (basso, chitarra, batteria), proponendo al pubblico le cover più famose del rock internazionale. Gia dal 2003 incomiciano ad
abbozzare brani scritti di proprio pugno per poi eseguirli dal vivo fino ad arrivare al 2005 dove iniziano la lavorazione del primo cd contenente otto brani
inediti dal titolo The Mirror pubblicato nel settembre 2007. Nello stesso anno vengono inseriti due nuovi elementi: Lorenzo Bucci alle tastiere ed il bassista
Francesco Barsotti.
www.nadesicoband.it
Cd1 Track 5
GIÙ
Mazca è sperimentazione e voglia di rigenerarsi continuamente. la musica dei mazca è un mantra avvolgente dove materiche pennellate di chitarra si
intrecciano a solide linee di basso e roboanti ritmiche impreziosite da accattivanti arrangiamenti analogico-digitali. Mazca è attento alla contingenza della
vita e da questa trae la propria linfa vitale.
www.myspace.com/mazcasound
Cd1 Track 6
MONSTER DER GESELLSCHAFT
Il progetto oginoknaus prende forma a Senigallia nel 1999. Nato dall’incontro di personalità diverse oginoknaus cerca di unire, esaltandone le peculiarità,
istanze estetiche distanti tra loro nel tentativo di comporre musica costantemente contingente. Il progetto oginoknaus vivrà fino a quando sussisteranno le
condizioni perché questo avvenga. Tali condizioni possono essere condotte ad un esiguo numero di fattori: divertirsi, mettersi continuamente in gioco, fare
musica per il piacere di farlo.
www.oginoknaus.com
Cd1 Track 7
LA GIOIA DI QUANDO ERO BAMBINO
Uno dei gruppi più rappresentativi della scena underground marchigiana. Iniziano la loro carriera artistica con la partecipazione al festival Arezzo Wave ed
alla compilation Soniche Avventure (Fridge Records/Sony). Hanno all’attivo due album pubblicati con la Fridge Records e due tour nazionali. Per
Gennaio 2008 è prevista l’uscita del loro terzo album in studio.
www.drunken-butterfly.com
Cd1 Track 8
TRY AGAIN
The Perfect Guardaroba suonano un rock/punk ’n’roll energico, melodico e travolgente, che unisce sonorità rock degli ’80 ad attitudini punk dei ’70, il
tutto rivisitato in chiave moderna sotto l’influenza di gruppi attuali (Mando Diao, Kings Of Leon, Black Rebel Motorcycle Club, The Hellacopters)
dando vita così ad un genere unico e davvero innovativo. Su Myspace sono stati pubblicati 3 brani che fanno da preludio ad un futuro album, che vedrà la
luce con l’arrivo del prossimo anno. Ad ottobre la band è stata impegnata nella realizzazione di un videoclip, che farà parte del lancio promozionale,
insieme ai tre brani, del nuovo corso del gruppo di giovani rockers. Nel tour invernale, sono previste, per loro, delle date in Inghilterra e in tutta la
penisola, mentre già sono confermate delle esibizioni in Germania.
www.theperfectguardaroba.com
Cd1 Track 9
BABY BOOGIE BOO
È nato a Milano nel 1950. A tredici anni suonava Guitar Boogie di Arthur Smith e nel 1964 è entrato nel suo primo gruppo, i Moods, che suonavano brani
di Little Richard, Ray Charles e The Yardbirds. Dopo l’esperienza con i Moods, Joe ha costituito gli Atomic Head, un gruppo rock-blues dal suono
grintoso che interpretava brani dei Cream, di Jimi Hendrix e brani scritti dallo stesso Joe. Dal 1971 fino al 1980, Joe ha girato l’Europa, fermandosi a
lungo ad Amsterdam ed a Londra, dove suonava nelle strade e nei metrò. Si è poi trasferito a Bologna dove, seguendo percorsi separati, lui ed Andy J.
Forest hanno rappresentato per circa un decennio il movimento blues locale. Nel 1981 ha conosciuto Ermanno Costa ed è nata una collaborazione sfociata
nella produzione del suo primo disco realizzato con The Blues Messengers: It’s My Life (1986 – Coast To Coast). E’ iniziato così un periodo di concerti che
lo hanno portato sui migliori palchi italiani: Pistoia Blues Festival, Porretta Soul Festival, Bologna Blues Festival ed altri, riscuotendo ampio consenso.
Da ricordare anche la tournée con Jorma Kaukonen. Nel 1990 il secondo disco, Blues Without Fronteers (Green Line). Nel 1998 è uscito il cd Melody In
The Blues dove il blues si incontra con la musica classica rappresentata dalla moglie Paulina Golas al violino. Nella primavera del 2004 esce The Blues Is
Back. Joe riappare quindi nell’estate dello stesso anno sul palco del Pistoia Blues festival, a distanza di vent’anni dalla prima esibizione, e torna a calcare i
palchi dei più importanti festival e club italiani. Marchio di fabbrica del cd sono, inevitabilmente, l’inconfondibile chitarra e la voce, assolutamente nera, di
Joe Galullo. L’ultima fatica discografica, Have A Good Morning, è uscito a fine 2006. Come nei precedenti lavori Galullo firma la quasi totalità dei brani
presenti in scaletta (dieci su dodici), spaziando dal blues al boogie alla soul ballad, e confermandosi come uno dei più puri, sinceri ed eclettici bluesman
italiani.
www.joegalullo.com
Cd1 Track 10
MCCOY
L’assurda band di Ripatransone (Ap), che ha subito notevoli mutamenti, propone il suo personalissimo rock ittico. “La sofferenza è per molti ostile,
ma non per noi che abbiamo saputo fare della nostra sofferenza una forma d’arte”. Di questo malcontento generazionale vive il suono dei VL,
acustico e fuorviante. Tutto accade nel 2001. Dalla spaccatura creatasi da alcuni gruppi locali, nascono i Varechina Loredana. Amanti del blues, ex
punkettari da strapazzo, casinari alla John Zorn, fissati per i campionamenti e gli sberleffi, amanti dei canti liturgici e delle processioni, del cabaret e
del teatro. Non hanno un termine preciso per definire la loro musica, il loro segreto è stato quello di essere stati male assortiti sin dall’inizio. Secondo
posto al Sound Good Festival 2003. Secondo posto ad ALTRISUONI 2004. Secondo posto a SOTTERRANEA 2004. Primo posto al Sound Good
Festival 2004. Semifinalisti REGIONE MARCHE Arezzo Wave 2006. Dal 2006 virando per il Rock Ittico e lasciandosi alle spalle refusi punk, si
esibiscono con una nuova formazione. Nel 2007 è uscito il primo CD intitolato Live in Studio.
www.varechinaloredana.splinder.com
Cd1 Track 11
THE 3RD OUTSIDER
La band si forma nel Marzo del 2006 come meltin’ di realtà esistenti e provenienti dall’underground piceno.
Sono stati inseriti nel filone post-core e pensano che sia una definizione che ben li rappresenti: nella loro musica si ritrovano i classici temi HC (Snapcase,
Deftones, Sick Of It All), passando per le nuove sonorità scremo e noise (Norma Jean, Chariot) toccando elementi Post-rock (ISIS, Mogwai).
http://mycfgrave.altervista.org
Cd1 Track 12
JESUS IS BETTER THAN SANTA
Più che band direi che Progetto sia il termine esatto, visto che di quello si tratta; tutto nasce dalla necessità di fare musica in maniera nuova e personale
senza però dimenticare gli insegnamenti dei grandi artisti che hanno contribuito alla mia formazione musicale. Ho preferito portare avanti un discorso da
solista, sia da autore, sia come musicista e direttore artistico, avvalendomi della collaborazione di diversi musicisti, coinvolti a differenti livelli e con un
background musicale assolutamente eterogeneo. Piume di struzzo, distorsioni selvagge, elettronica e passione… questo è ZAP.
www.zap-on-line.com
Cd1 Track 13
IL NOBILE DEL SEGUITO
Gli Oloferne nascono nel 1999 dall’idea di proporre qualcosa che coniugasse le varie influenze dei componenti. Rock, atmosfere medievali, world music e
spunti progressive vanno a fondersi nel folk rock d’autore che oggi contraddistingue la band. Numerose le collaborazioni: Gang, La Macina, Max Gazzè,
Aida Cooper etc. Il gruppo collabora anche con l’etichetta milanese Ethnoworld (che produce il primo disco, Oloferne) e con la Upr folk. Da qui
l’inserimento in diverse compilation, tra cui Capodanno Celtico e Laratro folk 2007. Nel 2005 la band partecipa ad un tour in Sud-America e presenta il
secondo disco Le parole del vento. La rivista Cosmopolitan inserisce gli Oloferne tra le band più rappresentative del folk rock italiano. Il gruppo è ora
impegnato nella registrazione del terzo disco.
www.oloferne.com
Cd1 Track 14
IN THE NAME OF THE ROCK
The Dogma nascono alla fine del 1999. Dopo la realizzazione di un demo, la band firma nel 2005 un contratto con la Drakkar Records/Sony-BMG e
l’anno successivo viene realizzato Black Roses, il loro primo cd. La band partecipa ad importanti festival internazionali come il Wacken Open Air (in
compagnia di Scorpions e Whitesnake) e si imbarca in un Tour europeo in compagnia del gruppo finlandese Lordi, vincitore dell’ Eurovison festival
2006. Nel 2007 vede la luce il loro secondo lavoro A Good Day To Die, dove questi giovani musicisti riescono a far convivere in un’unica opera heavy
metal, musica classica, elettronica e tanta sana energia rock.
www.thedogma.net
Cd1 Track 15
CERBERO
La formazione maceratese ha fatto della musica una vera e propria forma di impressionismo sonoro, dove i sentimenti si intrecciano, in un lungo viaggio,
ai ricordi e alle storie. Con L’ultimo Canto di Orfeo i Mètronhomme ci propongono un progetto musicale ambizioso, articolato in dodici composizioni
strumentali, dove le continue suggestioni visive, il ricorso a sporadici intermezzi narrati, la proiezione di videoclip come accompagnamento scenografico e
l’intervento simultaneo di un corpo di ballo spiegano l’esigenza di un palcoscenico teatrale. La notorietà del soggetto può d’altronde sollevare il quintetto
maceratese da obblighi didascalici, per esplicitarne piuttosto la minuziosa interpretazione sonora. Tra concilianti passaggi acustici e spiazzanti sferzate
elettroniche, la performance conta una durata complessiva di 75 minuti, senza mai perdere il valore evocativo dell’opera.
www.metronhomme.it
Cd1 Track 16
POLVERE DEI MIEI STIVALI
Il gruppo nasce nel 1998 come cover band e si distingue nel panorama musicale marchigiano proponendo un repertorio basato sui brani della folk singer
Ani Difranco. La passione nelle esecuzioni live e negli arrangiamenti dei brani regalano al gruppo numerosi riscontri positivi, come la vittoria di diversi
concorsi musicali locali per band emergenti ed un’assidua attività concertistica nei locali della regione. Il carattere molto personale del gruppo assume
forma e acquisisce maturità: a partire dal 2004, The Pincers iniziano a comporre brani inediti, volendo racchiudere in un prodotto originale le numerose
influenze musicali di cui i componenti del gruppo si circondano, collaborando con diversi musicisti e frequentando eclettici ambienti musicali. A partire
dall’estate 2006 un periodo molto intenso ha portato il gruppo a vincere il concorso nazionale Il Rock è Tratto a Savignano sul Rubicone (RN) e, a
seguito di ciò, ad esibirsi come band di apertura per il concerto di Niccolò Fabi a giugno, e dei Meganoidi e Cappello A Cilindro nello stesso mese.
Nell’inverno 2006 The Pincers autoproproducono il loro primo album Solo un rifugio momentaneo in tiratura di duemila copie.
www.thepincers.com
Cd1 Track 17
VELE SENZA VITA
Gli Ogam hanno all’attivo due produzioni discografiche: la prima LI MA TO (1995) dedicata al percorso fisico e spirituale del grande gesuita maceratese
Matteo Ricci e la seconda IL REGNO DELLA SIBILLA (2000) suite musicale ispirata alle leggende dei Monti Sibillini. Hanno partecipato a numerose
compilations nazionali ed internazionali (E cantava le canzoni - memoriale di Rino Gaetano (EMI); KELTIKA, CELTICA e WORLD MUSIC, ecc.).
Hanno prodotto tre colonne sonore per la RAI (documentari di Geo & Geo) e realizzato per il teatro le musiche per gli spettacoli La ballata del Vecchio
Marinaio di S.T.Coleridge con l’attore romano P. Giorgio, La Rosa, poema trobadorico di e con F. Scataglini e Nel Regno della Sibilla, spettacolo
multimediale sulle leggende dei Monti Sibillini. Hanno realizzato nel 1997, in qualità di ambasciatori musicali, il progetto Il Pullman del Levante, in
autobus da Macerata a Pechino, viaggio sulle orme di Matteo Ricci, suonando nelle principali città di Polonia, Ucraina, Russia, Kazakistan e
Mongolia. Premiati come migliore proposta musicale ad Arezzo Wave 91 e al Podium des decouvertes al Festival Interceltique di Lorient (Francia),
gli Ogam hanno all’attivo tournèe in Italia, Europa e Asia. Hanno partecipato (2002) con tre brani inediti cantati da Tiziana Ghiglioni alla compilation
CORPO DI GUERRA edita da IL MANIFESTO in cui partecipavano. Hanno lavorato nel CD e nella tournèe 2002 con la cantante Valentina
Giovagnini, con la quale hanno partecipato al festival di Sanremo, al Festivalbar e all’I-TIM tour.
www.artenomade.com
Cd2 Track1
COMANDANTE
Il nucleo dei Gang è formato dai due fratelli Sandro e Marino Severini. Gli esordi risalgono verso la metà degli anni ‘70, il momento in cui comincia a
manifestarsi, musicalmente e in altri ambiti, il fenomeno del punk. Il punk inglese era costituito in gran parte da disoccupati e emarginati che vivevano
nelle sterminate e difficilissime periferie londinesi. Qui matura la scelta di Sandro e Marino Severini. Assumono quindi come proprio modello il gruppo
dei Clash e compongono direttamente in lingua inglese, con tematiche e musicalità ispirati alla realtà del Sud del mondo, degli sfruttati, degli emarginati.
È questo il leitmotiv dei Gang. Nel 1984 incidono Tribes’ Union e si esibiscono assieme a gruppi come The Pogues, i Blaster, Jesus & Mary Chain e a
Billy Bragg. Nel 1986 esce il loro secondo LP, Barricada Rumble Beat, sempre in inglese e ancora più esplicito nei testi. Nel 1989 esce un album
interlocutorio, Reds; lo stesso anno firmano un contratto con una grossa casa discografica la CGD. All’inizio degli anni ‘90 lavorano a una trilogia con la
quale compiono la scelta definitiva di passare a comporre testi in lingua italiana. Alle chitarre elettriche si sostituiscono gli strumenti acustici. Il primo
risultato è l’album Le radici e le ali (1991), un album del tutto schierato nel solco della tradizione dell’ internazionalismo. Il progetto è quello di fondere il
rock con la tradizione popolare. In quest’ottica deve essere visto Storie d’Italia, del 1993, il loro secondo album in italiano che vede la produzione artistica
e la collaborazione con Massimo Bubola. E’ il tempo di collaborazioni fruttuose con artisti del calibro di Antonello Salis, Antonello Ricci, Mauro
Pagani, Daniele Sepe e Davide Riondino. Nel 1995 si conclude la trilogia italiana con l’album Una volta per sempre. Si sviluppa nel contempo un
nuovo rapporto dei Gang con l’arte e con il loro percorso individuale; cominciano ad essere attratti dall’epica e dalla poesia narrativa. Nasce l’album Fuori
dal controllo, dedicato a dieci personaggi della storia d’Italia visti come eretici. Collaborano con il gruppo folkloristico La Macina con il quale hanno
realizzano l’album Controverso (2000). Nella primavera del 2001 nasce il progetto Gang City Ramblers che congiunge due generazioni di combat-folkrockers i Modena City Ramblers con i Gang, sullo stesso palco a interpretare brani delle due formazioni. Nel 2002 fanno girare in rete una canzone
clandestina, All’ultimo sangue, regalata al movimento per la pace, contro ogni guerra. Nel 2004 pubblicano insieme al canzoniere popolare de La Macina
Nel tempo e oltre cantando.
www.the-gang.it
Cd2 Track2
GRAZIE
Provenendo da esperienze musicali diverse, han cercato un massimo comun denominatore che li unisse; il resto fu pura energia. Gugo ci mise il nome, e
sul tributo ai Manonegra nessuno ebbe, ovviamente, da ridire. “Iniziammo così con le prime suonate, ‘inkazzate’ come non mai; cover dei Clash,
Sublime, Stiff, Nofx e degli Specials. Intanto le prime idee di strutturare pezzi nostri iniziavano a prendere forma. Venne poi l’opportunità, grazie a Maro
e Sandro dei Gang, di suonare su di un VERO palco, facendo loro da spalla”. Un demo nel 1999 (un originale e tre cover) e nel 2000 il bell’esordio che
reca semplicemente il nome della band: 13 canzoni in inglese e spagnolo, con la collaborazione fondamentale dei fratelli Severini, dei fiati dei Radio
Babylon e della cornamusa dei Mortimer Mc Grave. Col Revolt Tour 2002 si inizia a suonare sul serio per l’Italia insieme a Banda Bassotti e Assalti
Frontali “con 5000 teste davanti al palco”, Giorgio Canali, Statuto, Los Fastidios, Erode, Fratelli di Soledad, Mercanti di Liquori, Skatalites,
Klasse Kriminale, oltre a “tre apparizioni al Tributo italiano a Joe Strummer a Bologna 2004, 2005 e nel 2006 al nuovo Estragon abbiamo strimpellato
con alcuni componenti dei Mescaleros, l’ultima band di Strummer”. Piccolo stop per riorganizzare le idee, fare tesoro delle esperienze live e lavorare ai
nuovi pezzi in italiano. “Con la fondamentale collaborazione dei fratelloni Severini iniziamo a registrare il nuovo lavoro che contiene 4 nuovi pezzi (in
italiano), 3 cover dei Gang rivisitate per l’occasione, e un tributo ai Clash, il progetto prende il nome di MALAGANG”. A Novembre del 2006 registrano
due brani, inseriti poi nell’album dedicato alla memoria di Peppe de Birtina.
www.malavida.it
Cd2 Track 3
TERRA DI MERCANTI
Il progetto RADIO BABYLON nasce nel 1997. Due anni dopo incidono il primo demo con il quale riescono a procurarsi diverse serate a livello
nazionale. Nel 2002 la maturità e l’esperienza, portano il gruppo alla realizzazione del primo CD ufficiale BUSKA. Nel 2005 vincono la finale AREZZO
WAVE Marche, rientrando così tra i primi 6 gruppi in Italia, su 1500 iscritti. Nel 2006 sono riusciti ad arrivare in finale nel concorso PRIMO MAGGIO
TUTTO L’ANNO partecipando alla compilation stessa. LEI NON SA CHI SONO IO, album uscito nel 2007, che vede la partecipazione straordinaria di
ROY PACI e FREAK ANTONI. Un brano dell’album MI PIACE VOLARE è stato scelto come colonna sonora dello spot del RED BULL FLUGTAG
e trasmesso da varie emittenti nazionali.
www.radiobabylon.it
Cd2 Track 4
CANTINA CANTARINI
La band RADIO NOE’ nasce a Jesi (AN), nel 1996. Nel 2001 autoproducono il loro primo CD TraSUDando, ispirato al tema del viaggio sia geografico
che esistenziale. Iniziano un percorso in bilico tra musica e poesia e presentano alcuni spettacoli e reading poetico-musicali: MANTRA DEL RE DI
MAGGIO (sulla poetica della beat generation), UN SASSO NELLO STAGNO DEL SESSO (sulla poesia erotica), COME SUGLI ALBERI LE FOGLIE
(sulla poetica pacifista). Nel frattempo partecipano a varie manifestazioni regionali e nazionali tra cui il Monsano Folk Festival, Santarcangelo dei Teatri,
Soundtrek II (con Lucio Dalla) e come finalisti al Premio Augusto Daolio (Sulmona). Nel dicembre 2005 presentano a Jesi, al Teatro Studio Valeria
Moriconi, il loro secondo album Cantina Cantarini. Il TGR trasmette un bel servizio sull’evento. Il 31 luglio 2006 partecipano al Monsano Folk Festival in
concerto con Gastone Petrucci del gruppo di ricerca popolare marchigiana la Macina.
www.radionoe.it
Cd2 Track 5
BAMBOLINA
L’esperienza parte all’inizio degli anni 90, quando Marco Fagotti fonda i Clinic, poi rinominati Velasco, che si dividono nel 1996; per i quattro anni
successivi Marco si dedica alla scrittura di colonne sonore per il teatro. Nel 1999 nascono i Luxluna e un album, Transfert, che vedrà la luce nel 2002 per
la neonata etichetta Anomolo (di cui Marco è uno dei fondatori). Nello stesso anno si uniscono alla band Paolo Fagotti alle tastiere e Archelao Macrillò
alla batteria. Nel maggio 2004 esce Io ricordo tutto e iniziano i concerti in tutta Italia e le prime recensioni della stampa specializzata. Nel 2005 il bassista
Riccardo Rosicarello lascia la band e viene sostituito da Alessandro Nardi. Ottobre 2006: esce Borgoapocalisse e il successo di critica e il
riconoscimento di stampa e pubblico arrivano immediatamente. Il 26 novembre la band viene invitata a suonare al teatro Masini di Faenza in occasione
della giornata conclusiva del MEI. Nel frattempo escono recensioni sulle principali testate nazionali (Rolling Stone, XL Repubblica, Rumore, Sentire
ascoltare, Mucchio Selvaggio ecc.). Nel 2007 la band decide di fermare momentaneamente l’attività anche in vista degli impegni, sempre più
coinvolgenti e impegnativi, di Marco Fagotti nella scrittura di soundtrack per il cinema internazionale.
www.luxluna.it
Cd2 Track 6
PELLEGRIN CHE VIEN DA ROMA
Il Gruppo Folk Vincanto nasce nel 2002 da una viva amicizia e da una solida collaborazione tra i cinque componenti, che dopo pluriennali
esperienze individuali nel campo della musica (popolare e non) hanno deciso di unirsi per interpretare e valorizzare il patrimonio sonoro, vocale e
ritmico delle Marche, aprendolo a salutari scambi e confronti con quello di altre regioni e nazioni. Ciò che anima la proposta musicale del gruppo
non riguarda soltanto il cosa ma anche e soprattutto il come: la ricerca stilistica e gli arrangiamenti sono curati nell’ottica di una fedeltà rispettosa ma
non pedissequa verso i modelli originali, e inseguono accattivanti contaminazioni tra forme melodiche, armoniche, ritmiche e testuali derivate da
radici differenti, fra cui quella autoctona prevale ma non prevarica. I Vincanto hanno al loro attivo la pubblicazione di due cd (Vincanto, 2004, e
Trainanà d’amore, 2007), oltre 200 concerti nell’intera area marchigiana e non solo, collaborazioni artistiche con la Regione Marche, con la
Provincia di Ancona e con numerosi comuni, enti ed associazioni del territorio, nonché l’organizzazione dei festival A Monsano la Pasquella e
terreAmare. Tra i tanti eventi cui hanno partecipato si segnalano il Folkest in Friuli, La Notte della Taranta in Salento, il Bardentreffen a
Norimberga e, nelle Marche, il Montelago Celtic Night, l’Adriatico Mediterraneo Klezmer, Bellente il Brigante e Vita mia - Gli amici cantano
Peppe de Birtina. In ben due occasioni il musicista galiziano Carlos Núñez, stella di prima grandezza della musica celtica e della world music, li ha
invitati a suonare con lui.
www.gruppofolkvincanto.it
Cd2 Track 7
LAS HOJAS TIENEN MUDANZA
Ripercorrere attraverso brani di epoca prevalentemente settecentesca e ottocentesca un viaggio tra le memorie musicali, parlando di guerra, d’amore, di
morte e di speranza. È il viaggio che propone il gruppo Búsqueda, un lavoro fatto di brani musicali quanto più sconosciuti e antichi possibile, rielaborati
rivestendo le melodie di un sound personale e vicino alla sensibilità moderna. L’obiettivo musicale dei Búsqueda è rappresentato dal nome stesso del
gruppo, una parola argentina che significa ricerca. I Búsqueda senza perdere di vista le radici storiche dei brani cha ricercano, li rileggono, li rinfrescano, li
riportano alla memoria. Il cd Búsqueda uscito agli inizi del 2007 si sviluppa sulla musica della tradizione popolare internazionale, sintetizzando il
percorso finora compiuto dal gruppo nei tre anni di attività concertistica.
www.busqueda.it
Cd2 Track 8
FAREWELL TO GARBATELLA
L’anima dei Mortimer si esprime essenzialmente dal vivo. I loro seguitissimi concerti sono un’occasione per una grande serata di musica e divertimento.
Hanno suonato nei principali festival di musica celtica in Italia e solo negli ultimi tre anni hanno realizzato più di trecento concerti solo nel territorio
italiano. Hanno prodotto tre CD: Celtamente (2001); Mortimer a Montelago (2004) e All’attacco (2005). In quest’ultima produzione hanno collaborato
con l’attore Neri Marcorè, con Edoardo Vianello, la storica voce della musica leggera italiana degli anni ‘60 e con i principali musicisti di musica
acustica italiana. Alcuni brani sono comparsi nelle compilation di Celtica e Keltika. Tre fan club sono stati aperti negli ultimi due anni.
www.mortimermcgrave.com
Cd2 Track 9
LU SALTARELLACCIU DE LU CELLU PAPARÒ
Il gruppo deve il suo nome all’uso dispregiativo che Kafka faceva della K (AMERIKA), al concetto di tappezzeria musicale tipico della sottocultura pop
degli anni ‘60 (MUZAK), al recupero di questo verso kafkiano operato dalla controcultura rivoluzionaria negli anni ‘70, all’ironia di ENO, ospite del 1°
PAVAROTTI AND FRIENDS, vittima delle definizioni farneticanti di un noto critico televisivo “I’M NOT POLYETHNIK MUZAK”. Esistente fin dai
primi anni ‘90, il gruppo suona un FOLK rigorosamente acustico, con la stessa carica emotiva del ROCK più elettrico, proponendo canzoni più o meno
antiche della tradizione popolare ed altre di propria creazione che s’innestano in questo contesto tradizionale in termini continuativi ed innovativi.
Cresciuto nelle birrerie, nei pub, nei club e, soprattutto, per strada, l’ensemble ha guadagnato sempre più piazze, teatri ed un largo seguito di estimatori.
Oliviero De Quintajé, creatore e inimitabile frontman del gruppo, è scomparso prematuramente lo scorso settembre, poco prima di far uscire il terzo
album, che vedrà comunque la luce.
www.dequintaje.com
Cd2 Track 10
VIENI VIA CON ME
I componenti del gruppo JOHN DOH hanno esperienze decennali nel campo della musica, avendo suonato con band e musicisti dai generi più svariati in
locali, manifestazioni e festival italiani e internazionali. I JOHN DOH si sono formati da qualche anno col presupposto di suonare musica propria
all’insegna del divertimento, esprimendo dal vivo passionalità, emozioni e tanta energia. Tra le esibizioni, oltre a performance in vari locali delle Marche,
va ricordato il Festival Rock Taunus 2004, Aloha Rock Festival 2005, Rock Away 2006.
Cd2 Track 11
LA MOSCA AL MIO ORECCHIO RUGGISCE
PER PRESA VISIONE è un progetto musicale nato nel 2004. La formazione diviene immediatamente di spicco nel panorama musicale del Montefeltro
e non tardano i riconoscimenti ufficiali: vincono il Premio Metauro 2005, partecipano al MEI 2005 come rappresentanti del festival Territorio Musicale,
vincono il premio come miglior testo al festival FANOTE 2005, arrivano in finale al concorso PRIMO MAGGIO TUTTO L’ANNO 2006, così come
al festival ROCK a FE 2007 di Ferrara e al FESTIVAL DELLE BELLE ARTI 2007 di Bologna. Attualmente stanno compiendo un lavoro, del tutto
sperimentale, che prevede l’impiego degli stessi elementi in formazioni ridotte (sassofono e contrabbasso, voce e sintetizzatori, flauto solo), operazione
che si sta rivelando di grande maturazione artistica e musicale. Nel 2008 uscirà il loro secondo disco che riassumerà queste esperienze.
Cd2 Track 12
PROFUMO
I Lanafina nascono nel 2005 con l’intento di comporre la loro musica miscelando canzone d’autore e suggestioni jazz. La loro ricerca artistica li avvicina
al teatro ed alla poesia, chiamandoli a partecipare come interpreti e arrangiatori al musical L’isola che c’è della compagnia anconetana Good Company.
Cercano inoltre di portare la loro musica all’interno di eventi culturali e così nasce la collaborazione col Centro mondiale della poesia e della cultura
Giacomo Leopardi di Recanati e col giornalista della RAI Giancarlo Trapanese, che seguono per l’Italia, durante le presentazioni del suo ultimo libro
Luna Traversa. Ricevono nel frattempo ottimi consensi alle selezioni del concorso nazionale Musicultura, arrivano in semifinale al Bologna Music
Festival ed al Mayem Acoustic Contest a Ferrara, sono scelti dalla Carosello Records per partecipare alle selezioni del Cornetto Free Music Festival.
www.myspace.com/lanafina
Cd2 Track 13
DOPPLER EFFEKTS (ENGLISH VERSION)
Paolo F. Bragaglia è musicista elettronico con uno stile particolarissimo ed eclettico. Vive e lavora tra le Marche e Milano. Nasce con la new wave, in
un mondo del tutto analogico e si spinge, imperterrito, fino ai nostri giorni digitali. Nel 1999 viene pubblicato per la FridgeZone il primo CD Magnum
Chaos, un disco di musica elettronica con la partecipazione di Mauro Pagani. Nel 2002 esce KINOMUZIQ una raccolta di estratti dalle colonne sonore
realizzate nel corso di un decennio per video e cortometraggi con ospite Steve Piccolo già bassista dei newyorkesi Lounge Lizards. Nel 2003 esce
Mensura, con la cantante Monica Demuru ospite in tre brani. Nel 2006 approda all’etichetta Minus Habens con il quarto disco Mystère du printemps e
compone la musica della performance Fornarina Urban Beauty Show a Barcellona e a Milano, con il producer/compositore/DJ inglese Howie B.
www.paolobragaglia.it
Cd2 Track 14
CATCHY
Gli Elettrodust nascono agli inizi del 2000 da un’idea del vocalist e pianista Dario “Dust” Faini. Incidono il loro primo demo e cominciano un’intensa
attività live, aggiudicandosi per due anni consecutivi il primo posto ai Festival di Sotterranea , Fuori Tempo, Rock no Stop e per ultimo il Premio
Mescal.
Aprono i concerti di Vasco Rossi, Elisa, Subsonica, Gloria Gaynor, Antonella Ruggiero, Morgan, Jimmy Somerville (Bronski Beat), Vinicio
Capossela, Quintorigo, Planet Funk, Afterhours.
Nel 2003 esce il singolo Blu in italiano, prodotto insieme a Marco Forni in collaborazione con Sony Music e nel 2005 il singolo The right crash in
inglese, prodotto insieme a Diego Calvetti e Mario Fargetta di Radio Dj, distribuito in tutta Europa.
www.elettrodust.com
Cd2 Track 15
ALL THE CUNTS IN THE WORLD
L’isteria artica è quella forma di pazzia acuta che assale chi vive costantemente tra il bianco dei ghiacci perenni. e, va da sé, il titolo di una canzone tratta
dal capolavoro dei residents, eskimo. aarctic_hysteria è il progetto solista (with a little help from well disposed friends) di theRaven, famigerato
arruffapopoli e cronista musicale di vecchia data (punkzine varie nei fine ‘70, poi il mucchio, music club, frigidaire, jam, rockerilla, rumore, l’indice
etc etc), tornato da qualche tempo alla musica suonata dopo svariati lustri di latitanza (anche una breve permanenza alle 4 corde negli storici ranxerox,
dopo che i fratelli Severini lasciarono per andare a formare i Gang). a_h concepisce solo pezzi di 30 secondi che spaziano, di volta in volta, dal punk
all’elettronica, dall’avanguardia colta (ahahaha) alla musica per bambini. phil spector no limit. Crede in Marco Van Basten.
www.anomolo.com
ARTENOMADE SPEDIZIONI
Humla il Nepal Più Lontano
di Maurizio Serafini
Foto di Maurizio Serafini, Luciano Monceri, Franco Borgani
A Kathmandu piove. Piove ormai da un mese. Quasi che il cielo volesse lavare i peccati di questa terra martoriata dagli odi.
Piove sul palazzo reale dove un sovrano non amato dal popolo ha usurpato lo scettro con la violenza secondo l’archetipo
shakespeariano di Elsinore in Danimarca. Piove sui cortei incessanti dei maoisti, indottrinati da una politica anni ’50
neanche più riconosciuta nella stessa Cina. Piove sulle terrazze dei locali di Thamel dove i gruppi rock combattono
un’assurda battaglia a suon di decibel nella vana speranza di attirare un turismo internazionale ormai sempre più fugace,
proteso com’è ad accelerare i tempi per raggiungere le alte valli montane. E noi piccola comitiva, più vicina all’armata
Brancaleone che ad un vero gruppo di sportivi pronti ad una spedizione himalayana, noi, qui a Kathmandu, a schivare
pozzanghere e petulanti venditori di balsamo di tigre. Siamo sette anime erranti, eterogenee, dai 19 ai 71 anni, che alla fine
del viaggio, troveranno una sintonia insperata. Ma si sa: le difficoltà del procedere creano veri compagni di viaggio. A pochi
chilometri dalla capitale c’è Kirtipur, cittadina adagiata su uno dei colli che s’affacciano sulla verde distesa di riso
conosciuta come la valle di Kathmandu. Villaggio Newari, cioè di quella primaria etnia nepalese che poi fondò la grande
città. Il sistema tribale è ancora vivo e vegeto e il mantenimento delle specifiche tradizioni sembra coinvolgere
trasversalmente le varie generazioni. La nazione unisce ma le differenze sono mantenute e rispettate. Così come le religioni:
induisti, buddhisti e musulmani convivono in un sincretismo esemplare. Swambayanath, meglio conosciuto come il tempio
delle scimmie, ne è una rappresentazione. Attorno alle are dedicate a Shiva si odono continuamente i cigolii dei cilindri
rotanti che levano i mantra a Buddha. Kirtipur è anche sede universitaria e allo CNAS (Centro Studi Nepalesi e Asiatici)
incontriamo l’antropologo Dilli Ram Dahal. Ci accompagna nei meandri della biblioteca d’istituto levando di continuo
consunti libri dalle scansie, come li avesse archiviati lui stesso. “Humla… Humla… Nessuno ancora si è dedicato
approfonditamente alle popolazioni dell’Humla. E’ un distretto poco conosciuto anche in Nepal”. E’ la conferma di quanto
avevamo percepito dalla navigazione in internet. Una sola pubblicazione trovata, di taglio fotografico e di origine americana:
Hidden Himalaya. “Da quel che so è abitata da etnie d’origine tibetana, ma aventi caratteristiche uniche. Popolano valli
remote e pressocchè isolate. E l’isolamento produce differenziazione. Qui c’è un interessante studio dell’antropologo
francese Levine sul tema della poliandria”. La poliandria è il matrimonio di una donna con più uomini appartenenti alla
stessa famiglia, essenzialmente fratelli. Ciò permette di non dividere e quindi depauperare il patrimonio, in ispecie sotto
forma di terre coltivabili, accumulato. “Ma come vi è saltata in mente l’idea di raggiungere l’Humla?”. Forse c’è un
desiderio ancestrale di ritrovare il paradiso perduto, di recuperare quell’essenza ferina sedata, a dirla con Jean Jacques
Rousseau, riarmonizzarsi con la natura, col mistero e coll’imprevedibile. Le nostre linee guida, tracciate dagli scritti del
grande orientalista Giuseppe Tucci, ci conducono dove i passi sono dettati da una saggezza millenaria, lontani da un mondo
scontato in cui tutto è diventato solo “noioso transito di cibo”. L’Humla è così remota che soddisfa il nostro desiderio di
unicità. Colorata nelle mappe fisiche esclusivamente di marrone, rare macchie chiare, per il resto solo intensa scurezza,
l’Humla è una piccola regione himalayana del Nepal nord occidentale ai confini con il Tibet. Sarebbe un regolare rombo se
non avesse subito un deciso morso alla propaggine nord occidentale dal distretto di Taklakot, o Purang che si voglia, in
Tibet. E’ interamente segnata dalla pennellata arricciata del fiume Karnali che rombando si fa spazio tra le precipiti pareti
montane per innestarsi poi in pianura nel grande bacino sacro del Gange. Nel Karnali confluiscono a perpendicolo tutta una
serie di strette vallate rese profondamente a V dallo scorrere dei vari khola, i fiumi nepalesi, e il sentiero che vuole
costeggiare il grande solco del fiume è costretto ad attraversarli sopra traballanti ponti di legno. L’acqua scivola ovunque,
sputata dalle viscere della terra o fragorosamente in volo dalle sommità montane. Eppure questo enorme patrimonio si
disperde del tutto a valle. Nessuna captazione, nessuna diga, nessuna centrale idroelettrica e i villaggi continuano a restare
senza corrente; spesso l’acqua potabile è così lontana dalle case che un’incessante processione di bimbi accorre alle fonti più
vicine con contenitori di tutti i tipi. E’ vero: l’acqua è ovunque, anche sulle nostre teste; da tre giorni non smette di piovere.
Da che siamo partiti a piedi da Simikot il cielo non ci ha ancora regalato una spera di sole e quando il cammino si inerpica
sul versante sud, abbandonando la costa del sentiero principale verso il Tibet, quell’acqua diventa neve. Superiamo un passo
di 4.500 metri avvolti da nebbie e gelo e scendiamo precipitosamente al villaggio di Charla, così remoto e sospeso nel nulla
da apparire irreale e impalpabile. Le case come tumuli di pietra irregolari, con i muri a secco coesi dall’unico cemento
disponibile: lo sterco di yak. Ovunque, sui tetti piani livellati da sola terra battuta, i frutti del raccolto recente: granaglie
d’orzo o grano saraceno, spighe e paglia, cataste di legna. La dieta di queste popolazioni è così povera che lo stesso latte
materno è privo di sostanze nutritive e la malnutrizione è fenomeno così diffuso che l’Humla annovera uno dei tassi di
mortalità infantile più alti del mondo. L’assistenza sanitaria del tutto assente, i farmaci irreperibili e quando ci sono non si sa
come usarli. Spesso siamo stati costretti a garantirci la corretta posologia quando, a richiesta d’intervento medico da parte di
persone malate incontrate nei villaggi, propinavamo le nostre scorte farmaceutiche. Gli sciamani, l’antica medicina
tradizionale, sono ormai in via di estinzione. C’è stata una guerra intestina tra il lamaismo buddhista e la religione Bon.
Quest’ultima, pur ispirata ai fondamenti del principe Siddharta, riconosceva nella figura dello sciamano il tramite con le
divinità. Il conflitto dei riti era evidente specie riguardo il sacrificio animale assolutamente non contemplato dal buddhismo,
che al contrario rispetta ogni forma vivente in quanto parte del ciclo delle reincarnazioni. Una guerra persa dalla religione
autoctona Bon che ormai sopravvive solo nei villaggi più remoti. A Charla l’ultimo sciamano risale a 35 anni fa. Fu cacciato
dai monaci del monastero del vicino villaggio di Yalbang che ancora oggi non sembrano aver dimenticato le vecchie
diatribe. Quando arriviamo ci accoglie una sorta di sindaco del villaggio anche se lui ci tiene a precisare che non esiste alcun
leader ma solo un consiglio di rappresentanti che ogni sera si riunisce a cerchio, perlomeno nella stagione estiva, nello
sterrato centrale per decidere delle sorti della comunità. Charla, narra la leggenda, fu fondato da un mercante di sale
proveniente dal Tibet che giunto in prossimità della valle incontrò uno stregone. Costui chiese in dono del sale ma il
mercante non acconsentì. Allora lo sciamano lanciò una maledizione e tutto il sale si trasformò in pietra. Dapprima ci fu la
disperazione ma poi il mercante se ne fece una ragione ed utilizzò quelle pietre per costruirci le prima case del villaggio.
Effettivamente solo un sortilegio poteva far nascere un insediamento in una località così amena, talmente amena che il
Regno del Nepal si è accorto solo 50 anni fa della sua esistenza. Il sindaco ci invita a bere un tè tibetano nella sua casa.
Nessuna finestra e le porte così basse che ti costringono a continue prostrazioni. Un solo punto luce sul tetto che
principalmente serve come sfiato al fumo del fuoco continuamente acceso. La luce attraversando dall’alto la densa cortina
sembra uno spot teatrale. L’atmosfera è irreale, i nostri occhi, irritati dal fumo, fanno fatica a mettere a fuoco le ombre che si
muovono silenziose attorno a noi, l’aria irrespirabile. Il monossido di carbonio sprigionato dalla combustione è una delle
cause principali delle intossicazioni e morti, specialmente di donne e bambini, di queste popolazioni. In gran parte si usa il
fuoco vivo anche se, da qualche anno, una stufa progettata a Nepalgunj dotata di canna fumaria, sembra stia diffondendosi
rapidamente. Dopo cinque giorni di cammino traversiamo il passo del Nara La, a 4.600 metri d’altezza. Lo strappo finale è
così ripido che sembra di percorrere uno scivolo di centinaia di metri al contrario. Dalla sommità, sempre segnalata dalla
bandiere votive lacerate dal vento, la vista si apre sull’alta valle del Karnali che entra in Tibet. A perdita d’occhio le bianche
cime senza nome fino alla faccia sud del Gurla Mandhata, la vetta che qualche anno fa, durante il nostro pellegrinaggio al
Lago Manasarovar in Tibet ci fece sempre da punto di riferimento con il suo versante nord. Il sentiero scende di nuovo
tagliando i contrafforti di una scoscesa montagna che per la sua colorazione bruna e per l’assenza totale di vegetazione
somiglia, per evocazione, alle valli montane dell’Afghanistan. Ed eccoci infine ad Hilsa, il villaggio frontiera. Oltre il ponte
c’è il Tibet, anzi la Cina. Il piccolo agglomerato di Sher ne è l’avamposto e da lì transitano tutte le merci di contrabbando
che arrivano al grande mercato di Taklakot. Dall’Humla si importa sale, pelli di leopardo delle nevi, ciotole di legno, essenze
erboristiche. La Cina, dal suo canto, è pronta per inondare di ritrovati tecnologici il Nepal, ma, al momento si limita a
vendere riso e colorati pacchetti di noodles, caramelle, spezie e conservati di tutti i tipi. Hilsa, come tutte le località di
frontiera è sporca. Ovunque, attorno alle case, cartacce e sacchetti che vorticano nei mulinelli del vento ed anche un
semplice tè, frettoloso ed incurato, preso in una locanda, sarà foriero per me, il giorno dopo, di una colica gastrointestinale.
Da Hilsa, con un’inversione a U, si rientra in territorio nepalese, lasciando alle spalle la valle del Karnali per entrare in quella
di Limi. L’anello si richiuderà a Simikot traversando, con più di dieci giorni di cammino, territori sopra i 4000 metri
d’altezza e raramente transitati. L’ambiente è fin da subito maestoso, cinto da vertiginose pareti rocciose strapiombanti che a
volte sembrano ostruire definitivamente il passaggio. Eppure il sentiero si infila in gole, serpeggiando, guadagnando terreno
tra i pazienti scavi umani della roccia, inerpicandosi sopra guglie per poi ridiscenderle tra massi caoticamente disposti. La
vegetazione d’alto fusto ormai scomparsa lascia posto a quel paesaggio desertificato che caratterizza il vicino altopiano
tibetano. La nostra carovana d’uomini e animali procede lentamente e a vederla, da più lontano, sembra miracolosamente
appesa sui contrafforti precipiti della montagna. Nessun altro all’orizzonte. Lontani dal mondo, dal nostro mondo
tecnologizzato: nessuna auto, nessun rumore se non quello delle acque, del vento e dei fischi dei nostri carovanieri che
guidano gli asini. Soli, profondamente soli con noi stessi, alla ricerca delle estreme risorse psico-fisiche per procedere. Il
primo giorno della Limi Valley lo ricorderò per sempre. La colica notturna mi aveva stordito: diarrea, vomito e febbre alta.
Camminavo per forza d’inerzia, come in un sogno. I miei compagni d’avventura, preoccupati, mi vedevano decisamente
sbandare sul ciglio del sentiero ma i miei passi continuavano imperterriti. Quell’aria sottile, quella luce abbacinante del sole,
quel blù cobalto del cielo e le sfocature delle mie visioni, tutto rendeva il mio procedere come una sorta di miraggio, un
galleggiamento, anzi un volo. Eppure mai si annidò in me la paura, l’idea di essere lontano, lontanissimo, da qualsiasi
soccorso medico. Vissi tutto con quella leggerezza che solo luoghi come questi ti permettono, così armonizzato con la natura
e con un concetto così alto del divenire che solo rare volte nella vita ci è permesso vivere. Anzi, forse, fu proprio questa
buona predisposizione che mi ha permesso di alzarmi il giorno successivo come se niente fosse accaduto. Tra i ricordi di
quel giorno non posso dimenticare quando, ai piedi dell’ultimo strappo della tappa, ormai disidratato, mi sono accasciato a
terra sconfitto dallo sforzo. Ebbene, una delle nostre guide, Tsering, alto almeno 15 cm meno di me e di 20 kg più leggero,
ha legato due sciarpe tra di esse e, al modo dei mitici trasportatori himalayani, cioè caricando tutto il peso sulla fronte, mi ha
trascinato in cima al passo dove era previsto il nostro accampamento. La mia tenda era già montata al riparo di una grande
pietra con su inciso il mantra Om Mani Padme Hum. E’ vero che questi ragazzi, questi uomini veri direi, sono adattatissimi a
fatiche del genere a queste quote ed è anche vero che hanno un’etica del lavoro e delle responsabilità da cui non si
sottraggono mai, ma le attenzioni di cui son capaci, la dedizione verso ogni componente del nostro gruppo dimostrano un
equilibrio ed una forza ormai quasi scomparsa in occidente. Le storie degli sherpa che hanno accompagnato le numerose
spedizioni sulle cime himalayane sono ormai diventate leggenda. Le nostre guide, i nostri portatori non abitano nella regione
del Sulu-Khumbu e non sono di etnia sherpa, vivono o a Simikot o a Kathmandu, ma mantengono anche essi quella
meravigliosa disponibilità, quella forza d’animo, quella incredibile capacità d’adattamento e quell’essenzialità creativa che
solo i popoli lontani dalle decadenti città, che vivono costantemente a contatto della natura, che non sono schiavi della
tecnologia e della burocrazia, che mantengono vive le tradizioni degli avi e rispettano il sacro e il divino, riescono a
comunicare. Durante il nostro trekking, era ormai consuetudine del tardo pomeriggio giungere all’accampamento della sosta
prevista e trovare la grande “tenda/ristorante” (così l’avevamo ribattezzata noi) allestita con tavolo, tovaglia e una tazza di tè
fumante pronta. Era un piacere poi vedere Maila, il cuoco silenzioso e sempre sorridente, primo cuciniere al mondo ad aver
raggiunto la cima dell’Everest, armeggiare con i suoi fornelli da campo per prepararci con mezzi di fortuna dei succulenti
manicaretti, improbabili per queste remote lande come la pizza o lo strudel. E ancora, Chandra, detto Sibì, la prima guida o
sirdar come si definisce in nepalese, che con la sua calma determinazione sapeva coordinare tutti i reparti della spedizione e
cogliere qualsiasi nostro malumore sapendolo immediatamente risolvere con l’attenzione e l’intelligenza di un fine
psicanalista. Shankar, la guida in seconda, dalla risata sonora e contagiosa, sempre pronto a cogliere i momenti di
affaticamento di ognuno di noi e a sostenere ed aspettare chi, di tanto in tanto, si attardava nel cammino. E infine, il già
citato Tsering, apripista sulla neve, padrone della rotta, spola tra i reparti in cammino. Credo che, a misurarlo, il suo percorso
sia stato il doppio degli altri. E gli instancabili portatori che, giunti all’accampamento dopo una tappa media di 7 ore
portando sulle spalle almeno 30 kg di bagaglio, ci aiutavano pure a montare le nostre tende. Dopo la cena, quando ognuno
rientrava nel suo sacco a pelo, ci sentivamo sereni in quel dormiveglia che annunciava il sonno ascoltando le loro allegre
canzoni che, mano a mano, sfumavano nel silenzio della notte. Il cuore della valle di Limi è l’unica parte antropizzata anche
perché sono finite le strapiombanti pareti dell’imbocco e il fiume si snoda in una larga rada che permette la coltivazione.
Oltre, invece, nell’alta valle, a quote ancor più alte, il freddo e la neve rendono difficile la stanzialità e gli unici incontri
possibili sono con i pastori nomadi che vivono nelle tende. I villaggi sono quattro: Limi, l’unico lontano dal sentiero
principale, Til, Halji e Jang. Sono distanti tra loro non più di 4 ore di cammino e formano una specie di consorzio
organizzato con rappresentanti di ogni villaggio. Questo consorzio, quasi come un demanio, serve essenzialmente per
stabilire i confini autorizzati dei pascoli, ad organizzare eventi religiosi comuni e soprattutto a stabilire delle regole di
mercato sancendo spesso delle penali, a mò di tribunale, a chi contravviene a queste regole. Ad esempio, in questa area
dell’Humla cresce spontanea una pianta, unica al mondo, la Cordyceps sinensis meglio conosciuta come yartsagumba. E’
una risorsa preziosa perché questo vegetale essiccato e triturato, secondo la farmacopea cinese, ha poteri energetici e
afrodisiaci straordinari. Gli abitanti di Limi che lo producono riescono a venderlo al mercato tibetano anche a più di 50 euro
al chilo. I versanti montani dove cresce questa pianta sono spesso comuni a più villaggi e non sono infrequenti gli
sconfinamenti demaniali per accaparrarsi il tesoro. Stessa cosa vale per le sempre più rare pelli di leopardo delle nevi. Questi
villaggi sono di origine tibetana e di religione buddhista lamaista. L’architettura tipica della casa è di pietra e a due piani: il
pianterreno per gli animali e il rialzato per le persone. Il tetto piatto di terra battuta per le granaglie e per la legna. Per salire
di piano in piano la tipica scala di legno, costruita in un blocco unico, con gli scalini modellati all’interno di un mezzo tronco
d’albero. Il villaggio solitamente è costruito attorno, o perlomeno nelle vicinanze, di un preesistente monastero. Sugli stipiti
delle porte quasi sempre campeggiano delle corna di yak. Nel punto centrale del villaggio domina un alto bastone di
preghiera e prostrazione dalla cui sommità si dipartono numerose file di bandiere votive che si collegano con i tetti delle case
circostanti. La divinità è sempre venerata in direzione delle alte cime montane che cingono i villaggi. All’ingresso dei piccoli
agglomerati il sentiero solitamente passa sotto l’arco di uno stupa decorato con affreschi che rappresentano, sotto forma di
mandala, le vite degli illuminati. Sempre all’ingresso dei villaggi si incontrano stupa, chorten e muri devozionali con
numerose pietre con su incisi i mantra di preghiera. A volte, lungo i corsi dei ruscelli, mulini ad acqua per la triturazione dei
grani. Più distante dalle case, quasi sempre in cima ad un colle, quello che per gli abitanti di Limi, o comunque per i tibetani
in genere, è il cimitero. La salma viene portata lì e, intera o spezzata, lasciata in pasto agli uccelli, come a completare il
naturale ciclo della vita e della morte. Tsepet Thuntump, giovane decoratore di mobili e pittore di thanka di Til, ci accoglie
nella sua casa. “La poliandria è ancora in uso ma sempre di più stanno crescendo i matrimoni monogami d’amore”. Lo dice
con un sorriso mentre sta ultimando la decorazione di una piccola madia seduto a terra. Lui che ha vissuto e lavorato in
India per 5 anni e poi è ritornato a casa per aiutare i genitori ormai anziani, forse, considera queste antiche tradizioni come
qualcosa da superare. Ad Halji entriamo nell’antico e silenzioso monastero. Luogo di meditazione e di preghiera. Nel
chiostro si affacciano un ballatoio di legno e due ripide e strette scale per salirvi. Procediamo con cautela come a non voler
disturbare quell’atmosfera sacrale. Invece ecco che dalle celle escono chiassosi e sorridenti i monaci. Non deve essere usuale
qui veder transitare degli stranieri. Ci mostrano zelanti i loro tesori. Mi colpisce particolarmente una statua del Buddha
risalente al XII sec. I fedeli sono così devoti ad essa, riconoscendone la soprannaturale forza che emana, che preferiscono
fare doni e prostrazioni alle vicine imitazioni fatte di burro di yak chiuse in una vetrina senza mai toccare e guardare
l’originale. In questo luogo senza tempo riesco finalmente a capire come si fa a sottrarsi dal tempo poiché mi accorgo che
non ho mai incontrato finora un orologio o un calendario. Difatti tutte le festività religiose non sono dettate dal succedersi
dei giorni e delle ore ma dal conteggio delle lune. Il vero calendario sta appeso nella volta celeste. Anche i compleanni non
si misurano per anno solare ma a lune piene. A Kathmandu abbiamo incontrato casualmente un vecchio newari che compiva
1000 lune piene. In quell’occasione il festeggiato viene portato da figli e nipoti con una portantina a mano in giro per il
villaggio, gli viene conferito un simbolo di prestigio consistente in un orecchino ad anello infilato nel lobo e può anche
permettersi di alzare il gomito, insieme alla sua famiglia, con il famigerato tsang, fermentato d’orzo. Nel monastero di Halji
anche i cicli di preghiera non sono scanditi dall’orologio ma da un complesso e geniale sistema di combustione d’incenso. In
una tavola di legno viene inciso un solco labirintico con un inizio e una fine in cui viene posta la polvere odorosa,
solitamente sandalo; il resto della tavoletta coperto di cenere. Un’altra base di legno va ad incastro con la prima cosicché il
tutto può essere capovolto come un piatto sulla padella per girare la frittata. L’arzigogolato labirinto di sandalo si erge sulla
piatta base di cenere e può essere così acceso dall’inizio. Prima che la lenta combustione bruci tutto il percorso passa circa
un giorno e mezzo sancendo l’inizio e la fine del ciclo di preghiera.
Raggiungiamo Jang, l’ultimo villaggio della valle di Limi, ma anch’esso di giorno è quasi completamente disabitato poiché
è tempo di mietitura e tutta la popolazione attiva, compresi i bimbi, si riversa nei campi coltivati. A passeggio si incontrano
solo gli anziani, ormai inabili al lavoro manuale, che fungono da baby sitter per gli ultimi nati. La raccolta dell’orzo impiega
tutta la manodopera possibile. Il maltempo è alle porte e solo una precisa consapevolezza dei segnali climatici stabilisce il
momento fugace del raccolto. Il lavoro è frenetico e senza sosta, ognuno impiegato in una fase. C’è chi con il falcetto taglia
fascine standard di circa 20 arbusti, chi le mette accatastate con la spiga a testa in giù formando dei precisi coni coreografici
e chi, in coppia, stacca le spighe dagli steli ponendoli in ampie gerle di paglia da trasporto con un sistema semplice quanto
efficace: due bastoncini di legno si stringono attorno al mazzo di spighe e con un movimento a strappo dalla base degli
arbusti il frutto del lavoro cade magicamente nella gerla. Il lavoro, senza ausilii meccanici, viene sempre accompagnato da
canti. La fase dello spulamento viene poi ultimata nei cortili delle case. Dopo due giorni, a causa di un’abbondante nevicata,
quei campi senza più voci si sarebbero presentati completamente imbiancati. Ciò è successo, di notte, proprio mentre
avevamo fatto accampamento sugli alpeggi dell’alta valle di Limi. Il giorno prima era stata una bellissima giornata di sole,
l’unica di sosta che ci eravamo concessi, proprio vicini ad una sorgente d’acqua calda in cui tutti ci siamo immersi per
ripulirci dalle fatiche di più di 10 giorni di cammino ininterrotto. La sera avevamo festeggiato col solo litro di vino portatoci
dall’Italia e con il primo e abbondante pasto a base di carne fresca. Un pastore infatti ci aveva venduto un montone e il
nostro cuoco ne aveva fatto pezzi da cucinare sul fuoco. In un luogo dove così sentito è il rispetto per ogni forma vivente
probabilmente la sorte di quel montone aveva sancito la nostra. All’alba, al nostro risveglio, fuori e sopra le tende 20 cm di
neve. E continuava a nevicare tra le foschie tenebrose che hanno reso famosa l’Himalaya. E di fronte a noi il passo più
impegnativo, il Nyalu La a 5.000 m di altezza. Di gran carriera cerchiamo di affrettare le operazioni di smontaggio tende e
carico degli animali per metterci in movimento prima possibile. Tra la bufera si comincia a salire di quota e come ci si
allontana l’un l’altro anche di pochi metri sembra di camminare tra i fantasmi. La neve fresca è sempre più profonda e
davanti, chi affonda i primi passi, si sfinisce. Ma il problema principale sono gli animali. In quel ripido canalone, nonostante
il continuo zigzagare, gli asini scivolano e spesso affondano nella neve fino al collo costringendo i carovanieri a sforzi
sovrumani per ricacciarli fuori. A circa metà ascesa si decide di ridiscendere. Il Nyalu La ci ha ricacciati indietro. Ci
accampiamo più a bassa quota. I carovanieri sembrano decisi ad arrendersi e a voler tornare indietro. Per noi è impossibile
farlo. Tra cinque giorni abbiamo l’aereo per Nepalgunj che è collegato con quello per Kathmandu che è collegato con quello
per Roma e per rifare il sentiero dell’andata ci vogliono più di 10 giorni. Le nostre guide parlano di elicottero ma, oltre al
costo esorbitante del mezzo, c’è il rischio maltempo per il volo e per l’atterraggio. Chiediamo un altro tentativo di
superamento del passo ma, specie i carovanieri, sembrano tutti poco convinti anche perché la neve sta continuando a
scendere. Fortunatamente il giorno successivo c’è il sole e la nostra insistenza riesce a far breccia tra tutti. Ripartiamo per
l’ultimo tentativo cercando di progredire con gli uomini davanti che compattano e gradinano il più possibile la neve per
permettere agli asini un più agevole procedere. Ma il cammino è lento. Arriviamo al crepuscolo ad un pianoro circa 200
metri sotto il passo. Avremmo dovuto essere già nell’altro versante ma gli animali sono sfiniti e infreddoliti. Si decide per un
bivacco forzato sul ghiaccio. Siamo a 4.800 m e la nostra preoccupazione è che cada nella notte altra neve. E’ un rischio che
potrebbe mettere a repentaglio la vita di tutti. Prima di ritirarci nelle tende, siamo tutti con il naso all’insù a guardare il cielo
che ci appare così pulito che la via lattea sembra una pennellata di vernice. Grazie a Dio il tempo si mantiene buono e il
giorno successivo ci attende una giornata luminosa ma le profonde sacche di neve fresca impediscono il nostro procedere.
Eppure il Nyalu La è lì, sembra a un tiro di schioppo anche se gli ultimi metri sono i più ripidi. Gli uomini potrebbero
arrampicarsi per una cresta rocciosa che affiora dal bianco abbacinante ma non è sentiero per gli asini e allora ecco giungere
la decisione estrema: gli animali torneranno a valle riportando indietro tutto ciò a cui si può rinunciare. Tutti i nostri bagagli,
invece, quelli personali delle nostre guide, le tende e un minimo di viveri per la sussistenza sono lì a terra, sulla neve,
ammonticchiati. Dio mio quanta roba e tutta da riportare a Simikot sulle nostre spalle. La nostra armata Brancaleone sullo
strappo finale che porta al passo sembra provata, anche dalla quota, e fortuna che i carovanieri si sono caricati dei bagagli e
ci hanno accompagnato fino in cima prima di salutarci. Qualche portatore fa addirittura tre viaggi. Dopo quattro ore
vinciamo il Nyalu La ma ora c’è da ridiscendere e l’altro versante ha altrettanta neve fresca. Tutti ci carichiamo più peso, noi
sui 25 kg, mentre i portatori, il cuoco e le guide arrivano anche a 50 kg di bagaglio. Lungo la discesa vedo per la prima volta
il loro volto contratto in una smorfia di estrema fatica, ma il più è fatto. Mano a mano che perdiamo quota la neve si fa più
bassa fino a scomparire del tutto. Traversiamo straordinari scenari montani fino a che la valle fluviale ci cambia ancora
radicalmente scenografia e improvvisamente ritroviamo il verde degli alberi. Dopo due giorni, al villaggio di Muchu, ci
ricolleghiamo con la valle del Karnali, col sentiero percorso all’andata, e lì possiamo rialleggerire i nostri zaini caricando il
grosso del bagaglio su dei cavalli da soma, nostri nuovi compagni di cammino per le ultime due tappe. Ma l’avventura non
finisce qui. L’ultimo giorno, camminando solo, in anticipo rispetto al gruppo, ad un bivio, sbaglio sentiero. Anziché
scendere al fondo valle risalgo per circa un’ora fino a trovarmi al villaggio di Chauganphaya. Chiaramente lì mi accorgo
dell’errore fatto ma l’accoglienza che ricevo compensa di gran lunga l’eventuale perdita di tempo. Tutta una comunità è in
festa ed ognuno, vecchi, uomini, donne e bambini si scambiano piccoli e semplici doni. Ci si è fatti belli per l’occasione. Le
bambine hanno tra i capelli coroncine di fiori mentre i maschietti le indossano al collo. Le donne si pettinano i capelli a
vicenda ed alcuni anziani sono addetti a segnare la fronte di tutti con il Tilak, il segno indù. Nella pasta del Tilak c’è
mischiato anche del riso che simboleggia prosperità. Incontro Lok, l’insegnante della scuola del villaggio, che parla inglese.
“Questo è l’ultimo villaggio di origine nepalese, salendo la montagna si ritorna in Tibet. Siamo nell’antica frontiera
culturale”. Conosco la sua famiglia che mi fa sedere nel cortile della casa e mi offre un tè. I bambini mi donano fiori, la
sorella di Lok mi mette in mano un cetriolo enorme. E’ come ritornare alle nostre vecchie feste di Natale quando si
regalavano noci e arance. “Oggi” continua Lok “è il giorno principale di questa festa induista che dura 15 giorni. E’ il
settimo giorno. Si parte con la prima luna nera di ottobre e si conclude con la luna piena”. Ecco che ritorna il calendario
appeso in cielo. “La festa si chiama Dainshiri. E’ una festa d’auspicio. In ogni casa, nella parte più oscura, si mettono a
bagno dei semi, riso, lenticchia, orzo, mais, ecc. Se i semi producono vita il raccolto sarà ricco altrimenti bisogna aspettarsi
carestia”. La mamma di Lok mi accarezza i capelli. Chissà se è interessata al biondo o è un gesto di compassione
universale? Lok mi saluta affettuosamente e mi dice che per arrivare a Simikot posso fare un sentiero secondario senza
dover scendere a fondo valle. “Mi raccomando non perderti. Ci sono tanti bivi. Se incontri qualcuno chiedi sempre la
strada”. Traverso un ponte di legno su un fiume e poi comincio a salire, salire, salire. Il sentiero non finisce mai. Arrivo ad
un passo. Una casa e una donna. Mi offre una mela. Tolgo lo zaino e siedo. Dopo cinque minuti altri viandanti si fermano
vicino a me. Uno di questi è Alex Zahnd, antropologo dell’Università di Kathmandu e direttore del RIDS (Rural Integrated
Development Service) che da 5 anni lavora nei villaggi dell’Humla per migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti. Sta
andando a fare un documentario video in uno dei villaggi più remoti. E’ simpatia a prima vista. Mi chiedo: perché non
averlo incontrato prima? Mi rispondo: pensi sia meglio non averlo incontrato per niente? Mi dice che il sentiero che sto
percorrendo è uno dei più belli e sconosciuti dell’Humla. Passa attraverso villaggi ancora da studiare. Il contatto con Alex è
avviato. Nelle pagine che seguono un’intervista che Arte Nomade ha fatto a lui via mail. Il mio ultimo pensiero è che non
esiste sentiero sbagliato ma solo modi sbagliati di percorrerlo.
EXTRAORDINARIO
ALEX ZAHND
UNA VITA PER I PIÙ POVERI
di Wendy Farinelli
Foto di Alex Zahnd
E’ Maurizio ad incontrare Alex Zahnd, nell’ultimo giorno del nostro trekking.
In una regione fuori dal mondo come la valle del Karnali, poco conosciuta anche agli stessi nepalesi, imbattersi in una
improvvisata troupe documentaristica da un lato e in un occidentale scarmigliato che può benissimo essere scambiato per
lo Yeti dall’altro, non è certo cosa di tutti i giorni. Superato l’iniziale stupore per il particolare incontro, salta subito fuori il
comune interesse per la regione dell’Humla di cui Zahnd si occupa da anni, documentandone usi e costumi. Oltre a nutrire
un interesse antropologico per la zona, Alex Zahnd si relaziona direttamente con gli abitanti dei villaggi attraverso il suo
lavoro con il RIDS (Rural Integrated Development Services), una ONG che ha come obiettivo il miglioramento delle
condizioni di vita della regione dell’ Humla.
Molto gentilmente Alex si è messo a nostra disposizione per offrirci un quadro più esaustivo sulla sua attività.
Alex, quando è cominciato il tuo interesse per l’oriente, e come hai deciso di trasferirti definitivamente in Nepal dalla
Svizzera?
- Mi ero appena laureato, lavoravo da tre anni come ingegnere e il lavoro mi piaceva molto; dentro di me avevo una malcelata
insoddisfazione e mi chiedevo continuamente se la vita fosse solo questo: lavorare fino a 65 anni, andare in pensione... e poi?
Sentivo che doveva esserci qualcos’altro, e questa consapevolezza mi veniva dalla natura. Sono sempre stato un’amante dello
sci, dell’arrampicata sportiva, e per questo motivo ero sempre a stretto contatto con la natura. La sua armonia, le sue semplici
leggi mi inducevano a pensare che tutto ciò che mi circondava non poteva essere incidentale. Dietro, doveva esserci qualcosa
di più grande. Cominciai a pormi le tre domande cruciali dell’esistenza: “da dove vengo? Perché sono in questo mondo? Dove
andrò dopo la mia morte?”. Con queste domande nel cuore ed una buona dose di amore per l’avventura, nel 1983, partii per
l’Asia con un amico. Scelsi l’Asia perché allora era ancora il paese dei grandi spazi, lo Shangri-la, la terra mistica che
racchiudeva diverse culture e terre misteriose.Viaggiammo per un anno con autobus e treni. Dopo un anno il mio amico tornò
in Svizzera e io comprai una bicicletta e cominciai a viaggiare in solitaria da Calcutta a Kathmandu e da lì fino in Tibet. In
Tibet non mi sono addentrato molto in quanto non c’erano strade. Tornai in Nepal e poi in India attraverso l’Himalaya,
percorrendo i sentieri più alti. A volte abbandonavo la bicicletta e camminavo per giorni, per settimane, alla ricerca di
qualcuno interessante a cui porre le mie domande confrontandomi ed imparando dalle loro risposte. Ho frequentato le persone
più disparate, lama, monaci, sadhu, mussulmani, sikh. Lavorai per qualche settimana nella casa per moribondi di Madre
Teresa in Calcutta e fu lì che per la prima volta sentii parlare del Vangelo. Vedevo le suore vivere il messaggio lasciato da
Cristo, portarlo quotidianamente tra la gente come testimonianza di un qualcosa che non era morto, ma ancora presente,
rimasi affascinato dalla loro gioia. Nel 1985 incontrai mia moglie Sheila, un’indiana, ci sposammo nel 1988 e ci trasferimmo
in Inghilterra per studiare teologia cercando di capire meglio questo nuovo messaggio che più degli altri dava una risposta
alle mie domande. In seguito lavorai per altri 5 anni come ingegnere prima di prendere la decisione di tornare in Asia con la
mia famiglia e nel 1996 ho cominciato a lavorare con il RIDS.
Quali problemi avete incontrato agli inizi?
-
Il primo problema è stato comunicare con la gente del posto. Abbiamo dovuto imparare la lingua sia per entrare
meglio nella realtà della cultura con cui avevamo a che fare che per una forma di rispetto verso le persone con cui
lavoravamo e vivevamo. Un altro problema è stata la non facile condizione politica nepalese; anni fa l’influenza
dei maoisti ha portato alla guerra civile, ci siamo fatti coraggio e siamo rimasti comunque a lavorare nei villaggi
più remoti. La vita in Humla di per sé è dura, il territorio è aspro. Con la mia famiglia abbiamo deciso di
trasferirci a vivere nei villaggi affrontando situazioni di estrema durezza. La nostra casa era come le altre del
villaggio, in pietra tenuta insieme da acqua, fango e sterco di yak. Il soffitto era molto basso per non disperdere
calore in inverno quando la temperatura fuori raggiunge i -20°. Mia moglie insegnava ai nostri figli in casa e dava
una mano alle altre donne. Eravamo a 7 giorni di cammino dalla prima strada percorribile e quando nevicava non
c’era nessuna possibilità di andarsene dal villaggio. Molti, soprattutto bambini morivano per malattie curabili con
medicine elementari di cui non disponevamo. Questa esperienza ci è stata utile per toccare con mano le condizioni
oggettive di disagio in cui si vengono a trovare gli abitanti delle zone povere e isolate.
In che modo il progetto “la famiglia dei 4” interviene nel miglioramento della vita quotidiana dei villaggi?
- Quello che il RIDS ha realizzato negli ultimi anni è un semplice progetto che va a migliorare le condizioni di vita nei
villaggi senza per questo modificarne la cultura e le abitudini. Prima di intervenire in loco è stata fatta una ricerca molto
approfondita, sotto la supervisione del prof. John Cannell dell’università di Kathmandu, per raccogliere quanti più dati
possibili che dessero informazioni attendibili sulle condizioni di vita e le esigenze reali degli abitanti. Tradizionalmente,
come in tutte le culture, è la donna che si occupa di cucinare. Nei villaggi viene generalmente utilizzato un odar un treppiedi
sotto al quale si accende il fuoco e sul quale vengono poi poste le pentole con le pietanze. Nelle case nepalesi non c’è nulla
che somigli ad un camino e cucinare con l’ odar in casa ha la conseguenza di riempirla di fumo con effetti disastrosi per le
vie respiratorie. Asma e malattie cardiocircolatorie sono all’ordine del giorno. Inoltre l’odar è anche l’unica fonte di calore
disponibile nei lunghi mesi d’inverno. L’intervento è semplice, il RIDS ha disposto delle stufe in ghisa con una canna
fumaria che convoglia il fumo all’esterno. I vantaggi dell’uso della stufa sono molteplici: il primo e il più immediato è la
riduzione delle malattie respiratorie a seguito dell’aria più pulita in casa, poi un risparmio di legna del 40% che, in zone dove
la legna è molto rara, rappresenta un notevole miglioramento dello sfruttamento delle risorse ambientali. Sulla stufa, inoltre,
possono essere cucinate contemporaneamente più pietanze ed essendo il metallo un ottimo conduttore di calore, dona anche
un tepore diffuso e salutare durante i mesi più freddi. In 7 anni sono state costruite circa 3.000 stufe la cui costruzione è stata
affidata ad un impresa artigiana di Nepalgunj, una cittadina a confine con l’India, creando posti di lavoro e incrementando
così l’economia della zona.
Come ha risposto la gente ai progetti del RIDS?
- Fin dal principio, sia negli interventi nella regione del Jumla, che ora in Humla, abbiamo deciso che i progetti dovevano
coinvolgere direttamente gli abitanti. Abbiamo proceduto lentamente così da far capire alle persone che cosa venisse loro
proposto, facendo in modo di farlo diventare il loro progetto. Il progetto delle stufe è collegato con quello della fossa
biologica; secondo il rapporto: una stufa, una latrina. Per avere la stufa si può accedere ad un sussidio economico. Per
ricevere il sussidio è necessario che almeno una persona di quella famiglia partecipi ad un corso di 3 giorni organizzato dal
RIDS, in cui si insegna come costruire una fossa biologica, una latrina insomma. Solo dopo averne costruita una per il
proprio gruppo familiare si può usufruire del sussidio. In questo modo il progetto viene portato avanti con la loro fatica e il
loro sforzo. Ciò mantiene vivo l’interesse e sono gli abitanti stessi a chiedere, poi, informazioni su altri progetti, come
l’acqua filtrata e i pannelli solari che forniscono sia luce (circa 5 ore al giorno) che acqua calda.
E una volta completati i quattro progetti principali?
- Abbiamo considerato anche altri due interventi supplementari che prevedono la realizzazione di serre familiari e un corso
rivolto alle donne per insegnare loro a preparare pasti iperproteici per i figli utilizzando le risorse del territorio. Così facendo
si cerca di abbassare il livello di mortalità infantile per malnutrizione.
Hai parlato spesso delle donne, ma qual’è la loro condizione reale in queste zone?
- Le donne hanno una vita molto dura. Basti pensare che il Nepal è uno dei paesi più poveri del mondo in cui l’aspettativa di
vita delle donne è minore di quella degli uomini. La lingua nepalese prevede diverse forme grammaticali a seconda se la
persona con cui si sta parlando è un uomo anziano, un conoscente o una persona di rango superiore. Per le donne si usa ta la
forma utilizzata per animali e cose. Per la metà della loro vita portano avanti gravidanze veramente estenuanti. La maggior
parte delle volte perdono il bambino a causa di malattie che sono facilmente curabili, quando loro stesse non muoiono di
parto. La famiglia è letteralmente sulle loro spalle, trasportano fino a 60 kg al giorno di acqua e legna da ardere. Durante il
loro ciclo mensile sono considerate impure e devono restare per 10 giorni fuori della loro casa, all’aperto, anche durante i
mesi invernali. Non è rara la notizia di donne che muoiono assiderate o bruciate perché hanno acceso un fuoco per scaldarsi.
La donna è considerata impura anche nel momento del parto e viene relegata in una stalla dove resta per 10 giorni separata
dal resto della famiglia. Inutile dire che molte muoiono. Oltre alla povertà, molte di loro devono convivere con l’alcolismo
dei loro mariti o con l’idea che il marito possa voler prendere una seconda o una terza moglie ed essere sbattute fuori di casa.
Inoltre trascorrono spesso la notte al mulino per macinare a pietra le granaglie base della loro alimentazione.
Credi che i progetti del RIDS stiano contribuendo ad accrescere in loro una sorta di autostima?
- Noi ce la stiamo mettendo tutta ma è difficile sradicare una mentalità e instaurarne in tempi brevi un’altra basata
sull’uguaglianza e il rispetto. Servono cambi generazionali. Per il momento stiamo cercando di farle cantare.
Prego?!
- Nella tradizione Humla, è molto forte la trasmissione orale. Quindi creiamo canzoni in cui le donne cantano delle loro
sofferenze e delle ingiustizie subite, canzoni in cui si ripete che donne e uomini sono uguali. I canti vengono intonati durante
la raccolta del grano o durante la semina, si spargono quindi nelle campagne costituendo una forma semplice ma efficace di
protesta.Usiamo lo stesso metodo per far imparare loro il funzionamento di una stufa o l’importanza delle latrine.
Ci sono “vecchie tradizioni” ancora in uso?
- Certamente, e sono un po’ la caratteristica culturale del luogo. Lo sciamanesimo, ad esempio, è ancora in auge. Gli
sciamani sono pochi ma ancora godono di grande credibilità. La gente si reca al dispensario locale solo dopo che lo
sciamano ha fallito nel suo tentativo di cura, a volte arrivando troppo tardi per poter fare qualcosa. La poliandria rimane solo
in Tibet, ma è ormai in declino. I matrimoni combinati invece sono comuni, l’età adatta è considerata di 12/15 anni per le
donne e 15/18 per gli uomini.
Come interviene la superstizione nelle loro vite?
- La gente teme moltissimo gli interventi del sovrannaturale, soprattutto dei bhuts, spiriti maligni.
Che rapporto hanno i giovani con la loro cultura? Tendono a mantenerla o sono attratti dal modello occidentale?
- Nei villaggi il glamour occidentale entra difficilmente. Il poco che entra, entra soprattutto dalla Cina, diventata ormai la
patria del consumismo. Il processo è comunque più lento che nelle città.
C’è molta fuga dai villaggi da parte dei giovani?
- Le condizioni in cui si trovano a vivere portano i giovani fuori dai villaggi attratti da migliori condizioni di vita. I giovani
vanno verso Kathmandu e verso le grandi città in genere, o in India, negli Emirati Arabi. Le ragioni sono semplici: le
famiglie non hanno terra a sufficienza da distribuire a tutti i loro figli quindi alcuni sono costretti ad andare altrove. Oltre a
10 anni di guerra civile, il Nepal ha recentemente avuto anche 10 anni di pessime condizioni climatiche che hanno portato
alla diminuzione dei raccolti (ecco il motivo delle serre) quindi ad un decremento dei già magri proventi che si ottengono
vendendo le proprie mercanzie nei mercati dei centri più grandi.
Le terre sono di proprietà dei contadini che le coltivano?
- Anche se il governo ufficialmente bandisce la differenza tra caste, all’interno delle regioni Himalayane è diverso. Ci sono
equilibri molto delicati nei villaggi, con gerarchie e ruoli ben precisi basati sull’osservanza delle caste e sul rispetto degli
anziani. In Humla coesistono due gruppi etnici: tibetani e nepalesi, molto diversi tra loro per lingua e cultura. Tra i nepalesi
ci sono diverse caste tra cui i Brahmini (casta dominante composta per lo più da sacerdoti), i Bellerist (classe media per lo
più commercianti) e i Saris che rappresentano la casta più bassa. Sono loro che lavorano la terra degli altri perché non ne
posseggono di propria arrivando fino a veri e propri legami di schiavitù.
Come si mantengono le famiglie?
- Se possibile attraverso la terra, vendendo il poco che avanza nei mercati di Simikot o nei villaggi vicini. Alcune famiglie
hanno dei figli che lavorano fuori e spediscono qualcosa, ma nessuno può provvedere al proprio nucleo familiare in maniera
ampia e completamente autonoma. Con i progetti del RIDS le cose sono migliorate un pochino, ma c’è ancora molto da fare.
Il risultato maggiore lo stiamo avendo coinvolgendo la manodopera locale e reinvestendola sui nostri progetti. Molti di
coloro che partecipano ai nostri corsi diventano poi a loro volta insegnanti e questo permette sia una rapida scolarizzazione
che un intervento concreto basato su esigenze reali, filtrate dalle persone del posto.
Credi che il turismo possa aiutare a migliorare le condizioni di vita delle persone?
I turisti sono abituati a vedere il Nepal delle cartoline, ignorando il vero Nepal. Circa l’80% dei 28 milioni di nepalesi
vivono la reale vita nepalese. La vita in Humla è ancora più diversa dal resto del Nepal. L’Humla è a 16 giorni di viaggio da
Surkhet la città più a sud della regione. In questa zona non abbiamo molto turismo perché i turisti preferiscono battere altri
sentieri diventati di moda. Quella del turismo è una risorsa veramente grande, ma anche un’arma a doppio taglio. Mi
preoccupa un po’ l’impatto tra la faciloneria dei turisti e la cultura e la dignità del luogo.
Che cosa si dovrebbe evitare di fare transitando su queste zone?
- Oltre a non lasciare rifiuti, non si dovrebbero considerare arretrate le popolazioni locali solo perché hanno condizioni ed
esigenze di vita differenti. Arrivare qui e giocare a fare del bene semplicemente regalando soldi o oggetti contribuisce solo a
rendere passive le popolazioni del luogo e soprattutto a far vedere gli occidentali come potenti boriosi.
www.rids-nepal.org
L’ALTRO MONDO
TOCCATE E FUGHE SU
TASTIERE INCANTATE
di Luciana Vagge Saccorotti
Un gruppo di re, di divinità e di semidei si era riunito un giorno in un bel prato erboso al centro della folta giungla. Una
grigia cappa di corrucciati nuvoloni pesava sulla terra. Tutti erano pronti a discutere, ma nessuno ancora parlava. Kawan
voleva denunciare la segreta relazione che la Kumari aveva con il re dei demoni. Li aveva visti mentre stavano
amoreggiando. Per iniziare la discussione si doveva aspettare l’arrivo di Indra, il dio del Cielo, ma la Kumari aveva fretta e
voleva andar via. Gli altri la criticarono e la trattennero. Indra scese in terra aprendosi un varco tra le nuvole. Era pallido,
emaciato, furioso. Gridava che il re dei demoni aveva conquistato il regno del Cielo, nonostante i furiosi combattimenti
contro di lui. Tutto era dovuto al dono che aveva ricevuto da Brahma, il dio supremo, dono che gli consentiva l’invincibilità
contro qualsiasi forza maschile. Per riconquistare il regno del Cielo occorreva uccidere il demone, e tutti decisero che fosse
la Kumari a farlo. Lei si oppose. Sarebbe stato un tradimento, disse, poiché tra loro c’era una relazione amorosa. Allora
Vishnu chiese segretamente a Kali, la madre della Kumari, di preparare un liquore che rendesse furiosi e di farlo bere alla
figlia per costringerla a decidersi a lottare contro il demone e a ucciderlo. Dopo che la Kumari ebbe bevuto il liquore, Kawan
le si avvicinò e disse: “il re dei demoni si vanta molto del suo potere su di te. Dice che sei nelle sue mani”. “Ora, il suo vanto
e il suo potere saranno distrutti” rispose furiosa la Kumari. “Chi pensa di possedermi sarà presto decapitato dalle mie stesse
mani”. Il demone era ansioso di vedere la Kumari. Lei era molto bella e lui avrebbe voluto sposarla. “Diventiamo una
persona sola e dimentichiamo il mondo”, le disse. “Uno non può essere due e due non possono essere uno. Tu sei un
demone e io sono una Vergine. Come possono il fuoco e l’acqua essere uno? Preparati ad affrontarmi”. Lui rise di questa
idea, ma dopo una lotta accanita, la Kumari sferrò nel collo del demone un colpo di scimitarra talmente potente che egli
cadde morto ai suoi piedi. (Manandhar, 31/34).
Il Nepal è il paese delle Kumari e leggende come questa, sulla bellezza, il potere, e l’intelligenza della dea bambina vivente
riempiono pagine e pagine di libri, si raccontano nelle lunghe serate d’inverno, attorno al fuoco, nelle case della valle di
Kathmandu, incastonata tra enormi catene montuose. Questa piccola vallata fertile, culla della civiltà nepalese, è abitata dai
discendenti dei Newar, una popolazione le cui origini sono piuttosto misteriose. Il periodo del loro massimo splendore risale
al XVII secolo durante il regno dei Malla, quando la valle era suddivisa in città-stato in rivalità tra loro e i commerci erano
molto fiorenti. Quando nel secolo XVIII il re di Gorkha unificò il Nepal, la lingua nepali soppiantò il newari come lingua
ufficiale. Gli abitanti mantengono però vive le loro antiche tradizioni, legate alla terra per il loro sostentamento e ai templi
per i loro culti.
Il culto della Kumari, la Dea vivente, è intensamente sentito tra i Newar. Kumari ha letteralmente il significato di vergine. È
l’incarnazione della Dea indu Taleju Bhawani, meglio conosciuta in India come Durga. Viene scelta, in qualunque
momento dallo svezzamento alla pubertà, tra le bambine di una casta buddhista delle famiglie Newar, gli Shakya, residenti a
Kathmandu, la stessa cui apparteneva il Buddha. Nonostante venga scelta tra i buddhisti è equamente venerata da buddhisti
e induisti. Secondo il censimento del 2001 i Newar costituiscono la sesta etnia del Paese, il 5,48%, circa 1.245.000 persone.
Parlano una lingua di origine tibeto-birmana con influenze indo-ariane. La società a caste dei Newar ha subito l’influenza
dell’analogo sistema indù. Presso questa popolazione, il figlio di un contadino sarà a sua volta contadino, ed è obbligatorio
sposarsi all’interno della stessa casta. Quanto alla religione i Newar si dividono tra buddhisti e induisti senza nessuna ostilità
o rivalità tra loro. I Newar hanno creato nella Valle di Kathmandu le tre città che oggi sono patrimonio dell’umanità
dell’UNESCO: Kathmandu, Patan e Bhaktapur. Lo stile architettonico dei Newar, che comprende l’invenzione del tempio
a pagoda, si è sparso in gran parte dell’Asia. I fregi in legno dei loro templi rappresentano soprattutto scene di tipo religioso
ed erotico.A Patan abbiamo trascorso un bellissimo pomeriggio tra i Newar, scaldati dal grande senso di ospitalità che
contraddistingue questo popolo. Ci hanno parlato della loro cultura, della loro fama di pittori di soggetti religiosi, delle loro
credenze, come quella che siano le vacche a condurre i morti dal dio degli inferi, della loro specifica cultura nei campi della
danza, della musica e della gastronomia. A sera, torniamo a Kathmandu. Il bimbo che ci sorride mentre ci allontaniamo ha il
kajal sugli occhi per proteggerli dall’inquinamento e dal sole, ci dicono.
Il Nepal è un crocevia di numerosi e diversificati gruppi umani, un mosaico culturale che comprende etnie di ceppo tibetobirmano e indo-ariano, il risultato di spostamenti migratori provenienti da nord e da sud, succedutisi per oltre 2000 anni.
Erano 61 le etnie censite in Nepal nel 2001. Un crogiolo di popoli che parlano 120 lingue, con differenti religioni e
sincretismi tra loro. Appena metà dei cittadini nepalesi parla la lingua nepalese come propria madrelingua. Mentre quasi il
20 per cento non la parla affatto. Secondo il censimento del 2001, l’80.6% della popolazione nepalese è induista e il 10,7%
buddhista. Esistono inoltre alcuni esigui gruppi di musulmani (4,2%) e cristiani (0,4%). Tra i gruppi riconducibili al ceppo
indo-ariano ci sono i Nepali, i Maithili, i Bhojpuri e i Tharu. I Tamang, i Newar, i Magar, i Rai-Kiranti, i Gurung, i
Limbu e gli Sherpa sono invece di origine tibeto-birmana. Uno dei gruppi etnici nepalesi più conosciuti è quello dei
Gurkha, famosi come i guerrieri che respinsero l’invasione islamica attorno al 1500, come regnanti unificatori del Nepal.
Questa che stiamo percorrendo, la valle dell’Humla Karnali, era ed è ancora oggi la Via del Sale dal Tibet al Nepal. Non
ha nessuna strada carrozzabile. Si può percorrerla solo a piedi o a dorso di mulo, o di cavallo come ho fatto io quando le
gambe si rifiutavano di reggermi. Il Karnali nasce dalle pendici meridionali del Gurla Mandhata e in tibetano è chiamato
Mabjhakhabab, il fiume che nasce dalla bocca del pavone. Incontriamo carovane di turisti o pellegrini provenienti dal
Kailash. Qui, la gente vive serena anche senza corrente elettrica che arriva solo a pochi villaggi e solo due o tre ore la sera.
Le donne sfoggiano bellissimi gioielli d’argento, impreziositi da turchesi e coralli. Intraprendendo questo viaggio,
speravamo di poter documentare sedute e riti sciamanici nei pochi paesini mimetizzati tra le rocce che stiamo incontrando,
Kermi, Puiya, Chala, Muchu. Ma le difficoltà del percorso, tra sentieri impervi d’alta quota, e il poco tempo a disposizione
non ci consentono nemmeno di soffermarci il tempo appena necessario per verificare il permanere tra queste popolazioni di
tale fenomeno religioso. Autorevoli studiosi hanno documentato in Nepal forme autonome recenti di sciamanesimo, dove
buddhismo e induismo interagiscono con lo jhakrismo (jhẵkri è il termine generico per indicare lo sciamano nepalese) dando
origine a visibili processi di sincretismo (Nicoletti, 106). La lettura dei lori saggi e le mie ricerche sullo sciamanesimo di area
siberiana mi inducono a dare un’interpretazione emotiva al gesto di un’anziana donna che mi viene incontro nel mio solitario
cammino. Sono sempre in ritardo sugli altri e, quindi, sono spesso sola. La donna, piccola, emaciata, con un anellino al naso,
mi fa segno di voltarmi e intanto s’inginocchia, le mani giunte in segno di saluto o di preghiera che, evidentemente, recita.
Mi volto. La vista di un fantastico arcobaleno, che sovrasta con il suo arco cime incoronate da nevi eterne, mi toglie il
respiro già affaticato dall’alta quota. Shambala e i suoi invisibili abitanti entrano di prepotenza nella mia mente. Nello
sciamanesimo siberiano, l’arcobaleno rappresenta il segno di una unione tra gli uomini e il mondo soprannaturale. Esista o
non esista più tra queste popolazioni il Bon, l’antica religione del Tibet preesistente al buddhismo, in cui sono riscontrabili
tracce sciamaniche, il gesto, la devozione e la preghiera di quella donna, mi fanno pensare a quelle formule magiche,
preghiere e recitazione di mantra che sembra rappresentino proprio il significato etimologico del termine Bon. OM MANI
PADME HUM. Le sei sillabe del mantra di Avalokiteswara, colui che è dotato di grande compassione, muovono le mie
agnostiche labbra. Arrivo a Hilsa, al confine con la Cina, due ore dopo gli altri. Conati di vomito inconcludenti e un antico
mal di schiena mi hanno accompagnato lungo tutta la lunghissima discesa. Domani, nei pressi di Manepene lasceremo
l’Humla Karnali ed entreremo nella valle del Limi. Per secoli il Limi è stato una parte di Ngari, una regione tibetana avvolta
nel mistero e conosciuta come tetto del mondo. Ngari è la terra del Monte sacro Kailash, il primo centro del buddhismo e
dell’antico Regno di Guge. Dopo l’invasione cinese nel 1961, fu tracciata una linea di demarcazione per dividere Ngari tra il
Tibet occidentale e Humla, nel Nord ovest nepalese. Il Limi finì così sotto il governo del Nepal. Indipendente, isolato e
ignorato dai governi di Cina e Nepal, Limi conserva ogni aspetto della sua cultura tibetana, le tradizioni e la religione che i
tibetani hanno invece perduto. Incontriamo diversi villaggi, Til, Halji, Limi. I villaggi hanno piccole fattorie con animali
domestici come yak, cavalli, capre e pecore. La loro principale produzione è l’orzo e il chang, una birra casalinga a base di
orzo. La neve imbianca la valle da novembre ad aprile. La popolazione ricava così poco dall’agricoltura che gli uomini sono
spesso costretti ad andare in inverno nelle remote foreste settentrionali dell’India, dove producono oggetti di legno da
vendere in Nepal, India e Tibet. Solo un poeta può descrivere quelle valli. Larghi pianori, verdi e gialli, abbracciati da
imponenti montagne rocciose, i cui pendii, ocra e marrone, giocano con le ombre per disegnare forme umane, volti. Alle
loro spalle, montagne più alte sembra vogliano proteggerle con l’amorevole premura della madre. Piccole nuvole bianche si
alzano verso i picchi più elevati. Sono fumetti dove scrivo preghiere perché qualcuno mi aiuti a concludere le interminabili
tappe. A Halji arrivo presto, sola. Gli altri sono andati per un’intervista a un pittore a Til. Lascio il campo e mi avvio verso il
paese, vecchissimo. Nei campi si raccoglie l’orzo. C’è tutto il paese sotto il sole che rende ancora più dorato quel prezioso
prodotto. Campi squadrati con arte, covoni che formano disegni geometrici. Donne ti sorridono. Io non posso parlare. Dove
sei Tucci? L’antico santuario apre le porte, chiuse da moderni lucchetti, alle 17. Lo visito più tardi, insieme al gruppo.
Piccoli ambienti scuri di mistero, uno dopo l’altro, uno dentro l’altro come in un gioco di matrioske. Campane di preghiera
gigantesche, tamburi dalla pelle consunta, originali clessidre dove l’incenso si consuma a tempi stabiliti, affreschi, mandala,
buddha. Tutto in una penombra che ti spinge indietro nel tempo, attraverso pareti che hanno una loro vita, che parlano di
secoli, di grotte di eremiti, di mistici sentieri della buddhità. .
La ricerca antropologica necessita di tempi lunghi, studi, conoscenza della lingua o ottimi interpreti, e di adeguata
preparazione. Tutte condizioni assolutamente lontane dal tipo di viaggio intrapreso, pur nelle buone intenzioni di poter
documentare, se non studiare e approfondire il fenomeno dello sciamanesimo. Vorrei, comunque, rilevare un dato
importante che contraddistingue questa gente di cultura tibetana, la poliandìa, una forma di matrimonio nella quale una
donna ha più di un marito o compagno allo stesso tempo. In alcune aree del Tibet e del Limi, appunto, una donna può
sposare il figlio maggiore di una famiglia e poi accompagnarsi anche ai suoi fratelli più giovani. Nel Tibet, e quindi in Cina,
la poliandria è, però, illegale. Do brevemente conto di questo aspetto interessante avvalendomi delle ricerche effettuate tra il
1974 e il 1976 da Goldstein (48/60). Come in molte aree di cultura tibetana, i matrimoni sono usualmente patrilocali,
monogamici o in regime di poliandrìa, che sembra essere un’ideale forma di matrimonio in famiglie con più di un figlio
maschio e campi agricoli di una certa importanza. E’ interessante notare che la poliandrìa in Limi funziona come un
autentico meccanismo di riduzione della popolazione, sebbene questo fenomeno non sia percepito dagli abitanti. La
poliandrìa, infatti, pur non riducendo la fertilità delle donne, riduce il numero di quelle esposte al rischio di concepimento.
I conflitti e le tensioni in questo tipo di alleanza famigliare sono, come è facile indovinare, frequenti. L’autorità tra i fratelli è
esercitata dal fratello maggiore e la subordinazione di quelli più giovani rende questi ultimi intolleranti e aggressivi. Senza
considerare gli affetti e il desiderio sessuale in rapporti in cui spesso la differenza d’età tra l’unica moglie e i fratelli più
giovani ha un peso rilevante. Perché, quindi, la scelta della poliandrìa? I soggetti intervistati da Goldstein l’hanno spiegata
con motivi prettamente materialistici: la necessità, cioè, di conservare intatte da una generazione all’altra le risorse
produttive della famiglia unita, la terra soprattutto e gli animali. La parcellazione della terra in piccoli lotti ridurrebbe
significativamente i mezzi di sostentamento della famiglia. Quanto al lavoro, la poliandrìa offre un ulteriore vantaggio.
L’agricoltura e la pastorizia, in zone come il Limi, richiedono mano d’opera simultanea in posti diversi, per ottenere il
massimo di produttività. In estate, per esempio, le donne della famiglia possono restare al villaggio e dedicarsi a lavori di
agricoltura. Mentre gli uomini possono o rimanere al pascolo con gli animali, o andare in Tibet a comprare sale, o restare al
villaggio per costruire e rivendere oggetti tra cui le loro famose ciotole di legno. Tutto questo è possibile in una famiglia
unita. Ciò che, è chiaro, non escluderebbe la presenza di più mogli. Ma con le donne in competizione l’una con l’altra,
aumenterebbero i conflitti e i conseguenti rischi di divisioni. Naturalmente, non tutte le famiglie con molti fratelli scelgono
la poliandrìa. Le famiglie molto povere, con poca terra e pochi animali non hanno proprietà da conservare e i loro membri si
dedicano solitamente alla produzione artigianale individuale. Inoltre, nei casi in cui esistono sufficienti risorse e opportunità
per sognare di poter vivere e lavorare individualmente in una comunità, magari con la donna che ami, i giovani abbandonano
volentieri la famiglia e la poliandrìa. Lascio la via dei bianchi fumetti di preghiera, parafrasando il titolo di un bellissimo
libro del lama Anagarika Govinda. La lascio dopo un viaggio faticosissimo ma magico. Un viaggio impossibile da
dimenticare, con compagni che fingevano di non dare importanza ai miei sempre più lunghi ritardi e che, chissà!, forse
guardavano con un po’ d’invidia il glorioso ronzino che mi traeva letteralmente in salvo nelle tappe più ardue da superare.
BIBLIOGRAFIA
- Goldestein, M.C., population, social structure and strategic behaviour: as assay on polyandry, fertility and change in
limi panchayat, INAS Journal, pp.47/62, 1976.
- Lama Anagarika Govinda, La via delle nuvole bianche, Roma, 1981.
- Manandhar, J.K., The legends of Nepal, Kathmandu, 2002.
- Nicoletti, M., Bon e sciamanismo: studio introduttivo di comparazione dei due fenomeni religiosi, in Mastromatteti,
R., Nicoletti, M., Riboli, D., Sani, C., Tremore e Potere, Milano, 2007.
VIAGGI MALEDETTI
UNA STORIA DI
BARCELLONA
di Luca Pakarov
Pare sia scoppiata la bomba atomica. S’è rovesciato tutto, quello che stava sotto è finito sopra e giù tutto il resto. Stilismo e
cosmesi della città. S’è capito quello che sta succedendo? Non mi ci trovo mica più a camminare su queste strade. Sono
giorni che vado avanti e indietro per il porto, la Barceloneta, mi arrampico fino Passeig de Gracia, uno sforzo per arrivare
a calle Verdi e scendo fino al Mercat de San Antonì, poi mi infilo nel Raval, calle della Cera, una pausa al bar Aurora e
di nuovo Rambla del Raval, calle San Rafael, poi Robador, calle San Pau ed arrivo alle Ramblas, quelle che conoscono
tutti, ma taglio diritto fino calle Escudellers, lì mi fermo in plaza Orwell, per gli amici plaza del tripi. Ho cercato in lungo e
largo quello che avevo lasciato in questa città, anni fa, ho guardato negli armadi e sotto i tappeti, dentro i negozi e fra le
fioriere, i bar poi ed i vicoletti. C’era gente che m’aveva avvertito sui cambiamenti, sulle nuove tendenze postmoderniste e
avanguardiste. Io ci avevo riso; nuove tendenze moderniste, avanguardismo? E che cazzo significa? Ma ora mi devo
ricredere, è capitato veramente l’irrimediabile, è finito tutto. Tutto quanto. Lontano da me i malinconici, i reazionari o i
romantici che trafficano sentimenti, per i quali il vecchio è sempre meglio ed i classici sempre di moda. Non voglio averci
niente a che fare con nessuno di questi ma qui, sinceramente, s’è esagerato. L’ho amata tanto questa città ma il prossimo che
viene a parlarmi della Barcellona contemporanea, fashion e cool, con bar in stile non so che ed i negozi delle grandi griffe,
vi assicuro che gli bestemmio in faccia. Peggio ancora sarà per il fricchettone che verrà a sciorinarmi la storiella della
Barcellona ribelle, okkupata e bohème, dove uno va a ganarse la vida, a fare l’artista… giuro che do di matto e lo tiro giù
con una testata… E’ avvenuto semplicemente quello che il rimpianto ma poco ascoltato Manuel Vázquez Montalbán
chiamava la decostruzione urbana. Mentre me ne stavo altrove, ‘sti frignoni qua, l’elite tecnologica, s’è messa d’impegno
come formichine a costruire di nascosto e senza dirmi niente, hanno scavato e buttato su grattacieli. Ma non è Barcellona
questa? Que va… Chi ci vive, i catalani, sa che tutto è iniziato con le Olimpiadi del ’92, un periodo d’oro quello, dove per
realizzare la Rambla del Raval spazzarono 5.000 ometti aggobbiti verso la periferia per fare spazio alla classe media. E’ la
stessa epoca in cui nacque il Museo d’Arte Contemporanea al nord del Raval (anche Raval è il nuovo, androgeno, nome
che sostituisce il più malfamato barrio Chino). Poi ha ripreso vigore con il Forum internazionale delle culture del 2004.
Una bella spintarella ad importare ambienti e stili di vita, mica no. Cito un altro paio di numeri a caso e poi giuro che la
smetto: 15.000 persone sono quelle che negli ultimi dieci anni si sono allontanate dal barrio di Gracia per l’aumento dei
prezzi; nel 2005 il credito totale dell’industria spagnola è stato più basso di quello delle attività immobiliari. Un panino col
prosciutto e un’aranciata. Può bastare. Onestamente, per dirla come si deve, me ne frego degli sfrattati, del diritto alla casa e
delle aree verdi, quello che mi scoccia è che mi cambino così l’habitat, che mi tolgano la gente, da un giorno all’altro, che
ripuliscano il centro in favore di asettici personaggi vestiti con polo e scarpe da tennis bianche, che affiorino ovunque bar
ecologici costruiti con materiale riciclato e bistrot politically correct, dove non c’è mai nessuno che spacca un bicchiere o
insulta sua moglie. E’ tutto santo e tutto per bene. Finiti i tempi dei bar illegali, tutti chiusi quelli in cui dovevi bussare una
porticina, o suonare un campanello rosso e dove sempre ti veniva ad aprire un personaggio, un nano o un travestito, usciti da
una pellicola di Almodovar. C’era il 101 per esempio, in calle de la Riera Alta, lì sì che ci trovavi gli artisti, cineasti, pittori
e mignotte pronte a far lezioni di bon ton, oppure al Lokal di calle Robador, un circoletto di anarchici dove aleggiava una
sincera aria di sconfitta e si finiva sempre con la testa dietro il bancone per fregare una bottiglia d’assenzio. Mi cresce la
rabbia quando sono costretto a farmi dieci fermate di metro per trovare un pusher serio. Ahiii Barcellona, città portuale per
eccellenza, che come Genova o Napoli, eretta con stradine strette, passaggi insidiosi, a difesa dei pirati ed ora pobrecita,
sventrata in onore della sicurezza e dei piani di riqualificazione, sta inerme contro l’attacco delle agenzie immobiliari ed il
saccheggio dei turisti. La marea colorata di tutte le bandiere del mondo ed urlante tutte le lingue conosciute ha conquistato
ogni angolo. Ha messo le tende ed ha appiccato il fuoco sul vecchio. E’ vero, li capisco i vacanzieri, ci si piscia bene per
quei vicoletti ombrosi ma almeno, qualche anno fa, c’era in aggiunta col prezzo della sbronza l’adrenalina d’una possibile
coltellata, l’emozione del pericolo d’una rapina o, nella migliore delle ipotesi, la sorpresa della doccia fredda d’una secchiata
d’acqua lasciata dalla vecchina del quinto piso. Senza far polemiche a basso prezzo, non si capisce com’è che i piani di
riqualificazione non sono mai per chi ci vive. Voglio dire che ci stavo meglio quando il barrio Chino era un quartiere
perigroso, che rispettava chi lo rispettava, quando in plaza Real una mandria di magrebini usciva dai quattro angoli del
colonnato e si lanciava sulla preda per lasciarlo senza un quattrino, quando per le Ramblas passava il mitico autobus 38 a
caricare tutti gli yonkies del centro (in fila alla fermata con il biglietto in mano) per scaricarli al quartiere gitano di Can
Tunis, sotto il cimitero. A
me sembra una maniera più divertente, più nostrana di viaggiare. Vivere in un posto ha senso solo se uno si conquista la
fiducia e l’intimità d’una città, si fa fregare, mena la strada e le ripiglia con gli interessi, per poi, lentamente, provando e
riprovando, far amicizia o in ultima istanza prendere un definitivo calcio in culo diritto per l’aeroporto. Hanno cambiato le
carte in tavola, è troppo facile adesso, troppo floscio e placido. Ora mi capita solo di vedere comitive di idioti che, per
confermarsi come tali, circolano con una fascia colorata del tipo primo cittadino e festeggiano il capo branco. Di solito una
cicciona o uno con la cravatta di traverso sulla fronte. E’ così, esiste un turismo dell’addio al celibato, non ci volevo credere
neppure io. Oppure provate a passare al lato di un gruppetto d’inglesi, quando gli state di fianco iniziate un coro, uno
qualsiasi, il primo oh oh oh che vi passa per la testa, è incredibile, vi prego tentate, vi troverete accerchiati da un’orda
d’omini sudati e sbronzi che abbracciandovi, intoneranno il vostro stesso ritornello. Altrimenti fate un gioco, lo ricordate
indovina chi?. Beh mettetevi in Rambla Canaletas, vicino plaza Cataluña, ci sono delle sedie, cacciate se necessario i
negretti che vendono fumo di plastilina, e cominciate a dire quali sono italiani e quali no. Li beccherete tutti per il modo di
gridare, di sbracciarsi ed, ovviamente, di vestire (zainetto Invicta e occhiali a goccia sono ridondanti). Nessuno ha più paura
di camminare per queste strade porca eva. Ditemi ora, qual è la miseria? Sul El Pais tempo fa spiegavano che perfino le
statue ed i saltimbanco delle Ramblas sono stati regolamentati… sì, r e g o l a m e n t a t i. I giullari di corte, gli spontanei,
gli artisti, devono chiedere un’autorizzazione che otterranno solo dopo previa esibizione dimostrativa in Comune. E’come se
l’autorità richiedesse la bella presenza per le puttane dei crocicchi. Vi rendete conto, è tutto un artificio, è un falso. A
proposito, anche le puttane sono cambiate, ora sono le cinesi a tener banco nei bordelli, costano meno e si possono
maltrattare. Una bella notizia ogni tanto. Non so come dirvelo, ma per me che ci ho vissuto tanto tempo fa tutto ciò mi
deprime. Ci ho messo almeno un anno a suo tempo per entrare nella città, per capirci qualcosa, per entrare in tutti i quartieri,
farli miei in qualche modo, per non farmi derubare e salutare la gente giusta. Barcellona, Parigi, Londra o Milano non sono
più mica tanto diverse.
Non c’entrano niente i monumenti o le lingue, è lo spirito delle città che s’è sbriciolato per amalgamarsi in un’unica portata
di nessun sapore. Mi sento frodato. Senza troppa escatologia, vi annuncio a trombe spiegate questa verità (appuntatevela):
presto finirà il turismo. Sì perché quando tutte le città diverranno anonime copie di altrettanto anonime città, quando ci
saranno solo baretti di design, con la mobilia rettangolare e le lucine che affiorano dalla barra bianca del bancone, quando i
lungomari saranno tutti Rimini e i negozi tutti Zara, allora in onor dell’amata/odiata globalizzazione, avremo un’unica città.
La nostra sarà una qualsiasi altra città. Oh, per me tanto meglio che odio viaggiare, ma sono certo che si prenderà un aereo
solo per far fare una passeggiata alla macchina fotografica e una pisciatina alla telecamera nel parco di Tokyo. Tornando a
Barcellona, io che sono uno attento, che ho spirito d’osservazione e critico, ho il nome, so chi è il responsabile di questa
sciagura. Oggi leggevo per caso un’intervista a Manu Chao (sempre per caso capitano certe cose) e pare che ogni volta non
possa fare a meno di citare Barcellona come la sua città ispiratrice, la città dove suona e dove vive, ci tiene a specificare.
Non gli basta parlarne, riporta strade e luoghi il maledetto, fa la mappatura delle sue giornate e non si rende conto di che sta
combinando, di quanti prendono appunti nel frattempo. Già nel quartiere dove vive non è visto bene per niente, certe scritte
sui muri lo confermano, mi meraviglio che qualcuno ancora non gli abbia dato una bella scardassata. La gente, i vecchietti in
questi vicoli che hanno visto di tutto e di più, che ospitarono Camillo Berneri nel ’37, hanno presto capito l’andazzo perché
si sono fatti un naso così per quello che puzza. Si son sentiti accerchiati quando hanno notato che dai balconi di calle Avinyò
o in plaza Milan si sporgevano tante testoline bionde con sotto gli occhietti azzurri. Loro non sapevano che esisteva gente
pronta a pagare affitti del genere in case del genere che fa però tanto etnico, tanto antiglobal, tanto Manu Chao appunto.
Quindi ci sarà poco da meravigliarsi se prima o poi, in un giorno di primavera con il sole tiepido, qualcuno tornerà ai vecchi
fasti puntando lo schioppo fuori dalla finestra, per una sana opera di cecchinaggio. Il colmo: alcuni giorni fa un tipo
magrolino italiano m’ha chiesto in pessimo spagnolo dove potevo trovare il bar di Manu Chao (esiste, ma non vi dico
manco morto dov’è), l’ho mandato a lui e la sua donna perroflauta (hanno sempre un cane e un flauto) nell’unica via rimasta
dove è meglio non passare, soprattutto di notte. Ci tengo a dire ch’ero uno che ha consumato il mangianastri della macchina
con i Mano Negra ma ora, questo qua, Manu Chao l’antiglobal globalizzatore non mi va proprio a genio. Ha villeggiato sul
mito del Raval, ha lasciato intravedere nelle interviste il suo mondo multiculturale di musichette e festicciole e poi ha
venduto tutto al mercato delle erbe. E’ normale, sicuro, io avrei fatto lo stesso in cambio di quattrini. Però poi sono partiti un
sacco di Manuchauisti, mezzi musicisti o liberi pensatori, figli dei fiori, debosciati o sognatori, pronti a seguire le tracce
giallo e verdi della gente della calle. Non so perché ma li immagino sempre gialli e verdi. Che gli frega al capo guru che tutti
i gringos alternativi, i nord europei assetati di sole e sangria, siano piombati qua pieni di soldi ad affittire e comprare, lui è
cittadino del mondo, lui quando vuole se ne fila in Brasile o a Parigi. A qualcuno interessa che negli ultimi 15 anni nella
città di Barcellona s’è moltiplicato per 20 la concessione con garanzia ipotecaria? Qualcuno sa quanti sono gli spagnoli, non
dico i barcellonesi, rimasti a vivere nel centro della città? Sapete chi paga tutto questo? Io a Manu Chao gli darei l’ergastolo.
Venite a Barcellona, ok, però se siete leggermente migliori di quello che credete, non dimenticate di passare per La Mina o
nel barrio di Sant Roc per esempio, lì ci troverete un sacco di quelli che una volta vivevano in centro… uomini che
lavoravano nel porto, ch’erano della Barceloneta prima dei barbari… la gente vera, le vere tapas ed i veri musicisti stanno
quatti nelle periferie… vi rapineranno sicuro ma ne varrà la pena… e se proprio volete documentarvi… lasciate le Lonely
Planet e date invece un’occhiata al film En costruccion… e a questo punto se ancora volete parlarmi di una città che suona
rumba e balla la movida sulla sua bella spiaggia artificiale, rispondo che a me, per queste strade piene di marmocchi ripuliti,
di spacconi con macchine fotografiche che ahimè non verranno rubate, riesce ad accompagnarmi solo l’autunno grigio di
Nick Drake. Da giorni sono a Lisbona in casa di amici. Pare rimasta quella in Lisboa Story di Wim Wenders; speriamo
che Manu Chao non passi di qua.
PAX MUNDI
ETIOPIA 2007-12-20
UN PROGETTO PER CONOSCERE LA CULLA DELL’UOMO
Testo e foto di Gianluca Frinchillucci
L’Associazione Perigeo Onlus nasce nelle Marche, da un gruppo di persone, diverse per formazione ed esperienze, ma
accomunate dalla voglia e dalla determinazione ad operare nel campo della solidarietà sociale. In collegamento con Arte
Nomade e altre realtà culturali marchigiane opera nel campo della solidarietà sociale tramite la promozione di progetti di
cooperazione internazionale per lo sviluppo delle popolazioni che vivono in condizioni di disagio, con particolare attenzione
alla tutela ed al sostegno delle popolazioni indigene di tutto il mondo, la partecipazione ad interventi umanitari e di
emergenza, la promozione di attività finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale dei popoli,
la promozione di attività di educazione socio-culturale e ambientale e di attività di formazione, quali ad esempio la
realizzazione di corsi di formazione sulla comunicazione interculturale e la comprensione delle diversità e corsi di
preparazione fisica, psicologica e logistica a spedizioni di ricerca e situazioni di emergenza. L’Associazione PERIGEO
Onlus si occupa dell’ Etiopia già dal 2004 con attività di intervento di vario genere, come ad esempio l’attuazione di
progetti di cooperazione allo sviluppo, di ricerche antropologiche, etno-archeologiche e storiche, con attività di promozione
dello sviluppo culturale e di documentazione. È solo a partire dal 2007, però, che l’azione dell’associazione in Etiopia si è
formalizzata in un progetto sistematico di intervento a favore di questo paese, chiamato ETIOPIA, Identità e Sviluppo, ed
ha assunto una veste più ufficiale grazie al patrocinio della Provincia di Trieste, del Comune di Trieste, del Comune di
Ascoli Piceno, del Comune di Sant’Angelo in Pontano, della Comunità Montana dei Monti Azzurri e della Parrocchia
S.S. Salvatore di Sant’Angelo in Pontano. ETIOPIA – Identità e Sviluppo è un progetto di cooperazione che affronta la
questione dello sviluppo dell’Etiopia da un punto di vista sia umanitario che culturale. Alla progettazione per il
miglioramento della qualità della vita dei soggetti beneficiari, infatti, si affianca una progettazione di tipo culturale che,
tramite ricerche, attività di documentazione e iniziative di sensibilizzazione, mira alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio culturale del popolo etiope. Il progetto è articolato in attività di vario genere: le attività di cooperazione allo
sviluppo e gli interventi di tipo umanitario, prevedono i progetti Scuola e Mission. Le attività di promozione dello sviluppo
culturale sono il Museo Etnografico Oromo e l’Istituto di Ricerca sui Popoli dell’Etiopia; ci sono poi attività di ricerca
antropologica ed etno-archeologica: il progetto Italia – Africa Orientale e Settentrionale e la realizzazione di video e
reportage fotografici. Parte delle attività dell’associazione in territorio etiope sono state programmate con la collaborazione
di Padre Angelo Antolini, un missionario cappuccino che svolge servizio in Etiopia da 26 anni, durante i quali ha fondato
importanti strutture religiose ed assistenziali nella zona di Dubbo e di Hembeccio. Oggi guida la Missione Cattolica
dell’Ordine dei Cappuccini di Kofale, in territorio quasi completamente mussulmano, ed è uno dei protagonisti della
prima spedizione organizzata e realizzata dai membri dell’Associazione Perigeo Onlus sotto l’egida del progetto ETIOPIA –
Identità e Sviluppo. La prima parte del progetto è stata portata avanti da un gruppo di italiane ed etiopi (chi scrive,
l’archeologo Luca Natali e Enrico Mazzoli, studioso e viaggiatore triestino). Il gruppo è partito da Addis Abeba diretto
verso sud, per avviare un nuovo progetto di ricerca dedicato ai popoli dell’Etiopia meridionale. Percorrendo centinaia di
chilometri è giunto presso il popolo dei Surma, ai confini col Sudan, per poi ripartire verso la Valle dell’Omo, non lontano
dai confini con il Kenia. Lì, dopo un incontro di approfondimento sulle culture locali con l’etnolinguista italiano Mauro
Tosco, ha documentato la vita degli Hammer. Queste azioni di esplorazione e ricerca, rientrano nel sotto-progetto Istituto
di Ricerca sui Popoli dell’Etiopia, volto alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale delle popolazioni indigene
dell’Etiopia. Il progetto consiste nella realizzazione di un Istituto di Ricerca sui Popoli dell’Etiopia con sede presso la
missione dell’Ordine dei Cappuccini situata nel distretto di Kofale (Regione Arsi Occidentale, Stato Oromo), che si
propone come polo di attrazione, per studiosi, ricercatori e per il flusso turistico che transita per la zona di Kofale in
direzione Bale Mountains. Nel corso della spedizione di luglio e agosto è stato raccolto importante materiale etnografico e
etno-archeologico, il quale rappresenta il primo nucleo di quella che diventerà una grande raccolta di materiale
antropologico ed etno-archeologico per la valorizzazione del patrimonio culturale dei popoli indigeni etiopi. Oltre alla
raccolta di materiale etnografico sono state realizzate ricerche antropologiche ed etno-archeologiche, come ad esempio la
scoperta di un sito archeologico a qualche ora di distanza dalla città di Kofale. Dopo essere risaliti al campo base della
spedizione, presso la missione dei cappuccini di Kofale, nel territorio degli Oromo, i membri della prima parte della
spedizione si sono riuniti con gli altri componenti del gruppo, giunti nel frattempo dall’Italia, ed hanno iniziato a lavorare al
progetto Scuola e Museo Etnografico Oromo. In un primo momento è stato preso contatto con la realtà locale e dall’analisi
della situazione scolastica è emersa l’importanza di assicurare il proseguimento della scolarizzazione offerto dalla missione
dei frati Cappuccini, che, al momento, è ferma alla classe IV, corrispondente circa alla nostra IV elementare, con l’intento di
garantire il completamento del corso di studi fino alla classe ottava (corrispondente alla nostra terza media). Un altro gruppo
di lavoro ha portato avanti il progetto Museo realizzando attività di ricerca e documentazione diretta sulla vita e sulla cultura
Oromo e lavorando intensamente in vista dell’inaugurazione ufficiale, che si è tenuta il 12 Agosto alla presenza del Vescovo
della Diocesi di Meki, cui appartiene la missione di Kofale. Il progetto consisteva nella realizzazione di un Museo
Etnografico Oromo, strutturato sulla forma dei moderni eco-musei, volto alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio
culturale dell’etnia Oromo. Esso intende diventare un polo di attrazione non solo per la popolazione locale, che ha
dimostrato di attribuirgli una grande importanza in termini di valorizzazione e promozione della cultura tradizionale, ma
anche per i numerosi turisti che transitano in questa zona diretti verso i Monti Bale, rinomata meta turistica.Le ricerche sono
proseguite poi nell’area geografica del Welayta (chiamata anche Wolaytta, Wolaita), presso una comunità di Fugà, in cui
sono state documentate le attività del fabbro, del vasaio, del conciatore di pelle e la struttura dei villaggi. Sono stati anche
realizzati studi etno-linguistici e storici. Il lavoro svolto nel corso della spedizione, proseguimento di un precedente ricerca i
cui risultati erano già stati presentati in due importanti convegni scientifici a Roma e Lisbona, ha concentrato le sue indagini
nell’approfondimento delle modalità di lavorazione delle pelli da parte dei Faki, nome specifico con cui vengono indicati i
conciatori di pelle all’interno della classe sociale dei Fugà, perchè svolgono questo lavoro ancora con tecniche preistoriche.
I protagonisti della ricerca sono stati una famiglia di conciatori di pelle del villaggio di Korche, nei pressi di Dubbo. Dopo
aver documentato le varie fasi della preparazione dello strumento utilizzato per conciare le pelli, è stata approfondita
l’attività di scheggiatura dell’ossidiana per la realizzazione dei raschiatoi, che avviene ancora con tecniche preistoriche.
Dalle testimonianze raccolte, risulta che questa ricerca ha ottenuto risultati molto importanti anche per quanto riguarda il
miglioramento della reputazione delle persone coinvolte: solitamente emarginata per via del lavoro di conciatori, considerato
impuro dopo l’esperienza con gli uomini bianchi, questa famiglia di Faki ha ottenuto maggiore rispetto ed accoglienza dalla
comunità, dimostrandosi felici e orgogliosi di collaborare nuovamente con i ricercatori del Progetto ETIOPIA, Identità e
Sviluppo. Successivamente, tornati nello Stato Oromo, i membri della spedizione si sono recati al Parco nazionale dei
Monti Bale e alle Grotte di Sof Omar, in considerazione del fatto che il nostro Museo Etnografico Oromo intende
diventare la naturale porta d’ingresso a questi celebri ed importanti luoghi, meta di numerosi turisti provenienti da tutto il
mondo. Il Parco del Bale, che si estende per oltre 2400 chilometri quadrati tra i 1500 e i 4377 metri d’altitudine, offre allo
sguardo del visitatore uno spettacolo emozionante: dalle distese erbose e verdeggianti della zona settentrionale dove, tra un
villaggio e l’altro, buoi e cavalli di rara bellezza pascolano tranquilli accanto a gruppi di facoceri, babbuini e altri animali
selvatici ai paesaggi lunari e desertici del Plateau Sanetti, dove tra bassi cespugli argentei e laghi montani, si aggira
guardingo il rarissimo Lupo Etiope ed è possibile incontrare solo sporadici pastori, magari bambini, col quaderno dei
compiti in mano a decine di chilometri da qualsiasi forma di civiltà. L’esplorazione è poi proseguita verso le grotte di Sof
Omar, antica dimora dello sceicco islamico Sof Omar e tutt’oggi luogo di riti e cerimonie pagane, dove sono stati allacciati
importanti contatti per l’avvio di un percorso turistico a valenza antropologica che coinvolga differenti centri di interesse
turistico dello Stato Oromo, a partire da Museo Etnografico Oromo di Kofale. Infine, sono stati realizzati video e reportage
fotografici delle varie attività svolte ed è stato raccolto importante materiale bibliografico per la realizzazione del Progetto
Italia – Africa Orientale e Settentrionale: progetto di ricerca sulla presenza italiana in Etiopia, Eritrea e Somalia, con
particolare attenzione all’approfondimento delle dinamiche che hanno caratterizzato e caratterizzano tuttora il rapporto che
lega l’Italia alle sue ex colonie d’oltremare.
ASSOCIAZIONE PERIGEO ONLUS
Via Quasimodo, 5 62012 Civitanova Marche (MC)
cod.fisc. 92014950437
tel. +39 333 1904643 fax. +39 0733 814718
Registrazione Anagrafe Onlus: Prot. n. 2199 del 26/01/2005
Riconoscimento Regionale n.63/RIC_12
[email protected]
c/c 103 ABI 08491 CAB 68872 CIN K
c/o Banca Cred. Coop. Civitanova Marche e Montecosaro
Ag. di Civitanova Marche, via S.Pellico (MC)
NUOVI ORIZZONTI
IL BEL BELGIO
di Pierfrancesco Giannangeli
Nel momento in cui scriviamo queste note il Belgio galleggia pericolosamente in una crisi politica dagli esiti imprevedibili.
Il Paese, infatti, da oltre centocinquanta giorni è senza un Governo. Nel giugno scorso ci sono state le elezioni, ma il leader
democratico-cristiano fiammingo Yves Leterme ha fin qui condotto negoziati senza un esito concreto. C’è chi vede in
questa situazione una pericolosa polveriera sul punto di esplodere, portando a una frattura non più ricomponibile tra i
fiamminghi del nord di lingua olandese, la parte economicamente più ricca del Paese, e i valloni del sud che parlano
francese. Si carica così anche di altri significati, oltre a quello puramente legato al piacere del nomadismo intellettuale,
questo nostro viaggio, che parte dal cuore dell’Europa politica, la capitale Bruxelles, e sale verso settentrione, puntando in
direzione di uno dei territori più affascinanti del Vecchio Continente: le Fiandre. La Grand-Place di Bruxelles è un
manifesto del barocco, chiusa com’è in tutti i suoi lati da palazzi che sono un’esaltazione di questo stile. Sono i palazzi delle
corporazioni (i macellai, i merciai, i battellieri), arricchiti dal municipio gotico. Si respira il tempo in questo spazio, non
quello immobile che fa diventare le architetture polverosi musei, quanto piuttosto il tempo che diventa patrimonio dell’uomo
che lo gusta affinando i sensi attraverso la bellezza. Quello stesso tempo che accelera, ma senza mai esagerare, nei quartieri
a ridosso del centro, Ste-Catherine e St-Géry, testimonianza di una società multiculturale che si integra senza cancellare le
identità. Passeggiando per queste vie e alzando la testa sui muri delle costruzioni, ci si tuffa nell’anima del fanciullino che
abita ciascuno di noi, perché molte sono le costruzioni abbellite dai particolari murales di queste parti. Piantandoci lo
sguardo, si riconoscono i personaggi dei nostri sogni di ragazzi, quelli cioè dei fumetti, arte di cui il Belgio è maestro. Qui
sono nati Tin-tin di Hergé e Le Schtroumpf di Peyo (pseudonimo di Pierre Culliford), vale a dire quelle simpaticissime
palline blu che in Italia conosciamo come Puffi. Ma anche il terribile Lucky Luke è originario di queste parti, partorito da
Morris. Chi volesse una sintesi molto accurata di tutte queste creature di matita, può andare al Centre Belge de la Bande
Dessinée, il Museo del Fumetto (rue des Sables, 20): oltre al piacere di incontrare tanti personaggi noti anche da noi, solo
il luogo merita la visita, essendo un notevole esempio di quell’Art Noveau che qui fiorì alla fine dell’Ottocento anche per
opera di Victor Horta. Saltando qua e là nelle suggestioni, va ricordato che il Belgio è il paese della birra: se ne trovano di
tutti i tipi, da quelle corpose e scure alla delicata bianca dei frati trappisti. Un luogo particolare dove andare a Bruxelles è À
la Mort Subite (rue Montagne aux Herbes Potagères, 7), un fascinoso bar, anch’esso in stile art noveau, dove si può
conversare, scrivere e leggere, ovviamente condividendo con tutti gli avventori la birra, il cui nome (a buon intenditor...) è lo
stesso del locale. Sempre restando sulla gastronomia, e non fermandosi al tipico piatto locale delle moules et frites, cioè le
cozze con le patatine fritte, come non restare incantati davanti all’altra gloria nazionale, la cioccolata. Qui ne fanno
giustamente un vanto, la sanno lavorare con fantasia e rispetto, e un buon posto dove andare è da Pierre Marcolini (place di
Grand Sablon, 39): praline e cioccolatini da favola prodotti da uno dei più antichi artigiani, le cui origini stanno
chiaramente nel cognome. Prima di andarcene, vogliamo soddisfare la curiosità forse più forte, perché con quell’immagine
sul sussidiario sono cresciute generazioni di studenti: andare a dare un’occhiata all’Atomium. Quando sui libri si parlava
della Confederazione del carbone e dell’acciaio, il nucleo da cui è nata l’attuale Unione Europea, la foto che accompagnava
il testo era immancabilmente la sua. E’ il fascino dell’infinitamente piccolo che diventa gigantesco, una molecola di cristallo
di ferro ingrandita 165 miliardi di volte, che diventa misteriosa ma familiare costruzione, eretta per l’Esposizione Mondiale
del 1958, alta oltre cento metri. Bellissima quando esce il sole e le sue grandi sfere color grigio ferro diventano dorate.
Qualche divagazione, infine, sul viaggio nel triangolo delle Fiandre profonde, quelle dove si parla in olandese e tutto è
scritto in olandese, che comincia ad Anversa. Certe immagini di Rubens si possono cogliere nella loro essenza solo se si
viene da queste parti. E poi scorci urbani spettacolari, che fieramente descrivono un’identità. Anversa, poi, è per nulla
sonnacchiosa, anzi è tra le città della moda che fanno tendenza in Europa. Qui sono nati gli Antwerp 6, un sestetto appunto
di stilisti audaci che da una ventina d’anni si sono imposti all’attenzione mondiale. Attenzione, audaci non significa
eccessivi, quanto piuttosto originali e capaci di attrarre: non c’è niente che non valga la pena di essere indossato in queste
collezioni, anche da noi italiani che le regole della moda le imponiamo. Una vera scoperta è poi Gand, la cui bellezza si
imprime negli occhi e resta nel ricordo per una delle opere pittoriche più affascinanti che esistano. Nella StBaafskathedraal c’è infatti la Adorazione dell’agnello mistico, una spettacolare pala d’altare in venti pannelli dipinta dai
fratelli Van Eyck, un’opera che mescola arte, ingegneria, studio della prospettiva, cura maniacale del dettaglio. Una di
quelle cose che, quando le vedi, non le dimentichi più. E infine, ultima tappa, Bruges. Un gioiello che rapisce di giorno e di
notte in modo diverso, ma altrettanto forte. Va vista, Bruges, percorrendo i suoi canali in battello, per coglierne il vero
spirito. C’è pure un luogo dell’anima, dove è bello perdersi: è il Begijnhof, il quartiere delle beghine che esiste dalla metà
del Duecento, dominato da un silenzio secolare che aiuta a ritrovare la pace perduta. A Bruges vive e lavora da una
quindicina d’anni anche un simpatico marchigiano. Originario della rocca di San Leo, vissuto tra il Montefeltro e la
chiassosa costa di Rimini, ha aperto in città un ristorante che merita di essere frequentato. Si chiama La Romagna a ricordo
delle origini, ed è la sede principale degli Inter Club del Belgio, in onore della fede calcistica. Un appunto, per concludere.
Nei negozi di giocattoli, ma anche dagli antiquari delle Fiandre, è facilissimo trovare teatrini in legno da montare, con tanto
di personaggi diversi da far vivere. Un esempio di civiltà, laddove il teatro è educazione fin dall’infanzia, sogno con cui
crescono i bambini.
APPUNTI DI VIAGGIO
CECCO D’ASCOLI
Un GranDe… ALTRO CHE STREGONE
di Giuseppe Matteucci*
*presidente dell’Associazione Culturale La Cerqua Sacra
Francesco Stabili di Simeone, meglio noto come Cecco d’Ascoli, nato ad Ancarano nel 1269 (la data non è precisa) e
morto a Firenze il 16 settembre 1327, è stato un poeta, medico, insegnante e astrologo/astronomo (al tempo le due
discipline erano unite), italiano. La sua nascita è avvolta nella leggenda. Alcuni autori sostengono che venne alla luce, su un
prato, durante una festa pagana orgiastica, probabilmente il Calendimaggio. All’età di 14 anni, cioè nel 1284, si recò a
Salerno a studiare medicina nella celebre università del Mezzogiorno poi si recò a Parigi per potenziare la sua cultura
sotto la disciplina di dottori famosi in filosofia e teologia. Verso il 1290, allorché di poco aveva varcato i 20 anni, tornò da
Parigi ed elesse Bologna a sede di studio e di lavoro scientifico. Entrò nel celebre ateneo, non in qualità di maestro, ma di
scolaro e, in poco tempo, si segnalò per ingegno e dottrina tanto da meritare, con suffragio degli studenti, l’onore della
cattedra di astrologia. Cecco, nel 1309 a Firenze, fu astrologo di corte di Carlo II d’Angiò. Durante il soggiorno nella
cittadina toscana strinse rapporti di amicizia con Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Guido Cavalcanti, Francesco da
Barberino ed altri (tutti membri, lui compreso, dell’associazione culturale I Fedeli d’Amore, quella che diede vita al dolce
stil nuovo). Insieme a Dante andò a Parigi nel 1311; successivamente con Guido Cavalcanti si recò in pellegrinaggio a San
Giacomo di Compostela in Spagna. Dal 1324 insegnò alla facoltà di medicina dell’Università di Bologna e qui subì,
dall’inquisitore domenicano Lamberto da Cingoli, la prima condanna per aver fatto dei commenti negativi sulla religione
cristiana, condanna che consistette in una grossa multa, la perdita del lavoro, il sequestro di tutti i suoi libri di astrologia ed
un certo numero di preghiere obbligatorie. L’ammirazione di studenti e colleghi era però tale che dietro loro pressione l’anno
dopo, nel 1325, Cecco riebbe la cattedra universitaria e venne addirittura promosso di livello. Durante il periodo bolognese
trascorse un breve soggiorno ad Avignone presso la corte papale come medico personale di Papa Giovanni XXII.
Nel 1326 Carlo, duca di Calabria, figlio primogenito del re Roberto d’Angiò, lo nominò medico di corte. I suoi studi di
astrologia ruotavano attorno ai commenti sul De principiis astrologiae del musulmano Alcabizio e il De sphaera mundi di
Giovanni Sacrobosco. Entrò in sospetto del duca dopo un oroscopo negativo fatto sulla di lui figlioletta, la futura Giovanna
regina di Napoli, la quale sarebbe stata, da grande, di lussuria disordinata. Per questa previsione, risultata poi vera, e per le
delazioni del medico fiorentino Dino del Garbo, collega nella corte del duca di Calabria ed invidioso della fama
dell’ascolano, Cecco fu sottoposto ad un duro processo: dovette subire inaudite torture e false accuse (tra l’altro fu definito
Maestro degli Ignoranti) e fu condannato al rogo dall’Inquisizione. Morì arso davanti la chiesa di Santa Croce a Firenze il
16 settembre 1327. L’inquisitore che lo condannò fu Frate Accursio. La forte e multiforme personalità di Cecco sembrò
resistere anche alle fiamme del rogo; qualcuno lo sentì urlare così: “L’ho detto, l’ho insegnato, lo confermo!”. Altri in
seguito riferirono di aver incontrato Cecco vivo dopo il 16 settembre 1327 e di averlo notato intento a curare un ragazzo che
era stato morso da una vipera, avvalorando così la leggenda relativa alla sua immortalità. L’immortalità fisica dello stesso è
incerta ma quella culturale è certa perché sarà sempre ricordato, tra l’altro, quale precursore della scienza moderna. Cecco
d’Ascoli segue la medesima sorte dei grandi intellettuali del suo tempo : Boezio, Ruggero Bacone, Pietro d’Abano ed altri
invisi al potere temporale della Chiesa.
BIBLIOGRAFIA DI CECCO D’ASCOLI
De principiis astrologiae: commento all’opera dell’astrologo arabo Alcabizio;
Tractatus in sphaerae: commento all’opera cosmografica Sphaera Mundi di Giovanni
Sacrobosco;
De eccentricis et epicyclis: opuscolo di scienza astronomica;
Prelectiones ordinarie astrologie habite Bonomie;
Acerba etas: più semplicemente noto col nome di Acerba, compendio enciclopedico,
manuale scientifico. È un trattato
vario nel quale si parla dei cieli e delle loro influenze, dell’anima, delle pietre, degli animali, di vari tipi di fenomeni
psicologici e naturali, della fortuna. Spesso polemico nei confronti di Dante Alighieri (famosa la frase “Qui non si canta a
modo de le rane”) ma solo per motivi attinenti la scienza non per la divina poesia del fiorentin poeta. L’Acerba, in
particolare, è un poema didattico di 4.865 versi in sestine.In esso Cecco dimostra di avere la mentalità del maestro al quale
piace insegnare con passione e con gusto impartire un insegnamento rigorosamente scientifico, rispettoso della verità della
scienza del suo tempo. Egli perciò, spinto da ragioni didattiche, da una parte cerca di vivacizzare la materia enciclopedica,
dall’altra si scaglia aspramente contro altre forme poetiche di evasione dalla realtà. Suo bersaglio preferito è pertanto la
Divina Commedia di Dante vista come la negazione della scienza vera, riepilogata da lui nell’Acerba,che perciò è stata
definita l’Anti Commedia. Infatti alla base delle convinzioni e delle conoscenze fisiche e naturali professate da Cecco non
c’è soltanto il pensiero filosofico scientifico di Aristotele o quello di Tommaso d’Aquino; c’è anche la conoscenza del
pensiero dei filosofi arabi. Sulla base delle loro teorie discute delle questioni scientifiche più dibattute nella società in cui
viveva. Per esempio: dell’ordine dei cieli, della terra ,delle eclissi, della natura, dei fenomeni atmosferici, delle Virtù, delle
scienze occulte, ecc. Il poema rimase incompiuto al V libro perché le sue opinioni scientifiche e teologiche, giudicate
eretiche, lo fecero condannare ad essere bruciato vivo sul rogo.
AFFASCINANTE IPOTESI SUL LUOGO DI NASCITA
Ad eccezione del Dizionario Enciclopedico Treccani che riporta “…. nato in quel di Ascoli, forse la città del Piceno ….”
tutti coloro che scrivono di Cecco d’Ascoli riferiscono che il famoso astronomo è nato ad Ancarano in provincia di Teramo
ma ciò contrasta con alcuni elementi certi relativi alla sua esistenza.
In particolare:
- J.W.Goethe, nella sua opera letteraria il Faust chiama Cecco d’Ascoli “il sabino, il negromante di Norcia”;
- Il documento autentico più antico di Cecco d’Ascoli (la famosa denuncia del Priore di San Leonardo in Golubrio), una
pergamena conservata nell’archivio comunale di Amandola, attesta che il famoso astronomo nel 1297 si trovava a
Montefortino;
- La presenza di Cecco sul Lago di Pilato è pluridocumentata. Vi si recava per osservare l’universo e disegnava in terra le
orbite dei pianeti (“la stupidità dei chierici”, come dice J.W.Goethe, ci vede i cerchi necessari a stipulare il patto con il
diavolo);
- Ad Ussita (MC), addirittura, Cecco non solo è presente ma è accusato di aver fatto sparire il bagno di Capo Vallazza (in
verità per procurare lo spazio necessario alla costruzione del Santuario di Macereto furono demoliti il Tempio della Dea
Cupra e l’annessa fonte miracolosa);
- Il dolce stil nuovo utilizzato da Cecco per comporre l’Acerba è molto simile al dialetto umbro-fermano e non ha niente a
che vedere con il dialetto abruzzese parlato ad Ancarano di Teramo.
Tutte queste circostanze, relative alla presenza di Cecco d’Ascoli sulle zone dei Monti Sibillini, pongono una domanda:
“….. e se fosse nato ad Ancarano di Norcia (vicino Preci), dove ancora oggi si celebra la festa pagana del Calendimaggio
(la celtica Beltaine*), dove i negromanti sono chiamati di Norcia e dove si parla il dialetto umbro-marchigiano, lo stesso
dell’Acerba?
Il dubbio rode ……. Chi vivrà vedrà.
Comunque indipendentemente da questa affascinante ipotesi Cecco d’Ascoli deve essere l’emblema del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini perché nessuno come lui li ha frequentati e valorizzati.
* il detto popolare sibillino “Dove vai a piantare Maggio?” (in dialetto “ Do’ vai a piandà Maggiu?”), con il significato
sessuale di “dove vai ad accoppiarti?”, proviene dalla festa celtica di Beltaine che era la celebrazione ove l’accoppiamento
era obbligatorio.
www.cerquasacra.8m.com
INCONTRI
MARIA RANDO
Ha due mani forti, Maria Rando, mani di scultrice. La sua casa/studio, nel borgo marinaro di Messina, si affaccia sul mare.
Quello stesso mare che pervade la sua opera, spalmato a piene mani sulle tele bianche, con tanto di onde e vortici blu. E se
da quelle superfici dense l’occhio si sposta sulle sculture bronzee o marmoree o di terracotta, la sensazione è la stessa,
materica, piena, generosa, ampia.
Arte Nomade
Numero 8
Dicembre 2007
Periodico quadrimestrale
aut. trib.Mc n. 521 del
25/06/2005
Spedizione in abbonamento postale
-70% - dcb - Macerata
Direttore
Pierfrancesco Giannangeli
Caporedattori
Luciano Monceri
Maurizio Serafini
Progetto Grafico e Impaginazione
Jerry Di Tullio
Matteo Maria Angelozzi
Produzione musicale
Arte Nomade edizioni
Iang Pipol TGR Marche RAI3
Collaboratori
Gianluca Frinchillucci
Wendy Farinelli
Alessandro Bolli
Luca Pakarov
Giuseppe Matteucci
Gianfranco Borgani
Luciana Vagge Saccorotti
Alex Zahnd
Editore
Arte Nomade srl
Via Giovanni XXIII, 31
62100 Macerata
Stampa
Tipografia BIEFFE - Recanati