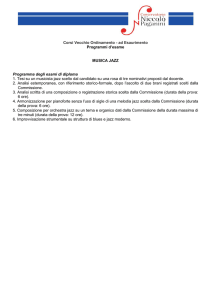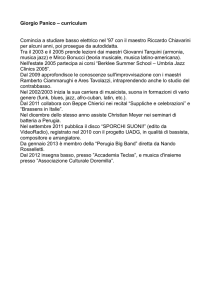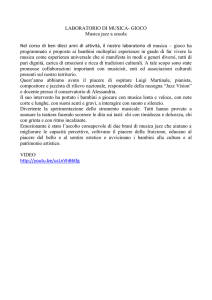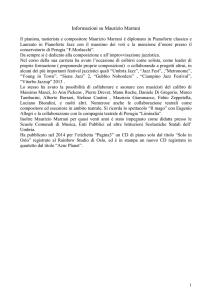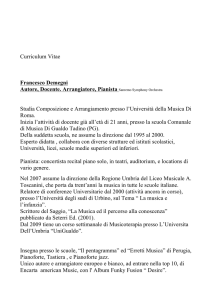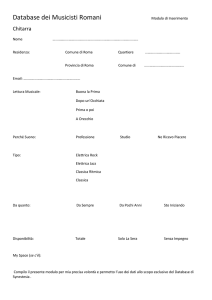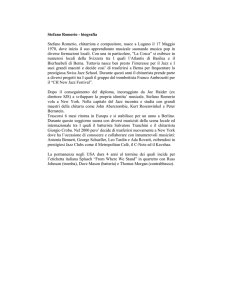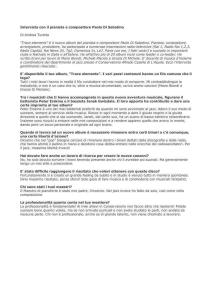Parliamo di musica
Introduzione
Fuggire dalle mura
Ho un amico che ascolta sempre musica indiana e trova molto noiosa Yesterday dei
Beatles. A lui pare proprio che non succeda nulla, nonostante tutti quegli accordi che vanno tanto
in giro per poi tornare a un riferimento di base. Son cose che piacciono all’Orecchio Occidentale,
dice lui.
La scala ascendente di Yesterday ci commuove perché le note che salgono ci comunicano
una tensione (e se scendono ci mettono tristezza). A lui tutto ciò non dice niente, per lui questa
tensione non va da nessuna parte. Ciò che a noi suona familiare a lui fa un effetto strano: le scale
dei Beatles sono orpelli di una popolazione “civilizzata” che non capisce, o meglio non capisce
più, essendosi abituato ai raga indiani.
La storia della musica come la studiamo noi (quando la studiamo, visto che nei nostri
licei è la grande assente) è quella della musica occidentale. Nessuno ci racconta di altri mondi, di
altre musiche. Oppure ci parlano del canto gregoriano, che utilizza i modi, come di un sistema
sorpassato quando in realtà esiste ancora, se non fosse che noi perlopiù non lo usiamo.
Questa visione della musica limita le nostre possibilità di ascolto.
La musica è un po’ come la democrazia: noi occidentali l’abbiamo raggiunta attraverso
diverse fasi, ma non è l’unico sistema di convivenza possibile. Ci sono posti dove la democrazia
non c’è perché non è il momento, non ci sono le condizioni, non se ne sente la necessità. E, in
ogni caso, oggi mi permetterei di dare per storicamente dimostrato il fatto che la democrazia
NON è l’unico dei mondi possibili.
La musica esiste in natura: ciò che non esiste è la “grammatica della musica”. Qual è il
confine tra musica e rumore? Chi lo decide?
In teoria, tutto è musica. Prendiamo gli uccelli: il canto di molti di loro ci sembra
musicale perché si avvicina al nostro sistema tonale, al nostro Orecchio Occidentale. Però anche
gli uccellini che pigolano suoni distanti dal nostro gusto stanno producendo musica, stanno
“cantando”.
Ci sono uccelli più musicali e altri meno?
Magari proprio quelli che si distanziano maggiormente dai nostri parametri di bellezza
stanno eseguendo un richiamo d’amore dolcissimo, o un lamento di dolore.
Noi abbiamo elaborato mille modi di inscenare un corteggiamento o celebrare un lutto.
Loro invece usano il mondo dei suoni in maniera netta per sottolineare un evento.
Recentemente si sono fatti degli esperimenti all’asilo con alcuni bambini facendo loro
ascoltare un pezzo di John Cage e Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, e i bambini hanno
scelto John Cage...
Ora, John Cage, compositore americano piuttosto controcorrente, propone una musica
piena di rumori, di cose buffe o strane (una volta fece suonare svariate radio
contemporaneamente) e ai bambini tutto questo è parso molto vario. Vivaldi invece
grammaticalmente è molto ordinato, pulito, piacevole, ma i bambini si annoiavano, un po’ come
il mio amico amante dell’India.
Il rischio è che, diventando grandi, finiamo per dare importanza solo ad alcuni aspetti
della musica: solo alla grammatica, alla logica e alla tonalità. Oppure unicamente all’ordine, e
ciò che non è ordinato ci sembra strano.
O ancora: mettiamo su un piedistallo il timbro, vale a dire che ci piace il suono di una
certa voce o di un certo strumento. Per non parlare del ritmo, in assenza del quale molti di noi
non sanno gustare nulla. Oppure dell’altezza: “Oh, quanto mi danno noia gli acuti”, “Uh, quanto
mi garbano i bassi”.
Invece la musica ha mille modi per farsi ascoltare.
Un pezzo fondamentale della musica classica, La Sagra della Primavera di Igor’
Stravinskij, è ricco di “effettacci” che di fatto sono fuori grammatica e dunque considerati poco
eleganti, soprattutto per l’epoca in cui fu eseguito per la prima volta, a Parigi nel 1913. (E
volarono dei fischi, suoni in quel caso facilmente decodificabili: dissenso puro, sdegno.)
Tuttavia, senza queste deviazioni di percorso la musica non sarebbe andata avanti. E il
jazz è sfacciatamente pieno di meravigliosi errori grammaticali.
Uscire dalla grammatica, sfidare le norme che di volta in volta la Storia o l’Accademia
hanno imposto alla musica è ciò che ha dato impulso a tutte le nuove correnti musicali, da
Stravinskij a Charlie Parker. La violazione, la bagatella, la fuga notturna dalle mura del collegio
è Tunica possibilità, perché è inutile fingere che quella grammatica non ci influenzi. Dovremmo
prendere un bambino e farlo crescere nel silenzio di una foresta e poi vedere che musica
produrrebbe.
Quando, negli anni Venti, l’erudito compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos eseguì le
sue musiche in patria di ritorno da Parigi dove era rimasto folgorato da Stravinskij e Claude
Debussy, fu insultato e accusato di importare spazzatura musicale. Oggi è considerato un genio,
il maggior compositore brasiliano.
Astor Piazzolla è stato accusato quasi di vilipendio, avendo tentato di pensare e scrivere
del tango non per i piedi e i corpi avvinghiati nella danza ma per la testa.
Oggi è il più famoso compositore argentino di tutti i tempi.
In altre parole: all’apparire della novità, si sono sempre avute reazioni molto forti. Forse
l’unico a scatenare l’ultima reazione forte è stato proprio John Cage, quando propose i suoi 4
minuti e 33 secondi di silenzio e disse che era musica. E che anche i suoni prodotti dal pubblico
in teatro durante queirinterminabile frazione di tempo erano musica. Parrebbe aver esagerato un
tantino... Però ha detto una verità: tutto può essere musica. Non esiste in natura un sistema per
distinguere il suono dal rumore. Niente regole sui rami degli alberi, ma l’uomo dagli alberi è
sceso anni fa e ne ha decise tante, di regolette e canoni, ed è da quelli che a volte serve fuggire
per trovare il centro del proprio mondo.
1
Imparare la musica
C’è un modo abbastanza facile per riconoscere un insegnante in gamba: è quello che
propone un programma su misura per tuo figlio. Non gli fa studiare le stesse cose di un altro
bambino, oppure, peggio, quello che ha studiato lui da piccolo...
Altrimenti, perché si tengono le lezioni individuali?
Gli insegnanti trascurano il fatto che si può imparare insieme all’allievo, ascoltando i suoi
desideri, le sue passioni del momento: se il ragazzo ha curiosità per un brano, perché non
approfondirlo? Molte volte si restringe il campo degli studi alle materie d’esame: sbagliatissimo.
Bisogna assecondare l’entusiasmo dell’allievo. Qualsiasi porta di entrata è valida per
iniziare un percorso nella musica. Entriamo, prima di tutto, poi vediamo che cosa succede.
«Nessuno nasce imparato», diceva la buona signora, e ognuno entra nel mondo in modo diverso.
Semmai si dovrebbe aiutare il bambino a riconoscere i propri pregiudizi, perché anche un
bambino di nove anni ne ha.
Io sono stato fortunato. Sono nato a Milano, ho trascorso l’infanzia ad Alba e a sei anni
andavo a lezione da un tizio che, nel retro di un negozio di strumenti musicali, dava lezioni
collettive. Quella mia prima esperienza è stata importante: nel retro della bottega ho cominciato
picchiando su un tamburo insieme agli altri bambini finché il tizio, dopo tre mesi, suggerì ai miei
genitori di portarmi da un vero maestro e fece il nome della signora Bartocci, diplomata in
pianoforte.
Lei mi fece lezione per sei anni, finché ci trasferimmo a Firenze e mi iscrissi al
Conservatorio. Ma si può anche andare avanti due anni a battere su un tamburo, mica si deve
diventare tutti musicisti.
La musica dovrebbe far parte del progresso cognitivo di ognuno di noi. Ti insegnano a
disegnare e non a cantare, ti insegnano a leggere e a capire le arti figurative ma non ad ascoltare
la musica, ti insegnano a godere del suono della poesia e non del suono di un clarinetto, ti
insegnano la storia della cultura del tuo e di altri paesi e non ti parlano mai dell’apporto dato dai
musicisti. Giuro che non capisco perché.
Non c’è governo che tenga, la musica e la sua storia non interessano a nessuno dei nostri
politici. Col risultato che ascoltiamo sempre meno. Ascoltiamo poco in generale: badiamo molto
al significato di quello che ci viene detto, ma pochissimo al timbro e al tono che viene usato. Più
andiamo avanti e più, con computer e telefonini, preferiamo scriverci credendo di evitare
malintesi... quando la solita mitica équipe di scienziati inglesi, che forse esiste solo nella fantasia
dei redattori di certi quotidiani, chissà, ci ha fatto sapere che il contenuto delle nostre frasi conta,
in caso di comunicazione diretta fra due persone, diciamo un 20 per cento: il resto è linguaggio
del corpo, odori, suoni, sguardi, accenti.
Ascoltare la musica significa riconoscere i suoni. Non è mica poco. Riconoscere il ritmo.
Il ritmo è la vita: il battito cardiaco, il polso regolare. Sapersi muovere a tempo con la musica
non è un’esperienza secondaria. Pensare che addirittura i sordi si fanno aiutare dalla musica,
spesso percependo le vibrazioni nella pancia.
Ora, da bambino, io prima ho visto la mamma, poi ho scoperto che si chiama “mamma” e
in seguito ho imparato a usare quel vocabolo tutte le volte che ne avevo bisogno. Perché ho
capito, consciamente o no, a quante cose può servire saper dire “mamma”.
La musica si insegna, in gran parte del mondo, partendo dal solfeggio.
In sintesi: prima io imparo come si scrive il Do, poi imparo a riconoscerlo quando lo
vedo scritto sul pentagramma, poi finalmente comincio a suonarlo e a goderne.
Ma se questo Do non me lo fai sentire, cosa me ne dovrebbe fregare di sapere com’è
scritto?
E perché lo devo riconoscere se tanto non ne conosco un utilizzo possibile?
Sarebbe come se per prima cosa imparassi l’alfabeto, poi la parola “mamma” scandita
bene bene, poi finalmente - da dietro un albero - uscisse la mamma vera e propria!
Un bambino nei primi anni della sua vita non scrive la propria lingua, la usa. E per scopi
ben precisi.
Perché non cominciare suonando, e magari non da soli ma con altri bambini? La musica è
condivisione, il suono nasce per comunicare.
Il problema del corso di musica è tutto qui: cioè che non ti fanno ascoltare, sentire la
musica. Ti negano il piacere della musica finché non hai imparato le sue regole. Che, e mi ripeto,
sono regole inventate e codificate in tempi recenti. Il sistema temperato, su cui si basa il nostro
Orecchio Occidentale, per fare un esempio, è stato creato sul clavicembalo tra il XVI e il XVII
secolo. In base a questo sistema il Do è un suono preciso, il Re è un suono preciso, e così il Mi, il
Fa e via dicendo.
È una convenzione, poiché in natura, tra il Do e il Re, ci sono mille altre possibilità, mille
sfumature che molti strumenti musicali, tra cui il pianoforte, non possono riprodurre.
Nel sistema temperato, una volta accordato, il pianoforte diventa la legge. Il violinista
chiede sempre il La al pianista, il quale per accordare il piano ha usato una convenzione fatta di
vibrazioni, e che si misurano con uno strumento d’acciaio chiamato diapason. Questo strumento,
se stimolato, produce una frequenza di hertz che dà origine a un suono. Ma non è sempre stato
uguale: nel 1885 a Vienna un congresso di specialisti decise che la frequenza doveva essere di
435 hertz. Poi è stata alzata a 440 e, nel corso del Novecento, è stata alzata ancora: oggi è di 442
hertz, ed è la nota che chiamiamo “La”.
Dunque, un tempo, il La era un’altra nota, più bassa: addirittura, nella musica antica è
usata una convenzione a 415, cioè più bassa ancora.
Fu il matematico Pitagora il primo a misurare le vibrazioni di una corda e a scoprire che
quella corda vibrando conteneva in sé altre note, i cosiddetti “suoni armonici”, e così capì che in
natura c’era più varietà.
Vale a dire che tutto poteva essere musica, tutto risuonava di note.
Successivamente si è deciso di darsi delle regole, diciamo così, non naturali, altrimenti
non se ne usciva più! Scoprendo, tramite la divisione della corda e per motivi matematici, che
per esempio il Do e il Sol funzionano bene insieme. In questo modo l’uomo ha “temperato”, cioè
ha mitigato, ha dato una misura alla natura e ha creato le note che noi usiamo sul piano, sulla
chitarra, con la voce.
Così nascono le note: sono semplicemente una decisione dell’uomo di dare una forma
alla natura.
2
Com’è fatta la grammatica della musica?
Le note si possono suonare una per volta o insieme, contemporaneamente: così nasce un
accordo. Gli accordi sono formati da un minimo di tre note: si chiamano “triadi”, in questo caso.
L’armonia è l’insieme degli accordi e la maniera in cui se ne vanno in giro. Ma,
soprattutto, l’armonia è il modo in cui gli accordi si concatenano tra loro: perché ogni accordo,
come ogni nota (e come le parole), ha senso in relazione a ciò che viene prima e a ciò che viene
dopo.
L’armonia è proprio il senso che gli accordi acquisiscono stando uno accanto all’altro, ed
è qualcosa che il nostro orecchio si è abituato da sempre ad apprezzare o a rifiutare, a riconoscere
o a considerare “strano” senza che si sappia bene il perché.
Ma un perché esiste.
Per esempio, mettendo insieme un accordo di Re minore, uno di Sol settima e uno di Do
maggiore diamo vita a una “progressione armonica” che al nostro orecchio piace molto, dal
momento che Joseph Kosma scrivendo Lesfeuilles mortes ci ha abituato a quel suono, e ben
prima di lui l’operetta e prima ancora i compositori romantici come Chopin.
È un tipo di progressione che noi definiamo “orecchiabile” e dove avvertiamo una
tensione: prima o poi la canzone tornerà al punto di partenza, e questo “ritorno a casa” ci fa
piacere, ci soddisfa, in qualche modo appaga le aspettative del nostro orecchio.
Il “ritorno a casa” è alla base della musica occidentale. È il cuore della cosiddetta
“tonalità”.
Prendiamo per esempio una forma musicale che chiunque ha sentito nominare: la
Sinfonia in Do maggiore.
Cosa vuol dire?
Non vuol dire che tutta la sinfonia suoni sempre nell’accordo o nella tonalità di Do
maggiore, ma che tornerà lì. Andrà in giro per un’ora ma alla fine tornerà al Do maggiore: tutti
gli accordi tenderanno a tornare a quel polo magnetico.
Gli accordi saranno definiti lontani o vicini proprio perché lontani o vicini da quel
“campo base”, che funziona come un centro: se non esistesse questo centro, non potremmo
percepire gli accordi lontani. È inevitabile. Quando l’accordo è bizzarro, è strano, lo è perché è
lontano dalla tonalità dominante: è lontano da casa.
Se un bambino che non ha mai ascoltato la musica mettesse le mani sul pianoforte a caso,
per lui quei suoni sarebbero tutti meravigliosi e non sarebbero in relazione a un suono più
piacevole. Stessa cosa se battesse su un tamburo: il tamburo gli piacerebbe quanto il Do
maggiore!
Il nostro orecchio di adulti occidentali invece insegue una consonanza, chiamiamola pure
“piacevolezza”. Insegue una concezione della musica prevalentemente tonale, qualsiasi tipo di
musica ascolti. Beethoven e i Beatles, armonicamente, stanno sulla stessa barca.
La melodia è la catena di note che viaggia sopra l’armonia e che vi si appoggia. A volte
nasce prima dell’armonia, a volte dopo.
Le canzoni non nascono necessariamente da una melodia: i jazzisti del cosiddetto periodo
“cool”, cioè i primi anni Cinquanta, prendevano gli accordi di una canzone famosa, tipo Just
Friends, per creare un altro brano. Qui bisogna fare attenzione a una cosa molto interessante, che
rende l’idea dell’importanza della melodia nel nostro sistema musicale.
Si possono prendere gli accordi (cioè l’armonia) di una canzone e usarli per farne una
nuova, ma non il contrario, cioè usare una melodia per crearne un’altra, poiché ci condurrebbe
dritti all’accusa di plagio.
Sembra incredibile, ma nessuno può essere accusato di plagio se usa gli stessi accordi di
Il cielo in una stanza di Gino Paoli o di I’ve got you under my skin di Cole Porter, mentre si è
accusati di plagio se si usano un certo numero di note uguali alla linea melodica, e ciò perché si
presuppone che l’orecchio segua la melodia.
La melodia comanda.
Io stesso l’ho fatto. Ho scritto un brano su accordi che già esistevano, ma in maniera un
po’ ardita. Ho ri-armonizzato Arrivederci di Umberto Bindi, cioè mi sono ispirato alla melodia di
Bindi per scrivere altri accordi, e su questi nuovi accordi ho creato una nuova melodia. Ero certo
che non se ne sarebbe accorto mai nessuno, e infatti così è stato: si tratta della Visione n. 3 del
disco I Visionari. Volendo, con una certa difficoltà, ci si può cantare sopra Arrivederci.
Nella storia del jazz è molto frequente. Charlie Parker era solito fare così: il suo celebre
pezzo Ornithology era basato sugli accordi di una celebre canzone di Irving Berlin, How high the
moon. Oppure Groovin’ high di Dizzy Gillespie, che era basata sugli accordi di Whispering, un
pezzo che Benny Goodman suonava negli anni Trenta, e che Gillespie trasformò
completamente... Questa prassi dei jazzisti di usare una cosa pre-esistente per farne una nuova - e
non lo facevano solo i jazzisti, già Johannes Brahms prendeva un tema di Händel e ci costruiva
su una serie di variazioni - ci svela qualcosa. E cioè che quella canzone di Berlin ha gli accordi
talmente concatenati bene, riconoscibili, gradevoli, che diventa una specie di canone universale.
Molti jazzisti moderni hanno creato soprattutto nuove melodie, componendole a tavolino o
improvvisando.
D’altra parte, riagganciarsi a una tradizione è la prassi del jazz. I jazzisti non si fanno
alcun problema a dichiarare le loro fonti di ispirazione. E possono essere le più varie: un giro
armonico, come già detto, oppure il repertorio, come Keith Jarrett che suona le canzoni celebri
dei musical degli anni Trenta e Quaranta (i cosiddetti “standard”), o Django Bates che invece li
stravolge; chi invece si rifà al blues, chi al free jazz o chi addirittura riparte dal dixieland, cioè il
jazz degli anni Venti. Nel jazz è raro che ci si presenti dal nulla, contrariamente a quanto avviene
nel pop e nella musica contemporanea, dove è frequente sentir dire: «Ho inventato un nuovo
linguaggio!». (Bah.)
Dopo armonia e melodia, al romanzo della musica manca il terzo grande personaggio: il
ritmo.
Il ritmo è un elemento centrale, fondamentale, perché non lo è solo della musica ma
anche della vita. Come quel bambino di cui parlavo prima che senza sapere nulla di musica
scopre che battere sui tasti del piano gli piace, nello stesso modo io dopo due colpi su un
tamburo ho capito che sono entrato in una struttura ritmica: mi bastano per intuire che potrebbe
essercene un terzo...
Come le note, che da sole, isolatamente, non hanno senso, anche il suono di un battito di
mani, un suono ritmico, se preso da solo vuol dire poco... Però se io lo ripeto comincia a formare
un discorso.
Il ritmo è anch’esso un ingrediente che può aiutarci a capire la musica che stiamo
ascoltando, a volte ancora prima degli altri due.
Il nostro Orecchio Occidentale è abituato a certi ritmi e non ad altri, e così alcuni ritmi
siamo in grado di riconoscerli subito, per esempio il tango, al contrario di altri che non seguono
la stessa logica e che sentiamo troppo “lontani da casa”.
Come nel linguaggio che usiamo per parlare, anche nella musica è ciò che è avvenuto
prima e quello che accadrà dopo a dare il carattere: da solo, un Fa, non ha molto senso. Che
senso ha? Ecco, ti suono un Fa, da solo, così, come se improvvisamente dicessi ARMADIO: che
senso ha?
Se invece aggiungessi, CHE STO PER COMPRARE DOMANI... allora la frase
comincerebbe ad avere un senso. Se a quel Fa aggiungessi altre due note sentirei affiorare una
melodia o un accordo: persino una melodia semplicissima può avere già molto senso.
Quando le note si concatenano possono trasmetterci una sensazione, un colore, un
mondo.
Per Mozart il Re minore era la tonalità di impianto della tragedia: nel Don Giovanni il
momento culmine è in Re minore. Ma è un’idea del compositore, il quale ne è talmente convinto
da trasmetterla ai suoi collaboratori e poi anche al pubblico.
È vero che esistono dei passaggi musicali che possono suggerire un certo tipo di
sentimento. Nel Seicento, Claudio Monteverdi usa un intervallo di semitono discendente per
ottenere come risultato una melodia malinconica. “Ohimè” nei suoi madrigali veniva cantato
solitamente su una nota che scende di un semitono (dal Re al Re bemolle, per esempio).
Nella stessa epoca il compositore inglese Henry Purcell, nell’opera Didone e Enea scrive
una parte di basso, meravigliosa, che è una scala cromatica discendente (Sol-Sol
bemolle-Fa-Mi-Mi bemolle-Re) ed è un lamento, è il culmine del dramma. È il momento in cui
Didone, abbandonata, canta quel che ricorderanno di lei dopo la sua morte (When I am laid in
earth).
Però, attenzione, stiamo sempre parlando della nostra maniera di percepire la musica, si
tratta sempre del nostro Orecchio Occidentale: ci sono musiche che noi definiamo “etniche” le
quali non sono costruite con questa logica dello “scappare e tornare” a un riferimento, non c’è
una “casa” da cui essere “lontani”. Invece si sta fermi su poche note per venti minuti e magari
l’accordo è sempre lo stesso.
Un altro elemento che possiamo aggiungere alla lista di elementi costitutivi della musica
sono quelle che chiamiamo “dinamiche”.
La dinamica nella musica è importantissima e ultimamente passa un po’ inosservata. E
invece è uno di quegli aspetti che per primi, senza che noi lo si sappia, ci avvicina o ci allontana
dalla musica.
Nella musica classica abbiamo dei brani, soprattutto all’inizio, dove gli strumenti
suonano in un modo che in gergo si chiama “pianissimo” e quasi non li si sente, e poi
improvvisamente il “pianissimo” diventa “fortissimo”, una specie di colpo di cannone! Dovrebbe
quasi essere vietato ascoltarla mentre si guida, si va fuori strada di sicuro.
Quei cambi repentini di forza, di volume, di suono, sono le dinamiche; e nella musica
classica le dinamiche pretendono un ascolto impegnato. Wagner non può essere un sottofondo.
Qualcuno ha mai sentito Wagner al ristorante? (Per carità, può essere successo, ma dubito che
aiuti la digestione, sul serio.)
Il pezzo pop, invece, è lavorato e mixato appositamente in modo che questo tipo di
contrasto non ci sia. L’assenza di dinamiche forti è la base del pop. La dinamica non deve mai
oltrepassare un certo limite e deve essere costante per tutta la durata della musica, che sia un
pezzo di Vasco Rossi o di Madonna. Chiamiamola “la musica della radio”: rispetta regole
rigidissime, dal punto di vista della dinamica.
Il teatro e il concerto giocano a svegliarci: quando il pubblico esce dall’effetto
anestetizzante della musica in radio e della TV si trova a dover partecipare, a svolgere un ruolo
attivo: è per questo motivo che, spesso, le persone percepiscono la musica classica e il jazz come
attività impegnative, come qualcosa di pesante: perché devono partecipare, ecco perché.
Perché la musica acquista senso se crea vita dentro di noi, se ci fa reagire.
La musica new age, il pop della radio, come la telenovela e la fiction giocano a non
impegnarti. La TV e internet ci hanno talmente assuefatto all’utilizzo della vista che pensiamo di
non percepire nulla se non vediamo. Oggi san Tommaso non chiederebbe a Gesù di poter mettere
il dito nelle sue piaghe. Si accontenterebbe di vederle.
Come dice il pianista Daniel Barenboim in un suo libro, quando attraversiamo la strada la
prima cosa che facciamo è guardare, non ci viene in mente di porgere l’orecchio e percepire il
suono del motorino.
L’idea che per capire la musica si debba per forza possedere un certo bagaglio culturale è
una furbata, spesso è una scusa per pigri, o una medaglia acquisita sul campo per chi crede di
essere fra quelli che la “capiscono”.
Avere gli strumenti per godere della musica non significa conoscere né l’armonia né
l’epoca in cui è stata scritta né il retroterra culturale del compositore, ma riconoscere qualcosa
che abbiamo dentro e che risuona.
3
Effetti, trucchi, convenzioni
L’opera era la musica pop del Settecento e dell’Ottocento, quando ebbe il suo trionfo: è
un linguaggio armonico complesso ma estremamente d’effetto.
Una persona totalmente digiuna di musica si commuove sentendo un’aria di Puccini: non
capisce esattamente ciò che sta ascoltando. Capita spesso a tutti noi: non sappiamo nel senso più
tecnico del termine cosa stiamo ascoltando, ma ci si muove qualcosa dentro, la musica ci
colpisce come una freccia.
Nell’opera lirica, le “arie” sono il cuore della faccenda: un tempo si poteva chiedere il bis
dell’aria anche prima che la rappresentazione finisse, subito dopo la sua esecuzione.
Anche se mancavano venti minuti alla fine della Turandot, il tenore poteva rifare Nessun
dorma anche cinque volte, a suon di applausi. Si bloccava l’azione, come con un DVD. Se non si
fa più è solo perché viene considerato volgare dal direttore d’orchestra.
Alla gente, più che l’opera intera, spesso interessano soprattutto le arie.
Il grandissimo Giacomo Puccini a fine Ottocento era a un passo da Broadway e dal
cinema. Puccini era uno che in ogni singola opera infilava tre successi che la mattina dopo la
gente fischiettava in bagno. Si usciva dalla Tosca con le lacrime agli occhi dopo aver visto la
protagonista buttarsi da Castel Sant’Angelo, ma il mattino dopo o la sera stessa si canticchiava
«E non ho amato mai tanto la vita!» (ohibò!), una bella canzone, che può vivere anche da sola.
Le arie di tutte le opere del mondo parlano di temi universali, raramente nominano
l’eroina o fanno riferimenti troppo precisi alla vicenda. Devono vivere di luce propria.
Oh! dolci baci, o languide carezze,
mentr’io fremente
le belle forme disciogliea dai veli!
Svanì per sempre il sogno mio d’amore... l’ora è fuggita... e muoio disperato!
E non ho amato mai tanto la vita!...
Che il protagonista si chiami Cavaradossi, e che stia per essere ucciso da un plotone di
esecuzione, non viene detto, in modo che l’aria sia isolabile. Grandissima astuzia dei librettisti.
Ripresa paro paro nei musical di Broadway.
Puccini era un caposcuola, da artigiano aveva ascoltato tantissima musica, dall’operetta
alle preziosità di Debussy. Poi andava al sodo. Come nella vita.
Era uno di Torre del Lago che andava a caccia, non nel caffè o nel salotto letterario con
Mallarmé come invece faceva Debussy. I suoi librettisti erano Giacosa e Illica, mica Gozzano o
Corazzini. I grandi letterati italiani l’opera la snobbavano. Di là dalle Alpi i binomi erano Claude
Debussy/Maeterlinck, Beethoven/ Schiller, Stravinskij/Cocteau. Tutt’altra cosa.
Qui da noi c’era la provincia, in Puccini l’osteria. Grande fantasia melodica e armonica,
in Puccini, come in George Gershwin, capace di scrivere capolavori sotto forma di canzoni della
durata di tre minuti.
L’aria è un fermo-immagine. Sul plotone di esecuzione si ferma tutto e il tenore canta
qualcosa di universale, che non c’entra con il plotone di esecuzione. E ti fa piangere, con due
ciccioni. Mica facile. Oggi è facile coinvolgere con Brad Pitt e Angelina Jolie a letto insieme. Lì
avevi la soprano grassa e il tenore brutto. Lui la ama! Ma come... la ama? È un mostro!
Ma l’opera non è qualcosa di naturale: si canta per quattro ore una vicenda di amore,
morte, tragedia...
(Del Parsifal qualcuno diceva, giuro non ricordo chi fosse ma si trattava di un genio di
sicuro: «È quell’opera che inizia alle sette, poi dopo tre ore guardi l’orologio e sono le sette e un
quarto».)
Se tu vedi per strada uno che entra dal farmacista cantando il suo dolore per venti minuti,
lo fai internare.
L’opera è un grandissimo artificio, che attiene a un patto e a un’epoca, a una cultura, e,
finite quelle, diventa difficile spiegare a mio figlio perché uno che sta morendo debba cantare per
venti minuti! Non abbiamo più quei codici, quei tempi, quelle modalità.
Il tutto è molto italiano. Si sa che in Italia, se piangi, sei perdonato.
Dimostra un po’ di sensibilità e ti vorremo bene, ti perdoneremo.
Flaiano sintetizzava così il pubblico italiano a teatro: «Oh, come mi sono divertita, ho
pianto tutto il tempo!».
Il brigatista Mario Moretti, quando Sergio Zavoli gli chiese di spiegare gli anni del
terrorismo, rispose: «È difficile, in un paese come il nostro, abituato al melodramma, spiegare la
tragedia!». Ed è vero.
La vera tragedia non sono quei funerali del Sud con le grida, le urla, le professioniste del
pianto attaccate al feretro. La vera tragedia presuppone due palle così. Che nel melodramma non
sono necessarie. Per questo, specie in Italia, facciamo fatica a “liberarci” dell’opera.
Il cinema ha fatto tesoro di questi meccanismi. Le colonne sonore devono comunicare
emozioni chiare, possono anche essere complesse talvolta, e appoggiarsi su schemi musicali più
arditi. Ma per anni hanno rimandato quasi inevitabilmente a Puccini, lavorando su archetipi
culturali.
C’è chi gioca con una certa ambiguità e chi invece lavora in maniera più chiara e diretta.
Nel primo caso, l’esempio più lampante e famoso è la musica di Profondo rosso, dei
Goblin. È una melodia molto semplice dove è la terza minore, il Do, a conferire la tonalità
minore. Ma prima di fartelo capire - cioè di dirlo al tuo orecchio - impiega due battute. Finché
non risuona quel Do, il brano potrebbe anche essere in maggiore. È una trovata che si rifà ai
“modi” gregoriani (scale diverse da quelle diatoniche e cromatiche a cui siamo generalmente
abituati) e alla musica di chiesa in generale: gli organi, i clavicembali.
La musica di chiesa è sovente richiamata nelle colonne sonore dei film del terrore poiché
gli argomenti sottesi sono quelli da sempre appannaggio della Chiesa: peccato, paura, omicidio,
colpa, senso di colpa, espiazione, punizione... L’effetto del terrore è basato su un procedimento
ambiguo e su un contrasto. In Profondo rosso abbiamo anche la filastrocca infantile che
annuncia gli omicidi, un altro colpo a effetto: la filastrocca è in tono maggiore, ma rimanda a
eventi terrificanti. Accade anche qualche anno prima, nel 1969, in Rosemary’s baby, la cui
colonna sonora fu scritta dal jazzista polacco Krzysztof Komeda: la filastrocca cantata da una
voce infantile, che dovrebbe essere gioiosa ma sotto nasconde accordi minori. Le filastrocche
infantili sono notoriamente in maggiore, come i canti popolari, tipo L’uva fogarina: ma se tu me
la intorbidisci con accordi minori, diventa qualcosa davvero di poco rassicurante...
L’altra strada è invece quella della chiarezza estrema, al limite della ridondanza: vedi alla
voce Star wars. La marcia di Darth Vader, il cattivo per eccellenza, è come l’entrata del
commendatore nel Don Giovanni di Mozart, su accordo minore. Ci comunica dramma, violenza,
minaccia.
John Williams, l’autore, fa risuonare tre volte l’accordo minore, risvegliando in noi
ascoltatori il ricordo della Marcia funebre di Chopin (in cui l’accordo risuonava, per la
precisione, quattro volte). E usa gli ottoni dell’orchestra per evocare atmosfere wagneriane,
dunque epiche.
Ne L’anello del Nibelungo, come in Guerre stellari, si narra una vicenda epica di
generazioni e di popoli che si scontrano. Ecco che John Williams, furbacchione, usa un colpo a
effetto per stuzzicare il nostro inconscio. Ci rimanda continuamente a Richard Wagner, che lo si
percepisca oppure no.
Stesso compositore, altra atmosfera: prendiamo il famosissimo tema di Indiana Jones:
pa-pa-pa-paaaaaa-pa-pa-paaaa! Quel paaaaa, dopo tre note, è un movimento ascensionale, un
intervallo melodico che richiama l’avventura, il tentativo dell’uomo di diventare Dio, di vincere
sulla natura. John Williams è un compositore di colonne sonore profondamente conscio dei
meccanismi cinematografici, dunque il male è il Sol minore e il bene è il Do maggiore.
I compositori conoscono e usano questi trucchi.
L’accordo maggiore più efficace di tutti ce l’ha regalato un compositore russo che io amo
particolarmente, cioè Sergej Prokof’ev, in Pierino e il lupo: è un Do maggiore che in breve passa
al La bemolle e vira verso un’atmosfera di inquietudine. Prokof’ev manipola il linguaggio
musicale a fini psicologici e il pubblico ne resta sconcertato. È come se lui ti dicesse: stai bene
attento! Pierino abita in una bella casa, con un prato fiorito, ma siamo fra due guerre mondiali e
là fuori c’è il lupo e neppure il Do maggiore si salverà (né tantomeno CI salverà).
4
Cos’è il jazz?
Il jazz è una musica povera. È una musica che nasce in America dai neri portati come
schiavi e dai vari immigrati (molti dei quali italiani). È la musica di gente che scopre un nuovo
mondo e ha fame.
Forse per questo motivo il jazz è una musica cannibale che da subito, proprio come un
cane che sbarca dalla stiva di una nave, si guarda attorno, comincia ad annusare l’aria e prende a
ingerire un po’ tutto quello che trova sul suo cammino. E nello stesso tempo, però, seleziona.
Seleziona quello che gli piace del passato, alcune tradizioni, sia “classiche” sia popolari.
Prendiamo i tanti ebrei del jazz americano delle origini, lo stesso George Gershwin. Questa gente
si portava dietro la tradizione della musica klezmer, che si avvertirà anni dopo anche nel
clarinetto del grande Benny Goodman.
Il klezmer è l’espressione degli ebrei dell’Europa dell’Est e, in quanto musica
tradizionale, a un certo punto ripete i suoi codici, poiché i funerali hanno certe regole, i
matrimoni altre, non si può uscire da quegli schemi.
Il jazz lo cannibalizza ed evolve, pur conservando, all’inizio, quell’impronta rituale.
Quando Louis Armstrong nacque a New Orleans all’inizio del Novecento, le
marching-band suonavano per accompagnare i funerali: verso il cimitero intonavano melodie
tristi, ma quando tornavano indietro la musica diventava allegra.
Prima di entrare nelle case borghesi e nelle sale da ballo, il jazz viveva per strada e
accompagnava la vita dei quartieri popolari. “Kid Ory e Joe Oliver si erano uniti per formare una
delle più formidabili jazz band che si siano viste a New Orleans” scrive Louis Armstrong nelle
sue memorie. “Spesso caricavano gli strumenti su un carro a sponde mobili e suonavano a scopo
pubblicitario per annunciare un ballo o qualche altro spettacolo. Quando giravano un angolo e
s’imbattevano in altre orchestre ambulanti, Oliver e Kid Ory ci davano dentro a più non posso.
Suonavano al meglio delle loro capacità e mandavano il pubblico in visibilio. Quando poi l’altra
orchestra si rendeva conto che non c’era gara e svoltava l’angolo, Kid Ory suonava col suo
trombone un motivetto che faceva impazzire il pubblico [...]. Era una canzoncina piuttosto
piccante, scritta apposta per celebrare la sconfitta dell’avversario...”
In questa descrizione mi sembra ci sia gran parte dello spirito del jazz e non solo, anche
della sua natura musicale: una musica di strada che raggiunge subito un grado di raffinatezza
elevatissimo e uno spirito di gara che, in qualche modo, si è mantenuto vivo fino ad oggi. Il jazz
è anche una musica di ego, una battaglia di ego dove il pubblico, a volte, decreta il vincitore.
L’assolo improvvisato del jazzista porta sempre con sé il rischio di apparire una forma di
“onanismo in pubblico”. Il tutto viene salvato da uno spirito comunitario, di gruppo che
condivide un rito, un rito di provenienza africana.
Certo, dalla strada questa musica è migrata nei bordelli, poi nelle sale da ballo, poi negli
studi di incisione, nei club, nei teatri e poi è tornata anche nelle piazze. La sua storia è quella del
Novecento ed è rapidissima, in continuo mutamento. Non per niente uno dei più grandi storici
del secolo scorso, Eric Hobsbawm, l’autore di Il secolo breve, era anche uno storico del jazz
(sotto il falso nome di Francis Newton).
Per un buon ventennio, fino agli anni Quaranta, il jazz fu musica da ballo. Duke Ellington
e la sua big band accompagnavano gli spettacoli al Cotton Club. (E trent’anni dopo invece
saranno in giro per il mondo a esibirsi per le regine o alla Scala di Milano... Che percorso!)
Dagli anni Cinquanta il Rhythm and Blues lo soppianta e così il jazz si “rifugia” nei
teatri. Negli anni Settanta si tinge di significati politici, diventa free jazz, contestazione e
movimento black power e in molte occasioni si suona con il pugno alzato, ma non dura. A
Woodstock arrivano Sly and the Family Stone, Jimi Hendrix e tutti gli altri, facendo una musica
più immediata, ricca anche di testi, di slogan, e più semplice da adottare come inno
generazionale.
Anche in Italia c’era il free jazz di contestazione, ma poi arrivavano gruppi come gli Area
e Francesco Guccini, che dal punto di vista politico erano molto più incisivi. Forse, per questo
motivo, da quel momento il jazz diventa una casta con delle regole sempre più esclusive, si
chiude un po’ in se stesso, o almeno questa è la percezione che si ha da fuori...
Il gruppo jazz sta un po’ in cerchio, come gli africani. Il cantante guarda avanti e canta
per il pubblico, i musicisti sembrano suonare per loro stessi. Come se non bastasse, a volte pure
il cantante se ne sta accartocciato su se stesso, come Chet Baker, avviluppato nella propria storia,
come a proteggersi dal mondo.
Il jazz è la musica più meticcia e ibrida che esista. Il purismo non ha niente a che vedere
col jazz, che è nato da un formidabile incontro di culture, senza guerre o battaglie se non quelle
ingaggiate dai musicisti contro loro stessi.
È un linguaggio musicale che permette di suonare tutte le sere anche lo stesso repertorio
ma cercando qualcosa di diverso, la sorpresa del momento, la trovata estemporanea che non
sarebbe mai uscita se pensata a tavolino.
Il fuocherello acceso da QUELLE persone in QUEL momento su QUEL palco davanti a
QUEL pubblico.
Che scalda come non mai e che il giorno dopo non c’è più e va riacceso da capo. E non è
mai IL fuoco perfetto ma sempre un fuoco di cui hai bisogno in quel frangente, espressione pura
che vola via dopo averti attraversato, come un vento che scuote le frasche.
5
Improvvisazione
Si può usare la struttura armonica di una canzone (nel jazz sono chiamati “standard” e
quelli storici vengono dal repertorio di Broadway о da Hollywood) per inventare nuove melodie,
nuove soluzioni armoniche, nuove frasi.
Questa è una delle possibilità dell’improvvisazione.
Agli albori del jazz i musicisti preferivano pensare a tutto ciò come a una serie di
variazioni sul tema, come nella musica del passato.
Senza rete si improvvisa eccome. È come costruire un ponte e nel frattempo salirci sopra
per arrivare dall’altro lato. Il ponte non è già lì, come quando si suona sugli accordi di Night and
day di Cole Porter.
E non è detto che si sappia cosa ci aspetta al di là. Val la pena mettersi in viaggio, anche
senza sapere dove andare.
Altre volte il ponte serve davvero per unire due punti precisi. Durante il bis dei concerti
in piano solo chiedo al pubblico quali brani avrebbe voluto ascoltare, me ne segno una decina e
poi invento un percorso per farli stare insieme. Possono intersecarsi, apparire all’improvviso o
essere annunciati. Possono sparire e riapparire. È quello che faccio anche durante l’intero
concerto, senza i puntini da unire, ma cercando di assecondare il suono che sta uscendo fuori. A
volte si tratta di spingere, di cercare. Altre volte davvero si tratta di abbandonarsi e lasciar fluire
la musica.
Erroll Garner suonava il piano da autodidatta e poteva attaccare un brano in qualsiasi
tonalità. Aveva anche l’orecchio assoluto, vale a dire la capacità di riconoscere senza margine
d’errore una nota, anche se a emetterla è un canarino o un aspirapolvere.
Faceva impazzire quelli che suonavano con lui, cominciando dai bassisti, che si
aspettavano Misty in Mi bemolle. E Garner una sera lo faceva in Re, un’altra in Fa. Era una
capacità, naturale in lui, che va sviluppata con l’esercizio in tutti noialtri che invece abbiamo
solo un orecchio relativo. (Ma la solita équipe di scienziati inglesi dice che ce l’abbiamo tutti
l’orecchio assoluto, dalla nascita, e poi la maggior parte di noi lo perde.)
È utile non solo per accompagnare i cantanti che vogliono suonare il tal brano in una
tonalità distante da quella originale, ma anche per accorgersi che lo stesso brano suonato in una
tonalità più alta o più bassa rivela tutt’altro carattere.
Ah, che eleganza, i pianisti di una volta!
Erroll Garner, Teddy Wilson, Nat King Cole - che prima di diventare un cantante
famosissimo era uno straordinario pianista - e ancora Art Tatum, Willie “The Lion” Smith, Oscar
Peterson, Red Garland, Wynton Kelly, Hampton Hawes, Roger Kellaway, Ray Bryant, Phineas
Newborn, Jaki Byard... Nei dischi risultavano morbidi, con un suono mai invasivo, raramente si
udivano gli estremi della tastiera. Successivamente, dagli anni Sessanta il modo di buttare giù gli
accordi cambia, sono accordi sgranati, come una manciata di biglie sul pavimento, addirittura
sporchi. Accordi che non sono più un oggetto cristallino, ma hanno qualcosa all’interno che crea
tensione, che “sporca”, spinge il suono oltre la piacevolezza.
Tempo fa mia figlia e io stavamo riascoltando l’accompagnamento che avevo registrato
per una canzoncina e a un certo punto lei mi fa: «Bella quella cosa, peccato che fai un errore!».
Le ho chiesto: «Che errore?». E lei ha risposto: «Due note troppo vicine».
Era un accordo con un semitono all’interno, che al suo orecchio risultava strano. E invece
è il suono di Bill Evans.
L’errore... Nel jazz l’errore può essere una porta che si apre.
A volte non sai bene cosa stai per dire e imbocchi una direzione. Altre volte invece
capisci proprio che hai sbagliato: sai benissimo cosa avresti voluto fare e non l’hai fatto! In
entrambi i casi devi essere pronto a cambiare strada. Il pubblico non sa dove avevi intenzione di
andare. Devi prenderlo per mano e convincerlo.
Certi personaggi del jazz all’inizio sono stati guardati con sospetto anche nella stessa
comunità jazzistica, perché la loro maniera di improvvisare rasentava l’errore. Ci si è spesso
domandati se uno sapesse davvero suonare e, più in generale, se per improvvisare fosse
necessario avere studiato “le regole della musica”.
Thelonious Monk, uno dei pianisti più celebri della storia del jazz, l’autore di un brano
leggendario che qualsiasi jazzista ha suonato e risuonato come Round midnight, era uno intorno
al quale ha sempre aleggiato il mistero. Suonava in modo stranissimo, in un modo totalmente
freak. La domanda era lecita: suona così perché “non sa suonare” o lo fa “apposta”?
Esiste un famoso aneddoto al riguardo. L’altro grande pianista dell’epoca del be-bop, alla
fine degli anni Quaranta, Bud Powell, raccontava di aver beccato Monk che, pensando di non
essere visto, eseguiva sul piano delle frasi che sembravano uscire dalle mani di Art Tatum.
Va detto che Tatum era il dio del pianoforte jazz, quello tecnicamente più dotato di tutti.
Arturo Benedetti Michelangeli e Vladimir Horowitz, due fra i più grandi virtuosi del piano
classico del Novecento, andavano ad assistere ai suoi concerti e ne rimanevano impressionati.
Aveva una tecnica spaventosa e suonava una musica jazz legata in maniera sotterranea alla storia
del pianoforte: nel suo jazz sentivi il ragtime, il quale a sua volta rimandava al pianoforte da
salotto ottocentesco, Chopin e Liszt, il pianoforte virtuoso. Art Tatum metteva d’accordo tutti e
paradossalmente oggi, proprio per la sua bravura evidente, rischia di passare inosservato in certi
suoi dettagli: perché su trentadue battute di virtuosismi impervi, c’è “nascosta” una piccola
battuta con una modulazione armonica molto moderna, assolutamente lontana dal jazz anni
Quaranta. Quanto fosse sorprendente in quegli attimi lo si può vedere solo trascrivendo le sue
improvvisazioni: anch’io da bambino l’ho fatto, usando un apparecchio Akai che rallentava la
velocità della registrazione senza modificare l’altezza delle note. In quel modo coglievo tutti i
particolari.
Dunque, tornando a noi: Monk sapeva in realtà suonare come Art Tatum?
Non si sa; secondo me, no.
Io non credo all’aneddoto, perché in tutti i dischi che ha inciso Monk non c’è mai traccia
di una cosa del genere.
Se invece fosse vero vorrebbe dire: vedete, anche un freak come Monk ha studiato!
Ma non è importante che lui sapesse suonare anche “bene”, non stiamo parlando di un
insegnante ma di un artista.
La cosa straordinaria è questa: che nel jazz, oltre ai capiscuola, ci sono questi personaggi
che spuntano improvvisamente e suonano come accidenti vogliono loro: tu sai che il disco è del
1959, ma potrebbe anche essere un altro periodo, non cambia nulla, Monk è un pianeta solitario,
caduto da chissà dove nel nostro universo.
L’aneddoto si conclude con Monk che, scoperto da Bud, gli fa: «Non lo dire a nessuno».
Anche se fosse falso, l’apologo ci racconta qualcosa: ogni jazzista vuole comunque avere
una propria voce, suonare “his own thing” anche a costo di risultare bizzarro.
A proposito di freak, mi viene in mente un’altra situazione che rende l’idea di come la
musica possa sorgere e poi sgorgare nel modo più casuale.
Ero a New York e stavo incidendo un disco insieme a Enrico Rava e al batterista Paul
Motian, una figura mitica del jazz che ha fatto parte del trio di Bill Evans negli anni Cinquanta;
anche lui era un musicista che faceva una cosa totalmente sua, inimitabile, per nulla
convenzionale. Motian pareva che suonasse melodie su uno strumento che invece, come
sappiamo, non produce note precise: per lui, tenere il tempo non era la cosa più importante. La
priorità, per lui, era dialogare alla pari con gli altri strumenti.
Era talmente stravagante, Motian, che quando oggidì senti un batterista che suona male,
prova a parlarci: ti dirà che si ispira a Paul Motian! Bella scusa. Lui sì che sapeva il fatto suo.
Insomma, in sala di incisione Paul Motian porta un pezzo suo, Gang of 5, e ci dice:
«Cominciate voi, io entro dopo, a un certo punto...».
Ogni volta che completavamo il giro della canzone, Enrico e io facevamo una piccola
pausa pensando che lui sarebbe entrato, invece non lo faceva. Mai.
Alla fine, nelle cuffie, sentiamo che dice: «Yeah, man, I love it!». Paul aveva fatto in
modo di ottenere una specie di suspense, di senso di attesa, e tuttora non so se lo fece apposta o
se davvero - come ci disse - gli piaceva quello che stava accadendo e non sentiva la necessità
della propria batteria nel brano.
Un’altra cosa bizzarra mi è accaduta con il compositore francese Hector Zazou, il quale
mi aveva invitato a incidere nel suo disco Strong currents: aveva già registrato la voce e gli altri
strumenti, mancava solo il mio pianoforte. Dunque, solo soletto, con Hector in studio, ho
realizzato la sovraincisione.
Quando esce il disco, scopro che Zazou ha tolto quasi tutti gli altri strumenti. Io avevo
suonato in maniera parca come non mai, pochissime note. Improvvisamente, invece, il pianoforte
è quasi nudo, a intersecarsi con la voce di Caroline Lavelle. Se l’avessi saputo, avrei riempito
molto di più. L’effetto finale è sorprendente persino per me, stento a riconoscermi.
Succede anche nel cinema: il regista taglia le scene, se vuole, in fase di montaggio. I
registi “usano” gli attori senza farsi troppi problemi. Anche molti produttori musicali lo fanno,
specie nel pop. In altri casi, invece, seguono anche loro l’onda e costruiscono il ponte a mano a
mano, passo dopo passo, cambiando idea durante il percorso.
Nella musica (come nella vita) c’è molta gente che dice di avere le idee chiare da subito.
Ammettere che qualcuno possa avere un’idea migliore e seguirla è la cosa più bella che possa
capitare. Basta essere aperti.
Lo spirito col quale salgo sul palco mi impone di fare ogni sera una cosa diversa. Il più
delle volte metto le mani sulla tastiera senza sapere che brano suonerò. Inizio, entro in
un’atmosfera che mi porterà a scegliere il brano (o a rimanere in una “open form”). Nel trio con
Jesper Bodilsen e Morten Lund da tempo non decidiamo più la scaletta: non si tratta più di
improvvisare su alcune canzoni secondo un programma di sala.
È come passeggiare in un posto che conosci e non conosci, provare nuove vie traverse,
che magari non porteranno dove avevi previsto di arrivare ma in un posto più interessante.
Assumersi dei rischi, è il bello del jazz. Perdersi. Però capita anche di dover insistere, proprio
quando sei incappato in un errore.
Esiste una storia che fa al caso: in un racconto fulminante di Woody Allen, il filosofo
Sandor Needleman cade da un palchetto a teatro e, per convincere tutti che lo ha fatto di
proposito, torna ogni sera per un mese e fa la stessa cosa nello stesso punto della pièce. Quando
gli dicono che può smetterla, che ormai ha convinto tutti, risponde: «Grazie, ancora qualche
volta... davvero, non è poi così male».
Un esempio: nasce un riff, una figurazione melodica o una frase ostinata di tot note che
sembra non portare da nessuna parte e avvitarsi su se stessa... Se la molli subito non condurrà a
nulla e rimarrà isolata. Prova a perseverare. La noia, il fastidio, si possono scavalcare e di là dal
muro potrebbe esserci qualcosa da scoprire.
Keith Jarrett si lancia in concerti di piano solo totalmente improvvisati. Si tratta di
composizione estemporanea pura, un grandissimo sforzo, un uomo solo che dà forma alla
musica, davanti al pubblico.
È uno dei tratti più affascinanti del jazz, e anche quello che lo rende un’esperienza
fondante del Novecento.
Una volta avevo appena terminato un set di piano solo al festival di Bath in Inghilterra.
Incontro nella hall dell’hotel il pianista Misha Mengelberg; mi chiese quanto tempo avessi
suonato, e gli risposi un’ora e mezza.
Disse che lui più di settanta minuti non avrebbe resistito, perché oltre quel tempo il
cervello umano non può continuare a inventare con freschezza ma entra nella routine. Certo,
Mengelberg ha un umorismo tutto suo e, come per altri grandi freak, non sai se ti sta coglionando
o consegnando una perla di saggezza. Ma l’avvertimento era chiaro: al bando la routine.
La firmo e la controfirmo, questa affermazione. Se fare musica significa suonare la stessa
musica sempre, tanto vale fare un lavoro vero.
Senza creatività ci si annoierebbe. Meglio esserci tutto, quando si suona, e non mettere il
pilota automatico alle mani.
Io poi adoro giocare con le aspettative, quelle del pubblico ma soprattutto le mie:
prendere una struttura, smontarla per farla rinascere diversa. Semplificare un’armonia
complicata, complicare un’armonia semplice, non prendere l’accordo che il mio orecchio va
cercando automaticamente per abitudine o perché “suona bene”.
E anche usare lo humour, perché è una sorpresa, perché ribalta la prospettiva.
E cambiare tipo di repertorio, perché il brano è sempre e solo un punto di partenza. Il
punto di arrivo non è dato.
Esagerava ma non troppo il pianista Misha Alperin, altro umorista raffinato, quella sera
in cui mi ha confessato che non ama leggere romanzi perché sono sempre più prevedibili della
vita e in buona sostanza perché i libri tendono a dirgli cosa sognare mentre lui vuole decidere da
solo i propri sogni.
6
Humour e comicità
To play in inglese significa in un colpo solo “suonare”, “recitare” e “giocare”.
Anche in francese usano solo jouer.
In Italia abbiamo tre verbi diversi... Per carità, è bello avere tanta ricchezza di
vocabolario, ma in questo caso forse, invece di guadagnare, perdiamo qualcosa.
Lo humour è un elemento del mio carattere ed entra di conseguenza nella musica.
Il mio sogno è costruire un concerto esattamente come la vita, non come i romanzi di
genere, che devono solo far paura o far ridere: un concerto non è come il teatro: spesso non hai i
cambi di luce, non ci sono personaggi nuovi che entrano in scena. Sei lì, magari pure da solo, e
vuoi suonare Che cosa sono le nuvole di Modugno-Pasolini, un brano di una semplicità
disarmante che va a toccare corde che non ti aspettavi di avere così scoperte, e poi una gag dove
imiti il vecchio 78 giri che salta.
Certo, si ha paura che la cosa possa distrarre, che la gente veda il dito e non quello che
c’è dietro, che le gag rovinino la musica. Invece ho scoperto che l’ironia fa parte della musica,
non è aliena allo spettacolo.
Sin da bambino pativo il fatto che a un certo punto si dovesse prendere una strada
precisa, nella musica come nella vita. Dover essere sempre serio, o essere sempre il simpaticone,
o essere sempre il primo della classe, o essere la teppa. Si è molto più variopinti e poliedrici
diamine, e sin da piccoli!
Ahimè, dopo che hai fatto il cretino la gente è portata a pensare che tu sia cretino in via
definitiva (“Once a cretino, always a cretino”) ed è difficile poi ribaltare la situazione.
Molti musicisti sul palco si danno un tono e nella vita sono completamente diversi. A me
quella pare una faticaccia.
Nel programma radiofonico con Riondino e Guerrini, “Il dottor Djembè”, abbiamo
invitato, negli anni, un sacco di musicisti che si sono divertiti anche a ridere e scherzare, che si
sono sentiti autorizzati (anzi, forse quasi obbligati, vista l’atmosfera in studio) a mostrare un lato
che si tende a tenere represso.
Così si smonta negli ascoltatori l’idea che la creazione debba sempre e comunque nascere
da uno stato di difficoltà, di disagio, di sofferenza. Che le canzoni d’amore più belle siano quelle
scritte sinceramente, ispirate alle proprie vicende. Che solo dalla strada debbano venire i grandi
dell’arte. Che essere stati una puttana o uno spacciatore o un tossico siano esperienze necessarie.
Sono stereotipi tali e quali allo smoking indossato dai solisti classici.
Strano che il jazz sia diventato così serioso, col tempo.
Come se i jazzisti, per il solo fatto di essere in pochi, dovessero essere “quelli seri”.
Poi c’è il grande rischio di intrappolarsi da soli, di non saper uscire dal registro che
“funziona”, di ripetersi senza andare a scandagliare il proprio fondo e vedere se c’è dell’altro da
portare in superficie.
Il cantante pop è il primo a trasformarsi in una icona, ancor prima che il pubblico lo
decida. Lavora al primo disco e già si tengono riunioni per decidere il look, il tipo di intervista,
l’atteggiamento... insomma, in una parola l’immagine.
Poi convive con la tremenda paura che il pubblico lo rinneghi, che non lo riconosca più,
che non segua le sue svolte, le sue evoluzioni, il suo cammino.
Ci vuol coraggio per rischiare, quando hai venduto milioni di copie con un certo tipo di
canzone. Oggi conviene farlo, anche ai divi del pop, tanto i dischi non si vendono più come un
tempo.
Inutile correre dietro al pubblico. Sta già scappando in un’altra direzione, correndo dietro
ad altri. Nella migliore delle ipotesi, preoccupandosi troppo del pubblico, si finisce come il
direttore d’orchestra di Le baccanti, un racconto di Julio Cortázar, che viene divorato dalla platea
presente in sala.
Tanto vale seguire il proprio percorso, non quello che “ha funzionato finora”.
Ma tutto ciò ha a che fare con la percezione che hai di te stesso, un argomentone che
lasciamo volentieri così, solo accennato, semplicemente suggerendo che, se Gassman avesse
continuato a usare solo il registro drammatico delle sue grandi prove teatrali, non avremmo avuto
capolavori del cinema come Il sorpasso o La grande guerra, che se Calvino avesse
semplicemente raccolto le fiabe italiane senza poi usarle come ispirazione, non avremmo avuto
la trilogia de I nostri antenati, che se Miles avesse semplicemente “battuto il ferro finché era
caldo” senza cercare strade diverse, non avrebbe inciso né Birth of the cool, né i capolavori con
Gil Evans, né Bitches Brew, che se Picasso e via dicendo...
7
Il palco
È difficile essere se stessi nella vita, figuriamoci sul palco.
Il contesto culturale da cui veniamo ci condiziona, è inevitabile. Eppure essere sinceri sul
palco paga. Sì, conviene. Per dirla con uno dei miei maestri, Bruno Tommaso, «andare sul palco
è sempre meglio che pagare uno psicanalista».
Non so se abbia senso che il direttore d’orchestra vesta ancora lo smoking: so che lo
smoking fa parte di una serie di regole, regole rigide che servono a preservare una certa idea di
cultura “alta” e di “ritualità”. Ma forse sarebbe ora di riflettere sul fatto che lo smoking del
direttore sortisce un effetto preciso: tenere a distanza il pubblico, rimarcare una differenza,
rivendicare una appartenenza culturale che è vecchia di secoli o lontana molti chilometri.
«Il medium è il messaggio» ci diceva, qualche era geologica fa, Marshall McLuhan. E lo
smoking è un messaggio.
Sul palco io salgo per vedere cosa può succedere.
Vorrei essere disposto all’imprevedibile, all’inaspettato, dunque presentarmi - per quanto
possibile - senza preconcetti, senza filtri, senza un codice che mi identifichi immediatamente.
Il pop vive di queste cose, proprio come la musica classica. Si costruiscono carriere intere
intorno al look, ai capelli lunghi del rockettaro, all’anfibio ai piedi, al giubbotto di pelle.
Molti jazzisti, per contro, si sono convinti che l’aria seria, diciamo pure il broncio, sia la
cosa più corretta da indossare, sul palco.
Dici: «Oh yeah, man!». E sei nato a Caianello.
È così importante il look che vorrei tanto non avere un look.
Si va sul palco cercando di dare il meglio di se stessi. (Sperando che non coincida con il
peggio.)
Ma cos’è il meglio?
Per ognuno di noi è qualcosa di diverso.
Non è affatto facile capire quali siano i talenti che abbiamo dalla nascita, anzi, è una delle
imprese più intricate. L’errore di valutazione è dietro l’angolo.
A me piace trovarmi lì sul palco ed entrare in comunicazione con il pubblico. Da
bambino volevo fare l’imitatore o il cantante, poi è arrivato il pianoforte ma non ha soffocato le
altre due vocazioni. Probabilmente avrei altri talenti, ognuno di noi ne ha e non pochi, ma mi
piace esplorare questi.
8
Ma che vuole, il pubblico?
Chissà cosa pensa il pubblico? Chissà cosa sente il pubblico?
Ognuno ascolta e vive la musica in maniera diversa, personalissima. Son ben buffi quegli
artisti che parlano del “proprio pubblico” come se si trattasse di un’entità molto chiara e definita
(di cui prevedono gusti inclinazioni commenti idiosincrasie).
Certo, esistono alcune tipologie di pubblico, inteso come massa di persone presenti in
contemporanea a uno stesso evento.
Ancora una volta si tratta di convenzioni, maschere che le persone lì sedute decidono di
indossare per comodità e pigrizia.
Esiste una gran fetta di pubblico che vuole essere rassicurato. Anche nei dettagli: vuole
ascoltare, al concerto, quello che ha già sentito sul disco... vuole vedere la solita storia della
Tosca, vuole che tutto quel che accade sul palco rientri in una linea ben precisa e chiara, come
mai accade nella loro vita quotidiana, in modo da sperare che ci sia un modo di raccontare e
raccontarsi che arrivi a trarre delle conclusioni. Vuole una lezione, un insegnamento, un
messaggio chiaro in modo da poter poi aderire o dissentire: proprio come i click su MI PIACE o
NON MI PIACE di facebook.
È un pubblico che vuole semplicità, ma non nella sostanza di quello che vedono... la
sostanza può essere pure molto complessa, può trattarsi di Pelleas und Melisande di cinque ore,
può trattarsi di Beckett, di Anthony Braxton, di Lutoslawski.
Vuole semplicità nei codici:
Io sono seduto qui in platea, tu sei lì sul palco.
Tu esprimi delle cose, io ti applaudo.
Ti applaudo se le condivido.
Se sei un virtuoso.
O se non ho voglia di pensarci troppo su.
Ma c’è anche una fetta consistente di pubblico che va a cercare cose che lo stimolino
davvero. Nel jazz molte volte le persone si trovano di fronte a qualcosa che non si aspettavano:
vanno ad ascoltare un artista di cui hanno un disco in trio e si beccano un duo con un’arpista
indiana o un omaggio a Monk con un rapper francese o un esperimento di improvvisazione con
danzatori. E il bello può essere proprio lì. Decidere di fidarsi di un tale artista e poi seguirlo per
vedere che cosa combina. Fare il viaggio con lui, senza chiedersi perché e dove si sta andando.
Vedere cosa combina l’artista sì che accende i sensi!
Senza contare il fatto che, nella maggior parte dei casi, l’artista non sa verso cosa sta
correndo. Poi certo risponde a delle interviste in cui parla di un percorso, di un progetto, di una
missione, di una chiamata... e via peggiorando.
(Ho scritto che questo accade nella maggior parte dei casi, eh, non ho scritto “sempre”.
Spero che nessuno se la prenda. Il mondo è talmente grande che c’è posto anche per quelli
davvero seri seriosi convinti. Ma sono meno di quanto sembri. Perlopiù i musicisti che ho avuto
il piacere di conoscere vogliono suonare e non usare la musica per fare altro, tipo emanare
proclami, mandare messaggi e lezioni di vita.)
Nella sala da concerto classica accade il contrario. Si entra e ci danno il programma, si sa
già quello che suoneranno, si dà per scontato che faranno il possibile per attenersi alle
indicazioni del compositore, vivo morto o moribondo che sia.
Abbiamo già la trama in pugno. Sappiamo già se si tratta di una commedia o di un
dramma. Dunque siamo pronti a emozionarci in un punto preciso e rischiamo di passare la serata
ad aspettarlo (pensiamo alle arie nelle opere... quante lunghissime Tosche per potere alfine
sentire E lucevan le stelle che, Puccini cattivone e crudele, ci scodella solo alla fine).
Chi fa televisione, poi, convive con una specialissima paranoia: la migrazione dei
teleutenti.
La fuga degli spettatori, l’evento più temuto, tanto da creare suspense su ogni singolo
secondo, grazie al fantomatico sistema Auditel.
Se si intervista lo scrittore Mario Vargas Llosa e lui parla del suo Perù, e dopo,
consultando i dati, ci si accorge che nel momento in questione è calato l’ascolto, tranquilli, ecco
la soluzione: non si parlerà più di Perù in quella trasmissione. Metodo geniale, semplice, diretto,
che regala al capostruttura molto tempo libero, non dovendo egli riflettere su quanto accade ma
solo agire in conseguenza a un dato preciso. Il capostruttura televisivo come il pubblico
dell’opera, ecco. Adotta un codice infallibile e non si interessa al resto del mondo e delle
contingenze. Due sole possibilità si presentano al suo orizzonte:
via il Perù dal palinsesto.
via Vargas Llosa che l’è un noiosone.
(Può solo peggiorare... c’è sempre l’opzione numero 3) via gli scrittori!
Ah, com’è lineare la visione della vita di queste persone. Piacerebbe che fosse così anche
fuori da quell’apparecchio? Vorremmo essere in grado di identificare un problema ed eliminarlo
subito, alla radice, senza porci questioni più complesse e tentare di inquadrarlo in un contesto?
Sì, forse ahimè ci piacerebbe, stiamo tentando di farlo in questo mondo in bianco e nero
che abbiamo costruito.
Io preferisco quando il pubblico ha pagato un biglietto. Quando suoni gratis c’è il
“rischio TV”... potrebbero cambiare canale in qualsiasi momento. Andarsene al primo accenno di
“noia”. Dunque non darti il tempo di sviluppare un discorso, di usare una subordinata.
La TV, al contrario, vive di frasi semplici a effetto e di falsi applausi continui, a mo’ di
conferma.
Nel mondo degli elettrodomestici, la televisione è decisamente il più insicuro.
9
Il concerto
Prima di salire sul palco non ho veramente paura; vince la gioia, l’emozione, a meno che
non debba suonare Gershwin o Ravel con un’orchestra sinfonica, perché in quel caso esiste
L’ERRORE.
Stai suonando una partitura conosciuta e sbagliare una nota significa letteralmente
sbagliare una nota, non percorrere una nuova strada o chiudere una porta e aprire un portone o
tentare una lettura differente.
L’idea dell’errore infastidisce tutti sin da bambini, eppure ce la portiamo dietro.
Nella musica classica c’è questo clima da esame, identico a quello che sentivo al saggio
di fine corso in Conservatorio, che faccio molta molta fatica a esorcizzare.
Cerco vanamente di consolarmi pensando che grandissimi artisti come Arturo Benedetti
Michelangeli e Glenn Gould temevano i propri errori al punto di suonare il meno possibile in
pubblico (o di smettere proprio).
Glenn Gould poi non amava le interferenze esterne, non voleva essere distratto dal colpo
di tosse, una cosa molto comprensibile.
Ma è il contrario del jazz, dove capita di interagire con le campane della chiesa del paese
in cui stai suonando.
Glenn Gould invece aveva elaborato Bach in un modo che per lui era la (sua propria e
personale) verità: per questo è stato uno dei primi a incidere dischi usando le moderne tecniche
di registrazione: tagliando e rimontando, utilizzando il proprio “meglio” per ottenere la versione
“definitiva” del tal brano.
Non aveva proprio bisogno, del pubblico.
Fra parentesi, il suo Clavicembalo ben temperato è un tacchino ripieno di accenti jazz; è
talmente personale da risultare lontanissimo dall’idea che si ha di Bach. Ed è elettrizzante come
poche altre cose sul pianeta.
Con il maestro Riccardo Chailly abbiamo lavorato sui dettagli di Gershwin prima, e poi
di Ravel. In quel caso ero alle prese con qualcosa di nuovo e antico al tempo stesso. Nuovo
perché mi trovavo di fronte a montagne da scalare (e in vetta c’erano già piantate bandiere
scintillanti da altri pianisti); e antico perché l’unico modo di studiare sodo era quello imparato
dal mio insegnante in Conservatorio a Firenze, il maestro Antonio Caggiula, proveniente dalla
scuola pianistica napoletana. Lui mi portò al diploma con molta perseveranza e pazienza,
seguendomi passo dopo passo ben al di fuori degli orari di lezione canonici.
La scuola napoletana ti insegna un modo ben preciso di articolare il dito e quando ci si
esercita, invece di provare il passaggio lentamente e poi sempre più veloce, si fa una battuta per
volta seguita da una pausa di una battuta, ma subito rispettando i tempi giusti. In questo modo il
brano lo si sente subito alla sua velocità, perché suonandolo lentamente c’è il rischio di
affezionarsi a certe cose belle che alla velocità giusta non potrai più tirar fuori.
Chailly ha grande senso del ritmo, essendo stato - sebbene per poco tempo - un batterista,
nelle estati della sua giovinezza. Questo aiuta molto la nostra intesa. Bisogna fare grande
attenzione a non volere “cantare” tutto, tutte le note. Col risultato di non decidere cosa è davvero
da mettere in rilievo e cosa deve o può stare sullo sfondo.
La tendenza a rallentare troppo, dunque a illanguidire la musica, è sempre dietro l’angolo.
Sin da bambini, quando si studia, si rallentano i passaggi difficili giustificandoli con la scusa
della espressività... Ricordo molti violinisti agli esami, quando li accompagnavo, che
rallentavano dove non era previsto ma semplicemente perché arrivavano i velocissimi
trentaduesimi con tripli salti acrobatici e per affrontarli dovevano prendere la rincorsa! Questa
tendenza rischia di rimanerti fissata in testa a vita.
Il secondo movimento del Concerto in Sol di Ravel, per esempio, è costituito da una
lunghissima melodia, meravigliosa, sempre in movimento ma anche piana, con una sua
tranquillità di fondo, che per Chailly e me non doveva assolutamente diventare miele.
Abbiamo mantenuto il tempo originale di Ravel (confortati dalla prima incisione di
questo concerto: al pianoforte Marguerite Long, dirigeva Ravel stesso) e fatto l’impossibile per
non deviare, gettando così una patina di ghiaccio su tutto il movimento. Per noi era la
contrapposizione fra l’estrema, malinconica cantabilità e la fredda sapienza compositiva cesellata
nel dettaglio a dare il cortocircuito che cercavamo.
Preparando la Rapsodia in blu di Gershwin, invece, ho tenuto a lungo in mente le
azzeccatissime sequenze del cartone animato Fantasia 2000, in cui un operaio che lavora su una
impalcatura sogna di suonare la batteria. A un certo punto molla il lavoro e corre a realizzare il
suo sogno, in un jazz club. È il momento del film preferito da mio figlio e a lui penso quando
suono l’agitato finale.
Nei giorni della registrazione del Concerto in Fa di Gershwin, a Lipsia, presi un sacco di
appunti “letterari”, immaginando situazioni cinematografiche evocatemi dalla musica (stavamo
pensando persino di metterle nel libretto del CD... fortunatamente ci siamo ricreduti, sarebbe
sembrato un invito affinché l’ascoltatore immaginasse di vedere le stesse cose... Quando invece
il bello della musica è proprio questo: ognuno di noi la sente in maniera diversa e ci trova dentro
cose diverse, e personali, non indotte da altri).
Ma soprattutto ho passato le notti a rivedere tutto Gene Kelly su YouTube. Perché la sua
leggerezza era l’effetto che cercavo. Volevo dare l’impressione di non fare alcuno sforzo, in un
brano che invece ne richiede, soprattutto dal punto di vista tecnico.
Gene Kelly balla e ride ma soprattutto fa cose difficilissime non con l’aria guascona di
chi te la fa pesare ma con l’incanto di chi rende quei movimenti, così studiati al dettaglio,
semplici e necessari.
È una sensazione che avevo già da bambino vedendolo ballare: finiva il film e pensavo di
poterlo fare anch’io. Uscivo dal cinema e mi sentivo pure io un acrobata.
Guardate i ragazzi dello spettacolo Stomp a Broadway o a Londra, che in un’ora e
quaranta giocano a rendere percussivo qualsiasi elemento a loro disposizione, da una scopa a una
scatola di fiammiferi, da un accendino a un lavabo. Hanno provato ore e ore e ore, è evidente,
eppure riescono a farcelo dimenticare, a farlo sembrare naturale. Godono loro stessi per primi
delle possibilità del loro corpo, delle loro mani, dei loro piedi, del loro talento. E senza fare
pesare nulla.
10
Lo spartito non è un libro
La musica sulla pagina non commuove: sebbene la capisca, da musicista, e dica: “Bello
questo punto”, conosca il suono che produrrebbe, non può commuovermi, mica la sento davvero.
Il suono è fondamentale.
La musica viene scritta per essere tramandata, ma non è una poesia. Che può essere letta
“nella testa”.
Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij è un oggetto finito.
Lo spartito non è un oggetto finito.
Va suonato.
La musica vuole movimento e suono. E interazione.
Pensare che lo spartito sia la musica è un travisamento, un equivoco. Che sembra piccolo
ma diventa macroscopico quando lo spartito diventa il Verbo.
Quello che conta è il modo in cui restituisco la vita a questi appunti scritti, il modo in cui
li porgo.
Per fare un esempio: meglio mettersi a guardare una puntata di “Dynasty” che uno
Shakespeare recitato male. Eppure sulla carta lo sceneggiatore di “Dynasty” è meno talentuoso
del Bardo, lo sappiamo.
Nel jazz tutto ciò è ancora più evidente, perché un blues di Charlie Parker per iscritto non
è un granché. Lo guardi e pensi: “Che sarà mai?”. Poi lo senti suonato, da lui o da un altro
grande, e prende le ali.
Nel jazz devi dare swing alle note, farcirle di accenti che nella partitura non ci sono. E
non ci sono semplicemente perché in molti casi non è proprio possibile scriverli: sono come le
cadenze che si hanno quando si parla. Come annotare il timbro di una persona, le sue pause, le
sue esitazioni? E la sua mimica, poi? E il suo accento?
Sul fronte opposto, in una partitura di musica classica si lascia poca libertà all’interprete.
Per convenzione tutto è annotato e va rispettato. Pochi sono i dettagli su cui “giocare” (to play).
La musica classica parte dal Dio spartito. Cominciano tutti da lì, dall’idea che in quella
partitura di Bach ci sia un diamante da tirare fuori.
E il lavoro dell’interprete rischia di somigliare a quello dell’archeologo o del decrittatore.
Fortunatamente i grandi solisti classici sono anche dei grandissimi creativi, proprio come
Glenn Gould quando prende Bach e decide di fame quel che vuole. Giustificato peraltro dal fatto
che il buon Bach quella musica lì l’aveva scritta per un clavicembalo, cioè per uno strumento con
tutt’altro suono e tutt’altre caratteristiche. Il pianoforte come lo conosciamo noi è datato primi
del Settecento. È nato grazie a numerosi tentativi di un brillante italiano alla corte dei Medici,
Bartolomeo Cristofori... E quando fu portato di fronte a Johann Sebastian Bach a Lipsia pare che
il Nostro non si sia affatto entusiasmato!
Dunque, se si tratta di forzare un po’ la mano trasportando la musica su uno strumento
differente, allora tanto vale fare un passettino in più e lasciar emergere qualcosa che non era
nelle intenzioni dell’autore...
La musica è di tutti, «Music in the streets», urlava Léo Ferré, prendendosela con quei
bacchettoni che volevano tenerla prigioniera nei santuari.
Un tempo, nei concerti per strumento solista e orchestra, s’improvvisavano le cadenze o
alcune parti di esse: le cadenze sono una piccola sezione armonica o melodica che in genere
conclude il brano. Arrivava perciò il momento in cui il pianoforte, o il violino, o il violoncello,
rimaneva da solo, e quella era una parte che i grandi interpreti improvvisavano rapsodicamente
prendendo spunto dai temi musicali presenti nel concerto. Oggi negli spartiti si scrivono anche
quelle parti: le ha codificate qualcuno, lavorando sul testo che doveva essere pubblicato.
In chiesa l’accompagnamento delle melodie non era vergato nota per nota, era riassunto
nei “numeri al cembalista”, indicazioni che peraltro somigliano tanto alle cifre (o sigle, o
accordi) che troviamo negli spartiti di jazz o di pop, dove un accordo di Sol maggiore si indica
con Gmaj o uno di Si minore con B-, abbreviando e usando i nomi delle note in inglese, cioè le
prime sette lettere dell’alfabeto. (A La, B Si e via dicendo.)
Gli Improvvisi di Schubert o le Improvvisazioni di Poulenc si chiamano così proprio
perché nascevano con quello spirito, poi venivano fissate su carta.
La musica si è irrigidita. Ma la scrittura può essere fallace. Il “fortissimo” annotato da
Mozart non è lo stesso di Stravinskij o di Poulenc. Sulla pagina, in entrambi i casi, c’è scritto
“fortissimo”, ma la stessa parola indica intenzioni completamente diverse. Su uno spartito si
possono scrivere un sacco di cose, ma non sarà mai tutto...
Prendete le pause nelle battute di Romeo e Giulietta: chi ti dice quanto devono durare?
Non Shakespeare. E comunque il tempo di oggi non può essere lo stesso di allora... E le pause, le
durate, le velocità sono in perenne mutazione perché cambia con gli anni il nostro modo di
percepirle.
«Vedeste il tempo che c’era ai miei tempi» dice Alice di Lewis Carroll.
Lavorare su queste cose con Chailly è molto istruttivo, perché lui conosce i vezzi dei
direttori e dei solisti, vezzi che rischiano di diventare Verbo col passare degli anni.
La grande ambizione di certi musicisti classici è filologica, cioè eseguire la partitura
come vorrebbe Mozart. Tradotto: una cosa impossibile!
Entra in scena il dogma: Mozart si fa in un certo modo! Se provi a cambiare, sei morto!
Per contro esiste la corrente di quelli che interpretano solo alla loro maniera...
Se Mozart resuscitasse sarebbe contento delle interpretazioni fatte della sua musica?
Molti grandi, Beethoven, Liszt, hanno preso la musica di altri compositori e l’hanno masticata e
riproposta diversamente: un esempio sono le Variazioni su un tema di Diabelli di Beethoven o le
parafrasi lisztiane di grandi temi dell’opera italiana.
Ah, questi grandi compositori del passato... sembrano tutti uguali, perché li abbiamo
messi tutti in fila, tutti senza braccia e senza gambe, menomati eternamente in una serie di busti
con tanto di parrucche. Tutti di una certa età, tutti seri, compresi nel loro ruolo, facendo la Storia!
Mai giovani, mai sfiorati dai dubbi, mai in mutamento, dunque mai VIVI, mai
PRESENTI. Immortalati, appunto, in un attimo che li rende monumenti, dunque lontani da noi,
che siamo persone che passano il martedì a sconfessare quello che hanno deciso e dichiarato il
lunedì, a cercare continuamente di fare bilanci delle nostre vite dimenticandoci di viverle.
Invece erano tutti molto diversi fra loro, questi grandi compositori.
Bach se ne stava a casa a scrivere circondato dalle figlie, dal coro della chiesa di Lipsia
che eseguiva le sue partiture più volte alla settimana.
Mozart, Paganini, Liszt erano perennemente in giro a suonare, erano virtuosi del loro
strumento, superstar. “Paganini non ripete” non solo perché non vuol concedere bis (uh! che
snob) ma più probabilmente (ho deciso io) perché ogni volta eseguiva il brano in maniera
diversa, mai uguale a se stesso.
Prokof’ev era giovane e ambizioso quando scriveva le partiture per il cinema di
Ĕjzenštejn! Non già pelato, occhialuto e vittima dello stalinismo! Possibile che la scuola sia
riuscita nel tentativo di farci credere che gli eroi del passato non avessero altre dimensioni? Tutti
tagliati con l’accetta, a tutto tondo, caduti dal cielo, unti dal Signore.
Stavamo parlando di interpretazione...
Bene, esistono casi più insidiosi di altri: per fare un esempio, Igor’ Stravinskij ha
interpretato e inciso di persona le sue creazioni.
Di fronte a quel disco cosa si fa? Sarebbe come se avessimo una registrazione di Carlo
Goldoni che recita La bottega del caffè. Solleverebbe alcune difficoltà, credo.
Ha ragione lui, dunque?
Insomma: no. Hanno ragione anche gli altri. “Hanno tutti ragione” direbbe il Tony
Pagoda di Paolo Sorrentino. La musica di Stravinskij, se vuole continuare a vivere, è bene che si
lasci suonare anche da altri. Che avranno una visione parziale ma magari riusciranno a illuminare
un lato nascosto di quel pianeta che neppure Stravinskij conosceva (a che è servita la psicanalisi,
se no?)
E i problemi non sono finiti. Nella Rapsodia in blu di Gershwin c’è un punto, prima della
riproposizione finale del tema in stile marching-band, in cui si esegue un “rallentando” davvero
epico. Il “rallentando” così marcato è diventato una convenzione, un’usanza. Chailly lavora
molto per ripulire la musica da sedimentazioni “a posteriori” che rendono ancora più difficile il
lavoro dell’interprete. Vogliamo davvero cercare di avvicinarci il più possibile alla volontà del
compositore, studiando il gusto della sua epoca, le sue intenzioni più o meno dichiarate? Va
benissimo, è una strada come un’altra, seguiamola pure, ma liberiamoci allora di quello che gli
altri hanno deciso riguardo alle intenzioni dell’autore (nella maggior parte dei casi l’autore era
già morto anche all’epoca dei suoi maggiori interpreti su disco, dunque...). Sì, stiamo parlando di
tornare al testo originale della Bibbia, mi rendo conto, scendo subito da questo pulpitone che mi
sono costruito e lo lascio lì a sedimentare...
Mi è accaduto un fatto ancora più curioso con il Concert champêtre di Francis Poulenc,
che ho inciso sotto la direzione di Jan Latham-Koenig: nella partitura il compositore francese
aveva annotato dei “rallentando”, e fin qui uno si mette a dormire tranquillo. Tranne che poi
esiste un’incisione diretta dallo stesso Poulenc e nel punto dove ha scritto “rallentando” invece,
che fa, proprio lui? Esatto: accelera!
Lì nascono certe discussioni!
“Bisogna dare retta all’incisione... l’autore è lì al pianoforte... saprà bene lui come la
voleva, no?”
“Per me, invece, lui ha accelerato perché il giorno dell’incisione gli girava così, magari
era emozionato.”
“Se lo ha scritto, è perché ci ha ragionato... diamo retta a quello che ha scritto.”
“Forse non lo ha scritto lui ma quello che ha curato l’edizione dello spartito.”
“Forse l’incisione è vecchia e il disco ha un problema e in quel punto gira più veloce” (il
passo successivo prevede anche interventi degli alieni o delle lobby degli stampatori di spartiti e
ve lo risparmio).
Si può andare avanti a lungo, e generalmente si smette per sfinimento.
Dubbi del genere sono sorti anche con il secondo tempo del Concerto in Sol. Ravel lo
aveva indicato tutto in tempo 34, non esiste alcuna indicazione che dica di rallentare. Mai.
Eccetto alla fine, poco prima dell’ultima battuta. In sostanza andrebbe eseguito a tempo costante.
Abbiamo ascoltato le varie interpretazioni, alcune celebri, come quella di Martha Argerich, e i
tempi su quel secondo movimento variano...
In quel caso, anche con Chailly, abbiamo ascoltato tutte le altre interpretazioni per capire
soprattutto cosa non ci piaceva, cosa non fare. Ci interessava TOGLIERE più che aggiungere.
Detta così, in un mondo di interpreti che rivendicano la propria visione dell’opera, ha il sapore
dell’esperimento. Forse lo è stato.
Mi piace ascoltare, in ambito classico, le interpretazioni che non mi convincono. Più
genericamente, mi piace ascoltare la musica che non mi piace.
Se la conosci, la eviti.
Mi aiuta a comprendere entro quali confini si muove il mio gusto. Dunque a capire qual è
il ring in cui posso divertirmi e inventare.
11
Qualche disco cult
Il disco è il nostro Delitto e castigo. Le incisioni storiche sono i nostri testi sacri: sui
dischi ci siamo formati, li abbiamo analizzati, e prima ancora copiati, tentando di eseguirli nota
per nota.
I dischi sono fotografie che abbiamo osservato nei minimi dettagli.
Far East Suite di Duke Ellington, registrato nel 1966, è uno di questi. A cominciare dalla
copertina: una cosa stramba. Si vede il Duca disegnato male che arriva su un tappeto volante,
tipo Renato Pozzetto a cavallo di una scopa sulla locandina di Mia moglie è una strega...
Dovrebbe dare l’idea di un’immagine esotica, però facilona: bene, trovo che sia una copertina
geniale. Come la musica che il disco contiene, d’altra parte. Nacque da una tournée che Ellington
e la sua orchestra avevano fatto in Medio ed Estremo Oriente e, sebbene nella sua autobiografia
il grande band-leader scriva che durante i viaggi raramente usciva dalla sua camera d’albergo (se
non per andare in teatro a suonare), la musica del disco sembra contraddire questa affermazione.
Duke, e con lui Billy Strayhorn, suo alter ego, dimostrano infatti una capacità incredibile
di assimilare elementi musicali lontani dalla loro cultura. C’è una ballad che è un capolavoro
assoluto, Isfahan. C’è un brano, Blue Pepper, nel quale Ellington prende una scala orientale,
ascoltata chissà dove, e ci costruisce sopra un blues. Il risultato è straordinario, perché non fa
l’effetto di una cosa appiccicata. Anzi, con pochi elementi presi a prestito dalla sua propria idea
di “Estremo Oriente” rinvigorisce la propria ispirazione e quella dei musicisti della big band.
Sembra Emilio Salgari quando scrive di mari del Sud senza essersi mai mosso dalla
propria scrivania.
Anche i Beatles fanno una cosa del genere nel disco Sgt. Pepper’s: prendono un sitar
(strumento tradizionale a corde) e su un accordo indiano elaborano un pezzo che ha una sonorità
“orientale”. Era stato George Harrison a innamorarsi della musica del famoso suonatore di sitar
Ravi Shankar.
I Beatles sposano la loro musica con quella indiana in una maniera molto efficace, ma
differente da quanto fa Ellington. Lui si appropria, metabolizza, introietta la scala orientale e la
trasforma nella sua musica in una sorta di procedimento alchemico. Miracoloso. È una cosa
completamente diversa. Suona stravagante senza essere kitsch. Di solito, invece, quando i
musicisti occidentali chiamano l’eschimese o l’aborigeno a incidere il risultato è kitsch. In
definitiva, quello che mi colpisce nella Far East Suite è la capacità di assimilazione
dell’elemento musicale estraneo, senza che magari Ellington sia mai uscito dall’hotel di New
Delhi. Mentre c’è della gente che vive in India dodici anni e che, se inserisce la musica indiana
nella propria, ottiene subito l’effetto patchwork.
Fondamentale è uno qualsiasi dei dischi del pianista Ahmad Jamal registrati con il suo
trio nel 1958-1959. C’è uno swing micidiale, grazie al basso di Israel Crosby e alla batteria di
Vernell Fourier. E poi c’è Jamal in grandissima forma. Accenna due note di Cheek to cheek e poi
smette di suonare il tema, lasciando la sezione ritmica da sola a far sentire la struttura degli
accordi. In pratica lo annuncia ma poi non lo espone. Tanto che uno del pubblico si mette a
fischiettarlo, perché ne sente la mancanza. Quando ascoltai i dischi per la prima volta l’effetto fu
straniante: “Fa troppe pause”, mi dicevo. Più del normale. Miles Davis lo amava e spediva i suoi
pianisti ad ascoltarlo, in quel periodo.
Ascoltate le pause di Miles: somigliano a quelle di Ahmad Jamal.
Una fotografia sonora che non ha mai smesso di intrigarmi è A Night at Birdland, in due
volumi, registrato nel 1954 dal batterista Art Blakey insieme al suo quintetto, i leggendari Jazz
Messengers. Il Birdland era un piccolo club di Broadway, chiamato così per via del soprannome
di Charlie Parker, “Bird”. Come tutti quei localacci della Cinquantaduesima Strada di
Manhattan, anche il Birdland aveva un palco piccolissimo. Nella registrazione si sentono il
rumore dei bicchieri, le risate del pubblico e, dal suono degli applausi, si intuisce che la gente è
rumorosa ma non numerosa. Mi affascinava quell’atmosfera: il pubblico così vicino ai musicisti.
Oggi è ancora così, da qualche parte. Una sera a New York sono andato ad ascoltare il
sassofonista Mark Turner in un club: venti persone al massimo stavano lì sedute, e il gruppo di
Mark ha suonato tre set di un’ora ciascuno con una energia incredibile. Recentemente ho suonato
in un grande teatro italiano, molto esteso in lunghezza. Il pubblico mi vedeva come un puntino e
io non lo vedevo per niente. In quel caso il localaccio mi manca un po’, emana un calore
insostituibile.
Nei due volumi di A Night at Birdland ci sono le composizioni di Horace Silver, che ho
adorato da subito. E poi c’è la tromba del grande Clifford Brown, con quel suono così personale
e quel fraseggio fluido che ancora oggi mi fa saltare sulla sedia come da ragazzo.
Un collega di mio padre mi aveva regalato un box contenente tre LP dal titolo History
ofjazz Piano. Avrò avuto nove anni e ancora non sapevo cos’era il jazz, ma in quel cofanetto
c’era la storia del piano jazz dagli esordi (dunque molto “stride-piano”, da James P. Johnson a
Fats Waller) fino agli anni Cinquanta di Oscar Peterson ma senza pianisti contemporanei.
Ricordo che lo ascoltavo senza sosta e c’erano anche pianisti di boogie-woogie come Meade Lux
Lewis e Jimmy Yancey, che allora cercavo di imitare. E ricordo che nei brani con Peterson
credevo che i pianisti fossero due. Avevo travisato le liner-notes (a mia discolpa, si sappia che
erano in tedesco).
Quel cofanetto è stato importantissimo, perché generalmente si comincia a insegnare la
“grammatica del jazz” partendo dal be-bop, cioè dalla fine degli anni Quaranta. Epoca nella
quale i pianisti tendenzialmente usano la mano sinistra per accompagnare e suonare gli accordi,
punteggiando; e trattano la mano destra come se fosse la voce di un cantante, o uno strumento
monodico solista.
I pianisti del cofanetto, anni Trenta e Quaranta, suonavano invece a tutta tastiera.
Facevano i bassi, servivano l’armonia, la melodia, una seconda melodia di contrappunto. Un
mondo ricchissimo, debordante.
Teddy Wilson nei dischi con Benny Goodman, Lionel Hampton e Gene Krupa suona in
continuazione. Cascate di note, e tutte con eleganza, gusto, senza riempire inutilmente gli spazi
ma rimanendo “dentro” la musica.
Nat King Cole nel disco in trio con Lester Young e Buddy Rich pure.
E Earl Hines poi... In grado di padroneggiare mille stili diversi (su YouTube si trovano
delle sue lezioni in TV... Divertente, elegante e sfavillante).
Nei primi anni Ottanta, alla fine delle trasmissioni RAI, molti ricorderanno che sullo
schermo compariva il monoscopio: era la sigla finale della giornata. E una notte l’immagine era
accompagnata da una musica che mi teneva incollato lì, cioè il sassofono tenore di Stan Getz
insieme alla voce di João Gilberto. Era il famigerato disco del 1963 intitolato Getz/Gilberto, che
fu il primo a circolazione mondiale in cui si incontravano il jazz e la bossa nova di Antonio
Carlos Jobim. Non avevo capito esattamente cosa fosse, che musica fosse, mi aveva colpito
l’atmosfera... Quel suono molto morbido, che era sia di Getz che di João ma anche della moglie,
Astrud Gilberto. Quel suono era molto cool (vocabolo che ovviamente non conoscevo all’epoca).
Non ricordo come ho fatto poi a scoprire che disco fosse... Non esistevano Google e altre
diavolerie. Devo averlo scoperto solo molto tempo dopo, forse grazie alla cantante fiorentina
Barbara Casini, che per prima mi introdusse nel mondo della musica brasiliana.
João, come Caetano, come Sinatra, Chet Baker, Louis Armstrong, Ray Charles, Stevie
Wonder, Billie Holiday, Elis Regina, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin sono tra le voci più belle
che siano state mandate sulla terra.
12
La musica non esiste senza l’empatia
Il poeta brasiliano Vinícius de Moraes diceva che la vita è l’arte dell’incontro. Solo che
nella vita mica ti scegli a una a una le persone con cui avrai a che fare.
Nella musica la situazione si fa interessante proprio quando suoni con chi vuoi davvero.
Tra improvvisatori si entra in comunicazione totale per due ore. Due ore totalizzanti, poi
magari non si va neanche a cena insieme. Oppure si suona tre giorni di fila intensamente e poi
capita che non ci si riveda per anni.
Sul palco si cerca di dare e prendere il meglio da chi lo divide con noi. Ci lampeggiano
davanti le passioni comuni, le direzioni verso cui possiamo andare insieme naturalmente. Per
intuito, fiutando l’aria, annusando gli altri. Cercando sempre il legame, il dialogo. Non solo per il
nostro bene, ma anche per il bene del pubblico e, in definitiva, per il bene della musica.
Bella vita, lì, sul palco, quando tutti salgono con la voglia di creare qualcosa di inedito
insieme, qualcosa che sia più della semplice somma degli elementi in gioco.
Certo che esiste l’altra faccia della medaglia. Sali sul palco con un altro e nasce la
competizione.
La storia del jazz è strapiena di aneddoti in cui i musicisti, di fronte a un novellino,
cercano di metterlo subito in difficoltà per vedere se può cavarsela, se può far parte del gruppo,
se è “uno di loro”.
Lee Konitz - forse inconsapevolmente, forse no - una sera mica mi ha detto il titolo del
pezzo che voleva attaccare, lo ha sussurrato al bassista, poi ha iniziato. E si registrava un disco
dal vivo, in quel caso. Ci sono un po’ di chorus senza pianoforte perché il pianista appunto sta
cercando di capire di che brano si tratti (Konitz non suona neppure la melodia del brano,
comincia direttamente a improvvisare sugli accordi della canzone).
Una volta, in Indonesia, ho partecipato a una jam session e ho visto Nico Gori, il
clarinettista che suona con me nel gruppo I Visionari, perdere la pazienza. C’era questo
sassofonista francese, indossava un cappellino, era partito con un “solo”, sguardo basso, suonava
bene. Nico sente il suono, l’inizio del suono, si volta e mi fa: «Questo mi sta antipatico».
Brandisce il clarinetto, lo monta come fosse un’arma, sale sul palco e quando arriva il suo
turno parte con un “solo”; lo prende alla larghissima, lento, fa un cenno al batterista di lasciarlo
solo con il basso, e comincia a costruire il “solo”, e il francese, a un certo punto, prende e se ne
va...
Quando alla fine il pubblico era in delirio, il francese era già uscito, aveva capito che la
cosa era rivolta a lui: una questione di maschi alfa. Una cosa tra loro due. Tipica del jazz alla
vecchia maniera.
Accadeva così a Kansas City e in altre città americane negli anni Trenta e Quaranta, dove
a tarda notte, nelle sale da ballo e nei jazz club si consumavano battaglie tra gente come Lester
Young, Coleman Hawkins, Ben Webster. Nel film Bird il giovane Charlie Parker sale sul palco
dopo aver fatto la fila insieme ad altri aspiranti e finalmente suona nella jam session. E il
batterista smonta uno dei piatti, lo tira e glielo fa atterrare accanto, tra le risate generali. Quanta
crudeltà.
Ma la jam session è una gara, vai a farti notare, a far capire che sei della famiglia, che
conosci i codici.
Quella sera, in Indonesia, Nico poi è tornato al tavolo e abbiamo ripreso a parlare da dove
ci eravamo interrotti. Non c’era un’esigenza musicale per quello che era successo sul palco; c’era
l’esigenza di mettere quello lì al proprio posto! Gli stava antipatico. Punto. Così, in modo vago.
È una lotta sotterranea e ogni tanto l’ego emerge e passa alle vie di fatto.
Aveva anche le sue belle ragioni Nico, vi dirò. L’atteggiamento del francese era un po’ di
chi passava di lì e, guardando il mondo dall’alto, faceva cadere la sua prosopopea addosso agli
astanti.
Nel jazz si scelgono i musicisti per le ragioni più diverse: amicizia, affinità artistica,
interesse, casualità. A me interessano la persona e la sua creatività: li scelgo così, non per il
timbro che hanno sullo strumento. Suono con Antonello Salis perché è Antonello Salis ed è
geniale: se invece della fisarmonica suonasse l’ocarina, per me sarebbe lo stesso. Così come
Mirko Guerrini: decide lui che sax suonare, l’importante è che sia lui. Ovvio, ci sono eccezioni:
quando ho fatto un lavoro su Frank Zappa volevo a tutti i costi il vibrafono, e ho cercato il
vibrafonista più adatto.
Alla fine, conta la musica.
Fra jazzisti non si parla così tanto di musica come si potrebbe supporre. Ancor meno in
termini tecnici. Ne facciamo - credo - una questione di magia. Da bambino immaginavo lunghe
discussioni e invece no, credo si tratti quasi di una legge non scritta e non detta secondo la quale
se la musica ha funzionato non c’è niente di cui parlare e in caso inverso non c’è bisogno di
entrare nei dettagli di quello che non ci ha convinto. Semplicemente, non era serata e avremo
modo di rifarci.
I musicisti fuori dal palco si aprono poco. Sul palco ci siamo divertiti, ci siamo detti un
sacco di cose senza parlare. Suonando. Abbiamo un canale in più, siamo dei privilegiati. Se
incontri musicisti aperti, salti le frasi fatte. Entri subito a un altro livello di comunicazione.
I duetti con altri pianisti, per esempio: mi è capitato con Martial Solai, francese, un uomo
che ha superato gli ottant’anni, tecnica mostruosa, una specie di Art Tatum contemporaneo: non
fa mai quello che ti aspetti, sta sempre creando, salta completamente dei passaggi che tu nella tua
testa utilizzi per ragionare, lo devi seguire. Persona di grande humour, un continuo ironizzare
con la musica e scartare di lato: fa una frase molto melodica seguita subito da uno sberleffo. Poi
dopo, a cena, parli di cose pratiche, inutili. Ti sei già detto tutto sul palco.
Con Chick Corea la cosa è diversa: sul palco con lui sto rischiando di più, perché se lo
ascolto troppo mi viene da imitarlo, sento i suoi dischi da quando sono bambino.
Lui è un uomo di settant’anni che tuttora parla molto di musica, di dischi: ascolta quello
che fai, rielabora, ci ragiona molto e ne parla anche a tavola ben volentieri, soprattutto può
passare molto tempo a sviscerare i suoi grandi amori, cioè i musicisti che ama.
Questo genere di figure che io chiamerei “generatrici di empatia” sono fondamentali per
un musicista. Uno così è anche Manfred Eicher, il produttore dell’etichetta tedesca ECM.
Quando sei in sala di incisione e lui è dietro il vetro mette una certa soggezione. Per lui hanno
inciso alcuni dei miei idoli, come Chick Corea, ma prima ancora Keith Jarrett; io ho cominciato a
incidere per lui nei dischi di Enrico Rava.
Eicher cerca di tirare fuori il meglio dal musicista. Cerca di tirare fuori la cosa che puoi
fare in quel momento e che non ti aspettavi di poter fare. Per questo è un grande produttore.
Vuole che tu per primo faccia qualcosa che a casa non avresti fatto. E come ci riesce? Spostando
l’attenzione su un dettaglio, piccoli consigli: è facile buttarsi giù quando dopo due ore che suoni
non hai ancora tirato fuori niente che ti piace. Se vede che ti accanisci su un pezzo ti dice di
lasciar stare. Nel jazz non si fanno troppe “riprese” dello stesso brano, si perde in freschezza.
Eicher ha così tanto carisma che i musicisti si lasciano condizionare e la musica prende una
direzione, che poi è quella che caratterizza i dischi ECM. C’è una linea sotterranea che unisce la
musica che produce, dal jazz norvegese di Jan Garbarek all’Argentina di Dino Saluzzi o il
Brasile di Egberto Gismonti.
L’incontro nella musica è fondamentale quanto delicato. Quando suono in ambito
classico cerco di adeguarmi alla situazione che trovo; talvolta sento di essere osservato con
sguardi da entomologo. A volte c’è l’orchestrale che viene subito a stringermi la mano e mi dice
che a lui piace il jazz e si annoia mortalmente a suonare in orchestra. Altre volte trovi quelli che
non ti guardano neanche e la cosa resta su un piano formale.
Poi c’è il capolavoro involontario del musicista che ti fa i complimenti per un concerto
tuo a cui ha assistito tre anni prima... (E tu pensi: “Ah, e stasera, ho fatto schifo?”.)
Io prediligo le sorprese.
E i musicisti che mi sorprendono sono quelli più lontani da me, dalla mia formazione,
come Rava, che è autodidatta e, quando improvvisa su una struttura, ragiona in maniera diversa
rispetto a me, che ho imparato da bravo bambino quale scala funziona sul tale accordo, quale
accordo funziona sulla tal melodia eccetera.
Quando suonammo insieme a Pat Metheny rimasi sorpreso dal fatto che non leggesse
molto volentieri la musica: preferiva imparare i brani a orecchio, come Salis d’altronde, il quale
poi se li ricorda per anni e non so assolutamente come faccia!
13
Ossi facili e ossi difficili
Improvvisare significa entrare in una strana relazione con il materiale su cui si è scelto di
lavorare, una sorta di scandaglio profondo che permette, a volte, di scoprire davvero lo scheletro
del brano; e di scoprire purtroppo, altre volte, che non ti piace improvvisarci sopra.
A me generalmente piace lavorare su composizioni semplici, perché si possono smontare
e rimontare. Nonostante ciò, a un certo punto mi ero messo in testa di fare un lavoro di
improvvisazione sulla musica di Sergej Prokof’ev, il compositore della magnifica favola
musicale Pierino e il lupo, che io adoro e sulla quale avevo già lavorato.
Subito però mi sono reso conto che il compositore classico ha montato le parti non
nell’unico modo possibile, ma con una tale logica, ferrea e meditata, per cui se si sposta un
elemento la musica cambia radicalmente e l’impalcatura non è più solida come prima.
Suonavo e ogni tanto osservavo Manfred Eicher al di là del vetro dello studio: era
impassibile. Brutto segno! La musica non fluiva davvero.
Alla fine ho abbandonato l’idea e mi sono messo a suonare tutto quello che mi passava
per la testa.
Nel disco Piano solo è rimasto un solo brano di Prokof’ev, un’improvvisazione su un
adagio giovanile del Piano concerto n. 1, un tema lineare, cantabile, che si presta a essere
estrapolato dall’insieme e trasformato in un canovaccio sul quale improvvisare, come fosse il
tema di una colonna sonora. Un’esperienza simile l’ha compiuta Herbie Hancock sul secondo
movimento del Concerto in Sol di Ravel, nel disco Gershwin’s world, ma ha scelto la via di
mezzo: l’orchestra suona esattamente la partitura di Ravel e lui invece improvvisa. Ma forse
andava scelta una strada unica, non un ibrido.
In gergo, lo “standard” è una canzone, un brano musicale su cui i jazzisti improvvisano.
Nelle pagine del Real Book, una raccolta di standard molto in voga fra gli studenti di jazz, le
canzoni sono ridotte a una paginetta con un numero esiguo di note e le sigle degli accordi. Si è
liberi di mettere le note nell’ordine che si preferisce, dove si preferisce e piace rispetto alla
battuta. Benché ci sia l’indicazione di un accordo, il pianista non lo suonerà ogni volta nello
stesso modo. La struttura non è mai una gabbia, bensì un trampolino.
Summertime di George Gershwin, ridotta all’osso, è fatta di pochissime note e otto
accordi. La medesima cosa la si può fare con l’adagio di cui sopra, che si può ridurre a poche
note e a qualche accordo, per poi rivestirlo diversamente. Per contro, la bellezza dell’intero
concerto di Prokof’ev non è l’osso bensì quello che c’è intorno, quindi bisogna fare molta
attenzione, come dicevamo prima.
Il jazz invece rosicchia l’osso, e lì trova il bello. Una canzone tra le mie preferite, il
samba Treni das onze, “il treno delle 11”, tradotta in Italia da Riccardo Del Turco con il titolo di
Figlio unico, si basa essenzialmente su una trovata della melodia: una sola! E su quell’unica
trovata puoi improvvisare quanto ti pare. È un osso facile. Sono in molti, i cantanti e gli
interpreti, che amano strutture semplici per poter poi inventare abbellire arricchire a piacimento.
Frank Sinatra, un interprete formidabile di canzoni, aveva addirittura i suoi compositori di
fiducia, come il grande Jimmy Van Heusen che per Sinatra scrisse dei classici come Come fly
with me, Like someone in love, Darn that dream, e molte altre. Sono strutture di trentadue
battute, semplicissime, formate generalmente da una parte A ripetuta due volte, poi una parte B e
di nuovo la A.
Una canzone dei Beatles è più complessa di un brano di Van Heusen. Nei Beatles
generalmente la B potrebbe avere un numero di battute dispari: oppure un cambio di tonalità
repentino, oppure essere una piccola divagazione del tutto fuori tema per poi tornare subito a
casa, alla A.
E ancora: gli accordi di un brano dei Beatles senza quella precisa melodia insieme alla
quale sono nati risultano magari strambi, e quindi, rispetto a Like someone in love - la cui
armonia è come una frase aperta, chiara, lineare -, non riescono a vivere di luce propria e a essere
usati come spunto.
Norwegian Wood dei Beatles è stata suonata abbastanza dai jazzisti, eppure non entrerà
mai nel repertorio di una jam session, e la ragione sta nella sua struttura “complicata”. Parte con
un microtema che sta su un accordo, ha un tema che si ripete diverse volte, ipnotico, che non
facilita le incursioni esterne.
Nel mio disco Smat Smat l’ho suonata, ma in una maniera che non definirei propriamente
jazzistica, piuttosto l’ho trasfigurata. Innanzitutto l’ho resa bitonale, usando un La maggiore alla
destra e un La minore alla sinistra. Due tonalità che viaggiano parallele sono la cifra stilistica di
compositori come il francese Darius Milhaud, ma sono effetti che fanno capolino qua e là in
qualsiasi musica (come nell’ultimo accordo di Tema do amor por Gabriela di Tom Jobim: La
minore sovrapposto a La maggiore).
Ispirandomi platealmente agli esperimenti di Lennie Tristano e Bill Evans, ho sovrainciso
due pianoforti e, non contento, ci ho aggiunto un terzo piano; ho accumulato, più che togliere, e
la canzone, lungi dall’essere stata smontata, è spinta al parossismo.
I pezzi dei Beatles nascevano in maniera particolare perché musica e parole venivano
create insieme, mentre gli autori di Broadway lavoravano separatamente: Jimmy Van Heusen
scriveva la musica e Sammy Cahn le parole. Addirittura c’erano compositori, come Jerome Kern,
che pare non sapessero o non amassero armonizzare, dunque una terza persona creava gli
accordi. E una quarta poi scriveva gli arrangiamenti, le parti per l’orchestra. Per il teatro e per il
cinema molte volte la musica nasceva in questo modo.
Le canzoni di John Lennon e Paul McCartney invece, contrariamente a quanto si crede,
non sono state scritte in coppia. Yesterday è di Paul, Norwegian Wood di John, per intenderci, e
via così. Fecero un accordo editoriale a inizio carriera per cui tutte le loro canzoni sono state
firmate da entrambi.
14
Comporre
Quando smonto e rimonto una composizione di Thelonious Monk o di Riccardo Del
Turco non mi faccio alcuno scrupolo. Le mie spesso sono composizioni troppo difficili, troppo
elaborate, io preferisco improvvisare su cose più semplici.
In veste di compositore posso dire che mi complico la vita. La complico anche ai
musicisti che suonano con me. Cerco l’originalità a tutti i costi: vengono trentadue battute, come
in uno standard americano... e allora ne devo aggiungere una in modo che siano trentatré! Viene
una conclusione logica su un certo accordo e allora devo per forza trovarne uno più improbabile.
Da sempre, comunque, la mia ammirazione va ai compositori di canzoni. Io non cerco di
scrivere uno standard perché ci sono già gli standard, e sono formidabili, sarebbe velleitario.
Nello stesso tempo, non vorrei scrivere cose complicatissime da compositore perché non
mi sento tale, non ho l’ambizione di un Gunther Schuller, che si è lanciato in esperimenti
ipermodemi cercando la cosiddetta “terza corrente” del jazz, teoricamente un incontro tra il jazz
e la classica.
Mi piacerebbe scrivere una cosa semplice e che funzioni. La cerco sempre, ma vado
anche in caccia della trovata, la particolarità, da jazzista. Ecco, là in mezzo, fra questi due paletti,
c’è una sconfinata terra da esplorare. Libera.
Il bello del jazz è la libertà. E penso ci siano svariati esempi di jazzisti che con la libertà
non hanno niente a che vedere, perché rifanno il jazz degli anni Quaranta o Cinquanta tale e
quale. O si danno talmente tante regole e tanti schemi che è come trovarsi di fronte a una
esecuzione di Chopin. Wynton Marsalis per esempio è uno che ama l’idea che il jazz diventi la
musica classica americana. Ma per fargli acquisire quello status, il jazz perderebbe in freschezza,
perché diventerebbe un monumento, una cosa da museo. Mentre i jazzisti dovrebbero potersi
muovere e non essere di marmo.
Lavoro al pianoforte, di solito mi vengono idee al sound-check, me le segno o me le
registro. Raramente mi siedo e decido che entro dopodomani devo scrivere tre pezzi, e non ho un
metodo prefissato.
Né una routine o una abitudine, come un Moravia che scriveva tutti i giorni tot ore.
Non riesco. Quando ho scritto un romanzo, La sindrome di Brontolo, stavo seduto a
rileggere e a correggere, e vorrei fare la stessa cosa con la musica, ma non mi riesce, mi annoio.
La realtà è che non mi sento un compositore. Il compositore è un’altra cosa: ha capelli
cotonati, di solito è un po’ sofferente e cura i dettagli. O forse dovrei essere soltanto più
indulgente con me stesso... Recentemente ho scritto un pezzo che non mi dispiace per il trio con i
due danesi, ma anche se poi decidessimo di non suonarlo non cambierebbe niente...
Tra le cose che ho composto (insieme a Paolo Silvestri) c’è il Concertane per trio jazz e
orchestra sinfonica, che in realtà è costituito da una serie di temi messi insieme, a volte
volutamente patchwork, provenienti da ispirazioni diverse. Il primo tempo per esempio era
ispirato da una poesia, Hymne des anciens combattants patriotes del surrealista francese
Benjamin Péret: mi era piaciuta e volevo musicarla. Infatti il movimento del concerto si chiama
Il vecchio combattente, ed è scritto sulla metrica di quella poesia: pacifismo ante litteram, contro
gli amanti della guerra.
L’ispirazione ogni volta arriva in maniera diversa, l’idea resta sospesa a lungo finché non
mi accorgo di averla copiata inconsciamente da qualcuno e allora di solito e con circospezione, la
metto da parte.
Johann Sebastian Bach non metteva neanche le mani sul clavicembalo per comporre!
Anzi, disprezzava chi lo faceva, li chiamava «i cavalieri della tastiera». Per gente come Bach la
composizione era un esercizio essenzialmente logico, una chiarezza della mente. Al cinema
abbiamo visto Mozart che detta il Requiem a Salieri sul letto di morte... Altri tempi... e che
eleganza!
Si è mai visto un jazzista che detta una improvvisazione mentre muore?
Io non ce lo vedo, John Coltrane, che mentre muore detta un “solo” a Sonny Rollins.
15
Amare, copiare, omaggiare
Io ho amato tanto Carosone.
Renato Carosone è un caso interessante. Proponeva uno spettacolo in cui suonava il
piano, da maestrone classico, con una spruzzata di jazz, usava ritmi provenienti dall’Africa,
cantava nel solco della tradizione napoletana non utilizzando solo il registro melodico ma
inserendo la macchietta, l’ironia, lo sfottò. In un colpo solo riusciva a fare mille cose, una sintesi
mirabile e unica. Erede di una grande e nobile tradizione, la usava per i suoi personali scopi.
E siamo al tema delle eredità da sviluppare. Prendiamo una grande eredità, quella lasciata
da Zappa.
Frank Zappa ha fatto cose incredibili, eppure oggi il rock è ingessato: i ragazzini che
fanno rock si muovono dentro codici rigidissimi, che sono: bisogna fare tre accordi, essere
sporchi, cattivi, di sinistra, o di destra, comunque contro il sistema, essere indipendenti.
Questo nonostante alcune eccezioni, come Robert Fripp che è arrivato e ha detto: «Io
voglio fare il rock, però mi alzo alle sette del mattino, vivo di discipline rigide e con
l’impassibilità del monaco zen suono in un enorme teatro tenda con gli occhiali scuri fissando un
punto preciso al centro del pubblico!». Difficile ripetere l’esperienza, perché parliamo di cose
autentiche. A Carosone e a Fripp esce tutto naturalmente; non vogliono provocare o stupire, e
chissà che non sia per questo che poi non fanno scuola!
La musica è fatta di influenze, spesso sotterranee, invisibili, che però sono fondamentali,
anche per capire cosa si sta ascoltando. E Frank Zappa in questo senso è un caso limite, molto
interessante. Per lui il mondo dei generi musicali non aveva senso, quindi lo dissacrava. Zappa
cambiava venti atmosfere in un solo brano, con intenzioni parodistiche.
E su questo intento parodistico costruisce un linguaggio: ci sono pezzi dove ogni due
minuti ti dà una serie di “schiaffi”. Non è mica facile, in musica. Noi accettiamo Se una notte
d’inverno un viaggiatore di Italo Calvino perché esiste una premessa che ci mette sull’avviso, se
non ci fosse saremmo lì a chiederci: “Ma che succede? Perché questi continui cambi di
registro?”. (Che ci sono anche in Francis Poulenc, in Hermeto Pascoal, in Django Bates, in tanti
altri.)
Zappa si assume questo rischio. È come se mettesse le virgolette, che sono stacchi
musicali, e produce citazioni a raffica: c’è un disco in cui, quando parte il ritmo latinoamericano,
si sente il rumore dell’aereo che decolla. Non è casuale che Zappa emerga nel periodo della
musica cosiddetta “fusion”, altrimenti detta jazz-rock, una mistura piuttosto rigida dei due generi
che io personalmente ho sempre un po’ patito, proprio perché avanzava per blocchi, un po’ come
certa musica contemporanea scritta: non fluisce; i blocchi si susseguono per spostamenti rigidi.
Zappa diceva: “Ah, sì? Vi piace il patchwork?”. E si metteva lì e faceva un patchwork più
patchwork di tutti. Scherzando anche sulle cose che gli piacevano, dal doo wop anni Cinquanta
al jazz di Eric Dolphy.
Gli piacevano i Beatles, eppure li prendeva di mira. Nel già citato Sgt. Pepper’s c’era un
po’ di tutto: l’orchestra sinfonica, il minimalismo, il sitar indiano, mancava solo il jazz. Il
risultato è un capolavoro perché ebbero l’intelligenza di tenere separate le citazioni e la
commistione non esclude che loro restino i Beatles. Zappa però prende bene la mira e va a
colpire subito il loro punto debole (e dichiarato): la voglia estrema di essere rivoluzionari usando
miriadi di informazioni per mettere in scena il trionfo del pop.
E subito dopo la pubblicazione del loro disco, nel 1968 lui esce con We’re Only in It for
the Money, un disco la cui copertina è la parodia della copertina dei Beatles, piena di personaggi
famosi accostati fra loro casualmente, da Marilyn a John Wayne passando per Gandhi ed Elvis...
Zappa non ha potuto diventare un caposcuola, perché la cover-band che rifà i brani di
Zappa non ha capito che non si può rifare, dal momento che lui era già una parodia. Ciò
nonostante, la cosa più “zappiana” che esista è italiana: Elio e le Storie Tese.
Elio è uno Zappa tradotto in italiano con l’aggiunta di una serie di altri elementi dal punto
di vista musicale: Zappa massacra il country e Johnny Cash e colpisce i Beatles e Bob Dylan,
mentre Elio deve colpire Paolo Vallesi e Amedeo Minghi.
Però la modalità è la stessa, Elio è diplomato in flauto e Zappa adora Edgar Varèse e
Aaron Copland, sono entrambi di provenienza “colta” (ahi! che brutto termine).
Zappa fa il rock, l’irriverenza è rock. Elio ha alle spalle il cabaret dei Gufi, funereo,
caustico e anticonvenzionale. In aggiunta, il gruppo di Elio è composto da bravissimi musicisti.
L’intento è quello di dissacrare, è una metamusica, è una lettura critica, sebbene a volte
escano degli enormi boli da risata grassa: ma c’è sempre la doppia lettura, lì, a portata di mano.
Elio se la prende con vizi e modelli che noi ben riconosciamo.
Zappa ha forse riassunto tutto quando si è candidato alle presidenziali americane e ha
detto che secondo i sondaggi fatti presso il pubblico dei suoi concerti lui stava vincendo.
Geniale.
E poi gli chiedono: «Perché gli americani devono votare per lei?». «Io almeno odio il
golf» risponde.
Zappa si definisce in relazione a quanto sbeffeggia gli altri. Si definisce spesso “in
negativo” rispetto al resto del mondo, che addita, giudica, riempie di buffetti o cazzotti.
È una funzione rigeneratrice, la sua. Svelare il ridicolo in mezzo alla tragedia.
O il contrario.
Zappa, amato anche dai compositori “colti” (aridàje!), forse solo perché fu sdoganato
dalla London Symphony e da Pierre Boulez, chissà, è il vero eroe del postmoderno. Un
esperimento come il suo non lo si sente più in giro.
Prima di lui, tanta ironia, ben più sottile.
Erik Satie che prende una canzonetta e la trasforma in altro, Darius Milhaud che prende
un ritmo sudamericano e gli appoggia sopra due melodie che si muovono in tonalità diverse fra
loro. Stravinskij che infiltra i vezzi del tango o del ragtime nella propria musica mantenendo
sempre il proprio ardito linguaggio musicale senza una sola concessione, senza arretrare di un
passo.
16
I generi musicali
I generi musicali sono nati per poter parlare di musica e sono diventati una moda,
portandosi dietro culture e contesti sociali ma anche idiosincrasie. Può capitare che una persona
non vada ad ascoltare un concerto perché sulla locandina c’è scritto “jazz” senza sapere che si
sarebbe trovato di fronte Richard Galliano, un sublime fisarmonicista, che lo avrebbe fatto
impazzire con i valzer parigini, i tanghi e molte altre cose bellissime...
Il genere musicale può creare una barriera e spaventarci, e così perdiamo la possibilità di
provare certe emozioni e di cibarci di cose nuove.
Bisogna sapere cosa cercare nella musica, come nella vita. “Chi cerca trova”, dice il
saggio...
Se decido a tavolino che una donna è bella solo se è alta, o se è bionda, allora è finita: mi
sottraggo da tutta una serie di esperienze possibili.
I generi musicali avrebbero un’origine nobile, vale a dire la destinazione d’uso: la musica
per il matrimonio, per il funerale, per la festa, la musica per la meditazione. E ancora: la musica
per il teatro, la musica per accompagnare le funzioni religiose, la musica del martedì, del
giovedì, la musica per il vespro. Destinazioni, queste, in genere ormai tramontate o, peggio,
scivolate in imbarazzanti equivoci. Il festival etnico invita il coro della Tanzania e, invece di
andare in Africa ad ascoltare la musica nel suo contesto, si prendono quei musicisti e li si mette
sul palco di un teatro all’italiana, come allo zoo. Il coro canta prima la musica del matrimonio e
poi quella del funerale e il pubblico, in delirio, che applaude: il che va benissimo, per carità, a
patto che non si dica poi di aver “compreso”.
Il pubblico non ha colto la differenza fra i due brani; non può, giustamente: non ha gli
strumenti per farlo. E anche per i musicisti può essere una strana esperienza: di solito quella
musica la cantano al funerale mentre ora sono in un teatro di fronte a una platea di gente seduta
che, purtroppo, fa finta di emozionarsi.
Ennio Flaiano, ascoltando in casa di amici dei canti popolari, li definiva «folclore dal
sapore vagamente ricattatorio».
Persino il rock and roll è nato come una danza: il termine fu inventato da un DJ
radiofonico ed è diventato paradigma di un intero mondo, quello dei “giovani” (contro i
“matusa”, come direbbe Elio).
E da lì in poi si incidono dischi per i giovani, si scrivono libri per i giovani, si vendono
oggetti vestiti applicazioni da computer per i giovani.
Prima degli anni Cinquanta del secolo scorso, mica esisteva la categoria dei “giovani”.
Che è stata inventata - e resiste tuttora - per fini consumistici.
Negli anni Trenta i surrealisti non si dichiaravano “giovani”. Guardate le foto d’epoca:
sono lì in giacca e cravatta che si danno un tono, altro che giovani! Eppure sono loro ad avere
coniato gli slogan poi ripresi nel Sessantotto (“L’immaginazione al potere”). Loro sì erano ribelli
nelle cose che contavano, non nel look.
La ribellione di un surrealista era contro un padre immaginario, contro un Nietzsche,
mentre i “giovani” di venti anni dopo si ribellano molto più semplicemente contro il vero padre
che non li fa uscire per andare a ballare, una cosa, converrete, ben più spicciola.
E da lì in poi rischiano costantemente di venire inscatolati in ribellioni create ad hoc da
un partito, un movimento, un mass media... O da un gruppo musicale.
Quando ai giovani tolgono il “roll”, cioè lo sbandamento del ballo, il rock diventa un rito,
una religione di massa, in cui si va ad adorare il cantante dannato che probabilmente morirà o sta
già morendo lì sul palco e che ha sostituito l’eroe del jazz che non era necessariamente bello
(facciamo pure una eccezione per Chet Baker), non era ricco e moriva nell’anonimato. Se ne
andava come aveva vissuto, moriva a titolo personale, senza incarnare i sogni di una
generazione.
Insomma, i generi sono etichette che provengono da origini esterne alla musica, volute
perlopiù dai mass media.
E, insieme, ecco apparire un altro bel termine: la “musica commerciale”.
Mah... Disco-music, ecco, musica da discoteca, mi pare un termine onesto, che definisce
una cosa piuttosto precisa, con una sua funzione netta: far ballare. E dove? In discoteca, è scritto
nel nome!
Ma se cominciamo a parlare di musica commerciale diventa difficile intendersi: quasi
tutta la musica è commerciale. Anche la Quinta di Beethoven viene pubblicata su disco e
venduta.
E “musica d’ascolto” invece cosa vuol dire? Ahi, orrore!
Azzardo una spiegazione: si tratta di un imperativo, e neppure troppo mascherato. Musica
d’ascolto: la devi ascoltare a tutti i costi. E in silenzio. Micidiale.
Eppure si usa ancora.
“Scusa, tu fai musica d’ascolto?” E che domanda è? Presuppone che tutta l’altra musica
vada fatta passare non dalle orecchie ma dal naso? O dalla bocca?
Ancora una volta non usiamo termini musicali.
Li usiamo nei media per semplificare le notizie, dando sempre per scontato di aver a che
fare con un pubblico bue.
17
Carioca
Antonio Carlos Jobim prende le mosse da Chopin. Sia Retrato em Branco e Preto che
Insensatez vengono da un medesimo studio di Chopin, nel senso che si ispirano armonicamente
alle prime battute dello Studio numero 6, opera 10, in Mib minore.
Sono accordi molto ricchi, che potrebbe usare un Bill Evans in ambito jazz ma che
nessun autore di canzoni contemporaneo di Jobim (i nostri gloriosi Tenco, Endrigo, Bindi, Paoli)
userebbe.
La struttura di Retrato em branco e preto (“Ritratto in bianco e nero”) si avvicina ai
“lieder durchkomponiert” di Schubert.
Cosa significa? Che brani come quello citato, ma anche Chega de saudade per citare un
altro hit, non si possono suddividere in sezioni come gli standard del jazz (solitamente A AB A).
Sono ABCD, cioè composti di sezioni che non si ripetono. Sono canzoni più complesse.
Tanto è vero che gli interpreti brasiliani cantano sia la strofa sia il ritornello con eguale
intensità, mentre nella tradizione della nostra musica leggera attendiamo “a gloria” il ritornello,
che di solito è in tonalità maggiore anticipato da una strofa magari in minore proprio per creare
l’effetto di contrasto.
La canzone di Antonio Carlos Jobim no: non segue questa logica.
Ma ci sono casi ancora più singolari, come Águas de Março, che è quasi una filastrocca,
tanto che Giorgio Calabrese l’aveva tradotta per Mina proprio usando termini infantili (“madama
dorè”, “il babau”, “la fata Morgana”) come si trattasse di un gioco. Poetico, ma pur sempre un
gioco.
Questa canzone è un esempio straordinario, direi quasi unico, di una semplice trovata
melodica - ma semplice semplice - che si ripete in continuazione variando di pochissimo.
È una trovata paragonabile forse a Se telefonando di Ennio Morricone, una struttura
circolare. Se non fosse che Se telefonando sale di tonalità mentre Águas de Março non si pone
neppure questo problema.
Se telefonando è una storia d’amore struggente: il succo è “Vorrei lasciarti e non so come
fare”... insomma, un’aria d’opera, non a caso introdotta da una brevissima strofa poi subito
lasciata in un angolo, come fosse un recitativo, a raccontare l’antefatto.
Águas de Março non racconta alcuna storia, è una sospensione totale, un elenco di cose,
stupefacente, canta la bellezza.
Vogliamo parlare della Garota de Ipanema? (“La ragazza di Ipanema”).
Ha una parte B elaboratissima, che non ha pari in alcuno standard americano, e che
comincia nientemeno che con un sospiro! (Nella versione di Sinatra il sospiro diventa un “uuuh”
o, se preferite, un “mmh” ben più marpione).
La canzone di Jobim ti entra in testa ma senza dare l’impressione di essere stata scritta
con quell’intento, bensì per via di un impeto poetico: e non annoia mai. Garota de Ipanema
risuona da più di cinquantanni nei piano-bar, negli ascensori, sugli aerei di tutto il mondo e
nessuno si stanca.
Conoscevo la bossa nova ma lì mi fermavo, prima di andare la prima volta a Rio nel 2006
con il mio gruppo, i Visionari.
In quel caso abbiamo registrato il progetto Carioca. E ho incontrato, oltre a un pugno di
grandissimi musicisti brasiliani, un repertorio sconfinato che prendeva il nome di “choro”.
E ancora una volta parliamo di generi musicali... i confini, in Brasile, sono sfumati tra
musica alta, erudita e pop.
Il compositore colto Heitor Villa-Lobos, osannato oggi in tutti i programmi di musica da
camera, poteva suonare choro alla chitarra in un bar sotto casa sua e la popstar Djavan canta
tranquillamente Villa-Lobos e nessuno si scandalizza. Il grandissimo Radamés Gnattali prendeva
vecchi choro e li arrangiava per sestetto o per l’orchestra della radio reinventandoli
completamente, poi scriveva anche musica sinfonica.
Il samba è una grandissima invenzione che tiene insieme i poveri delle favelas e i
playboy bianchi. Tutti ballano il samba, tutti si riconoscono nel samba. Ha fatto da collante fra
popolazioni diversissime fra loro. Neanche la religione sarebbe riuscita a fare altrettanto.
Il jazz e la musica brasiliana si incontrano spesso perché sono due grandi musiche
meticce e che hanno fame: e sono onnivore, trovano qualcosa che a loro piace e se la vogliono
mangiare, introiettare.
Pensate agli albori del jazz, che a volte crea un nuovo stile instaurando un rapporto di
fresca imitazione di qualcosa, al limite della parodia: il ragtime è una specie di musica da salotto
americana. A Parigi le ragazze di buona famiglia si dilettavano con la polacca di Chopin.
Il musical è l’operetta viennese ma senza quel senso di decadenza e di favoletta possibile
da qualche parte in un qualche tempo imprecisato in un ducato lontano, bensì farcito di tutta
l’opulenza possibile e piegato all’idea del sogno americano.
King Oliver considera normale storpiare una marcia funebre, perché noi a New Orleans
vogliamo vivere anche se siamo a un funerale, okay, vi è chiaro?
Anzi... Se dalla Germania nazista ci mandate una melodia chiamata Moritat von Mackie
Messer scritta da un certo Kurt Weill, noi la carichiamo di swing, la traduciamo in inglese come
Mack the knife e ci improvvisiamo sopra, con allegria. Via le sovrastrutture ideologiche. Brecht?
Brecht chi? A noi interessa lo spiritaccio che si annida in quei quattro accordi piazzati bene.
Questo è lo spirito che anima il jazz all’inizio. C’è un popolo in grande difficoltà (schiavi e
immigrati) in marcia verso la gioia.
I brasiliani cannibalizzano in maniera ancora più spinta, cioè si rimangiano tutto, da Jimi
Hendrix a Gerry Mulligan, digeriscono tutto come nel Manifesto Antropófago redatto nel 1928
del poeta Oswald de Andrade, perché bisogna capire prima di tutto che il Brasile è
brasilocentrico. Per il Brasile tutto è Brasile, è l’unico paese al mondo dove nelle canzoni
vengono nominati continuamente fiumi, città, gli altri compositori, i poeti. E non c’è altro paese
dove le religioni vivono tutte insieme perché va bene così, perché Deus è brasileiro, come diceva
non a caso il titolo di un film di laggiù.
Nel film di Glauber Rocha, Deus e o Diabo na terra do sol, Dio e il diavolo si scontrano
lì, nel sertão, il deserto baiano, mica in Vaticano!
Le religioni ci sono, eccome, ma la vita è la vita e il brasiliano cerca il proprio cammino
personale fuori dai dogmi. «È proibito proibire» cantava Caetano Veloso.
Tutto è brasilianizzato in Brasile. Okay, esistono i Beatles e i Rolling Stones, ma in
Brasile che fanno? Inventano il samba-rock. Gilberto Gil vuole rifare Bob Marley? Okay, ecco il
samba-reggae.
Caetano Veloso ha rifatto Billie Jean e non ne è uscito nemmeno un omaggio a Michael
Jackson, è una cosa sua, totalmente originale: al giornalista che gli chiedesse perché lo fa
Caetano risponderebbe perché sì, non c’è una ragione: lo faccio e basta. Quando gli hanno
domandato perché ha inciso un disco in spagnolo ha risposto: «Per ampliare il mercato». E
perché l’omaggio a Fellini? Perché da bambino guardava i film di Fellini. Le canzoni americane?
Perché le sentiva alla radio. Cioè, si può fare qualsiasi cosa e tutto con la massima naturalezza.
Per piacere. Per amore della musica, omaggiando i propri eroi, portandoli in palmo di mano ma
anche in avanti, in pieno presente, e magari verso il futuro.
João Gilberto è un caso abbastanza unico di qualcuno che, impermeabile all’esterno, ha
fatto per tutta la vita la stessa cosa e ha influenzato tutti.
Ha una missione per conto di Dio, come dicevano i Blues Brothers, quasi asociale: non
ascolta. Lo si vede in un video con Jobim. Lui tira dritto. E Jobim al pianoforte è costretto a
seguirlo mentre taglia qua e là dei quarti su Corcovado (che Jobim stesso avrebbe composto,
ehm).
Nel disco in cui suona con l’orchestra sinfonica diretta da Claus Ogerman, João ha inciso
prima la sua voce e la sua chitarra e l’orchestra dopo. Mi piace immaginare che a quel punto lui
se ne fosse già andato.
Ecco, se c’è uno che ha ispirato João Gilberto è Chet Baker: il tono dimesso, quel modo
di cantare da non cantante, al limite della stonatura, che diventa tenero, affascinante. Il cantante
bravo rischia spesso di non comunicare, mentre quello con i difetti può commuovere, con
l’onestà e senza trucchi. Frank Sinatra, che non aveva la tecnica di Ella Fitzgerald, commuoveva
eccome...
Joào Gilberto negli anni Settanta aveva ascoltato Estate di Bruno Martino alla Bussola e
poi l’aveva rifatta togliendo il verso “Odio l’estate”, perché lui, baiano, non poteva dire quella
cosa: odio l’estate! Ma siamo pazzi?
Caetano Veloso, baiano pure lui, è un caso compieta- mente diverso.
Non c’è un solo Caetano, si direbbe quando lo si analizza. C’è il polemista, l’intellettuale,
poi il Caetano che vuol fare l’avanguardia e viene mandato in esilio in periodo di dittatura, c’è il
provocatore che toma in patria e si veste da donna cantando samba. E c’è almeno un altro
Caetano, che è per noi il Caetano raffinato di una certa età, portatore di poesia, commovente,
intimo. Come nel film di Almodóvar, Parla con lei, in cui la sua apparizione è una nuvola di
bellezza in un film pieno di tragedie. Nello stesso tempo, anzi proprio in virtù delle sue molte
facce, Caetano è pop. Io ho visto da vicino il performer e il poeta, che può cantare qualsiasi cosa,
anche l’elenco del telefono, e renderlo magico: abbiamo suonato insieme a Umbria Jazz, prima
di rientrare per l’ennesimo bis (non avevamo più nulla che avessimo provato) io gli ho proposto
A voz do morro, un antico samba di Zé Kéti, e Caetano l’ha cantata in una tonalità troppo alta per
lui - non c’era stato il tempo di concordarla - ma con la freschezza di un giovane che si butta, ci
prova, senza arroganza. Ecco un altro tema che esiste in musica: la generosità.
E poi Caetano canta benissimo i brani napoletani, Luna rossa su tutti, per motivi
musicali, non solo sentimentali.
Napoli e il Brasile sono due stazioni della stessa linea ferroviaria. E in mezzo c’è il fado
portoghese. La maniera di cantare, chitarra e voce. E i temi: il ricordo, il lutto, l’amore lontano.
La Bahia di Dorival Caymmi, grandissimo, che scriveva canzoni fatte di pochi versi,
semplicissimo, poetico, molto efficace. E la grande differenza con i francesi e gli argentini, i cui
temi sono più cittadini, si relazionano a cose che accadono davvero: mentre il napoletano, il
portoghese e il brasiliano stanno ricordando qualcosa che è già accaduto o che sperano che
accada, o che forse non accadrà mai, che è la stessa cosa: nostalgia, saudade; nel tango no... in
ogni strofa succede qualcosa, volano i coltelli!
I’ te voglio bene assaje è al presente per modo di dire, lui canta che le vorrà sempre bene
e che morirà per lei facendola struggere di sensi di colpa. Munasterio ‘e Santa Chiara è la
speranza che il tempo non passi mai a cambiare le cose che abbiamo conosciuto in gioventù.
I nostri cantautori della scuola genovese si erano innamorati musicalmente anche dei
brasiliani, non solo dei francesi.
«Era una casa molto carina, senza soffitto senza cucina» (un testo cantato da Endrigo su
una musica di Vinícius de Moraes). Perché è al passato?
E ancora... «Chissà se finirà, se su quel fiore una farfalla volerà», da quella canzone di
Endrigo che cantava non a caso anche un brasiliano doc, Roberto Carlos: in Canzone per te si
usa il futuro ma per parlare di un presente che si teme già in odore di passato. Lontano lontano di
Luigi Tenco ha lo stesso impianto. “Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ricordare i miei
occhi, i miei occhi che ti amavano tanto...” Come nelle opere di Vinícius de Moraes... E il
presente dov’è, il presente, in questi poeti impegnati a fare altri progetti, mentre la vita accade?
18
Si può parlare di musica?
Mi sono abituato a parlare di musica a suon di interviste. Più di quanto capitasse a un
musicista d’altri tempi, perché oggi ci sono molti più mass media: giornali, radio, TV, ma anche
blog, siti, fanzine. Ne faccio una al giorno. Di conseguenza, io che parlo tanto di una seria
distinzione in campo musicale, quella che faceva Ellington fra musica bella e musica brutta; io
che penso come Pat Metheny che sia possibile dividere i musicisti in due categorie, quelli che
suonano la musica del mondo in cui vivono e quelli che suonano la musica del mondo in cui
VORREBBERO vivere; io che non amo il termine “contaminazione” perché - come dice Paolo
Fresu - sa di ospedale; io che non amo definire questo e quello in termini di generi musicali, poi
alla fine mi trovo a usare questa terminologia più volte al giorno.
D’accordo allora... Usiamo pure questi termini, ma non quando immaginiamo la musica
né tantomeno quando la ascoltiamo.
In altre parole, si può anche parlare di rock, di reggae, di ritmica latina, di
accompagnamento jazz, di “tiro” funky, ma poi si dovrebbe ascoltare la musica. Perché spesso,
parlandone, si descrivono dettagli in maniera peregrina; cioè se io dicessi che Debussy usa degli
“accordi di quarta” e compone pensando a scale musicali orientali, direi il vero, okay. E
potremmo parlare di orchestrazione, di concatenazione degli accordi, di sviluppo del tema e via
dicendo.
Ma sono termini tecnici, che il lettore medio non riesce ovviamente a padroneggiare. E
allora ci si lancia a dire che Debussy usa sonorità liquide o che “il suo legame con il simbolismo
di Mallarmé” o che “la sua francesità fin de siècle” e blablabla tutto bello e a volte pure poetico
ma tutto riguardante le cose INTORNO alla musica, non la musica in sé.
I titoli di Debussy sono stati proposti dai suoi amici, dopo aver ascoltato le composizioni.
Le suggestioni extramusicali di Debussy sono extramusicali, certo, ma le suggestioni musicali
sono musicali (monsieur de La Palisse starà fermo immobile nella tomba, dalla gioia, dopo
questa affermazione).
Parlare di musica è diventato infine parlare di tutt’altro. Con nessun giornalista mi
metterei a parlare di un arrangiamento dei Visionari. Senza la pretesa di essere Debussy, anch’io
avrei i miei bei dettagli da discutere, posto che a qualcuno possano interessare.
E invece dirò che in quel brano abbiamo scelto di avere una sonorità funky, e si fa prima!
D’altronde anche il pittore non parla mai dei materiali che usa.
Nel primo Novecento i musicisti frequentavano i letterati e si erano messi a parlare con i
termini che avrebbe usato Jean Cocteau, in termini letterari, ironici, aulici, con riferimenti alla
pittura, alla scultura, allo strutturalismo, alla psicanalisi, al sesso; e dunque tutti noi quando
parliamo di musica siamo dentro ad altre categorie, parliamo per colori oppure per sensazioni,
emozioni... “questa musica così romantica...”.
Ma cos’è il Romanticismo? Dovrebbe essere una corrente ben precisa, dovrebbero essere
Chopin e Liszt, invece vien fuori - per estensione, ma accidenti che estensione! - che se ci
commuoviamo di fronte a un tramonto, o se qualcuno dice: “Ti amo”, o se regaliamo un fiore,
siamo romantici.
«Le parole sono importanti» diceva Nanni Moretti, e non gli si può dar torto. E molte di
quelle che usiamo per parlare di arte e di emozioni hanno cambiato il loro significato più di altre.
C’è un problema in più, con la musica. Tutti in fondo possiamo parlare di un romanzo
senza necessariamente avere gli strumenti critici di Harold Bloom o di Giacomo Debenedetti,
no? Possiamo quantomeno raccontarne la trama, come ci insegnavano a scuola, senza tirare in
ballo le nostre emozioni o opinioni personali.
Con un brano musicale la cosa sarebbe piuttosto bizzarra. O meglio: potremmo farlo
riferendoci unicamente al testo di una canzone.
Che so... Emozioni di Battisti-Mogol è un brano che parla di tanti piccoli pensieri, a volte
senza senso, che a ognuno di noi è capitato di vivere o anche solo di immaginare.
Ma se invece volessimo parlare di Giant steps di John Coltrane?
E quante volte i grandi compositori dovevano scrivere quel brano entro il tal giorno, altro
che urgenze creative...
Nel periodo delle avanguardie storiche, i musicisti come Satie, Debussy, Ravel,
Stravinskij tendenzialmente volevano occuparsi di musica. Questo il loro primo pensiero. Al loro
fianco, i Cocteau e i Breton volevano sovvertire l’ordine delle cose.
Ma quando i musicisti sparavano giudizi sui loro contemporanei, spesso erano giudizi
dettati da uno scontro di ego o da problemi di rapporti interpersonali, vicende di vita privata,
antipatie, piccole invidie.
Debussy amava Wagner, Satie amava la musica antica, Ravel adorava i neoclassici.
È improbabile che i musicisti vogliano usare la propria musica come arma. Kurt Weill
incontrò sulla sua strada Bertolt Brecht, se no chissà... avrebbe continuato a scrivere sinfonie e
concerti per violino come da giovanissimo... E subito dopo aver lavorato con Brecht a opere e
cantate che hanno lasciato un segno nella storia sociale dell’arte e del mondo, è finito a
Broadway a scrivere canzoni, è entrato a far parte proprio di quel mondo che nel teatro con
Brecht usava in maniera sarcastica, a mo’ di citazione.
I grandi che hanno fatto la storia del jazz non volevano prendersela con quelli venuti
prima di loro, farli scendere dall’altare e sostituirli. Charlie Parker e Duke Ellington non hanno
mai fatto proclami. Ma anche i Led Zeppelin, i Beach Boys, i Beatles non ne fanno. Give peace a
chance canta John Lennon, e parla di amore e rivoluzione, ma se ha un bersaglio sono i politici, i
potenti... Non si tratta certo di altri musicisti, per i quali nutre grande rispetto.
Insomma, più parliamo di musica più ci allontaniamo dalla cosa in sé...
In un vecchio e favoloso numero televisivo della TV inglese anni Sessanta, Dudley
Moore fa il rocker che canta una canzoncina in slang americano, ricca di allusioni sessuali e in
definitiva soprattutto di rime buttate là perché suonino bene e accompagnino la danza (Groovin’
the bag, Mama).
Peter Cook, nella parte del giornalista molto british, si siede con lui per analizzare il testo,
alla ricerca del significato, per poterlo poi spiegare agli ascoltatori, come se questo tipo di analisi
potesse aiutare il pubblico inglese a comprendere meglio lo spirito del brano. Ne viene fuori una
gag comica formidabile.
19
E parlare di cultura?
Il 1° dicembre 2007 Umbria Jazz e il governo brasiliano hanno organizzato una serata in
una favela di Rio chiamata Pereira da Silva, detta anche Morrinho, dove non domina più il
narcotraffico. Il palco era stato sistemato in un campo sportivo ai piedi della favela con l’aiuto
degli abitanti. A un certo punto alcuni degli uomini che lavoravano in città salendo la strada per
tornare a casa hanno intravisto le macchine della polizia (che era il servizio d’ordine del
concerto) e hanno cominciato a sparare, dato che una macchina della polizia dentro una favela
può voler dire solo una cosa: vengono a massacrarci. Bisogna tenere presente che gli abitanti
delle favelas perlopiù non sono iscritti all’anagrafe dunque letteralmente NON ESISTONO. Chi
ha visto il meraviglioso film Cidade de Deus ne sa qualcosa.
Insomma, fortunatamente non sparavano sul pianista, e l’inconveniente si è risolto
velocemente con l’intervento di alcune donne che hanno spiegato ai loro uomini che andava tutto
bene, si trattava solo di una occasione speciale, un concerto.
Per la seconda volta un pianoforte a coda entrava in una favela di Rio. Il pianoforte era
anche lo stesso, identico. (Devono aver pensato: “Se è sopravvissuto una volta, rimandiamo
lui”.) Ma la prima volta il pianista era Tom Jobim. Scusate l’annotazione e la botta con annessa
ruota del pavone, ma quando ci vuole ci vuole.
È solo un preambolo per raccontarvi che il giorno prima ho potuto fare un giro per la
favela, dunque salire fino in cima alla collina. Naturalmente accompagnato da un ragazzo, un
diciottenne, che abitava lì. A ogni angolo c’era gente che mi guardava come se fossi un alieno,
ma bastava che lui facesse un cenno col capo perché potessimo proseguire senza problemi.
Questo sì che è stato un privilegio da pochissimi.
Ed è accaduto perché dovevo andare a visitare una specie di plastico che cinque anni
prima, per gioco, gli abitanti avevano cominciato a costruire in cima al monte, cioè una favela in
miniatura, fatta con mattoncini e con qualsiasi tipo di materiale raccattato qua e là.
Il plastico non era soltanto una scultura permanente ma era anche un gioco. Ognuno dei
partecipanti poteva gestire un personaggio. Se moriva, per esempio ucciso dalla polizia, non
poteva più continuare. La polizia entrava spesso in una certa zona della favela dove la mia guida
di conseguenza (me lo ha detto con una faccia schifata) non andava volentieri, anzi la
sconsigliava.
C’erano anche le terme per far rilassare i personaggi, dove i maschietti oltre ai massaggi
potevano ottenere anche ben altro.
L’opera di questi ragazzi era stata scoperta da un critico d’arte il quale poi li ha invitati
alla Biennale di Venezia perché allestissero là la loro piccola favela.
Dunque i ragazzi del Morrinho trascorsero due-tre mesi (credo di ricordare) a Venezia,
dove, mi riferiva il mio accompagnatore, hanno tentato di giocare a pallone in tutti gli angoli,
impresa non semplice nella città lagunare.
Il fulcro del racconto è questo. A un certo punto il ragazzo mi guarda e mi dice: «Per me
tutto è iniziato a quindici anni come un gioco (e anche come sfogo legittimo, vista la situazione
di degrado in cui sei cresciuto, aggiungerei io, ma zitto). Ora arriva questo che mi dicono essere
un signore importante e ci spiega che è Arte. Boh. Io so solo che, se comincio a pensare che è
Arte, non mi diverto più, dunque continuo a pensare che sto facendo un gioco».
Voi, da europei che devono tenere un concerto lì il giorno dopo e che arrivate col
pianoforte a coda, il gruppo, l’impianto e l’ufficio stampa di Umbria Jazz, la BBC al seguito,
l’Hotel a Copacabana, come vi sareste sentiti?
Il minimo - ed è veramente il minimo - che posso fare a questo punto è tenere a mente la
frase e il modo in cui mi è stata affidata da quel ragazzo. E tentare di applicarla al mio modo di
vivere la musica. Ora che l’ho anche scritta, la rileggo e mi suona sempre più saggia.
20
La musica è seduzione?
L’ego ce l’abbiamo tutti. Ultimamente viene anche nutrito con cibo scadente. Tanto vale
dargli da mangiare roba buona.
Più metti il tuo ego al servizio della musica, più ne guadagna la musica e più ne guadagna
il tuo ego. Cioè viene gestito, ridimensionato, veicolato verso qualcosa di creativo. E sempre
comparato a qualcuno che ha fatto musica prima di te e che ti ha ispirato, che ti ha folgorato e ti
ha fatto scegliere quella strada. O costantemente affiancato a qualcuno che sta producendo suoni,
canzoni, sinfonie, improvvisazioni, che tu non potresti produrre, che sono lontane da te o dalle
tue possibilità ma che ti incantano.
È innegabile che, quando sali su un palco, il tuo ego in qualche modo ha a che fare con la
seduzione. Insomma, uno si scopre animale seduttivo ma non per questo misterioso... Qui volevo
arrivare.
Nel mestiere del musicista non c’è niente di misterioso.
Count Basie, anzi, abbassando parecchio il livello della discussione, diceva dal microfono
presentando la sua big band: «Stasera siamo così contenti di suonare per voi che lo faremo gratis.
(Pausa, magari un applauso.) Però vogliamo essere pagati, e molto, per i chilometri di furgone
che abbiamo fatto per arrivare fin qui».
Per sedurre bisogna fare attenzione a non giocarsi subito tutte le carte. Il mio insegnante a
Siena Jazz, il pianista Stefano Battaglia, me ne parlò in termini molto chiari: «Bel solo hai fatto
su quel blues, ma dopo due chorus avevi già detto tutto. Invece devi avere il coraggio e la
sicurezza di prenderti i tuoi tempi e non buttare in campo tutto come farebbe appunto un
insicuro, passando poi per aggressivo».
Da bambino io volevo far ridere: gli amici, il pubblico occasionale, chiunque.
E volevo l’applauso perché avevo fatto ridere.
Non volevo sentirmi dire “bravo”: non ho mai considerato la musica e il palcoscenico in
termini di bravura, di abilità, di gara.
... E pensare che esiste il campionato mondiale di fisarmonica! Per decidere chi è il più
veloce. L’idea fa un po’ sorridere, o no?
... Ed esistono dei referendum fra i giornalisti che decidono chi è il più bravo chitarrista
dell’anno o addirittura qual è la migliore ristampa di un disco del passato... Siamo una genia
innamorata delle classifiche, come se davvero poi contassero nella vita. (Che fine hanno fatto i
primi della classe? Ecco un buon titolo per un thriller di Costa-Gavras.)
Per inciso, il salomonico Enrico Rava dice: «I referendum sono una stronzata, ma già che
esistono conviene vincerli», il che mi pare sempre un’ottima filosofia da tenere presente.
Fin da bambino mi infastidivano tutte quelle espressioni mutuate da paesaggi bellici
come “Hai fatto il culo a tutti”, “Fai le buche in terra”, “Quello col sassofono spacca il culo ai
paperi” (o ai passeri, a seconda della regione e della presenza maggiore di questa o quella specie
sul territorio), “Ah, quando suona lui non ce n’è per nessuno”. Non mi piacciono neppure oggi.
Preferisco uno “yeah” piazzato bene, insomma un complimento che non sia una
dichiarazione di guerra nei confronti del resto del mondo.
Far commuovere, o divertire, ecco... quello è un campo dove la seduzione entra in gioco,
nelle pieghe, nelle sfumature... Ed è quello, ammetto, che mi piace fare.
Nel frattempo cresciamo in una società di esibizionismo spietato e spesso malato alla
radice. Un marziano a Roma, una commedia di Ennio Flaiano con Vittorio Gassman, non era
andata per niente bene a Milano, e lui, tornando a Roma, disse: «L’insuccesso mi ha dato alla
testa».
Su facebook vige la regola della verità (anche falsa, purché sia venduta come verità). E lo
stesso Flaiano di qualche riga sopra diceva: «La verità, dal momento che me la impongono, non
mi interessa più».
Tutti a sbatterti in faccia la loro storia, le loro passioni, il loro passato e il loro presente; e
ti avvertono: “Io sono fatto così”, “Io sono un porco”, “Io sono una persona seria...”, “Io sono un
papà, questo è mio figlio, ecco la foto”, “Io amo l’Egitto, ecco l’Egitto”, “Io amo la cucina thai,
scrivetemi solo se amate la cucina thai”. Facebook è un mondo di gente quadrata, o che si vuol
credere tale con tutte le proprie forze, con una grande paura di essere ferita dagli altri, di non
saperli comprendere, di non sapersi far capire.
Arriverà un momento in cui sapremo usarlo meglio.
D’altronde si tratta in fondo in fondo di un nuovo elettrodomestico che ci è caduto in
mano senza il libretto delle istruzioni.
Nel frattempo io risolvo col palco.
E sul palco non porto solo “il musicista”, come se ci si potesse concedere a fettine. Ci
porto anche il resto dell’uomo, perché altrimenti dove lo metterei, visto che suono tutte le sere?
Oh, dove mi metto, dove mi appoggio nel frattempo?
Sono lì per creare, per divertirmi e per dialogare con altri musicisti.
Io voglio godere del talento altrui, non restare a guardarlo. Assaporarlo, farmi
attraversare, accogliere la sua baldanzosità. Anche quando non parrebbe servire a nulla di
concreto. Alla faccia della formica ammucchiarona che accumula, mette via e non capisce la
cicala che canta.
Un guru degli anni Settanta come Tom Robbins diceva giustamente: «Il solo motivo per
cui Dio ci tollera è il nostro talento per le stronzate».
È lì che lo sorprendiamo. Non quando ci occupiamo di religione, di scienza, di
ragionamenti. Quando ci dedichiamo alle cose inutili. Quando fondiamo un fronte per la
liberazione dei nani da giardino. Quando passiamo le notti a soffiare in un tubo o a pestare su
una tastiera cercando di usare l’insieme dei nostri ego per ritrovare un’armonia perduta, o meglio
per inventarne una nuova, fosse anche solo per qualche attimo di felicità (quello in cui i jazzisti
alzano la testa nello stesso momento e si sorridono).
21
Come convivere con il successo?
Da un giorno all’altro, nei primi anni Novanta, la mia amica Irene Grandi veniva fermata
per strada, fotografata, indicata. Questo perché era stata al festival di Sanremo.
Anch’io ero ventenne all’epoca e pensavo che quel tipo di successo pareva aprirti un
sacco di porte ma perlopiù ne chiudeva. Il successo è quella cosa che dovrebbe migliorare il tuo
rapporto con te stesso, non complicarti la vita.
Da bambino io non pensavo: “Voglio essere fermato per strada!”.
Pensavo: “Voglio essere Chick Corea”. E non pensavo assolutamente alla vita di Chick
Corea ma al suo modo di suonare. Non avevo messo in conto una vita di viaggi e neppure la
possibilità di una vita “di successo”.
Crescendo, poi, ho cominciato ad annusare l’idea (molto diffusa anni fa) secondo la quale
se nel jazz fai i soldi sei in qualche modo un venduto.
Keith Jarrett, per dire, avrebbe tradito la causa perché prende un sacco di soldi.
Di fatto, se Jarrett prendesse “solo” diecimila euro suonerebbe tutte le sere e gli altri
davvero non lavorerebbero più. Ma è un concetto “di mercato” che apparentemente stride con la
vita del jazzista, che è un vero artista solo se fa la fame.
I soldi per me non sono mai stati un problema, ammetto. A quindici-sedici anni suonavo
tre volte alla settimana al Jazz Club di Firenze, prendendo quarantamila lire a sera. Ero in trio
con Antonio Licusati al basso e Andrea Melani alla batteria. Studiavamo insieme, prendendo a
turno uno dei nostri idoli e cercando di imitare il suono del suo trio (ricordo in particolare Bill
Evans e Monk).
Eravamo molto fortunati perché, oltre alle prove a casa mia, potevamo poi subito
confrontarci con un qualche pubblico (distratto, pieno di turisti in vacanza, ma tant’è: ci serviva,
e parecchio).
Ho fatto qualche matrimonio e suonato in qualsiasi contesto, tranne forse il piano-bar e il
liscio.
A parte il servizio civile per un anno in cui sono stato un bibliotecario, non ho mai fatto
un altro lavoro nella mia vita. E lavoro da quando ho quindici anni, dunque da venticinque.
Il successo non è arrivato all’improvviso, ma con calma. Ed è quel tipo di successo che
mi permette di fare la musica che mi piace. Gino Paoli è costretto a cantare Sapore di sale tutte le
sere, io no.
Molti pensano che siano i soldi o la possibile visibilità a spingere un musico ad accettare
o no di lanciarsi in una nuova avventura.
Risponderò citando un esempio lontano nel tempo.
All’età di venti anni, da appassionato di be-bop e del jazz anni Trenta, sono entrato
improvvisamente in un gruppo pop-rock (La forma, dove militavano già Irene Grandi e Marco
Parente) essenzialmente per fare colpo su una ragazza che mi piaceva e che non sopportava il
jazz.
Non le piacque neppure questo gruppo, ma ormai era andata, c’ero dentro.
Questo per dire quali profonde motivazioni ci possono essere dietro alcune scelte
artistiche, così profonde da non meritare talvolta di venire davvero a galla.
Il successo del cantante pop è il più infido. Nasce una coazione a ripetere. Si tenta, una
volta imbroccato un hit, di fare le stesse cose affinché il pubblico le riconosca, ti riconosca. La
canzone è un ambito che ha leggi rigide le quali però hanno ispirato fior di capolavori. Devi
contenere tutto in poche righe, con strutture chiare, strofa-ritornello, strofa-ritornello, terza parte,
ritornello. C’è chi esce eccome da queste gabbiette, ma provate a pensare a molte delle canzoni
che vi capita di ascoltare anche per caso alla radio, o anche a quelle che amate di più... spesso,
mascherata o no, usano questa struttura.
E soprattutto parlano d’amore. E di lì non si scappa. Ed è il motivo per cui la musica
strumentale è tanto più libera.
Non è tenuta a rifarsi al solito antico tema della persona amata, desiderata, spesso e
volentieri non raggiungibile.
Tema antico ma ancora una volta non così globale come immaginiamo.
L’amor de lonh (“l’amore da lontano”) che cantavano i trovatori provenzali è poi passato
nel Romanticismo e ancora ci attanaglia; ma in buona parte del mondo, fuori da questa piccola
Europa che consideriamo il centro di tutto, raramente si apriva bocca per cantare i propri
personalissimi turbamenti per una bella figliola o un bel figliolo. In Africa i cori tradizionali non
lo fanno quasi mai. E non creano nuove canzoni per vendere dischi.
22
È possibile che esista la musica senza musica?
L’ascolto è la prima cosa da non dare per scontata. Io suono con una orchestra sinfonica,
ma non è affatto detto che mi stia ascoltando, che ci stiamo ascoltando. Si può suonare anche col
paraorecchie e senza che il pubblico se ne accorga.
Molti cantanti pop tirerebbero dritto anche se all’improvviso morisse il bassista per un
colpo apoplettico.
Capita di suonare in qualche disco incidendo la propria parte da solo. Il gruppo magari ha
già inciso, di solito il cantante è l’ultimo, per poter cantare sorretto dalla band intera. Ma una
volta ho suonato e Massimo Ranieri aveva già cantato su un piano “finto”. Altre volte, e come
nel caso di Ranieri si trattava di un duo piano e voce dunque una vicenda “intima”, non ho
incontrato proprio l’artista per cui ho suonato (Claudio Baglioni; ma successe anche con la mia
amica di sempre, Irene Grandi, per un disco di Hector Zazou che ci volle insieme per registrare
un proprio brano: non si trovava il giorno adatto per essere tutti contemporaneamente nella stessa
città).
Il cantante deve avere un grande controllo del suo strumento, la voce, e
contemporaneamente ascoltare gli altri. Provate voi a parlare e intanto ascoltare quel che dice un
altro. Insomma, a non farvi distrarre dalla vostra propria voce, però continuando a “controllarla”.
Devi avere un relax tale da poter ascoltare il tuo proprio strumento da dentro. Io il pianoforte
mica lo ascolto da dentro. È uno sforzo ascoltarsi. I bambini che studiano musica dovrebbero da
subito suonare insieme agli altri: c’è chi arriva al diploma, dunque diventa maestro di musica, e
ha passato la sua vita suonando a casa da solo. Con il risultato che non sei in grado di ascoltare
qualcun altro. Che hai un senso del ritmo magari molto personale... troppo personale. Insomma...
non vai a tempo neanche con le cannonate.
La musica è invece l’arte dell’ascolto. Ascoltare e parlare e insieme sentire quello che
accade attorno. La nostra società oggi insegna il contrario: scriviamo a turno in una chat o via
SMS, poi leggiamo, quindi riflettiamo sulla risposta. Nella vita reale devi essere venti volte più
reattivo e presente a te stesso.
Il cantante sin da bambino, come il violinista, è abituato a essere accompagnato da un
altro strumento, il piano, che l’ascolta e lo segue. Pavarotti canta e l’orchestra lo deve seguire.
Non esiste il caso contrario. Ma in questo modo si alimenta l’ego del cantante, che per natura è
già portato all’ipertrofia (parliamoci chiaro, se no uno farebbe il notaio o il fornaio, esistono
tante di quelle professioni...). Invece bisognerebbe sempre procedere insieme, se si suona
insieme. Certo, si guida e ci si lascia guidare, a turno. O ci si danno dei parametri da seguire.
Credo che sappiate quanti carabinieri ci vogliono per avvitare una lampadina... Uno che
tiene la lampadina e tantissimi che girano la casa. Ecco, esiste anche la versione sulle cantanti:
quante cantanti ci vogliono per avvitare una lampadina? Ne basta una, sta ferma con la
lampadina e il mondo le gira intorno!
(E poi esiste anche con i chitarristi: ce ne vogliono tanti, perché uno avvita e gli altri
stanno intorno dicendo: “Ma io andavo più veloce, lo facevo meglio, non l’avrei fatto così...”.
Sui pianisti, che io sappia, non esistono, ma forse, semplicemente, a me non le raccontano.)
Finché non ho suonato insieme a Caetano Veloso, che adoravo da sempre, non potevo
sapere se avrebbe ascoltato quello che gli accadeva intorno, e poi ho scoperto che sì, lo fa. Alla
faccia del suo essere una superstar della musica. Se suono una certa frase, con una certa
intenzione, durante una pausa del suo testo, Caetano cambia e sta DENTRO il discorso musicale.
Non ripete a memoria la lezione, è così rilassato da poter andare oltre la propria ansia da
prestazione e lasciarsi dunque trasportare da quel che succede.
Passando alle voci del nostro paese, Petra Magoni ha studiato musica antica e sa leggere
uno spartito (... non che sia così usuale fra i cantanti pop!), è curiosa di ciò che sta succedendo
oltre la sua propria parte. Può fermare la barca che sta andando e dire: “Non mi piace, non mi
sembra adatto quel tale accordo, quel tale passaggio”. Si parla di musica e non di ego, non di
affermazione personale.
La musica, come il teatro, non è in mano solo al regista, e se c’è una diva alla quale tutti
devono stare attenti per intercettare i suoi cambi di umore tutto diventa più difficile. Diventa
un’accolita di persone che fanno di tutto per mettere a proprio agio il protagonista, il signor
Stocazzo.
Ricordo un magnifico Giardino dei ciliegi al National di Londra in cui gli attori erano
bravissimi ma proprio perché a emergere era Čechov. E un Riccardo III pochi giorni dopo
all’Old Vic costruito troppo intorno a Kevin Spacey il quale, seppur bravissimo, non riusciva da
solo a trasformare lo spettacolo in un’esibizione perfetta in tutte le sue parti.
E non basta l’umiltà, perché ci sono artisti umili che in ogni caso non sanno ascoltare.
Questo è dovuto anche al Conservatorio. All’epoca in cui ho studiato io, si poteva stare lì dentro
ben dieci anni a suonare il pianoforte sempre da soli. C’era un corso di musica da camera che
con un po’ di abilità si poteva saltare, dunque nessun musicista al tuo fianco, mai.
Sull’ascolto devo molto a Enrico Rava (ed è riduttiva, la frase... a Rava devo molto di
più; per dirne giusto un’altra, mi ha dato una grandissima iniezione di fiducia nelle mie
possibilità sin dal 1996, anno in cui abbiamo suonato insieme per la prima volta e io mi sono
reso conto che stava ascoltando con attenzione tutti gli accordi che buttavo giù sulla tastiera
durante i suoi assolo).
Ognuno nel suo gruppo può indicare una direzione per la musica, estemporaneamente,
senza necessità di parlarne. Mica abbiamo un direttore, noi, che ci dice quando iniziare e finire.
In un gruppo guidato da Rava si è tutti alla pari. Questo è stato decisamente un
grandissimo insegnamento, non verbale, da parte sua: una volta che io ho scelto di suonare con
certi musicisti (e ho l’EMORME fortuna di poter sempre scegliere con chi suonare, da molti anni
in qua), non voglio dir loro cosa fare. Tantomeno dir loro dove hanno sbagliato, dopo un
concerto. Lo sanno benissimo. E non sono più bravo di Morten Lund, per fare un esempio, né
sulla batteria né in generale. Questo è un modo di stare insieme, sul palco, di fiducia nelle
capacità e nella sensibilità dell’altro, che è difficile riproporre nella vita reale ma anche nelle
altre musiche. Il direttore non può fidarsi così dei propri orchestrali. Primo, perché è lui l’unico
che ha una visione d’insieme del brano. Secondo, perché appunto questa visione condiziona tutte
le scelte musicali; si tende alla perfezione, a un’idea ben precisa. Il jazz, al contrario, non tende
all’assoluto, mai, ma alla scintilla del momento.
Terzo, last but not least, alcuni dei musicisti di fronte a lui se fanno un errore cercano di
mascherarlo, per tirare a campare e non essere rimproverati. Capita anche nelle migliori
orchestre, con tutta quella gente, spesso poco gratificata da quel che sta eseguendo.
E nel mondo del pop? Il cantante o l’arrangiatore vogliono un giro di basso preciso, un
tipo di suono che hanno in mente, una struttura molto chiara e sempre uguale a se stessa tutte le
sere.
Io adoro la libertà, in musica. Per questo devono averla anche quelli che suonano con me.
Credo sia una bella fetta dello spirito del jazz, questo.
Una signora un giorno davanti alla scuola dei miei figli mi ha fermato e mi ha detto che
mi aveva visto in televisione con il mio quintetto, in “Sostiene Bollani”, e diceva a un’amica che
era lì: «Devi vedere, sembrava che suonassero ognuno per conto proprio, ognuno faceva la
propria cosa, invece no, stavano facendo lo stesso pezzo...». E sebbene non avesse mai ascoltato
il jazz ha detto che le era piaciuto. Ho trovato il punto di vista della signora molto acuto: ognuno
suona quello che vuole, ma ascolta quello che fanno gli altri; se fa questo effetto, siamo già a
buon punto. Molti si accorgono solo della prima parte della descrizione della signora e ne
deducono che il jazz è un animale strano, con più teste, che non si capisce dove voglia andare.
23
Si può imparare ad ascoltare la musica?
Se vado nella foresta amazzonica, mi dispongo all’ascolto vero di quello che avrò
intorno. Se vado sempre nel Club Méditerranée in qualsiasi posto del mondo, non mi dispongo
ad ascoltare un bel niente e la volta che metto il piede su un’ortica dico: “Ah, ma che posto di
merda! La prossima volta vado a Rapallo!”.
Ma è anche vero che la vita è breve, e molti di noi hanno deciso di non volersi prendere il
tempo necessario per approfondire.
Osvaldo Pugliese è stato un compositore e direttore d’orchestra fra i più importanti del
tango argentino. Aveva fama di portare fortuna. Per questo alla sua morte è stato fatto santo, con
una investitura ufficiosa, da parte dei musicisti. Al sassofonista John Coltrane hanno addirittura
dedicato una chiesa, a San Francisco. La motivazione è splendida: “St John non era solo un
musicista jazz ma uno che era stato scelto per guidare le anime verso Dio”.
Il santino di San Pugliese, “Protector de los musicos”, nel dubbio io lo porto sempre nel
portafoglio e la preghiera scritta sul retro ha una prima riga chiara e limpida: ”San Pugliese,
protégenos de todo aquel que no escucha”.
Che meraviglia, basterebbe da sola.
“Proteggici da tutti quelli che non ascoltano.”
Sarebbe bello che la gente si incuriosisse e capisse che il jazz, per esempio, si può
apprezzare di più andando a vederlo dal vivo e non si tratta solo di stare a guardare quei cinque
jazzisti sul palco che se la ridacchiano. Quelli che a un certo punto del brano si guardano tra loro
e ridono e tu dici: “Ma cosa ridono?”. E c’è sempre qualcuno nel pubblico che ride anche lui,
come per dire: “Io ho capito”. Ma non ha capito, perlopiù finge per non restare al palo.
Certo, il pubblico non è più quello degli anni Settanta e generalmente non si è fatto la
quantità di canne che si sono fatti i musicisti, quindi non ha capito, no... Sono esclusi per questo.
Se può consolare, lo sono anche i musicisti, a volte.
Una volta ad Amburgo, con il mio gruppo, i Visionari, poco prima di salire sul palco
Nico Gori e io avevamo fumato l’erba (piuttosto impegnativa) di un amico, un musicista tedesco.
Durante il concerto a un certo punto gli altri tre del gruppo hanno smesso di suonare e ci hanno
lasciato da soli per quindici minuti. E Guerrini a metà concerto ci fa: «La prossima volta
mettiamo una regola, o fumiamo tutti o non fuma nessuno!». Era davvero difficile entrare in
comunicazione.
Altra grande lezione della vita: si rende necessario, ai fini dell’empatia che stiamo sempre
e comunque cercando su un palcoscenico, assumere tutti, per quanto possibile, le stesse sostanze.
Io ricordo che abbiamo suonato su un accordo di La bemolle maggiore per un quarto
d’ora e Nico alla fine del set mi fa: «Non sapevo che conoscessi After The Rain», e io rispondo:
«Cosa?». E lui: «Ma se l’abbiamo suonata prima, in duo! Il pezzo di Coltrane!». Io gli ho detto:
«Ma è tutta in La bemolle?». E lui: «No, ha degli accordi!». «Sì, lo immagino, ma io non li ho
mica fatti, stavo fermo sul La bemolle!»
Non so chi fosse messo peggio, fra i due.
Il jazz non dovrebbe essere una cosa da iniziati.
È un peccato, voglio dire, che ci si fermi al: “mi ha emozionato”/“non mi ha
emozionato”, come su facebook. Poi io sono il primo a emozionarmi, a piangere, e se piango
sono il primo a stupirmi di me stesso, significa che la musica ha vinto. Anche se piangi per una
canzonetta di qualche anno prima perché ti ricorda un amore... ed è un sentimento nobile anche
quello, non è che uno può sempre piangere per i palestinesi. E piango su Concato, che adoro...
Se già la gente riuscisse a capire le dinamiche tra i musicisti, i compiti, chi sta
accompagnando, o su cosa stanno lavorando, improvvisando, un giro di accordi, un’idea ritmica,
troverebbe più affascinante il tutto.
Anch’io, come ascoltatore, a volte me lo chiedo: cosa stanno facendo? Ricordo di aver
assistito a una serata di Steve Coleman nel 1988 a Zurigo e di aver passato il tempo a contare
sulle dita di due mani per capire che tipo di ritmi stessero utilizzando. Il divertimento maggiore
della serata è stato quello lì, ma insomma un divertimento c’è stato: lascia fare, che di questi
tempi va bene così.
Ci sono cose interessanti da scoprire in tutte le musiche. Bisogna capire cosa può esserci
di stimolante, e darsi un minimo di parametri per ascoltare con maggiore consapevolezza.
Non puoi confrontare direttamente Dostoevskij e Calvino, che sono due mondi diversi:
sarebbe come mangiare una melanzana aspettandosi il sapore di fragola. In Conservatorio
tentano di spingerti a cercare sempre le stesse cose in tutti i compositori: la grandiosità, l’amore,
la forza, la dolcezza, il romanticismo, il canto: fai cantare questa frase, perché se la fai cantare è
bella.
No! C’è anche altro!
Se decido che la freddezza di Ravel è la cosa che di lui mi incuriosisce, significherà, da
esecutore, non indulgere troppo nei “rallentando” e negli “accelerando” per emozionare la gente
o per farlo sembrare Rossini.
È ambizioso, però, lasciare da parte il birignao del sentimento. E questo birignao che
ancor oggi ci imprigiona è quello che poi fa spiegare a un ragazzo la musica in termini
imbarazzanti: questo accordo è triste, mentre questo è allegro. Non è vero. È una convenzione.
Dipende sempre da dove è collocato, quell’accordo. Lontano lontano e Un giorno dopo l’altro di
Tenco sono costruiti su una tonalità maggiore che più maggiore non si può. Cos’hanno di
“allegro”, di grazia? E Impressions di Coltrane o So what di Miles Davis sono melodie
incastonate splendidamente su un accordo minore... Le trovate tristi?
La musica nasce da un uomo primitivo che batte su un tamburo ed è un richiamo, o un
avvertimento, o un canto d’amore o un lamento funebre. Nasce per motivi pratici, liturgici,
religiosi, per segnalare un periodo dell’anno.
Il piacere arriva dopo.
Da poco tempo ci mettiamo a sedere in poltrona per ascoltarla, la musica. Fino alla fine
dell’Ottocento nessuno ascoltava la musica del passato. Bach veniva studiato dai musicisti, ma,
una volta morto, non si eseguivano più le sue partiture. A Lipsia semplicemente si assumeva un
altro maestro di cappella che scrivesse nuova musica per ogni funzione religiosa in cui fosse
necessaria. È stato Felix Mendelssohn a inventare il concetto di “repertorio” nella prima metà
dell’Ottocento. Quando è diventato direttore della Gewandhaus a Lipsia ha deciso che bisognava
cominciare a suonare anche la musica del passato. Wagner, poco dopo, ha deciso che bisognava
spegnere la luce in sala durante l’opera e addirittura nascondere l’orchestra, un’idea di magia: da
dove arriva la musica? Dove sono finiti i musicisti? Così ha inventato il cinema... L’orchestra è
in buca, non dovete guardarla e farvi distrarre! A fine Ottocento a Bayreuth assistevano a
L’anello del Nibelungo e si domandavano: “Ma da dove arriva la musica? Dal cielo?”. (Dagli
inferi, direi, vista la posizione dell’orchestra.)
A un certo punto, nella storia del mondo, abbiamo cominciato a scrivere e a suonare
semplicemente perché era “bello” e si poteva stare seduti, a occhi chiusi, ad ascoltare. Molto
prima dell’avvento degli impianti stereo e delle cuffie, ma molto molto dopo l’apparire sulla
terra dei primi suoni.
Musica non più necessariamente legata a un testo, a un’epoca. Musica per la musica.
Ascolto per l’ascolto. Gioia per la gioia. Improvvisamente l’uomo fa una scoperta che cambierà
il corso della storia della musica. E anche della sua stessa storia.
Niente mi tiene più in vita del godimento per il godimento.
Ecco il vero spettacolo.
Buon ascolto.
Ringraziamenti
I miei genitori, Maddalena e Roberto, che mi hanno sempre assecondato.
Tutta la mia famiglia.
I miei molti insegnanti di musica... Silvana Bartocci, Antonio Caggiula, Franco Rossi,
Luca Flores, Mauro Grossi, Franco D’Andrea, Bruno Tommaso.
Enrico Rava.
Le persone che lavorano con me da anni: Mario Guidi, Monica Manetti, Daniele
Brunacci, Roberto Lioli, Nicola Adriani, Sebastiano Lo Re, Paolo Netti, Andrea Maiolino, Alceo
Cataudella.
Marta Treves della Mondadori che ha pazientato con pazienza.
Alberto Riva senza il quale non riuscivo proprio a ingranare. E grazie perché mi fa
sempre ridere appena mi risponde al telefono.
Chick Corea e tutti i musicisti incontrati in questi anni
e Valentina, che oltre ad avermi dato preziosi consigli, mi ha regalato ultimamente un
paio di libri di Flaiano che son serviti enormemente come elargitori di gioia e spunti di
riflessione (si è capito, leggendo il testo?).