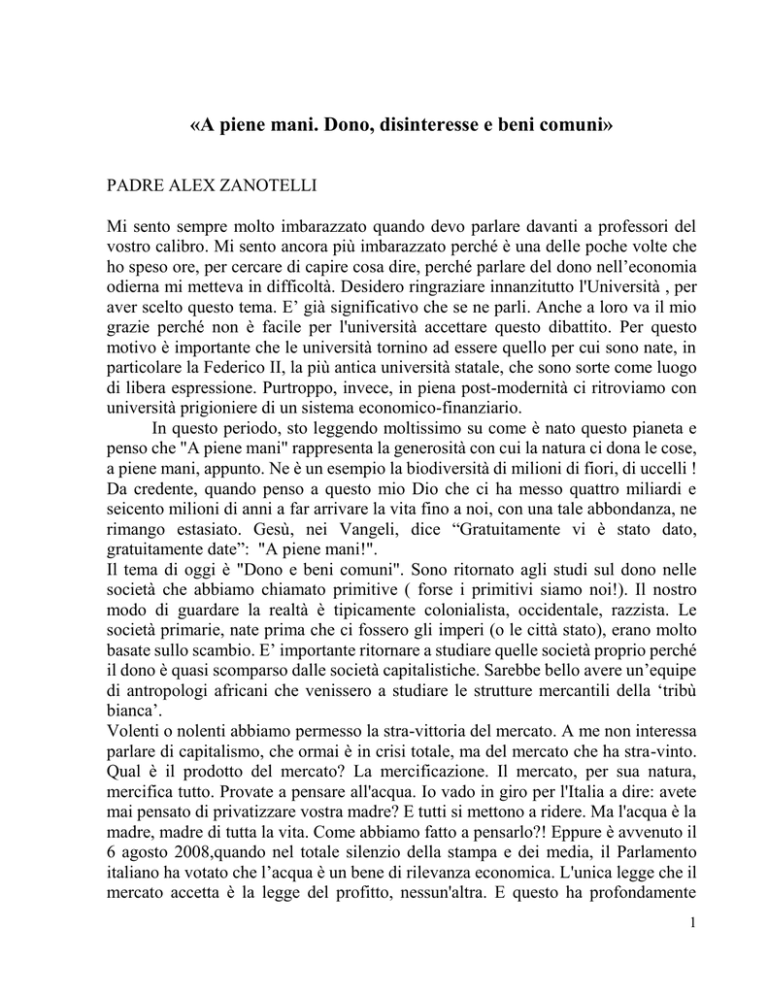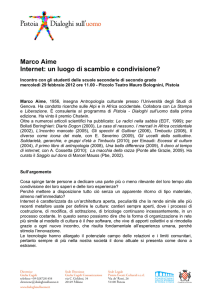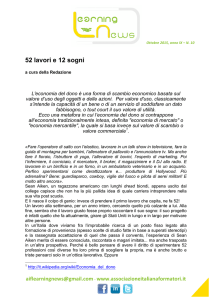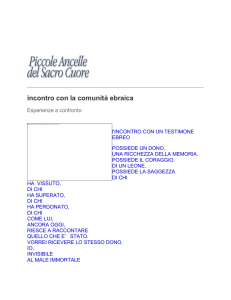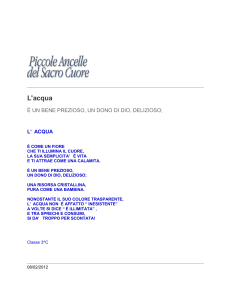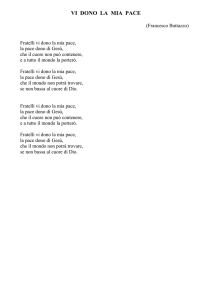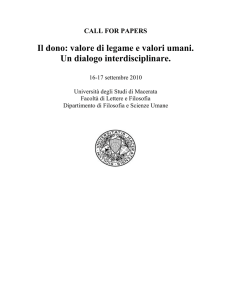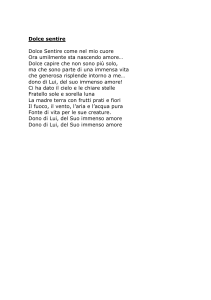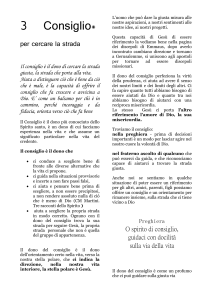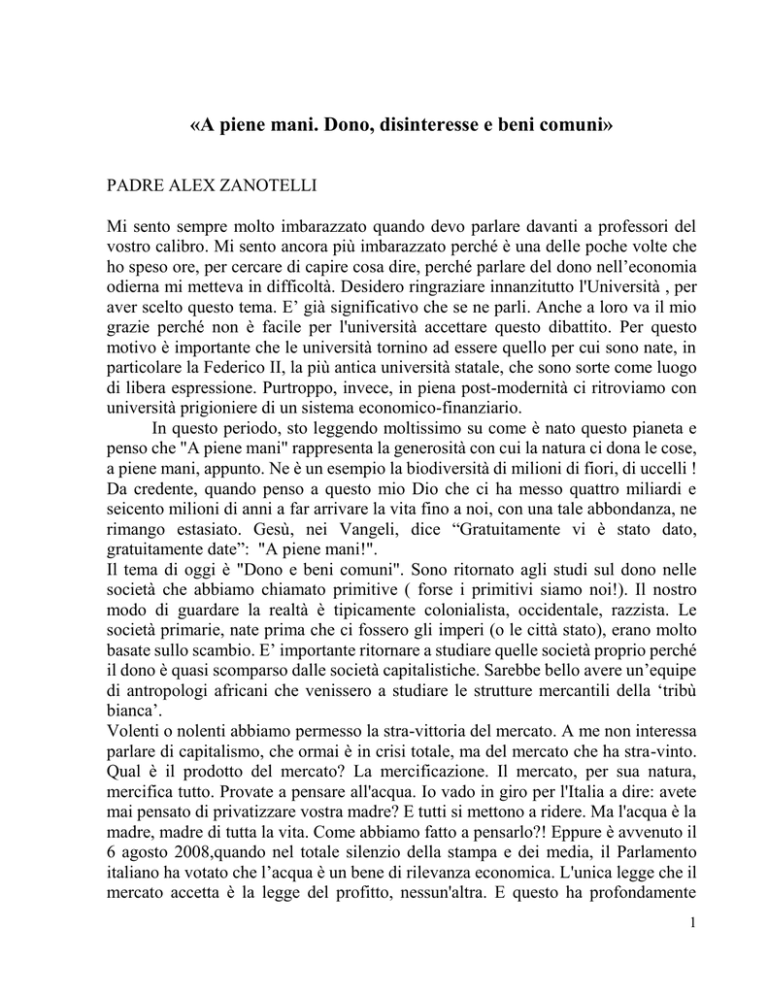
«A piene mani. Dono, disinteresse e beni comuni»
PADRE ALEX ZANOTELLI
Mi sento sempre molto imbarazzato quando devo parlare davanti a professori del
vostro calibro. Mi sento ancora più imbarazzato perché è una delle poche volte che
ho speso ore, per cercare di capire cosa dire, perché parlare del dono nell’economia
odierna mi metteva in difficoltà. Desidero ringraziare innanzitutto l'Università , per
aver scelto questo tema. E’ già significativo che se ne parli. Anche a loro va il mio
grazie perché non è facile per l'università accettare questo dibattito. Per questo
motivo è importante che le università tornino ad essere quello per cui sono nate, in
particolare la Federico II, la più antica università statale, che sono sorte come luogo
di libera espressione. Purtroppo, invece, in piena post-modernità ci ritroviamo con
università prigioniere di un sistema economico-finanziario.
In questo periodo, sto leggendo moltissimo su come è nato questo pianeta e
penso che "A piene mani" rappresenta la generosità con cui la natura ci dona le cose,
a piene mani, appunto. Ne è un esempio la biodiversità di milioni di fiori, di uccelli !
Da credente, quando penso a questo mio Dio che ci ha messo quattro miliardi e
seicento milioni di anni a far arrivare la vita fino a noi, con una tale abbondanza, ne
rimango estasiato. Gesù, nei Vangeli, dice “Gratuitamente vi è stato dato,
gratuitamente date”: "A piene mani!".
Il tema di oggi è "Dono e beni comuni". Sono ritornato agli studi sul dono nelle
società che abbiamo chiamato primitive ( forse i primitivi siamo noi!). Il nostro
modo di guardare la realtà è tipicamente colonialista, occidentale, razzista. Le
società primarie, nate prima che ci fossero gli imperi (o le città stato), erano molto
basate sullo scambio. E’ importante ritornare a studiare quelle società proprio perché
il dono è quasi scomparso dalle società capitalistiche. Sarebbe bello avere un’equipe
di antropologi africani che venissero a studiare le strutture mercantili della ‘tribù
bianca’.
Volenti o nolenti abbiamo permesso la stra-vittoria del mercato. A me non interessa
parlare di capitalismo, che ormai è in crisi totale, ma del mercato che ha stra-vinto.
Qual è il prodotto del mercato? La mercificazione. Il mercato, per sua natura,
mercifica tutto. Provate a pensare all'acqua. Io vado in giro per l'Italia a dire: avete
mai pensato di privatizzare vostra madre? E tutti si mettono a ridere. Ma l'acqua è la
madre, madre di tutta la vita. Come abbiamo fatto a pensarlo?! Eppure è avvenuto il
6 agosto 2008,quando nel totale silenzio della stampa e dei media, il Parlamento
italiano ha votato che l’acqua è un bene di rilevanza economica. L'unica legge che il
mercato accetta è la legge del profitto, nessun'altra. E questo ha profondamente
1
mutato l'antropologia di chi vive nel mercato. Noi non siamo più quelli che eravamo
cinquanta, sessanta anni fa: c'è qualcosa che è mutato radicalmente nel nostro
pensiero, nella nostra interiorità. Ma c'è qualcosa ancora di più grave che è avvenuto:
dal Settanta ad oggi si è passati dal mercato alla finanziarizzazione del mercato, cioè
non contano neanche più il mercato e la merce ma conta solo la finanza. E questa è
diventata pura speculazione. Non sono un esperto di finanza ma dagli studi emerge
che il Pil mondiale, totale e reale, sarebbe sui sessantamila miliardi di dollari mentre
il giro speculativo si aggirerebbe intorno ad un milione di miliardi di dollari, che vuol
dire che fra il reale e lo speculativo c'è qualcosa come quindici volte in più del reale.
I soldi controllano tutto l'apparato economico ed è in questa trappola mortale che
dobbiamo collocare il problema dono e beni comuni. Il sistema
economico-finanziario - più finanziario che economico - tra l'altro nelle mani di
pochissime persone, in tutto forse tre-quattrocento ‘famiglie’, permette al venti per
cento della popolazione mondiale di "papparsi" l'ottantatré per cento delle risorse del
resto del mondo: è puro cannibalismo. Tre miliardi di persone devono accontentarsi
di due dollari al giorno mentre un miliardo deve vivere sotto un dollaro al giorno. La
conseguenza è un miliardo di affamati e cinquanta milioni di persone che
ammazziamo per fame ogni anno. Sì, perché noi li uccidiamo. Notate, per
permettere a così pochi di "papparsi" tutto, ci sono le armi. Nel 2009 abbiamo una
spesa mondiale di 1.520 miliardi di dollari (dati SIPRI). L'Italia è uno splendido
esempio. Venticinque miliardi di euro è il bilancio Difesa 2010:neanche se fossimo
invasi dagli Ufo! Non abbiamo soldi per il terzo settore e per la scuola, ma
venticinque miliardi di euro sì per le armi. La guerra in Iraq è costata solo agli Stati
Uniti in cinque anni tremila miliardi di dollari. Abbiamo tante armi atomiche che
potremmo far saltare almeno quattro volte per aria il mondo. E allora capite la follia
totale: il venti per cento del mondo si sta pappando quasi tutto ad una velocità
incredibile protetto da armi potentissime, e tutto questo sta pesando sull'ecosistema
a tal punto che stiamo minacciando il futuro del Pianeta. Stiamo minando la
possibilità che future generazioni potranno sopravvivere su questo pianeta. E’ una
situazione gravissima. Viviamo dentro un sistema che io definisco di morte:
ammazza per fame, ammazza per guerra ed ora sta ammazzando il pianeta! E' la
negazione di tutto quello che possono essere dono e bene comune. Oggi c’è solo il
mercato, che permette a pochi di vivere da nababbi, lo difendiamo con potentissime
armi. E in questa maniera stiamo mettendo in pericolo il pianeta stesso. Capite a che
punto di negazione di tutto siamo arrivati?! Quest'economia ci ha ridotti a robot, a
cose. Ma se troviamo il coraggio di guardare in faccia la realtà e poi capire che cosa
significa antropologicamente questo tipo di sistema, ci rendiamo conto che stiamo
andando alla morte. L’unico documento delle Chiese che ha fatto questa analisi è
quello di Accra delle chiese Riformate(2006). Questo documento è stato preparato
da trecento delegati delle chiese Riformate di tutto il mondo. Nella prefazione del
2
documento i delegati raccontano che sono andati a visitare la fortezza di Elmina, da
dove partivano gli schiavi per le Americhe. I delegati rimasero costernati al vedere
che nella fortezza c’era una cappella dove il governatore e i soldati olandesi
andavano a pregare, mentre sotto c’erano gli scantinati con gli schiavi incatenati. I
delegati delle chiese del Nord rimasero schoccati.”Ma non sta avvenendo la stessa
cosa oggi?-risposero i delegati delle Chiese del sud-“Voi pregate nelle vostre
bellissime Chiese climatizzate, mentre noi, destinati a morire, preghiamo nei
bassifondi della storia.” Purtroppo le Chiese oggi nel nord del mondo sono parte
integrante di un Sistema che uccide per fame, per guerra e uccide il pianeta. Eppure
se c’è una parola che è parola –chiave del Vangelo è proprio il dono,la condivisione,
lo spezzare il pane “a piene mani”. E’ stato proprio il Papa Benedetto XVI a ritornare
su questo tema nella sua enciclica sociale Caritas in Veritate:
"La dottrina sociale della Chiesa ritiene che possano essere vissuti rapporti
autenticamente umani di amicizia, socialità, solidarietà e reciprocità anche
all'interno dell'attività economica e non soltanto fuori di essa o dopo di essa-afferma
il Papa. La sfera economica non è eticamente neutrale né di sua natura disumana e
antisociale. Essa appartiene all’ attività dell'uomo e, proprio perché umana, deve
essere strutturata e istituzionalizzata eticamente. La grande sfida che abbiamo di
fronte a noi, fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo in questo tempo di
globalizzazione e resa ancora più esigente dalla crisi economico-finanziaria, è
dimostrare, a livello sia di pensiero che di comportamenti, che non solo i
tradizionali principi dell'etica sociale quali la trasparenza, l'onestà, la
responsabilità non possono venire trascurati o attenuati, ma anche che nei rapporti
mercantili il principio di gratuità e la logica del dono come espressione della
fraternità possono e devono trovare posto entro la normale attività economica".
"Ciò è un'esigenza dell'uomo nel momento attuale ma anche un'esigenza della
stessa ragione economica. Si tratta di un'esigenza al contempo della carità e della
verità. [...] La vita economica ha senz'altro bisogno del contratto, per regolare i
rapporti di scambio tra valori equivalenti. Ma ha altresì bisogno di leggi giuste e di
ridistribuzione, guidate dalla politica e inoltre di opere che rechino impresso lo
spirito del dono”.
E’ la prima volta, in campo cattolico, che emerge questo tipo di riflessione
sulla “gratuità” e sul “dono”, nel contesto dell’economia globalizzata. E la
conclusione che Benedetto XVI tira da queste premesse, mi sembra molto
significativa per la nostra discussione.
"La vittoria sul sottosviluppo richiede di agire non solo sul miglioramento
delle transazioni fondate sullo scambio, non solo sui trasferimenti delle strutture
assistenziali di natura pubblica, ma soprattutto sulla progressiva apertura in un
contesto mondiale a forme di attività economica caratterizzate da forme di gratuità e
3
di comunione. Il binomio esclusivo mercato-Stato corrode la socialità mentre le
forme economiche solidali che trovano il loro terreno migliore nella società civile,
senza ridursi ad essa, creano socialità. Il mercato della gratuità non esiste e non si
possono disporre per legge atteggiamenti gratuiti. Eppure sia il mercato sia la
politica hanno bisogno di persone aperte al dono reciproco”.
Questo significa che deve nascere un uomo nuovo: ’homo planetarius’ .Se ‘homo
sapiens’ vuole sopravvivere, dovrà fare un salto antropologico. Io sono convinto che
il bene non si può imporre: le peggiori dittature della storia sono state quelle dei preti
e dei talebani. Il bene deve nascere da dentro, è un salto di coscienza che ognuno di
noi deve fare. Quindi è fondamentale un cambiamento antropologico, un
cambiamento che per noi che viviamo nel Nord del mondo è difficilissimo da fare ma
è essenziale: deve nascere un’altra umanità. Padre Balducci nel suo volume L'uomo
planetario afferma che l'uomo a un certo punto dell'evoluzione umana dovette
rispondere in maniera creativa al nuovo ambiente : nacque così homo sapiens. Oggi
deve nascere homo planetarius, la cui caratteristica sarà il dono e la gratuità.
In secondo luogo, dobbiamo ricordarci che l'uomo è essenzialmente un animale
sociale, quindi ecco l'importanza delle comunità locali. Io sto sperimentando
l'importanza di tutto questo sul problema acqua, la madre, che il mercato ha
mercificato. Con il referendum stiamo cercando di ripublicizzare. Sono molto grato
ai giuristi (tra questi Alberto Lucarelli) che hanno fatto le tre domande referendarie,
che costituiscono una sberla a ‘O’ Sistema’. Nella prima, chiediamo che l'acqua
venga dichiarato un bene di non rilevanza economica; nella seconda, che l'acqua
venga tolta dal mercato; con la terza chiediamo chiede che il profitto venga tolto
dall'acqua. E' proprio una sberla totale al Sistema. Quindi con questo referendum ci
stiamo giocando tutto. Ci giochiamo tutta la partita sui beni comuni: l’acqua è dono
di Dio. E l'acqua è il più fondamentale dei beni comuni. E’ una sfida epocale! Pochi
lo hanno colto così bene come Raj Patel, nel suo recente volume Il valore delle cose
e le illusioni del capitalismo :
"Per riconquistare la politica, anche noi dovremmo far leva su più immaginazione,
più creatività, più coraggio-afferma Raj Patel. Dovremmo tenere a mente che i
trionfi della democrazia non provengono dalle urne, ma dalle circostanze che
rendono quella democrazia possibile: uguaglianza, responsabilità delle proprie
azioni e la possibilità della politica. Dovremmo essere consapevoli del fatto che
trasformandoci in tanti mostri di Greenspan, ruolo per il quale veniamo
generalmente educati fin dalla nascita, battezzati nella cultura del consumo e
oberati di desideri materiali fino alla morte, la nostra felicità individuale e collettiva
verrà irrimediabilmente distrutta. Un futuro sostenibile avrà bisogno di mercati che
dovranno però essere tenuti sotto controllo per evitare che le motivazioni, le
passioni, le risorse che alcune persone traggono da essi continuino a corrompere il
resto della società e del pianeta. Dobbiamo imparare a vedere, valutare,
4
amministrare il mondo in maniera più democratica, rendendoci conto che la
proprietà ed il governo sono molto più malleabili di quanto non abbiamo mai
ritenuto possibile. Questa a conti fatti sarà un'impresa collettiva. Non è cercando
individualmente la felicità che riusciremo a trovarla. Essa potrà scaturire soltanto
dalla libertà di vivere insieme, di partecipare a quella politica democratica che ci
aiuterà dare il giusto valore al nostro futuro comune".
UGO OLIVIERI
Il nostro incontro è basato su un dato metodologico che voglio mettere subito al
centro della riflessione e cioè che oggi esiste un duplice interrogativo cui siamo
esposti come soggettività e come soggettività delle conoscenze con le quali ci
confrontiamo. Il primo interrogativo è quello dei confini delle discipline e quindi il
problema è quello dell'interdisciplinarietà. Il fatto che io ed Alberto Lucarelli
parliamo due linguaggi diversi che debbono trovare un punto comune è la sfida di
questo seminario a partire, per me, da alcuni testi di riferimento. I primi testi cui
penso sono due saggi di Emile Benveniste: Problemi di linguistica generale e
Vocabolario delle Istituzioni indoeuropee. Benveniste è un grande indoeuropeista
che si pone il problema di determinare le regole di funzionamento della
comunicazione accanto a un lavoro sulla semantica di base delle istituzioni sociali.
Questo serve per porre la questione della soggettività del linguaggio (cioè chi
enuncia, da quale luogo enuncia e da quale posizione di potere enuncia) e questo
consente di fare una riflessione sulla cultura, perché Benveniste nel Vocabolario
delle Istituzioni indoeuropee, dopo aver detto che cos'è il segno, come si enuncia il
segno, enumera una serie di voci quali “dono”, “città”, “gioco”, e fa un'analisi
genealogica della parola, dall'indoeuropeo alle soglie della modernità. Benveniste,
quando faceva questo, pensava ad un linguaggio comune europeo, si poneva il
problema, dopo la Guerra mondiale, di ricostruire un lessico comune europeo. Ecco
l'interdisciplinarietà: tra me ed Alberto Lucarelli deve esistere un lessico comune che
poi consente l'interdisciplinarietà.
Voglio ora porre un problema di fondo: quanto e come, oggi, le discipline
sono interrogate e cambiate dalle pratiche? Questo rapporto è sempre stato pensato in
senso unilaterale, dalle discipline alle pratiche. Quando mi riferisco alle pratiche
voglio dire che Alberto Lucarelli, ad esempio, produce una pratica a partire dalla
propria disciplina, ha una effettività di quello che pensa dentro la disciplina, cioè
redige dei pareri giuridici che mutano alcuni aspetti del sociale. Ma siamo proprio
sicuri che noi, come letterati, non agiamo dentro le pratiche? Le nostre pratiche sono
quelle dell'insegnamento e la pratica cambia la disciplina: è questa l'ipotesi su cui
stiamo lavorando. Definire categorialmente le tre parole “dono”, “bene comune” e
“società postmoderna” serve a dire che è esistito un mondo di cose, in cui il dono per
5
i popoli arcaici (non li chiamiamo primitivi perché effettivamente la ricerca
antropologica non li chiama primitivi ma arcaici) serviva come scambio. Questo
mondo di cose utilizzava gli oggetti (il dono) per far entrare in contatto le
soggettività: attraverso questo passaggio si poneva la soggettività, cioè i popoli
arcaici usavano il dono per porre la soggettività e poi, ad un certo punto, per porre la
regalità, la sovranità. Noi oggi abbiamo trasformato questo dono in regalo.
C'è un'introduzione al rapporto Censis di quest’anno scritta da De Rita che è su
questo molto chiara poichè un sociologo come De Rita afferma che noi viviamo in
una società di desideri senza autorità, cioè desideri senza simbolizzazione. Il regalo
non è più dono, non è più simbolo: in una società di desideri senza norme e di norme
senza desideri, che quindi diventano autoritarie, il regalo non serve più a comunicare
ma si deve consumare. E' un'analisi di tipo psicanalitico della società italiana per
spiegare il berlusconismo. Su questo su Il Manifesto” c'è stato un dibattito perché De
Rita ha contaminato il linguaggio sociologico con quello della psicanalisi, la sua
analisi della società italiana è un esempio di contaminazione. Noi vogliamo andare in
questa direzione: le pratiche interrogano le teorie perché il rapporto non è più
univoco ed unidirezionale ma biunivoco. Cercheremo di mettere in campo una
interrogazione categoriale di questi tre lessemi “dono, bene comune, società
postmoderna” iniziando, oggi, con un'interrogazione sulle prime due categorie,
perché riteniamo che il problema attuale sia quello di vivere in una società di flussi di
informazione e non più in una società di oggetti. Noi vogliamo fare una genealogia
della società di oggetti, dei rapporti linguistici di potere di una società di oggetti per
arrivare a determinare il nostro posto linguistico e di potere dentro una società di
flussi di informazioni. La nostra analisi è che se non si governa questo processo
conoscitivo siamo tutti fuori da ogni possibilità di intervenire nel reale. Oggi sempre
di più si sta restringendo in un modello decisionale piramidale il governo simbolico e
non - lo abbiamo sentito dalle parole di padre Alex Zanotelli - dell'informazione, dei
beni comuni, ecc. e se non spieghiamo al sapere comune, cioè a noi stessi, il governo
delle informazioni come funziona e, quindi se non facciamo una riflessione radicale,
concettuale, categoriale su alcuni dei cardini di questo flusso informativo, siamo
destinati a fare dei discorsi essenzialmente ed unicamente o ideologici o di
retroguardia. Con questo non pensiamo di fare un discorso di avanguardia ma di
radicare nel nostro sapere comune un'interrogazione sulle nostre discipline e quindi
sulla nostra soggettività.
ALBERTO LUCARELLI
A me tocca continuare brevemente l'introduzione legata alla natura e all'oggetto di
quest'iniziativa e ovviamente lo faccio da un'angolazione che non può che essere del
6
giurista e soprattutto di chi studia il diritto con metodo giuridico positivo, diacronico
e sincronico ma soprattutto di chi studia gli istituti classici del diritto pubblico, quelli
del principio di uguaglianza, la solidarietà, i beni pubblici, il principio di
responsabilità, la partecipazione. E proprio nel percorso di approfondimento di
queste categorie classiche del diritto pubblico, chi studia questi istituti non può che
sentirsi sempre più limitato nell'estensione, nella qualità e nella quantità del suo
pensiero sia teorico che applicativo, come si diceva prima, e quindi
progressivamente, io direi necessariamente, attratto da prospettive, metodi, e
contenuti che sono apparentemente extravaganti rispetto a un giurista ma che in
realtà non lo sono.
Quindi ben consapevoli di non voler scivolare tra le languide e lascive braccia della
interdisciplinarietà, troppo spesso paravento a confuse, disinvolte e pasticciate tesi,
ben consapevoli di voler procedere con metodo giuridico ma con l'apporto da una
parte di differenti correnti di pensiero, dall'altra con la manifesta specificità verso le
pratiche sociali e la cittadinanza attiva. Dunque, il pensiero e le analisi diventano più
complessi per un giurista positivo, si è costretti ad attraversare zone oscure che
sembrano non lasciare spazi e luce ma che durante il percorso impongono umiltà,
curiosità, voglia e desiderio di mettersi continuamente in discussione. Il tutto ha
l'obiettivo di cercare di mettere in asse le pratiche sociali con la riflessione teorica, di
sollecitare riflessioni multidisciplinari, di configurare nuove teorie aperte, che
partendo dalle categorie classiche sappiano o cerchino di arrivare a traguardi ed
obiettivi partecipati, che siano in grado di contribuire progressivamente a quel
meccanismo virtuoso che partendo dal binomio informazione e formazione
permanente possano dar luogo a consapevoli processi partecipativi forti e, per quanto
possibile, di resistere e resistere a fenomeni di cooptazione e di strumentalizzazione.
Nel caso specifico, di chi parla, la sfida è particolarmente complessa. Chi studia il
diritto positivo studia i valori, studia i principi, studia le regole ma per metodo è
costretto - lo dico tra virgolette - a partire dall'analisi di un principio giuridico, di una
norma prescrittiva, di una regola, e comunque è costretto, per serietà e rigore, a
confrontarsi con la dimensione dell'effettività. Il seminario che oggi mette in
relazione il dono con il bene comune ed è bene da subito, dunque, evidenziare che sia
la categoria del dono, quale oggetto di politiche pubbliche sociali, nelle quali si
incrociano interesse e disinteresse, sia la categoria del bene comune non presentano
un autonomo fondamento giuridico ma hanno una innegabile valenza giuridica,
hanno una dimensione giuridica, ancorché indiretta, quanto meno sotto il profilo
valoriale. Dunque, dono e bene comune sono categorie che al di là del riferimento
normativo, al di là del fondamento giuridico, hanno valenze ed implicazioni
giuridiche. E queste implicazioni giuridiche devono essere poste in collegamento
attraverso una nuova lettura della cittadinanza, attraverso le pratiche sociali dei
movimenti, dei comitati, delle associazioni che si configurano in quella che
7
possiamo definire cittadinanza attiva o, per definire meglio, nelle nuove dimensioni
della partecipazione o, per andare oltre, io direi che le nuove dimensioni del diritto
pubblico - o per fermarci a uno stato precedente - nelle nuove dimensioni del
pubblico.
Dal punto di vista metagiuridico, non può non rilevarsi che nelle dinamiche sociali il
dono quale azione oggetto di politiche pubbliche sociali e non la donazione,
tecnicamente intesa, innesca un circuito di scambio, prestazione contro prestazione.
Donare significa regalare qualcosa di sé che il donatario sarà obbligato a restituire
(teorie delle obbligazioni sia naturali che pecuniarie). Le dinamiche sociali che
spingono al dono, in questi termini, poco avrebbero in comune con l'istituto giuridico
della donazione: da una parte abbiamo il dono, dall'altra la donazione, perché
quest'ultima è un negozio giuridico attraverso il quale una parte (il donante)
intenzionalmente arricchisce l'altro (il donatario) disponendo di un proprio diritto o
obbligandosi a disporne, senza conseguire un corrispettivo. Il contratto di donazione
sorge allo scopo preciso di arricchire un altro soggetto; ne segue che elementi della
donazione sono lo spirito di liberalità e l'arricchimento. Mentre la donazione esplica
i suoi effetti in ambito di dinamiche di ordine civilistico ed individualistico, il
fenomeno metagiuridico del dono va ben oltre tali dinamiche. Esso non resta
nell'ambito di una rigorosa applicazione individualistica del diritto romano di natura
codicistica, secondo una logica tipicamente proprietaria, ma avrebbe anche
implicazioni pubblicistiche e sociali. In sostanza, non soltanto si donerebbe anche
per ricevere - fattispecie stravagante rispetto alla donazione - ma si donerebbe
soprattutto affinché l'altro doni, innescando meccanismi di selezione ed interessi del
controllo sociale.
Ci sarebbero in sostanza tre momenti legati al dono, tutti e tre con una
potenziale dimensione giuridica: la donazione, non intesa tecnicamente come dicevo
prima dal punto di vista giuridico, l'accettazione e la restituzione, ovvero donare,
ricevere, ricambiare. E' la configurazione di una società concepita su basi orizzontali
dove il principio di uguaglianza sostanziale cede al cospetto del principio di
sussidiarietà orizzontale, fondato sulla spontaneità dell'azione del singolo individuo
dando luogo a quella che è stata definito l'agire solidale del proprio interesse ma
anche solidarietà di gruppo.
Le pratiche del dono in quanto espressione delle politiche sociali a rilevanza
pubblica sono regolate ed assumono una dimensione pubblicistica, passando da una
dimensione individualistica ad quella pubblicistica, e non sono lasciate più al libero
arbitrio religioso ed economico ma sono regolate con finalità che rientrano nella
determinazione delle politiche pubbliche, attraverso i diritti di prestazione e, in senso
più ampio, attraverso lo Stato sociale. Tuttavia il modello verticale fa troppo spesso
assumere ad un soggetto pubblico le caratteristiche negative del proprietario, lo Stato
proprietario, e laddove diventa escludente tende a trattare il bene di un soggetto
8
proprietario pubblico, bene di sua appartenenza come un dominus assoluto,
sottovalutando la funzione e soprattutto il soddisfacimento di diritti fondamentali
attraverso il bene stesso: tutta l'attenzione si concentra sul bene, sulla sua dimensione
economica, ancorché il dominus sia pubblico, sulla sua capacità di fare profitto e
quindi anche sulla possibilità di darlo in concessione ai privati (siamo alle acque
minerali e all'abuso del diritto del proprietario pubblico che svende a concessione di
quattro soldi al privato l'utilizzo delle stesse). Questo processo genera quello che è
stato definito da Pietro Rescigno negli anni '60 l'abuso del diritto, ancorché esercitato
da un soggetto pubblico, la dimensione sociale della nostra Costituzione che aveva come ricordava Mario Rusciano - nel rispetto del principio di eguaglianza
disciplinato le pratiche del dono, entra in crisi perché entra in crisi quel modello della
separazione tra Stato e cittadino che invece era stato garanzia di immunità a forme di
contaminazione pubblico-privato. In sostanza, il modello verticale, che avrebbe
dovuto democraticamente regolare le pratiche sociali del dono, è troppo distante sia
dalla cittadinanza attiva che dalle sue pratiche, sia dalla funzione del bene oggetto
del dono, anche e soprattutto se espressione di utilità materiali, cioè il modello
pubblicistico verticale entra in crisi. Tale modello non impedisce che le regole
giuridiche del dono continuino a muoversi all'interno delle dicotomie classiche
(soggetto pubblico-soggetto privato, bene pubblico-bene privato) non percependo le
nuove istanze e anzi regredendo a forme di sussidiarietà orizzontale si reagisce
all'invadenza del soggetto pubblico, regredendo a forme precedenti, in alcuni casi,
anche le teorie illuministiche. Cioè attraverso forme di governance escludenti,
corporative, lobbistiche, affaristiche, che tendono artatamente ad anestetizzare le
forme naturali del conflitto. La critica a questo modello, ovvero lo Stato sociale,
viene risolta con un indebolimento dello spazio pubblico (si pensi alla sussidiarietà
orizzontale della nostra Costituzione, o anche al progetto di federalismo fiscale e
demaniale che io amo definire federalismo per abbandono - di beni, di servizi
pubblici, di diritti...) o attraverso una generale privatizzazione degli spazi pubblici,
come servizi, beni o rapporti di lavoro. Il dono riassume quella configurazione
antidemocratica ed escludente, violenta, individualistica, tipica dello stato
presociale, facendoci piombare in una democrazia postmoderna che fa rivivere la
legge del più forte. Ecco dunque la necessità di un ragionamento aperto e
partecipato, occorre ragionare su come mettere in collegamento le pratiche del dono
con quelle del bene comune, partendo da un dato, ovvero che oltre alle categorie del
bene pubblico e del bene privato esiste, per l'appunto, una nuova categoria giuridica
che è il bene comune e che la sua governance non può prescindere da pratiche sociali
virtuose, fondate su modelli di gestione partecipativa attraverso le quali lo Stato
continua a donare diritti di prestazione, diritti sociali, ma dona anche porzioni della
sua sovranità su beni di appartenenza collettiva, appunto sui beni comuni, che
vogliono sfuggire a quel rapporto dominus-bene, romanistico, civilistico,
9
individualistico, che vogliono sfuggire a quel rapporto di appartenenza escludente
del dominus con il bene al regime proprietario proprio perché beni di appartenenza
collettiva. In sostanza, la finzione giuridica della sovranità popolare ed in un certo
senso anche della rappresentanza popolare che hanno consentito alle istituzione
pubbliche, al soggetto pubblico di dominare gli spazi pubblici o gli spazi comuni,
anche in termini negativi, ovvero decidendo di volta in volta e con grande
discrezionalità di abbandonarli o di farli sfruttare da privati o di consentire ai privati
di fare affari sui beni di appartenenza collettiva, cederebbe dinanzi all'incedere della
teoria giuridica dei beni comuni; questa cessione si concretizzerebbe in una forma
metagiuridica di dono.
Dunque, democratizzazione delle pratiche del dono evitando forme
regressive o postmoderne (le privatizzazioni sono le versioni postmoderne dei
rapporti feudali) e per quanto riguarda i beni comuni, donare porzioni di sovranità e
agevolare forme di gestione partecipativa. Tutto ciò impone una riflessione sulla
nozione di contre-démocratie, quale risultato di un insieme di pratiche di controllo,
di impedimento, di giudizio, attraverso le quali la società civile, la cittadinanza
attiva, fa l'esperienza del suo ruolo richiedendo la trasformazione del comune da
luogo di non diritto a luogo di diritto: potremmo dire, dal pubblico al comune. Questi
io credo che saranno, dal versante giuridico, i temi centrali sui quali puntiamo: sono
ancora in forme embrionali ma sono dei punti centrali sui quali vogliamo puntare la
nostra attenzione nel ciclo di seminari che ha inizio oggi.
Carlo OSSOLA
E' stato ripreso un progetto che nacque qui a Napoli alla metà degli anni Ottanta,
certamente un po' troppo ambizioso, ma non tutto va perduto di quello che
utopicamente si sogna e cioè di far rinascere l'esperienza, almeno dal punto di vista
delle istanze soggiacenti, di cui tre non dico protagonisti ma almeno fautori del
progetto ora sono qui: Roberto Esposito, Ugo Olivieri ed io. Tra poco ritornerà qui
anche il quarto, cioè Francisco Jarauta. Questo progetto è poi proseguito anche con
un corso tra fine anni Novanta ed inizio Duemila Figure del dono tra mito e
consumo; poi abbiamo continuato con un corso al College de France con un corso
che, provocatoriamente, si intitolava - si trova sul sito della mia cattedra - "In pura
perdita", cercando di vedere una storia Otto-Novecentesca, in questa radicalità che
rinuncia ad ogni forma di scambio perché si pone in pura perdita di sé. Vecchie
abitudini nostre di formazione chiedono, prima di passare alla fase propositiva che
sia fatta prima un'analisi critica, una sorta di autocritica e critica dei concetti che si
mettono in campo, perché altrimenti si rischia immediatamente di mitizzarli o di
ideologizzarli e quello che vorrei qui fare rapidamente è una ipotesi critica in ordine
10
al dono - come ha già fatto Roberto con una focalizzazione intorno al termine
munus, ripreso nella sua diramazione semantica che è molto importante.
Il primo elemento che vorrei mettere in rilievo è che, in realtà come ha detto
Roberto Esposito, noi oggi siamo in una società nella quale è bene pensare che il
dono non esiste, anche per le ragioni dette prima da Alberto Lucarelli, cioè che se si
teorizza il dono, in realtà si retrocede ad una società dalla quale veramente
vorremmo non essere condizionati. La ragione per la quale è importante criticare il
concetto di dono è che - oltre le cose già dette - esso suppone un passaggio, un
andare e venire, una distanza che viene colmata, pur provvisoriamente, un percorso,
in sostanza, e suppone, in definitiva, una territorialità. I modi stessi con cui nel libro
di Starobinski, Largesse vengono rappresentate le forme storiche di dono mette in
rilievo come la maggior parte di esse suppone la territorialità, l'elargire, il buttare il
dono, perché è dal carro trionfale che si elargisce (e-largior, elargire: presuppone
una territorialità) cosa che oggi mi sembra difficile da predicare. Credo che abbia
ragione Zygmunt Bauman quando dice che noi oggi viviamo in una società liquida
che, in quanto tale - liquida proprio nel senso che non ci sono argini - togliendo la
territorialità ha tolto tutto quello che ha anche il termine giuridico. Se posso
avanzare questa ipotesi, direi che la figura del dono classico oggi sparisce per
mancanza di pertinenze territoriali. Nel rapporto annuale del Censis di tre anni fa,
Giuseppe De Rita è arrivato a dire che in realtà in Italia noi non viviamo neppure in
una società liquida, che permette quanto meno il concetto di flusso, ma in una
società mucillagine, cioè dove il flusso non c'è perché viviamo in acque stagnanti
che quindi creano continuamente mucillagine, spore, alghe, cioè fenomeni
degenerativi del flusso, nonché del territorio che non c'è.
Due domande io vorrei porre in questa sede, cioè: a) si può riconsolidare una
società liquida? Lasciamo perdere per un momento l'idea di società mucillagine,
altrimenti dovremmo chiudere qui il seminario, dire che la storia è finita, il Paese è
finito, eccetera; b) ammettendo e non concedendo che si possa riconsolidare una
società liquida, dove si può porre il principio di una bildung, di una costruzione
(che però in tedesco è anche formazione) capace appunto di ricostruire un
territorio? E poi, subordinatamente, quali sono le virtù, l'ethos, che suppongano e
siano in grado di produrre la costruzione di un edificio? Mi riferisco ad una casa
comune, con i presupposti teorici già evocati, cioè alla difficile costruzione del
passaggio - che non è senza inquietudine, senza perdite, senza problematicità –dal
pubblico al comune. In un momento in cui il pubblico è fortemente attaccato dal
privato e dalla teoria delle privatizzazioni, siamo in quella congiuntura nella quale
si rischia di perdere il pubblico, senza aver costruito il comune e quindi perdendo
da ambedue le parti. Questo è politicamente un problema molto serio, cioè è
necessaria la costruzione del bene comune, che ha una gittata temporale lunga, ma
con la conoscenza che se perdiamo anche il pubblico rischiamo di perdere l'uno e
11
l'altro.
Voglio ancora porre un'altra questione che deriva dal cambiamento anche di
titolo che proposi anche io stesso all'Einaudi, che accettò e così pure l'autore, del
titolo francese di Starobinski (non per una questione di filologia ma perché il titolo
italiano di questo seminario “A piene mani” deriva appunto dal titolo dell'edizione
Einaudi di Largesse), la cui traduzione letterale sarebbe stata Largizione o
Elargizione ma evidentemente insufficiente rispetto a tutti i casi che contempla il
termine così come l'ha usato Starobinski. Proposi quindi questo titolo A piene mani,
teoricamente più neutro, anche se suppone una sovrabbondanza da una parte e da
un'altra no, per cui è anche pericoloso. Ma mi sembra meno pericoloso che non il
termine largio che è particolarmente inficiato da un'osservazione dei Padri della
Chiesa, in particolare di Ambrogio, il quale dice in un bellissimo latino che quando
tu elargisci al povero non dai del tuo ma restituisci del suo. Dunque, questo termine,
fin dalla concezione classica, è un termine estremamente ambiguo e implica quello
che è stato a lungo opposto dalle società moderne, soprattutto di stampo
protestante, alla compensazione elargitiva delle società fideistiche e cioè che al
dono, all'elemosina va sostituita la giustizia. Se uno stato funzionasse nella sua
perfetta redistribizione egualitaria non ci sarebbe bisogno di donativi. Ecco che
questa critica, che viene già dall'interno della Chiesa cioè che non c'è bisogno di
elargizione ma di restituzione, è un elemento assolutamente importante: noi non
possiamo parlare di dono se dietro non c'è prima di tutto un problema di giustizia.
Diciamo che ipoteticamente nelle grandi teorie comunitaristiche, dai quaccheri ai
kibbutz - si ricordi l'origine socialista dei kibbutz - l'idea comunitaria è fortissima:
non ci sono povertà o dono ma ci sono lavoro ed eguaglianza: dai quaccheri ai
kibbutz è un'utopia che ha attraversato l'Occidente, si può discutere su come sia
finita ma è indubbio che dobbiamo tenerla presente problematicamente, per il fatto
che nessuna interpretazione ed esecuzione del dono è in grado di sostituire il
principio di una giustizia egualitaria. A controprova, si può benissimo vedere che le
società ancora oggi basate sul quarto pilastro che è l'elemosina, cioè le società
islamiche, sono le più profondamente ingiuste. Basta guardare le società islamiche
dove esiste una possibilità di verifica e sono quelle in cui poche famiglie hanno
tutto il petrolio, tutta la ricchezza e con gli altri si pratica l'elemosina; le società
islamiche o re-islamizzate non sono appunto reislamizzate per ragioni religiose ma
per conservare questo privilegio e quindi questo quarto pilastro, che in realtà è un
potentissimo fenomeno di conservazione sociale.
Tutto questo noi dobbiamo prenderlo globalmente in carico perché non
possiamo astrarci, non viviamo in una società solo occidentale: se è una società
globale anche questi elementi ne fanno parte. Naturalmente mi sono posto - e lo
lascio qui come problema aperto - un dilemma che mi sarebbe caro sviluppare di
più, proprio perché per un certo aspetto è già stato lanciato da Roberto. La mia
12
preoccupazione è quella di proporre delle virtù pubbliche nella loro storia e
definizione: non è un elenco, perché gli elenchi sono tacitamente conservatori
perché si elimina la scelta, quindi la responsabilità, invece c'è una necessità di
esercizio di responsabilità. Queste virtù pubbliche che vorrei qui proporre sono tali
perché presuppongono questo fondamento che dicevo prima di bildung, questa
territorialità, in quanto sono esse stesse tetragone, cioè fatte di quattro begli angoli
pilastri di fondamento. Sono tetragone perché sono così definite nel primo libro del
De Officiis di Cicerone: De quattuor virtutibus unde omnia vitae communis officia
manant, prudentia, iustitia, fortitudine et temperantia. Cicerone riprende un
termine della Politica di Aristotele, III libro, e dice, in sostanza, che nel capitolo
parlerà delle quattro virtù dalle quali promanano tutti gli officia, cioè tutti i
reciproci obblighi della vita comune (si badi, non dice della vita pubblica); esse
sono le quattro virtù cardinali, come noi le chiamiamo oggi, cioè sono quei cardini
attorno a cui ruotano le porte dell'aprire e del chiudere, e sono cardini, vorrei dire in
termini shakespeariani, quando l'autore dice nell'Amleto che il mondo è fuori dai
cardini, ricorda la linea aristotelico-ciceroniana dell'agire del mondo che è andato
fuori dai cardini politici (fortezza, giustizia, temperanza e prudenza). Queste sono
virtù classiche che il Cristianesimo ha assolutamente integrato, con una rilettura di
Ambrogio e di Agostino di queste virtù, vengono persino ridotte quelle aristoteliche
a queste quattro: è un momento drammatico, secondo me, della storia del
Cristianesimo perché facendo così esso salva l'eredità greco-latina ma, a mio modo
di vedere chissà cosa ne direbbe Alex Zanotelli, condanna definitivamente l'eredità
evangelica. Non dimentichiamo che l'unica volta in cui Maria parla nell'Evangelo è
un discorso di violenza paradossale in cui si dice: "L'anima mia magnifica il
Signore ed il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore [...] perché ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha
rimandato a mani vuote i ricchi". Quando leggete questo testo, all'interno di una
tradizione ebraica - perché la vita pubblica del Cristo deve ancora avvenire - è un
rovesciamento definitivo, una ri-voluzione, un re-volvere, che crea un altro spazio.
Già i Sinottici sono più prudenti perché le Beatitudini pronunciate dal Cristo sono
una risposta alla Madre, una risposta alla tradizione ebraica nella quale parla la
Vergine, ed esso non è più un avvenimento ma una promessa. "Beati voi che ora
avete fame perché sarete saziati; guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame".
Già nella storia delle comunità che hanno scritto questi Vangeli, c'è la perplessità
per la Vergine che sta dentro tutta una tradizione profetica e dice che è accaduto
mentre per le comunità che scrivono gli Evangeli è una promessa. Insomma, dopo
150 anni non era ancora accaduto e quindi gli Evangeli sono già dentro questa
materia storica di un Magnificat che non si è magnificato, per cui nasce già dalle
comunità degli Evangeli un tempo storico che, nel succedersi dei secoli, porta poi
all'operazione agostiniana-ambrosiana che è un'operazione drammatica, secondo
13
me. E' il consolidare questa eredità greco-latina a scapito di una ipotesi vetero e
neotestamentaria con cui alle quattro virtù cardinali si aggiungono le tre teologali
fede, speranza e carità. Noi siamo oggi nella situazione paradossale di aver buttato
via sia il Magnificat e le virtù teologali sia il dibattito sulle radici cristiane d'Europa
è stato di una povertà sconcertante proprio per ignoranza, perché non si è neanche
tenuto conto che tutto stava già scritto, anche nei Testi canonici, nella cultura
d'Occidente, che il Cristianesimo si è affermato rinunciando alla parte più
consistente e profetica della propria origine e che si è affermato facendo proprio in
toto il sistema aristotelico delle quattro virtù cardinali. Andiamo ad analizzarle
come ipotesi politica. E' indubbio che, quando si guardano come ipotesi politica,
sono virtù che più che dello scatto in avanti sono della resistenza nei tempi gravi:
temperanza, giustizia, fortezza...
Giungendo ad un punto di sutura tra l'uomo classico medievale e l'uomo
moderno, quando voi vedete l'affresco del Buon Governo a Palazzo pubblico a
Siena, grande progetto dell'Italia comunale, gli effetti del buon governo vengono
testimoniati dalla rappresentazione allegorica delle quattro virtù cardinali a cui è
aggiunta, come garanzia e come frutto che sono state ben esercitate, la pace. Qui
ritorna il discorso di Zanotelli, una parte dell'umanità si afferma sull'altra,
precisamente perché il suo obiettivo globale, ultimo non è la pace ma il dominio,
quindi per esercitarlo si ha bisogno, appunto, di strumenti di dominio; mentre gli
affreschi del buon governo sono dichiaratamente impostati: le quattro virtù e al
centro, sopra il trono delle libertà comunali, la pace. Passiamo dal tempo
medievale-moderno al tempo moderno-contemporaneo e giungiamo ad una
testimonianza letteraria molto importante di Italo Calvino ne "La giornata di uno
scrutatore" (1963) il protagonista Amerigo che è dentro il Cottolengo, luogo di
marginalità e di esclusione, arriva a queste conclusioni: "La vanità del tutto e
l'importanza di ogni cosa fatta da ognuno erano contenute tra le mura dello stesso
cortile. Bastava che Amerigo continuasse a farne il giro e sarebbe incappato cento
volte nelle stesse domande e risposte. "Chi agisce bene nella storia - provò a
concludere - è nel giusto". E aggiunse in fretta. "Certo, essere nel giusto è troppo
poco". Ecco, qui noi abbiamo la proposizione fondamentale con cui si può criticare
oggi il concetto delle quattro virtù.
La cultura della destra non ha mai avuto una teoria pubblica ricca. Quando si
è affermata la teoria dei soggetti della quale noi oggi siamo a vario modo vittime?
Con le Estati di Nicolini, con la politica dei soggetti di Occhetto, la Sinistra si è fatta
interprete di categorie che non le erano proprie e le ha regalate ai migliori interpreti;
non è un prodotto quello che viviamo che, nelle matrici culturali, venga da Destra
ma è un regalo assurdo fatto da una classe politica imbelle che ha sostituito alla
politica che sembrava negativa - e in effetti il termine non era scelto troppo bene,
dell'austerità prodotta da Berlinguer sei o sette anni prima - con una politica dei
14
soggetti che ha avuto gli esiti che abbiamo visto. Quindi io credo che proprio per
rispondere alla domanda di Calvino, se stare nel giusto sia sufficiente o meno,
occorra necessariamente sostituire una politica dei soggetti con una teoria dei fini.
Faccio un esempio molto semplice: se dico - visto che padre Zanotelli l'ha citata - la
povertà è ingiusta, in una teoria dei soggetti, nella quale stiamo vivendo, ci si
adopera a definire una ragionevole soglia della povertà perché essa può
contemperare un po' di povertà e un po' di marginalità, distribuendola dietro varie
categorie sociali; mentre invece la teoria dei fini ci dovrebbe spingere a trovare le
modalità per una ridistribuzione delle risorse tale da eliminare l'aporia di partenza e
cioè la povertà. Già oggi sembrano democratici ed ultra, socialdemocratici e
portatori di welfare, quelli che vogliono definire la soglia della povertà ma è
un'aberrazione perché restiamo sempre dentro la politica dei soggetti mentre, se
prendiamo sul serio la teoria dei fini, l'idea di soglia di povertà è semplicemente
aberrante perché la povertà non può entrare in una simile teoria. Ma se prendiamo
invece una politica dei soggetti non dico che ci sta benissimo dentro ma ci può
stare.
Chiudo con una ipotesi di lavoro. Credo che tre cose siano assolutamente
necessarie:
1) C'è bisogno di un bene comune ma, dato che la conquista sarà lunga, bisogna
stare attenti nel passaggio dal pubblico al comune a non perdere quel poco di
pubblico che c'è ancora.
2) Non sappiamo quanto durerà la lunga notte che dobbiamo attraversare, ne
discutevo ieri con Gustavo Zagrebelsky. Ecco perché ho proposto il canone classico
delle virtù cardine di Aristotele e del De officiis. L'impressione di Zagrebelsky e
anche la mia è che la notte durerà a lungo: non basterà aver cambiato governo e ceto
dirigente perché basta guardarsi un po' intorno nelle nostre università: chi forma
una classe dirigente degna di questo nome? Con quali criteri avviene la selezione di
questa classe dirigente?
Il rischio è che i complessi sociali nei quali si forma, per così dire, l'avvenire della
società, sono talmente compromessi che c'è anche da domandarsi se quella che noi
prendiamo come l'aberrazione di un sistema che dovrebbe ritornare alla propria
normalità non sia invece l'espressione di un cambiamento già avvenuto a cui hanno
contribuito molte generazioni di mancata dignità civile di questo Paese. Quindi, se
vale la teoria che vale una notte per disfare e poi ci vogliono trent'anni per
ricostruire, le notti in cui si è prodotta questa formazione di società sono state tali
che l'attraversamento potrebbe essere di ottanta, novanta anni, cioè di tre, quattro
generazioni. Allora se la notte è lunga è assolutamente necessario avere virtù di
attraversamento, perciò arriviamo anche al terzo punto cioè che la sostituzione della
teoria dei fini alla politica dei soggetti non può prescindere da un bagaglio minimo
di trekking notturno: noi dobbiamo attrezzarci anche per una lunga notte. Qual è il
15
vettovagliamento morale minimo se la notte è lunga? Il sistema che è stato più
lungamente collaudato è quello che va da Aristotele a Cicerone a Sant'Agostino alla
teoria del buon governo, con i correttivi engelsiani e calviniani cioè se basti essere
nel giusto.
3) Se le prossime generazioni riusciranno a tenere, ecco che bisogna fin da ora
uscire da una politica dei soggetti, che è molto debole e poi già espropriata, e
ritornare ad una teoria dei fini che invece è in grado di fornire strumenti di lavoro
più adeguati.
16