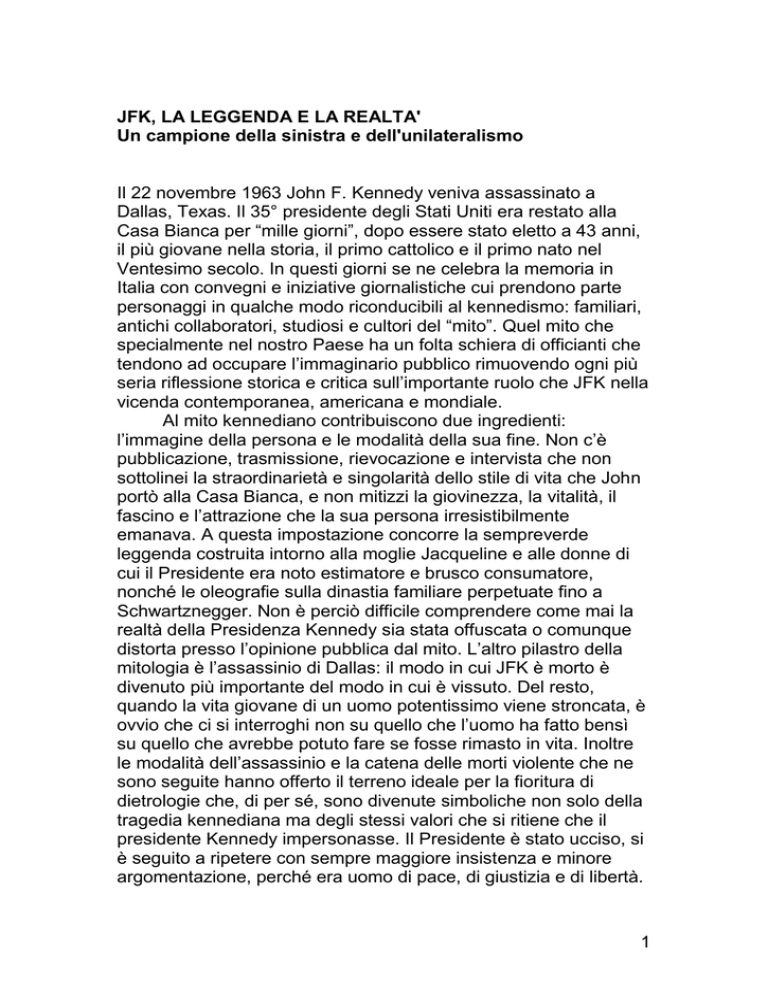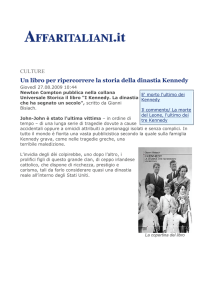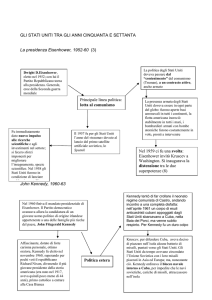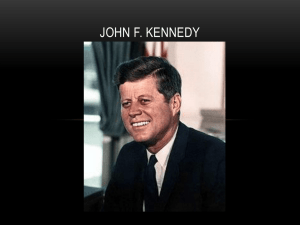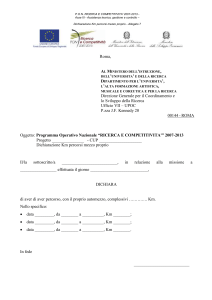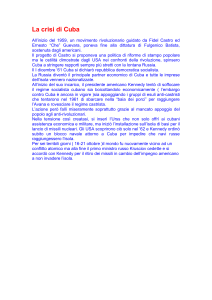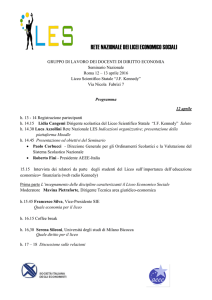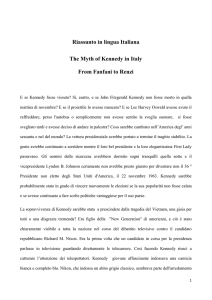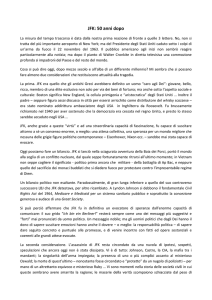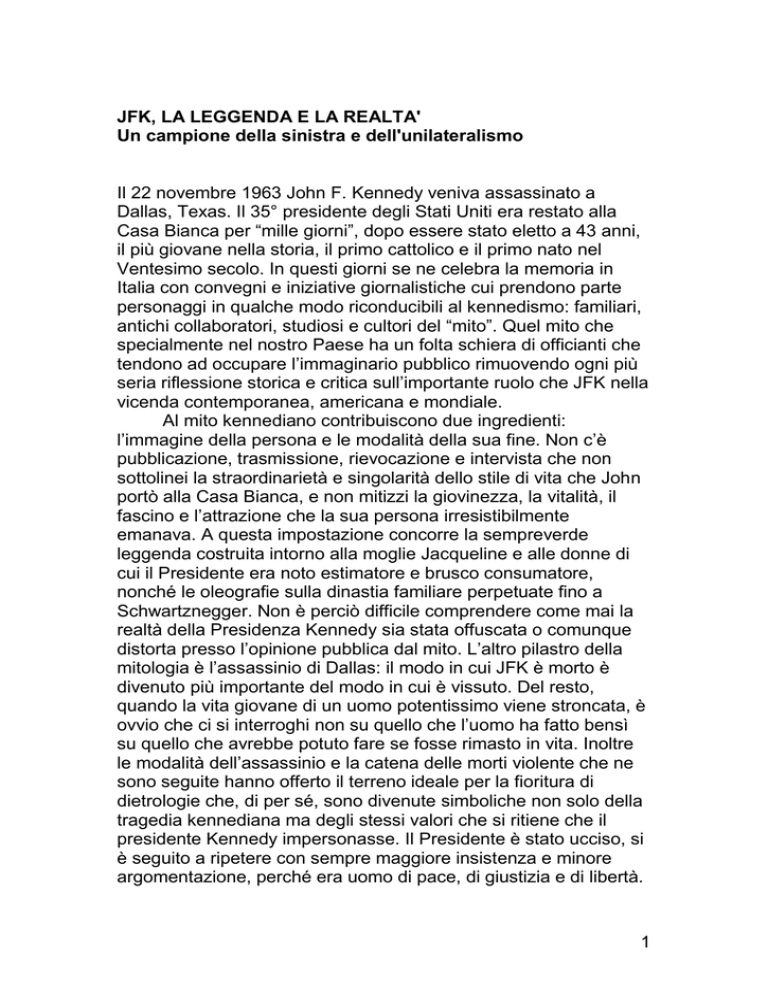
JFK, LA LEGGENDA E LA REALTA'
Un campione della sinistra e dell'unilateralismo
Il 22 novembre 1963 John F. Kennedy veniva assassinato a
Dallas, Texas. Il 35° presidente degli Stati Uniti era restato alla
Casa Bianca per “mille giorni”, dopo essere stato eletto a 43 anni,
il più giovane nella storia, il primo cattolico e il primo nato nel
Ventesimo secolo. In questi giorni se ne celebra la memoria in
Italia con convegni e iniziative giornalistiche cui prendono parte
personaggi in qualche modo riconducibili al kennedismo: familiari,
antichi collaboratori, studiosi e cultori del “mito”. Quel mito che
specialmente nel nostro Paese ha un folta schiera di officianti che
tendono ad occupare l’immaginario pubblico rimuovendo ogni più
seria riflessione storica e critica sull’importante ruolo che JFK nella
vicenda contemporanea, americana e mondiale.
Al mito kennediano contribuiscono due ingredienti:
l’immagine della persona e le modalità della sua fine. Non c’è
pubblicazione, trasmissione, rievocazione e intervista che non
sottolinei la straordinarietà e singolarità dello stile di vita che John
portò alla Casa Bianca, e non mitizzi la giovinezza, la vitalità, il
fascino e l’attrazione che la sua persona irresistibilmente
emanava. A questa impostazione concorre la sempreverde
leggenda costruita intorno alla moglie Jacqueline e alle donne di
cui il Presidente era noto estimatore e brusco consumatore,
nonché le oleografie sulla dinastia familiare perpetuate fino a
Schwartznegger. Non è perciò difficile comprendere come mai la
realtà della Presidenza Kennedy sia stata offuscata o comunque
distorta presso l’opinione pubblica dal mito. L’altro pilastro della
mitologia è l’assassinio di Dallas: il modo in cui JFK è morto è
divenuto più importante del modo in cui è vissuto. Del resto,
quando la vita giovane di un uomo potentissimo viene stroncata, è
ovvio che ci si interroghi non su quello che l’uomo ha fatto bensì
su quello che avrebbe potuto fare se fosse rimasto in vita. Inoltre
le modalità dell’assassinio e la catena delle morti violente che ne
sono seguite hanno offerto il terreno ideale per la fioritura di
dietrologie che, di per sé, sono divenute simboliche non solo della
tragedia kennediana ma degli stessi valori che si ritiene che il
presidente Kennedy impersonasse. Il Presidente è stato ucciso, si
è seguito a ripetere con sempre maggiore insistenza e minore
argomentazione, perché era uomo di pace, di giustizia e di libertà.
1
Dunque la morte di JFK ha alimentato ciò che la sua vita non è
stata o, forse, è stata solo in parte ma che molti speravano che
potesse essere.
* * *
Parte importante delle celebrazioni romane avrà Arthur
M.Schlesinger Jr, storico di prestigio ed autore nel 1967 di A
Thousand Days: John Kennedy in the White House, capostipite
della letteratura di glorificazione kennediana: “Ha riportato questo
Paese indietro alle sue migliori tradizioni, ripulendo nel mondo
l’impressione di una vecchia nazione e di un vecchio uomo
[Eisenhower], stanco, antiquato, timoroso delle idee, del
cambiamento e del futuro… Ha trasformato lo spirito americano…
Le energie che ha messo in moto, gli standard che ha affermato, i
propositi che ha ispirato e gli obiettivi che ha stabilito guideranno
negli anni che verranno la terra che amava”. E’ fuor di dubbio che
l’elezione del giovane Presidente dopo gli “anni del conformismo”
di Eisenhower, abbia rappresentato una svolta psicologica nella
massima istituzione americana, la Presidenza, tanto più in quanto
avvenne contemporaneamente alla nascita e allo sviluppo di quei
movimenti sociali nuovi che avrebbero dominato la scena
americana negli anni Sessanta ben oltre lo stesso Kennedy. Ma
quel che in Italia viene spesso mistificato, è proprio il senso
dell’opinione di Schlesinger Jr. che lo stesso storico avverte
essere “non una storia comprensiva della presidenza Kennedy,
ma una memoria personale di una persona che ha servito alla
Casa Bianca durante gli anni di Kennedy”. Alimentare il mito
kennediano sulla base di queste opere, è un cattivo servizio che si
rende anche all’onestà di chi propone una memoria così
appassionatamente personale, consegnata al pubblico a poca
distanza da un assassinio così impressionante. Per fare un
paragone comprensibile è come se in Italia si scambiassero le
memorie di Tonino Tatò per una storia di Enrico Berlinguer.
Un’altra opera che ha avuto grande influenza nella
percezione popolare è il Kennedy di Theodore C.Sorensen, il
collaboratore del Presidente addetto a scrivere i discorsi e quindi
all’origine diretta della retorica cresciuta sul verbo kennediano:
“Sarebbe difficile misurare John Kennedy con un metro storico
ordinario. E’ stato un uomo straordinario, un politico straordinario e
2
uno straordinario Presidente. Come nessun grafico nella storia
delle armi può riflettere accuratamente l’avvento dell’atomo, così
credo che nessuna misurazione del bene e del male è adeguata
per JFK. Una mente così libera dalla paura, dal mito e dal
pregiudizio, così opposta alle cantonate e ai cliché, così riluttante
alla finzione e ad essere ingannato, ad accettare o riflettere la
mediocrità, è rara nel nostro mondo, e ancor più rara nella politica
americana. Senza diminuire alcuno dei grandi uomini che hanno
fatto i Presidenti in questo secolo, non vedo come John Kennedy
possa essere secondo a nessuno”. Se però ci si vuole sottrarre
alla “Leggenda Camelot” che seguita a riproporre stancamente
quel che all’indomani della scomparsa del Presidente scrissero da
memorialisti i suoi più stretti collaboratori (anche Sorensen avverte
“un appassionato partecipante non può essere un osservatore
obiettivo), e si vuole tentare un’analisi più circostanziata, è
opportuno fare una ricognizione della storiografia che per
quarant’anni ha seguitato ad interrogarsi sulla Presidenza
Kennedy ed a proporre nuove interpretazioni.
* * *
Non pochi storici che potremmo definire “revisionisti”, hanno
esplorato i diversi aspetti della Presidenza Kennedy, specialmente
quando sono state rese consultabili fonti in precedenza
indisponibili. E’ così che è stata messa in dubbio con sempre
maggiore consistenza la linea Schlesinger/Sorensen considerata
come una ricostruzione tendenziosa volta a gonfiare i successi e a
minimizzare i fallimenti della Presidenza. Non mi riferisco qui a
tutti quegli aspetti “personali” riguardanti il suo stile di vita che
hanno portato JFK a sfiorare alcuni boss del crimine organizzato,
e neppure alle sistematiche menzogne circa il suo stato di salute,
le sue medicine e droghe che potevano influire sulla sua condotta
politica. Non è questo il metro per valutare il senso politico della
Presidenza, se non per quel tanto che poteva influire sulle scelte e
sui comportamenti politici. Interessa piuttosto la scoperta e la
conoscenza che si sono andate allargando di vicende e atti della
sua Amministrazione tenuti nascosti, nonché i solidi
approfondimenti che sono stati messi in ombre dall’eccessiva
enfasi sull’immagine dell’uomo.
3
Con la pubblicazione dei “Pentagon Papers” nel 1971, si è
avanzato il sospetto che Kennedy sarebbe entrato ancor più
pesantemente di quel che fece in Vietnam, sulla stessa linea poi
seguita dal successore Lyndon Johnson, con un’interpretazione
che ribalta quella accreditata dai kennediani. Nel 1975 una
commissione del Senato rendeva pubblica un’inchiesta sui
presunti tentativi di assassinio di leader esteri incluso Fidel Castro
da parte della CIA, i cui piani furono in gran parte preparati
durante l’Amministrazione Kennedy. Lo storico Garry Wills, nel
suo The Kennedy Imprisonnment: A Meditation on Power del
1982, sottolinea come il tentativo di invasione di Cuba preparato
dalla Cia non fu praticamente sottoposto ad alcuna analisi da
parte del nuovo Presidente con l’effetto sia di mandare allo
sbaraglio gli esuli cubani sia di provocare un danno di immagine
per gli Stati Uniti. Anche la cosiddetta operazione “Mangusta”,
preparata successivamente per ribaltare Castro, fu rovinosamente
abbandonata, così come risultarono dei fallimenti i laboratori di
tattica controinsurrezionali sperimentati in Vietnam. Un altro
storico, Thomas Reeve, in A Question of Character sostiene che
la ragione della debolezza della leadership di Kennedy stava nella
completa mancanza del senso di moralità che fu alla base
dell’autorizzazione della spedizione della Baia dei porci,
dell’escalation in Vietnam e della tardiva conversione alla politica
dei diritti civili. Thomas Paterson, da parte sua, contesta un altro
luogo comune della leggenda kennediana secondo cui negli ultimi
mesi di vita il Presidente stava sviluppando un più maturo e
moderato approccio alla politica estera. Herbert S.Parmet in JFK
del 1983 ritiene che l’inclinazione di Kennedy per le guerre segrete
all’estero abbia favorito le crisi internazionali degli anni successivi,
un fallimento pari alla mancanza di determinazione nel far votare
dal Congresso programmi di riforma all’interno. Più recentemente,
nel 1991, James N. Giglio in The Presidency of J.Kennedy dà un
giudizio più equilibrato sull’intera Presidenza: “Gli Stati Uniti
stavano meglio nel novembre 1963 alla morte del Presidente di
quanto lo fossero all’inizio nel gennaio 1961…In conclusione JFK
è stato superiore alla media dei Presidenti americani, buono ma
non grande”. Infine tra i tanti altri che si sono occupati della
questione, Michael R. Beschloss in The Crisis Years: Kennedy
and Khrushev 1960-1963 apparso nel 1991 distingue nella politica
estera di Kennedy tra la mancanza di abilità nelle questioni di
4
lungo termine e la buona capacità di risolvere le crisi di breve
termine.
* * *
Le molte ricerche apparse negli ultimi trent’anni modificano
notevolmente le interpretazioni agiografiche più diffuse che hanno
tenuto e seguitano a tenere banco presso i cultori del mito
kennediano . Ma per fare un bilancio complessivo occorre
superare sia la linea cosiddetta “Camelot” (il mito), sia quella antiCamelot, tentando di concettualizzare i principali snodi che hanno
caratterizzato la Presidenza Kennedy in politica estera e in politica
interna. Quando JFK fu eletto alla Presidenza come Democratico
con un esiguo margine di voti sull’avversario Repubblicano
Richard Nixon (vice di Eisenhower), gli Stati Uniti si trovavano in
piena Guerra fredda. La linea portante della politica estera era il
“contenimento” del blocco sovietico con l’uso, se necessario della
“rappresaglia massiccia” anche atomica. Il confronto/scontro tra i
due blocchi era ideologico, politico, militare e anche, per così dire,
morale. Durante la seconda Presidenza Eisenhower (1955-61), si
era diffusa l’impressione che gli Stati Uniti fossero in posizione di
ripiegamento, quasi per un complesso di inferiorità rispetto
all’URSS guidata dal nuovo aggressivo leader post-staliniano
Chruscev che puntava sull’espansione economica e sulla gara
tecnologica. Si aggiunga che il movimento comunista
internazionale non era più limitato all’Unione Sovietica ma fioriva
in ogni angolo del mondo, in Asia, Africa e America latina, sia
direttamente (Cina) che attraverso le forze della decolonizzazione
al massimo del vigore. A questo clima, che fu definito di “apatia”
occidentale, contribuirono negli Stati Uniti anche l’immagine
pubblica di un Eisenhower che apparve logorata, la malattia e poi
la morte (1959) dell’artefice della politica estera John Foster
Dulles, e il lancio dello Sputnik (ottobre 1957), il primo ordigno
spaziale che apparentemente indicava la preminenza tecnologica,
quindi militare, dei sovietici.
E’ su questo sfondo che l’elezione di Kennedy nel novembre
1960 assunse il significato di una svolta radicale il cui banco di
prova non poteva che essere il ruolo internazionale dell’America in
un mondo diviso con un’accentuata competizione tra i due blocchi.
Il giovane Presidente si connotò subito e continuò ad agire fino
5
alla fine come un energetico e fervente anticomunista che fece
della contrapposizione dura all’Unione Sovietica di Chruscev e più
in generale a tutte le forme in cui si manifestava il comunismo
internazionale, la sua missione centrale. Ricorrendo alle categorie
usate nel mondo bipolare, John Kennedy deve essere senz’altro
definito un “Cold Warrior”, sottospecie “falco” , ben più dei suoi
predecessori Truman ed Eisenhower e di molti dei suoi
successori. Questo aspetto è stato talvolta occultato da quei
cultori del mito che hanno voluto vedere in JFK un campione della
distensione (perseguita nell’ultimissima parte della Presidenza
dopo una vita passata a mostrare muscoli), se non addirittura il
rappresentanti di una sinistra corriva e accomodante con il mondo
comunista. Tutte le sue brevi ma intense iniziative in politica
estera e militare e le sue scelte tattiche e strategiche non possono
che essere lette in questo quadro, anche se alcune furono
coronate da successo e altre da fallimenti, alcune ebbero vero e
proprio carattere di scontro ideologico altre invece aprirono la
strada alla trattativa tra i due blocchi come nel caso del Limited
Test Ban Treaty tra Urss, Usa e Gran Bretagna dell’aprile 1963.
* * *
La filosofia di JFK più volte enunciata faceva perno sulla
convinzione che l’avversario sovietico e comunista andasse
affrontato con ogni mezzo ricorrendo alla totale mobilitazione delle
energie americane. E’ vero che sostituì alla strategia della
“massive retaliation” di Foster Dulles, quella della “risposta
flessibile” elaborata dal Segretario alla difesa Robert McNamara,
ma questo nuovo indirizzo faceva perno sul pesante riarmo sia di
natura convenzionale, sia atomico tattico e atomico strategico.
Senza volere entrare nei dettagli, è un fatto che Kennedy sviluppò
straordinariamente gli armamenti di ogni tipo, per esempio la
costruzione di una quarantina di sottomarini nucleari e i missili a
testata multipla. Del resto le più importanti vicende della sua breve
ma travagliata Presidenza parlano chiaro. Appena insediato alla
Casa Bianca, nel gennaio del 1961, ruppe le relazioni con la Cuba
di Castro e diede il via libera al tentativo di invasione della Baia dei
Porci (aprile 1961), senza peraltro assumersi la responsabilità
dell’iniziativa preparata dalla CIA né correre in soccorso degli
esuli cubani mandati allo sbando sull’isola. Nel primo incontro con
6
Chruscev a Vienna (giugno 1961) si mostrò molto più duro del suo
predecessore, tanto da meravigliare l’interlocutore sovietico. In
uno storico discorso del luglio 1961 enunciò i principi della sua
politica muscolare: rafforzamento dell’armamento nucleare e
convenzionale, orgoglio della potenza americana che doveva
essere incontrastata nel mondo e proclamazione della sua
superiorità atomica che sarebbe stata usata in caso di necessità.
Quando nell’estate del 1961 fu costruito il Muro a Berlino,
Kennedy reagì con estrema durezza raffermando per la prima
volta che gli americani sarebbero restati in Europa, in particolare
in Germania, a tempo indeterminato assicurando la difesa del
vecchio continente dall’espansione sovietica: “Credo che i
comunisti comprendano che Berlino Ovest è per noi di interesse
vitale e che abbiamo intenzione di rimanerci”. Nella crisi dei missili
a Cuba (autunno 1962) costrinse Chruscev a fare marcia indietro
arrivando sull’orlo dell’abisso nucleare anche se portava qualche
responsabilità per avere fornito l’alibi all’intervento sovietico a
protezione dell’isola centroamericana a cui erano stati diretti
diversi progetti di invasione. L’Alleanza per il progresso disegnata
per l’America latina sul modello del Piano Marshall non andò molto
avanti perché non faceva affidamento su classi dirigenti locali in
grado di gestire sviluppo economico e democratizzazione. Dove
tuttavia furono maggiori le responsabilità nel fallimento della sua
politica anticomunista fu nel Vietnam. Si deve a Kennedy e a
nessun altro che alla sua decisione l’intervento militare americano
in quella regione asiatica condotto con il criterio dell’escalation fin
dal 1961 per combattere il comunismo, una strategia che portò
alle ben note disastrose conseguenze che affondarono il suo
successore Johnson.
Anche per quel che riguarda i rapporti con l’Europa
nell’ambito dell’Alleanza atlantica, si tende ad ammorbidire quel
che fu il reale atteggiamento di Kennedy. Il giovane Presidente era
sì per cultura “più europeo” di altri Presidenti, ma nei rapporti
atlantici agì da deciso “unilateralista “ e “interventista”. Nella
gravissima crisi di Cuba, gli alleati europei furono tenuti
completamente all’oscuro; a Berlino fu chiaro che gli Stati Uniti
intendevano dirigere senza interferenze l’intera politica occidentale
e, più in generale nella strategia del riamo nucleare, fu proprio
durante il periodo kennediano che i poteri di comando furono
concentrati nelle mani americane sì da provocare la reazione di
De Gaulle: “Nei prossimi mesi” dichiarò nella sede qualificata del
7
National Security Council nel gennaio 1963, “sarà necessario
concentrarsi sugli interessi degli Stati Uniti. La nostra politica
[europea] è stata molto generosa, ma noi abbiamo perso la nostra
potenza economica e la nostra influenza su quei Paesi. Non
crediate che gli Europei facciano qualcosa per noi checché gli
Stati Uniti abbiano fatto per loro. Sarà necessario che i nostri
rappresentanti difendano con molta forza gli interessi americani”.
* * *
Il Presidente è stato descritto come il sostenitore all’interno
dei diritti civili. La realtà storica è alquanto diversa. Il movimento
per i diritti civili incentrato in un primo tempo (1956-1963) sulla
desegregazione degli Stati meridionali nasceva dalle popolazione
locali guidate dai pastori delle chiese nere (Martin Luther King) e
poi sostenuto dai giovani attivisti bianchi e neri che venivano dai
movimenti militanti nonviolenti sorti nelle università del Nord.
Quello dei diritti civile era dunque un movimento autonomo dalla
politica tradizionale, specialmente da quella del partito
Democratico che nazionalmente si reggeva ancora sulla
coalizione rooseveltiana composta dai sindacati, i gruppi etnici, i
liberal progressisti e i conservatori segregazionisti del Sud. John
Kennedy, per essere eletto nel 1960, ebbe bisogno anche del
sostegno determinante dei Democratici del sud (Dixiecrat) attestati
su posizioni fortemente anti-diritti civili. Proprio per questo l’intera
politica interna kennediana fu assai prudente nell’intervenire sui
diritti civili, almeno fin quando, nella primavera 1963 a Birmingham
in Alabama, vi fu una durissima repressione del manifestanti neri
da parte della polizia locale. E’ solo allora, a soli tre mesi dalla sua
morte, che si colgono nel discorso all’Università dell’Alabama dei
segni concreti ed espliciti di attenzione alla situazione dei neri del
Sud. Per la prima volta la desegregazione viene definita da
Kennedy “una questione morale” più che “una questione politica” e
viene preannunciata un’iniziativa legislativa federale per i diritti
civili che sarebbe stata portata a compimento nel 1964 da Lyndon
Johnson. Ma la campagna per i diritti civili era iniziata da ben dieci
anni con la storica sentenza della Corte suprema (Brown vs.
Board of Education) che aveva dichiarato di per se portatrice di
disuguaglianza la separatezza (segregazione) tra neri e bianchi.
In definitiva i risultati della politica interna di Kennedy furono
poveri, poverissimi. E’ invece L.B. Johnson il Presidente
8
Democratico che riuscì a realizzare su grande scala il più vasto
programma sociale riformatore mai messo in atto dopo
F.D.Roosevelt con una serie di provvedimenti sui diritti civili, il
welfare e il sostegno ai poveri e marginali. John F. Kennedy non
aveva la forza per fare approvare in Congresso proposte
riformatrice, anche ne avesse voluto la voglia, ne avesse avvertito
la priorità e l’urgenza, cosa di cui c’è da dubitare, almeno stando
ai documenti.
Il Foglio
18 novembre 2003
| Torna agli articoli | Scrivete a [email protected] |
9