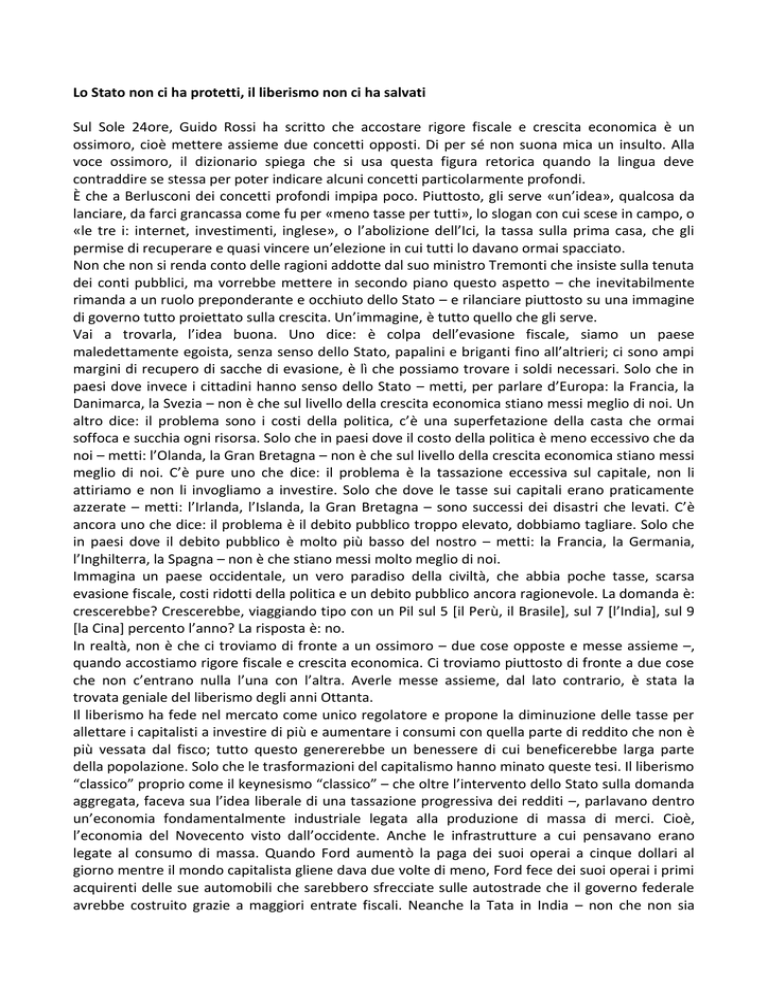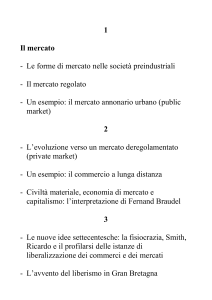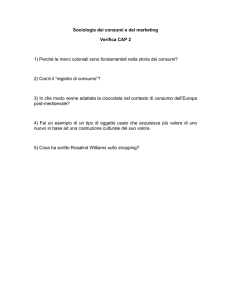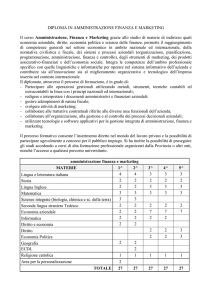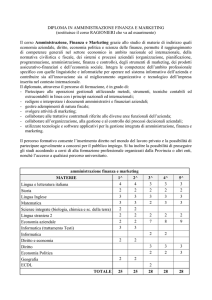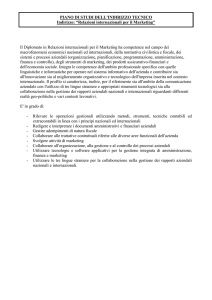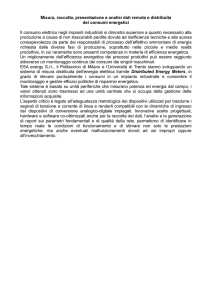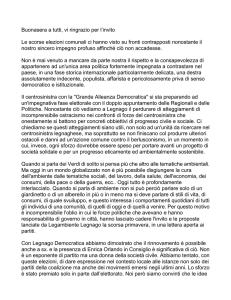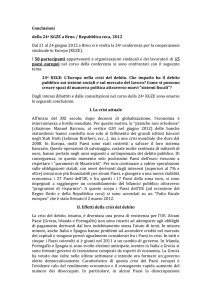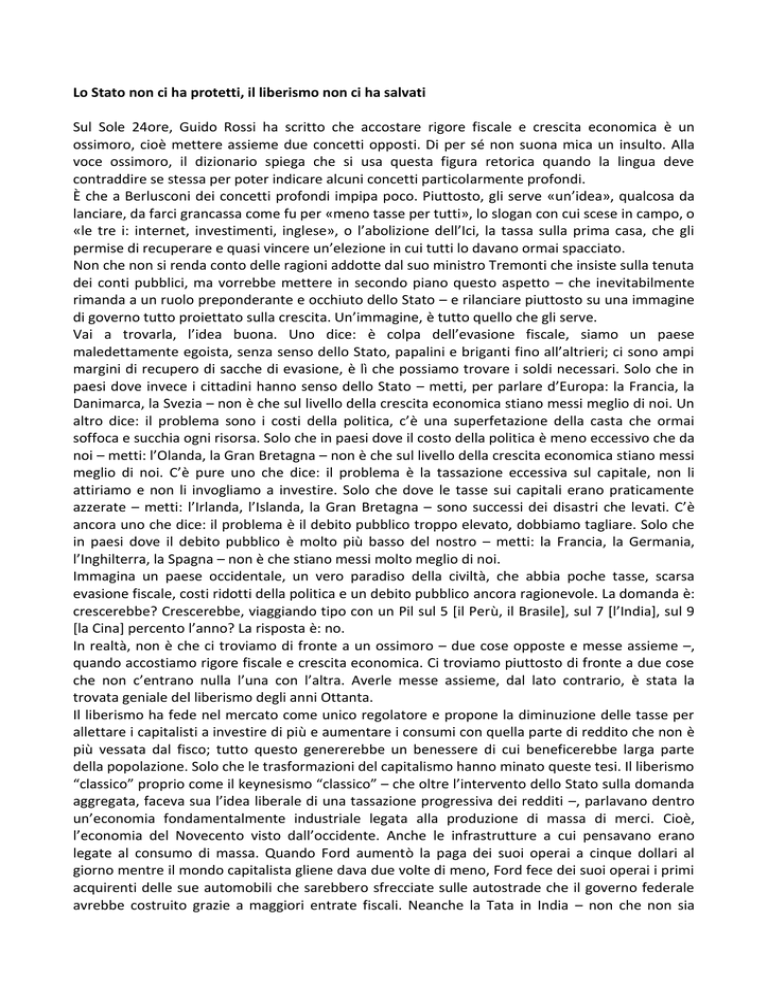
Lo Stato non ci ha protetti, il liberismo non ci ha salvati
Sul Sole 24ore, Guido Rossi ha scritto che accostare rigore fiscale e crescita economica è un
ossimoro, cioè mettere assieme due concetti opposti. Di per sé non suona mica un insulto. Alla
voce ossimoro, il dizionario spiega che si usa questa figura retorica quando la lingua deve
contraddire se stessa per poter indicare alcuni concetti particolarmente profondi.
È che a Berlusconi dei concetti profondi impipa poco. Piuttosto, gli serve «un’idea», qualcosa da
lanciare, da farci grancassa come fu per «meno tasse per tutti», lo slogan con cui scese in campo, o
«le tre i: internet, investimenti, inglese», o l’abolizione dell’Ici, la tassa sulla prima casa, che gli
permise di recuperare e quasi vincere un’elezione in cui tutti lo davano ormai spacciato.
Non che non si renda conto delle ragioni addotte dal suo ministro Tremonti che insiste sulla tenuta
dei conti pubblici, ma vorrebbe mettere in secondo piano questo aspetto – che inevitabilmente
rimanda a un ruolo preponderante e occhiuto dello Stato – e rilanciare piuttosto su una immagine
di governo tutto proiettato sulla crescita. Un’immagine, è tutto quello che gli serve.
Vai a trovarla, l’idea buona. Uno dice: è colpa dell’evasione fiscale, siamo un paese
maledettamente egoista, senza senso dello Stato, papalini e briganti fino all’altrieri; ci sono ampi
margini di recupero di sacche di evasione, è lì che possiamo trovare i soldi necessari. Solo che in
paesi dove invece i cittadini hanno senso dello Stato – metti, per parlare d’Europa: la Francia, la
Danimarca, la Svezia – non è che sul livello della crescita economica stiano messi meglio di noi. Un
altro dice: il problema sono i costi della politica, c’è una superfetazione della casta che ormai
soffoca e succhia ogni risorsa. Solo che in paesi dove il costo della politica è meno eccessivo che da
noi – metti: l’Olanda, la Gran Bretagna – non è che sul livello della crescita economica stiano messi
meglio di noi. C’è pure uno che dice: il problema è la tassazione eccessiva sul capitale, non li
attiriamo e non li invogliamo a investire. Solo che dove le tasse sui capitali erano praticamente
azzerate – metti: l’Irlanda, l’Islanda, la Gran Bretagna – sono successi dei disastri che levati. C’è
ancora uno che dice: il problema è il debito pubblico troppo elevato, dobbiamo tagliare. Solo che
in paesi dove il debito pubblico è molto più basso del nostro – metti: la Francia, la Germania,
l’Inghilterra, la Spagna – non è che stiano messi molto meglio di noi.
Immagina un paese occidentale, un vero paradiso della civiltà, che abbia poche tasse, scarsa
evasione fiscale, costi ridotti della politica e un debito pubblico ancora ragionevole. La domanda è:
crescerebbe? Crescerebbe, viaggiando tipo con un Pil sul 5 [il Perù, il Brasile], sul 7 [l’India], sul 9
[la Cina] percento l’anno? La risposta è: no.
In realtà, non è che ci troviamo di fronte a un ossimoro – due cose opposte e messe assieme –,
quando accostiamo rigore fiscale e crescita economica. Ci troviamo piuttosto di fronte a due cose
che non c’entrano nulla l’una con l’altra. Averle messe assieme, dal lato contrario, è stata la
trovata geniale del liberismo degli anni Ottanta.
Il liberismo ha fede nel mercato come unico regolatore e propone la diminuzione delle tasse per
allettare i capitalisti a investire di più e aumentare i consumi con quella parte di reddito che non è
più vessata dal fisco; tutto questo genererebbe un benessere di cui beneficerebbe larga parte
della popolazione. Solo che le trasformazioni del capitalismo hanno minato queste tesi. Il liberismo
“classico” proprio come il keynesismo “classico” – che oltre l’intervento dello Stato sulla domanda
aggregata, faceva sua l’idea liberale di una tassazione progressiva dei redditi –, parlavano dentro
un’economia fondamentalmente industriale legata alla produzione di massa di merci. Cioè,
l’economia del Novecento visto dall’occidente. Anche le infrastrutture a cui pensavano erano
legate al consumo di massa. Quando Ford aumentò la paga dei suoi operai a cinque dollari al
giorno mentre il mondo capitalista gliene dava due volte di meno, Ford fece dei suoi operai i primi
acquirenti delle sue automobili che sarebbero sfrecciate sulle autostrade che il governo federale
avrebbe costruito grazie a maggiori entrate fiscali. Neanche la Tata in India – non che non sia
giusto – potrebbe oggi fare una cosa simile: per produrla a un costo talmente basso da sostituire i
motocicli in tutto il mondo asiatico non può avere salari paragonabili ai cinque dollari di Ford. Né
la Cina, il cui capitalismo si serve di uno Stato militare, può far crescere troppo i suoi consumi
interni, costruendo una classe media agiata e spendaccione. Perderebbe tutto quel risparmio che
gli permette di continuare a investire in infrastrutture e macchinari e know how. La produzione
industriale di massa non è più da tempo una prerogativa occidentale.
Ma a stroncare il liberismo ci ha pensato la finanziarizzazione del capitale. Il grande capitalismo
industriale non è più redditizio. È redditizio investire capitali dove la parte fissa [macchinari] è
minima e la parte viva [lavoro] va compressa al massimo sino alla servitù e all’illegalità [come da
noi accade nell’edilizia, nei servizi, nella cura]. Per questo si sposta seguendo il costo più basso del
lavoro e gli incentivi di governi. Sono per lo più produzioni a bassa qualità e basso costo,
posizionate per fasce basse di reddito. Ma qui è ormai la Cina, la fabbrica del mondo, o il Bric a
farla da padrone. I grandi gruppi finanziari non investono più in capitale, la cui remunerazione è
troppo bassa e troppo diluita nel tempo, ma si lanciano nella finanza e spesso nella speculazione
che garantisce ritorni rapidi e colossali. Ma la spesa in consumi di questi profitti, nonostante il
lusso esagerato [yacht, elicotteri, ville e castelli, opere d’arte, automobili di ogni epoca, squadre di
calcio] non ha alcuna influenza duratura nella creazione di posti di lavoro e, in genere, nella
crescita. L’oligarca russo o il principe saudita ne sono un esempio perfetto. Spendono fortune, ma
questo non crea economia virtuosa. E per quanto le spendano, continueranno a arrivare sempre –
almeno finché gas e petrolio continueranno a servire –, in un circolo vizioso. Se ci si pensa un po’,
è esattamente il principio dell’economia mafiosa e criminale. La finanza globale non è borghese.
Borghese, per dire capitalista industriale.
In occidente, per parafrasare un termine militare, viviamo ormai in un’economia a bassa intensità.
Messa così cinicamente e realisticamente, l’unica cosa da fare è essere prudenti.
I democratici, il centrosinistra, la socialdemocrazia, la terza via, come dir si voglia, dopo aver
abbracciato il credo della privatizzazione e della dismissione dello Stato [da Blair a Prodi, da
Clinton a Schroeder, sebbene in forme diverse] sembrano ritornare a una qualche idea dello Stato
come regolatore. D’altronde, in Italia, è stato sempre il centrosinistra a varare le manovre più
lacrimose e sanguinarie, da Amato a Prodi, e quelle che più hanno minato i diritti del lavoro [da
Craxi in giù]. E erano gli unici che potevano farlo, per la vicinanza ai sindacati. Così, un
commentatore come Galli della Loggia nel chiedere riforme che abbattano privilegi e corporazioni
è a questo che pensa, a un governo di centrosinistra – è il mainstream del post-berlusconismo –
che si prenda in mano il cerino del debito pubblico e faccia a pezzi ancora di più la spesa sociale.
Perché, diciamolo, quando si chiede di ridurre il debito pubblico, si traduce in riduzione delle spese
sanitarie, delle pensioni, dell’assistenza, delle forme di difesa dalla disoccupazione e dalla nonoccupazione. Alla ripresa, alla crescita, chi ci pensa? Dovrebbe arrivare di suo, per induzione e per
magia. Ma non è così.
Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, e Susanna Camusso, segretario della Cgil, arrivano
a dire esattamente le stesse parole: «Occorre una riforma fiscale che diminuisca le tasse su
imprese e lavoratori e aumenti l’aliquota delle rendite finanziarie». Può bastare, ridurre le tasse su
imprese e operai – non che non sia giusto –, in un’economia dove la produzione materiale di beni
è ormai una quota sempre meno significativa della ricchezza? Può bastare a creare quella parte di
risparmio da destinare a investimenti e consumi? E in quali investimenti, in quali consumi?
Colpiamo la rendita finanziaria allora. Spostiamo il carico dalle persone alle cose, come ripete
misteriosamente Tremonti da un po’, alla ricerca di 80 corposissimi miliardi per una riforma
fiscale. Non alzando l’Iva perché questo finirebbe per ridurre ancora i consumi e perciò a
deprimere ancora la produzione. La rendita allora.
Dirò una cosa antipatica: la finanza globale non è il demonio. Non che non sia giusto trovare delle
regole, mettere dei tetti ai bonus, tassare la movimentazione: ma i cicli economici che abbiamo
conosciuto negli ultimi trent’anni sono fatti di speculazione finanziaria, crescita momentanea dei
consumi, indebitamento sociale, esplosione della bolla, recessione, nuova speculazione finanziaria.
Nella stagnazione che caratterizza da trent’anni l’economia dell’occidente dopo i gloriosi
trent’anni dal 1945 al ’75, quelli della produzione di massa legata alle automobili e agli
elettrodomestici, l’unica cosa che ha creato movimento e sviluppo [a partire dall’innovazione di
internet] è stata la finanza globale. Senza finanza globale e senza eccitazione drogata delle Borse
non avremmo avuto high tech, le ricerche sul genoma e tutta la nuova medicina, quelle
sull’agricoltura e la possibile green economy. E il futuro sta tutto qui.
Basta l’austerità a creare sviluppo, cioè occupazione? Basta – non che non sia giusto – la
tassazione progressiva dei redditi? No, che non basta.
Perché il punto vero è questo, a cui non risponde più il liberismo e neppure il keynesismo: come si
crea occupazione, cioè reddito in occidente? E quale occupazione? E quale reddito?
Nicotera, 12 giugno 2011