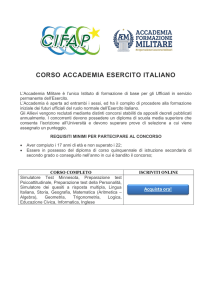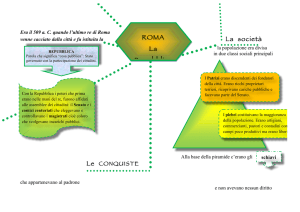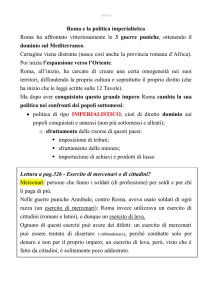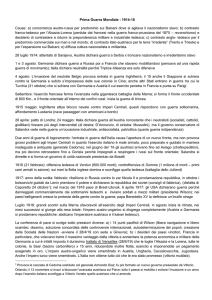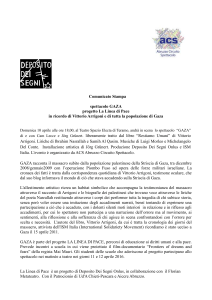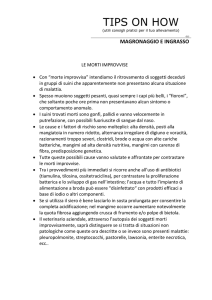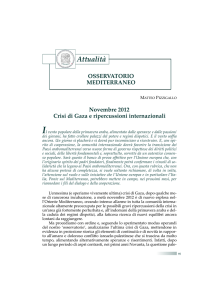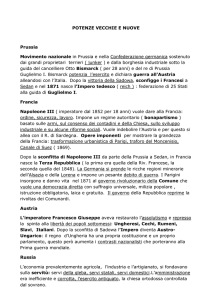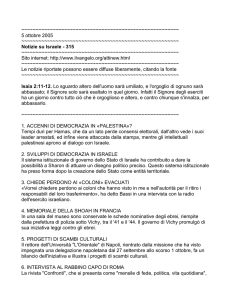Sproporzioni della guerra a Gaza
lanfranco caminiti
L’asserzione sulla sproporzione numerica dei morti a Gaza fra le file palestinesi e quelle
israeliane – tutti da una parte, pochi dall’altra – come evidenza d’un massacro, fatta dall’ex
ministro degli esteri D’Alema anche se non è certo il solo a dirlo, induce a alcune
considerazioni.
Massacro non è parola di etimologia italiana, viene dal francese, e sta a indicare: uccidere
selvaggiamente e in gran numero degli esseri che non si possono difendere [tuer avec
sauvagerie et en grand nombre des êtres qui ne peuvent se défendre]. È un’espressione che è stata
traslata a indicare un efferato gesto degli uomini contro altri uomini – prigionieri, a
esempio: a Katyn fu compiuto il massacro di circa diecimila ufficiali polacchi nelle mani
dell’Armata rossa – da un precedente uso a indicare un gesto umano verso animali affidati
in custodia, buoi o agnelli. Un’azione di macelleria [macecre]. L’espressione si diffonde dal
Seicento dopo la notte di san Bartolomeo e il massacro dei protestanti, riuniti a Parigi. Per
quel che se ne sa, i morti fra i cattolici furono pochissimi, mentre a migliaia furono tra i
protestanti. Esseri inermi a te affidati: gli ugonotti erano in festa e si affidavano a Caterina
de’ Medici. Una definizione su misura. Forse non si attaglia propriamente alla descrizione
del rapporto fra palestinesi e israeliani, anche se viene spesso spontaneo pensare a Gaza
come a una forma di prigione. Ma l’uccisione in gran numero di bambini e donne e uomini
inermi da parte di un esercito lascia indurre a quell’espressione, fossero pure molti di più i
morti da parte israeliana. Pure, diciamo: l’eccidio di Cefalonia o la strage di Sant’Anna di
Stazzema, e non è una proporzioni di morti, è una deliberazione a uccidere in quantità.
Nell’orrore delle descrizioni della guerra cerchiamo parole tra sinonimi, forse come un
maggior rispetto per le vittime. Ma a Katyn, a Cefalonia, a Sant’Anna – e in centinaia
d’altri luoghi – non ci furono morti fra gli esecutori: i massacri, e le stragi e gli eccidi, non
prevedono che muoia anche solo uno di chi uccide. La proporzione è fuori luogo. Chissà
se proprio questo si intendeva.
Nei commenti di molti analisti e politici, la considerazione sulla sproporzione numerica
dei morti a Gaza si è spesso accompagnata a un’altra espressione sulla sproporzione:
l’«uso sproporzionato della forza» da parte di Israele in risposta ai razzi Quassam, senza
riferimento a esseri inermi o affidati in custodia, bensì alla proporzione della forza, degli
apparati militari: i Quassam fanno poche vittime, i cannoni israeliani ne fanno in quantità.
Ed è sulla combinazione delle due espressioni – insieme sembrano fare un ragionamento –
che vanno fatte delle considerazioni.
La conta dei morti
Sulla base della conta numerica dei morti – uno a molti in due campi opposti –, ogni
attentato suicida d’un «martire del jihad», o meglio: una serie di quelli che “riescono” e
nelle intenzioni di chi li compie tutti dovrebbero “riuscire”, sarebbe un massacro. I
«martiri» attentatori che si fanno esplodere puntano proprio a rovesciare la fragilità
militare: l’uno può ucciderne tanti, basta salire su un autobus – e anche questa è
un’evidenza. Si dovrebbe dedurne, in questo caso, un uso sproporzionato della debolezza
militare. Ma nessuno userebbe un’espressione simile: chi, fra i due campi in guerra, è
debole militarmente – il riferimento è al confronto sulla forza degli apparati militari –
prevedibilmente userà qualunque mezzo senza proporzione e, nell’opinione comune, gli è
quasi «naturalmente» concesso: come potrebbe battersi senza ricorrere a qualunque
mezzo? Per senso comune, questo ci aspettiamo: che l’uno possa combattere
scompostamente in nome di principî, mentre l’altro debba attenersi a delle regole. Ma
nella guerra asimmetrica, come ormai si definiscono le guerre ma che forse sarebbe più
giusto definire: nella guerra sproporzionata, la sproporzione dei morti da una parte e
dall’altra in ogni evento bellico – e un attentato, una azione che appartiene alla strategia
militare e politica, ormai lo è come un mitragliamento o un assedio –, va in conto. Fa parte
di quel mostruoso calcolo che tocca a chi raccoglie e cataloga le spoglie. Non fu proprio il
numero impressionante dei morti – per fortuna poi diminuito, ma sempre rilevantissimo –
nell’attentato alle Torri gemelle del settembre 2001 compiuto da meno d’una dozzina
d’uomini tra le cose che colpirono?
Curiosamente, durante la guerra del Vietnam, la «conta dei morti» fu voluta e
puntigliosamente eseguita dall’esercito americano nel tentativo di dimostrare che stessero
vincendo. Nella seconda settimana del 1968 i portavoce dell’esercito comunicarono il
nuovo record di nemici uccisi: 2968, che batteva quello settimanale precedente, del 19-25
marzo 1967, di 2783. Poco dopo scoppiò la decisiva offensiva del Tet, e il generale
Westmoreland disse presto che era costata al nemico numerose perdite – avevano subito
contato i morti –, il che era vero, ma certo non bastava a spiegare tutto.
Ma negli attacchi suicidi se per un verso si tratta spesso di esseri inermi quelli contro cui
sono rivolti, quegli stessi non sono certo a loro «affidati»: sono considerati, tutti, nemici, o,
almeno, tutti pregiudizialmente ostili, in quanto appartenenti a una razza, una religione o
una nazione. A esempio, il Fronte nazionale di liberazione algerino, come già praticava
l’esercito francese, usò anche il terrore; lasciava bombe nei bar frequentati da francesi,
facendo puntualmente dei «massacri» – come, ricorrendo impropriamente alla propria
lingua, li definivano i giornali parigini: i francesi in Algeria non si affidavano certo agli
arabi. E a nessuno a Parigi veniva in mente la sproporzione numerica, perché era un
argomento evidentemente poco adatto in una situazione “coloniale” – dove pochi, i «forti»
d’una razza, governano i molti, i «deboli», di un’altra: l’Algeria, propriamente, era
occupata e governata dai francesi. E lo stesso – qualunque cosa si voglia dire in proposito –
non può esattamente dirsi della striscia di Gaza. La striscia di Gaza è l’Hamastan.
A Gaza, da una parte e dall’altra, ci si considera tutti nemici, o, almeno, tutti
pregiudizialmente ostili. La conta dei morti viene spietatamente fatta.
La reazione sproporzionata
Il ragionamento sulla sproporzione della reazione è complicato: il bombardamento di
Dresda nella Seconda guerra mondiale fu un massacro, voluto e pensato come tale; l’uso
del fosforo nelle bombe, già provato su Amburgo, si intensificò allora e forse non è mai
smesso: il più recente, prima di Gaza, è stato a Falluja. L’esecutore di Dresda, il colonnello
Harris, fu per sempre marchiato come macellaio – ritorna la motivazione originaria del
termine –, ma certo non dovette deciderlo da solo: era pensato come un colpo decisivo alla
nazione tedesca. Era così? Era necessario militarmente, il febbraio del 1945? Era
«sproporzionato» al bombardamento di Coventry e al continuo piovere su Londra delle
V2 tedesche? E il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki – agosto 1945 –
cos’altro fu se non un massacro come mai visto? Era necessario per piegare l’esercito
giapponese? Era «sproporzionato»? Allora si disse, e così lo si «giustificò», che mise fine
alla guerra nel Pacifico. Era allora possibile giustificare l’Armata rossa che avanzando
verso Berlino rase al suolo, stuprò, depredò, deportò, cercando di raggiungere una
qualche propoporzione – un risarcimento – con quello che avevano fatto i tedeschi
avanzando verso est?
Tutto questo sta «dentro» guerre convenzionali, a uno scontro tra eserciti, e poco si
attaglierebbe a Gaza. Ma quello che ci fa sempre orrore in realtà è il coinvolgimento dei
civili, non lo scontro tra eserciti proporzionati, non le proporzioni. Per dire di una guerra
convenzionale, alla battaglia di Verdun, nella Prima guerra mondiale, ci furono 540.000
perdite tra i francesi e 430.000 fra i tedeschi, e alla Somme si contarono 620.000 perdite tra
inglesi e francesi, contro 450.000 tedeschi. Le cifre raccontano di una proporzione: ma
l’angoscia non viene meno, nasce dalla somma, dal cumulo. Dall’insensatezza, dagli orrori
della guerra. Dopo Waterloo, per anni, gli inglesi rastrellarono a fondo il terreno
tutt’intorno – in uno spazio grande la metà di Villa Borghese ci furono sessantamila morti
in una sola giornata – recuperando milioni di bushel di ossa di animali e uomini che
mandavano in Gran Bretagna per triturare e usare nell’industria, e forse questo ci colpisce
quanto il numero dei morti della battaglia stessa. Tutto ciò ci sgomenta, ma tuttavia è
diverso dall’orrore che proviamo per il coinvolgimento dei civili: i civili, in guerra,
dovrebbero essere affidati agli eserciti, a tutti gli eserciti. Ma così non sembra più,
ammesso, appunto, sia mai stato.
Il 16 marzo 1968 – mentre Westmoreland faceva ancora la conta dei morti dell’offensiva
del Tet – la 23° divisione di fanteria dell’esercito americano che combatteva nel villaggio di
Son My, nel Vietnam centrale, massacrò in un solo giorno trecentoquarantasette civili
disarmati. Gran parte del massacro avvenne in un piccolo agglomerato di nome My Lai.
Vecchi, donne, bambini, neonati furono sistematicamente eliminati a colpi di pistola o
fucile. Le donne furono percosse con i calci dei fucili, alcune violentate, sodomizzate. Fu
ucciso anche il bestiame, che venne poi gettato nei pozzi per avvelenare l’acqua. Gli
americani buttavano bombe nei rifugi sotto le case dove gli abitanti avevano cercato
riparo, e sparavano a quelli che, per sfuggire all’esplosione, scappavano fuori. E forse
questo più che la conta dei morti spiegava quel che stesse accadendo in Vietnam. Ma ci
volle del tempo per saperlo. Come venne riferito da un tenente dell'esercito sudvietnamita
ai suoi superiori, fu una «atroce» vendetta, avvenuta poco dopo uno scontro a fuoco con
delle truppe Vietcong che si erano mischiate ai paesani.
La reazione sproporzionata di ogni esercito colpisce i civili. Propriamente, ci sembra che
un esercito agisca «sproporzionatamente» quando colpisce i civili della parte avversa.
Quando li massacra. Forse va messo in conto che gli è connaturale. Tra le convenzionalità
della guerra degli eserciti c’è il massacro.
I massacri degli eserciti
Gli eserciti [ora con l’appoggio e il bombardamento preventivo dell’aviazione e a volte
della marina] cannoneggiano le popolazioni: accade così ormai, accadde in Cecenia e in
Kosovo e prima in Serbia, accadde in Iraq, è accaduto nella striscia di Gaza. Forse è sempre
accaduto. Forse semmai adesso nelle intenzioni strategiche dei militari – la Nato, gli
americani, i russi, gli israeliani –, probabilmente, c’è davvero anche un affidamento alla
«intelligenza» della tecnologia, cioè a che i missili e i proietti siano mirati e non facciano
“troppe” stragi, “troppo” massacro: ma, nei fatti, ogni tecnologia è perfettibile e sbaglia, o
le informazioni umane che le diamo sono errate, e, insomma, qualche massacro va sempre
messo in conto, gli strateghi lo sanno. A volte, e in genere nel correre d’un conflitto, vi
sembrano del tutto indifferenti. A volte, già prima le stragi si considerano solo come
«effetti collaterali». A volte, come accadde a Srebenica – di nuovo un macellaio, Mladic –,
sono volute.
L’evidenza del massacro di Gaza sta nella decisione politica: un esercito che interviene
contro un territorio, per riprenderne il controllo o per ritorsione, può produrre massacri.
Un esercito se si muove fa quello che è il suo mestiere: distruggere senza riguardo. Quali
sono i limiti della sua proporzione?
Ma allora: la colpa degli israeliani è quella di avere un esercito militarmente troppo
potente, cioè adeguato alla propria potenza tecnologica, come ogni esercito rispecchia la
tecnologia di una nazione? Dovrebbe averlo e nello stesso tempo trattenerlo? Dovrebbe
averlo e attrezzarlo proporzionatamente ai suoi nemici dell’area, che so, coi razzi
Quassam? Ma la deterrenza di Israele – un territorio minuscolo con una popolazione
limitata – sta proprio nella sproporzione tecnologica tra il suo esercito e quello dei vicini
ostili dell’area. La sproporzione tecnologica assume qui il carattere della scorrettezza
concessa a chi è più piccolo contro chi è più grosso. O pensiamo che qualcos’altro – se non
un certa sconfitta – ha trattenuto e trattiene, che so, la Siria? L’ultima guerra
proporzionata, cioè convenzionale, nell’area fu combattuta nella guerra dei Sei giorni, fra
Israele e Egitto, Siria e Giordania, e andò come è andata. Anzi, è proprio il convincimento
che sia quasi impossibile battere Israele sul piano della guerra convenzionale che da
sempre ha indotto i regimi e i governi arabi a finanziare «altre» forme di guerra.
Pure, anche evidenziando la differenza fra quanto accadde a Sabra e Shatila a opera delle
milizie libanesi cristiano-falangiste contro campi profughi praticamente inermi sotto lo
sguardo complice delle forze armate isareliane e quanto accaduto in questi giorni a Gaza;
anche ammettendo che il fermarsi dell’esercito israeliano alle porte di Gaza city sia stato
dovuto a un “freno” già programmato, che potesse permettere la tregua oltre che al timore
di trovarsi impantanato, come già in Libano, e poi sconfitto; anche se questo e quell’altro,
l’evidenza del massacro è sotto gli occhi, e non è necessario computare accuratamente i
morti. E sta nella decisione politica dell’intervento militare. Sta nella fine d’ogni margine
di manovra politica. E il governo israeliano non si è sottratto: ha avocato a sé il massacro.
Guerre convenzionali e no
Il punto è che la guerra tra eserciti «pari» non si dà più, o almeno l’Europa e l’Occidente
non hanno mai vissuto nella loro storia un periodo di assenza di guerra così prolungato. A
volte non ce ne rendiamo conto. La guerra – come certi rifuti tossici, o certe produzioni –
sembra essersi dislocata lontano da qui. E moltiplicata. A volte è quasi davvero possibile
immaginare e temere che possa esplodere, che so, tra l’India e il Pakistan, e ci si è quasi
anestetizzati all’idea che in Africa sembra ormai incancrenita, nelle forme più varie e
spesso orribili come le «guerre dei bambini». Ma nessuno immagina che possa scoppiare
domani o dopodomani tra la Francia e la Spagna o la Slovacchia e l’Ungheria o la
Germania e la Russia o il Giappone e la Corea. L’ultima incongrua guerra “occidentale” è
stata per le Falklands, ma l’Argentina del tempo con difficoltà poteva essere collocata a
pieno titolo nell’occidente. Nel mondo, l’ultima guerra proporzionata, convenzionale forse
è già fuori luogo dirlo, è stata quella tra Iran e Iraq e è costata milioni di vite umane. Non
tali possono essere considerate la Prima guerra del Golfo e le più recenti invasioni di
Afghanistan e Iraq: non può esserci proporzione militare nella decisione di intervento di
un esercito di una potenza mondiale contro un territorio, anche se non inerme e attrezzato
militarmente in qualche modo per fare fronte proporzionalmente ai suoi paragonabili
nemici d’area. E non può esserci proporzione militare perché non c’è alcuna proporzione
tecnologica fra le potenze e il resto del mondo. Ma la situazione medio-orientale è
particolare: l’Iran potrebbe anche lavorare o già avere la bomba nucleare e con essa
farebbe centinaia di migliaia di morti in Israele, eppure non sarebbe questa sua forza
militare a trattenere successivamente l’esercito israeliano dall’invaderlo, ma l’estensione
geografica e l’infinita popolazione. Probabilmente, sarebbe solo una guerra nucleare, fatta
a mezzo di bombe nucleari. Un vero Armageddon. Funzionerebbe in quell’area – come ha
funzionato fra est e ovest con la guerra fredda – il bilanciamento nucleare?
La tregua
Il massacro è la forma propria dell’intervento di un esercito contro un territorio senza
esercito o con un esercito inadeguato: e Hamas non è un esercito, qualunque cosa la si
voglia definire. E suona ipocrita la giustificazione del governo e dell’esercito israeliani che
si sono detti «costretti» a colpire tra la popolazione per stanare Hamas: Hamas vive tra la
popolazione, non è, appunto, una struttura “separata” e individuabile come un esercito.
L’asimmetria e la sproporzione della guerra d’oggi sta qui: per stanare Hamas va colpita la
popolazione. Succede pure in Afghanistan, nelle zone tribali di confine col Pakistan e fra i
pashtun. E, viceversa, la forma di lotta di un territorio senza esercito o con mezzi
tecnologici limitati contro un esercito assume la forma della guerra scorretta, con cinture
easplosive, razzi, quel che si ha o si rimedia per infliggere il maggior numero di morti. In
questi casi, la tecnologia funziona da limite e non da semplificazione: forse, si potrebbe
aggiungere, per fortuna. Non sono sicuro che Hamas si sarebbe finora trattenuto
dall’usare mezzi capaci di procurare un maggior numero di morti dei Quassam se li
avesse avuti. Hamas, qualunque cosa la si voglia definire, «fa la guerra» a Israele. Forse
come neanche l’esercito del Mahdi di Moqtada al Sadr la fa in Iraq contro gli americani.
Se è sacrosanto interrogarsi sull’intervento israeliano, è altrettanto sacrosanto interrogarsi
sull’efficacia della strategia di Hamas. Schierarsi sulla base delle considerazioni umane e
delle emozioni è sin troppo facile. E purtroppo non cambia granché, a quanto pare.
Schierarsi in Medio-oriente da una parte o dall’altra è la fine dell’immaginazione della
politica, dell’impegno della politica. È lasciare parlare la guerra. Purtroppo, manifestare le
proprie opinioni sul conflitto assume a volte la forma meschina di uno schieramento a fini
propri, strumentali, dentro scenari e polemiche di parrocchie e di provincialismo.
Il governo israeliano sembra ormai assolutamente insensibile all’opinione pubblica
internazionale: non sente ragioni. O sente solo le ragioni di chi si schiera a prescindere
sulla giustezza del suo operato. Anche qui, è inimmaginabile che chi ha deciso
politicamente l’intervento dell’esercito non avesse già messo in conto che l’orrore avrebbe
suscitato l’indignazione di tutto il mondo. Forse si sono stufati di sentire una opinione
pubblica internazionale che sembra solo criticare quello che loro fanno: ma d’altronde a
chi mai si potrebbe rivolgere l’opinione pubblica occidentale se non al governo israeliano?
Ad Hamas? Quale linguaggio, quali mediazioni, quali riscontri ci possono essere oggi con
Hamas? Israele è occidente, è come noi, Hamas no, e lo rivendica. Israele ha un’opinione
pubblica, Hamas no. Può essere che la sordità del governo di Israele sia una situazione
strumentale e una condizione contingente, dovute all’avvicinarsi della scadenza elettorale.
Ma chissà cosa accadrebbe con Nethanyau al posto della Livni e Barak. D’altra parte, fosse
pure vero, e fosse pure falso che occorreva non solo ripristinare il senso di sicurezza e di
protezione tra gli israeliani ma persino l’onore debilitato dei militari in Libano contro
l’Hezbollah, è mai possibile immaginare Israele senza un esercito? Può sembrare più
ragionevole e meno orribile o più proficuo politicamente che il Mossad elimini uno a uno i
capi di Hamas con assassini manuali o con sofiscati attrezzi che cadono dal cielo o sbucano
dal suolo pilotati da intelligence e collaboratori in loco? E ancora: qualcuno può pensare
che la strada per la soluzione del conflitto medio-orientale sia sciogliere l’esercito
israeliano?
Oggi si può dire che una svolta al conflitto può venire solo da Hamas. La credibilità
politica e sociale dell’Autorità nazionale palestinese è crollata: magari l’Anp non ha tutta
la responsabilità, ma una parte sì, nell’aver trasformato un popolo laico, produttivo,
inzeppato di intelligenze, abilità e professioni in una «colonia» di fondamentalismo
religioso. È difficile pensare che dopo Gaza l’Anp riacquisti autorevolezza e potere, anche
se spinta dall’Europa o dagli Usa. E da Israele. Una svolta al conflitto può venire solo da
Hamas: dalla strategia e dalle decisioni politiche di Hamas. Dalle scelte sulle alleanze, i
finanziamenti, gli schieramenti. Hamas può avere un ruolo storico straordinario – persino
a livello globale, e basti pensare al significato simbolico che continua a avere la questione
palestinese – se riesce a dare una «forma politica» nuova alla sua militanza, al suo
sostegno e radicamento popolari, persino al suo fervore religioso. Non è una cosa facile: al
Qaeda è pronta a fare proselitismo in una radicalizzazione sempre più evidente, non solo
tra i palestinesi ma anche dentro la Lega araba. Hamas può persino ridare forza a quella
parte di società israeliana che soffre per il conflitto e è disposta alla pace, trova ragionevole
e necessario ritirarsi dai Territori occupati, smettere l’embargo a Gaza, e adesso è ridotta al
silenzio o all’afasia e all’insignificanza tollerata.
Una svolta al conflitto può venire da Hamas. L’Europa potrebbe fare, in tal senso. La
tregua è fragile. La tregua dovrebbe essere non un tempo di attesa, ma un momento di
fervore della politica. Ieri l’altro, in uno scontro che sarebbe avvenuto nei pressi della
centrale di Gaza, ai valichi di frontiera del Kissufim, un soldato israeliano è rimasto ucciso
e tre sono rimasti feriti in un'esplosione. L'aviazione israeliana avrebbe quindi attaccato un
obiettivo palestinese vicino a Khan Yunes, uccidendo un militante e ferendone un'altro.
Qui tutto sembra proporzionato.
Roma, 28 gennaio 2009