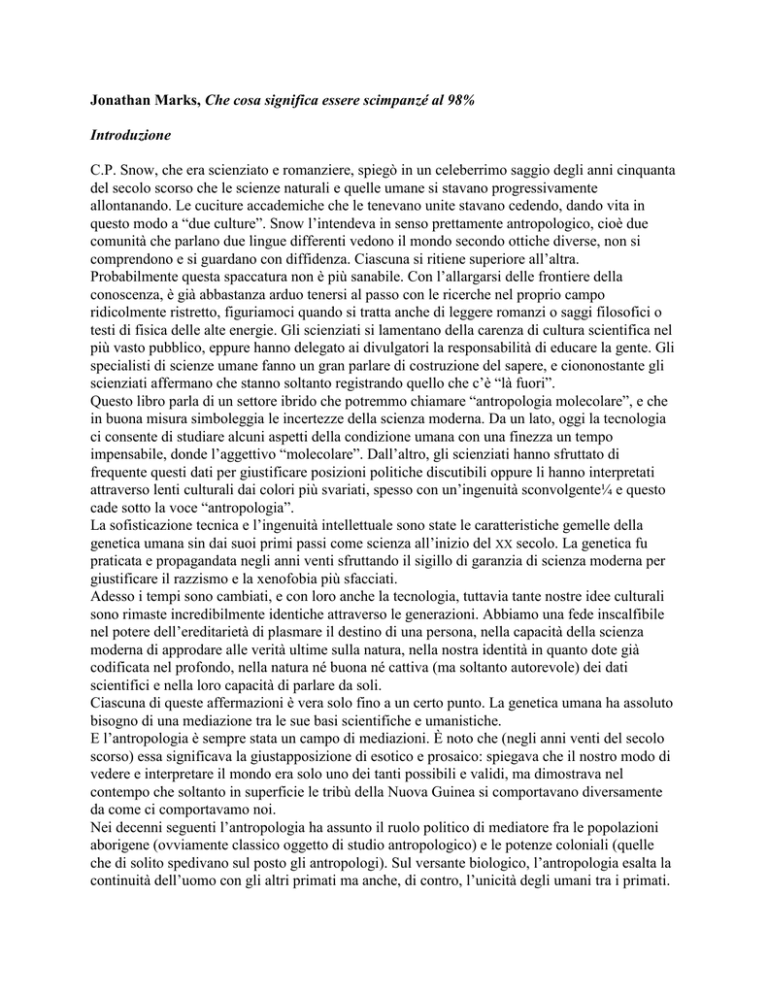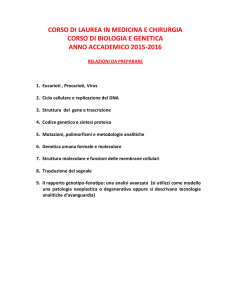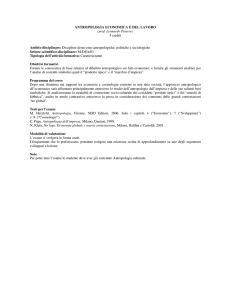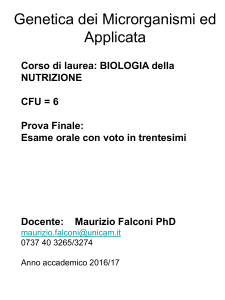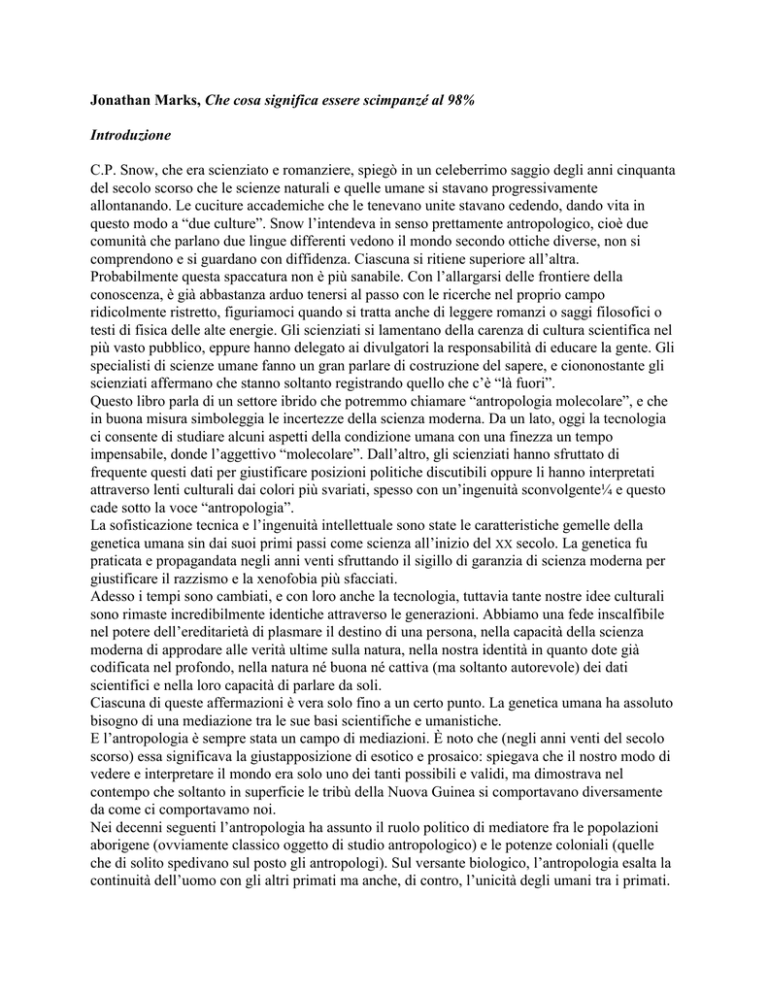
Jonathan Marks, Che cosa significa essere scimpanzé al 98%
Introduzione
C.P. Snow, che era scienziato e romanziere, spiegò in un celeberrimo saggio degli anni cinquanta
del secolo scorso che le scienze naturali e quelle umane si stavano progressivamente
allontanando. Le cuciture accademiche che le tenevano unite stavano cedendo, dando vita in
questo modo a “due culture”. Snow l’intendeva in senso prettamente antropologico, cioè due
comunità che parlano due lingue differenti vedono il mondo secondo ottiche diverse, non si
comprendono e si guardano con diffidenza. Ciascuna si ritiene superiore all’altra.
Probabilmente questa spaccatura non è più sanabile. Con l’allargarsi delle frontiere della
conoscenza, è già abbastanza arduo tenersi al passo con le ricerche nel proprio campo
ridicolmente ristretto, figuriamoci quando si tratta anche di leggere romanzi o saggi filosofici o
testi di fisica delle alte energie. Gli scienziati si lamentano della carenza di cultura scientifica nel
più vasto pubblico, eppure hanno delegato ai divulgatori la responsabilità di educare la gente. Gli
specialisti di scienze umane fanno un gran parlare di costruzione del sapere, e ciononostante gli
scienziati affermano che stanno soltanto registrando quello che c’è “là fuori”.
Questo libro parla di un settore ibrido che potremmo chiamare “antropologia molecolare”, e che
in buona misura simboleggia le incertezze della scienza moderna. Da un lato, oggi la tecnologia
ci consente di studiare alcuni aspetti della condizione umana con una finezza un tempo
impensabile, donde l’aggettivo “molecolare”. Dall’altro, gli scienziati hanno sfruttato di
frequente questi dati per giustificare posizioni politiche discutibili oppure li hanno interpretati
attraverso lenti culturali dai colori più svariati, spesso con un’ingenuità sconvolgente¼ e questo
cade sotto la voce “antropologia”.
La sofisticazione tecnica e l’ingenuità intellettuale sono state le caratteristiche gemelle della
genetica umana sin dai suoi primi passi come scienza all’inizio del XX secolo. La genetica fu
praticata e propagandata negli anni venti sfruttando il sigillo di garanzia di scienza moderna per
giustificare il razzismo e la xenofobia più sfacciati.
Adesso i tempi sono cambiati, e con loro anche la tecnologia, tuttavia tante nostre idee culturali
sono rimaste incredibilmente identiche attraverso le generazioni. Abbiamo una fede inscalfibile
nel potere dell’ereditarietà di plasmare il destino di una persona, nella capacità della scienza
moderna di approdare alle verità ultime sulla natura, nella nostra identità in quanto dote già
codificata nel profondo, nella natura né buona né cattiva (ma soltanto autorevole) dei dati
scientifici e nella loro capacità di parlare da soli.
Ciascuna di queste affermazioni è vera solo fino a un certo punto. La genetica umana ha assoluto
bisogno di una mediazione tra le sue basi scientifiche e umanistiche.
E l’antropologia è sempre stata un campo di mediazioni. È noto che (negli anni venti del secolo
scorso) essa significava la giustapposizione di esotico e prosaico: spiegava che il nostro modo di
vedere e interpretare il mondo era solo uno dei tanti possibili e validi, ma dimostrava nel
contempo che soltanto in superficie le tribù della Nuova Guinea si comportavano diversamente
da come ci comportavamo noi.
Nei decenni seguenti l’antropologia ha assunto il ruolo politico di mediatore fra le popolazioni
aborigene (ovviamente classico oggetto di studio antropologico) e le potenze coloniali (quelle
che di solito spedivano sul posto gli antropologi). Sul versante biologico, l’antropologia esalta la
continuità dell’uomo con gli altri primati ma anche, di contro, l’unicità degli umani tra i primati.
E in senso più generale media tra sapere accademico sul mondo (“scienza”) e saggezza
tradizionale o culturale (“cultura popolare”, che potremmo anche chiamare “sapere folklorico”).
Anche l’antropologia molecolare deve assumere per forza il ruolo cruciale di mediatore. La
genetica propaganda un’analisi scientifica tipicamente moderna della condizione umana, e
pertanto l’antropologia molecolare prende in esame sia le popolazioni umane nei loro rapporti
reciproci sia la nostra specie rispetto alle altre. Però nello stesso tempo siamo costretti a chiederci
quale significato e valore attribuire a questi studi. Per quanto riguarda la vita, il benessere e i
diritti dell’uomo la genetica ha fornito da sempre qualche scusa a chi voleva rovinare la vita alla
gente, una giustificazione per tenerla sottomessa o per chi voleva ingraziarsi i ricchi e i potenti
cercando i capri espiatori nei poveri e in quanti non avevano voce in capitolo. Perciò oggi va
tenuta d’occhio molto più di altre pratiche scientifiche, più bonarie e meno corruttibili.
Questo libro, invece di limitarsi a promettere di analizzare oggettivamente, in maniera
spassionata e gentile, la nostra costituzione fisica ereditaria (per essere inevitabilmente colto in
fallo), parla di come può una scienza genetica dell’umanità affrontare i vari problemi. Alcuni di
questi problemi sono politici, come il colonialismo e i diritti degli animali, altri si trovano entro i
confini della tradizione folklorica come il razzismo e l’etnocentrismo, altri ancora riguardano
semplicemente il modo in cui la scienza si presenta al pubblico.
“Antropologia molecolare” è un termine paradossale coniato nel 1962 da un biochimico per
indicare lo studio dell’evoluzione umana basato sulle differenze nella struttura delle biomolecole.
Il paradosso sta nel fatto che, per quanto suoni come un ramo dell’antropologia, un suo ramo
molecolare, è in realtà soltanto la biochimica applicata alle classiche tematiche antropologiche. E
visto che questo nuovo settore aveva un’impostazione tecnocratica, chiunque poteva fare
“antropologia molecolare” indipendentemente da quanta antropologia masticasse sul serio.
Per quanto vi possa sembrare innocuo, provate a pensare al caso opposto. Dove andrebbe a finire
una “biochimica antropologica” se non sapeste un’acca di biochimica?
Con questo saggio voglio dimostrare che, allorché l’avveniristica tecnologia della genetica
molecolare si è coniugata a un “sapere antropologico folklorico”, i risultati sono stati sempre di
valore tremendamente limitato. È successo per esempio negli anni venti del Novecento, quando i
genetisti cercarono di riscrivere i nostri parametri sociali incolpando della miseria i geni dei
poveri. Il crollo delle Borse e la Grande depressione si rivelarono una salutare doccia fredda per
questi scienziati.
Ed è andata così nei successivi anni sessanta, quando la genetica diventò molecolare e i suoi
praticanti iniziarono a lanciare affermazioni apparentemente profonde, tipo “dal punto di vista
dell’emoglobina, l’uomo è soltanto un gorilla anormale”. A quanto pare, questo baldanzoso
signore non immaginava che il punto di vista dell’emoglobina non fosse il massimo riguardo al
problema in discussione: dalla cima dell’Empire State Building Chicago e Los Angeles sembrano
sovrapposte all’orizzonte, mentre non è altrettanto vero dal Golden Gate.
Ecco una classica domanda antropologica: qual è il punto di vista più elevato? Un modo
antropologico di affrontare il problema sarebbe chiedersi cos’è che possiamo scorgere da un
punto di vista mentre dagli altri rimane nascosto.
In genere, si ritiene che il punto di vista della scienza sia superiore a tutti i concorrenti.
Soprattutto lo pensano gli scienziati. Ma anche in questo caso sarebbe conveniente ammettere
che può esserci più di un punto di vista scientifico, e che il significato di qualsiasi specifica presa
di posizione scientifica potrebbe non essere lapalissiano. Così nel decennio scorso ci siamo
sentiti dire di continuo che siamo diversi appena per un misero 1-2% dagli scimpanzé sotto
l’aspetto genetico, e perciò¼ perciò cosa?
Dovremmo concedere i diritti umani agli scimpanzé, come hanno suggerito alcuni attivisti?
Dovremmo accettare come naturale la promiscuità e la violenza genocida che alligna sotto una
patina di umanità e ogni tanto esce allo scoperto, come hanno proposto certi biologi? Oppure
dovremmo andare in giro nudi e dormire sugli alberi, alla stregua degli scimpanzé?
Naturalmente nessuna di queste proposte consegue per forza dalla somiglianza genetica tra
umani e grandi scimmie, anche se le prime due sono state avanzate in anni recenti all’interno
della comunità dei cattedratici e promosse su popolari mezzi di comunicazione. (Fortunatamente
non è successo con la terza.) Però tutte sembrano derivare logicamente dalla somiglianza
genetica.
Il punto di vista antropologico o culturale ci permette di analizzare con occhio critico alcuni
preconcetti che diamo spesso per scontati riguardo la genetica.
Il primo tema affrontato da questo saggio è: che cosa significa la somiglianza genetica tra umani
e grandi scimmie? Su che cosa si basa? Ha implicazioni profonde per la comprensione della
nostra natura?
Vedremo che l’universo delle somiglianze genetiche è piuttosto diverso dai nostri preconcetti sul
significato delle somiglianze. Per esempio, la struttura stessa del DNA prevede differenze non
superiori al 75% per quanto possano essere diverse le specie messe a confronto. Eppure il fatto
che il nostro DNA sia simile a quello di un soffione per oltre il 25% non comporta che noi siamo
soffioni per più di un quarto, ammesso che abbia senso parlarne. Vedremo una dimostrazione
elementare dello scontro fra sapere folklorico e dati scientifici, e dello sfruttamento del primo da
parte dei secondi. La misura in cui il nostro DNA somiglia a quello di una scimmia non prefigura
in nulla e per nulla la nostra somiglianza generica con gli altri primati, men che meno le
conseguenze morali o politiche che ne possono derivare.
Poi proseguirò prendendo in esame le differenze genetiche all’interno della specie umana e il
modo in cui si sono incrociate con i nostri tentativi di classificare la gente secondo razze. I
genetisti hanno tentato di ricostruire la storia evolutiva della nostra specie con alterne fortune,
trovando spesso quanto si aspettavano, identificando razze durante una generazione solo per
negare la loro esistenza in quella successiva. Il punto di vista dell’antropologia molecolare, una
scienza sociale dell’ereditarietà, getterà nuova luce sia sulla scienza sia sull’uso che ne facciamo.
Forse il tema più spinoso della biologia moderna, riportato in auge dalle polemiche su un libro
del 1994, The Bell Curve di Richard Herrnstein e Charles Murray, è la genetica
comporta-mentale, un campo in cui i modelli della diversità comportamentale umana possono
essere messi a confronto con i modelli noti di variabilità genetica, permettendoci così di
analizzare in mod
o critico le politiche apparentemente derivate da basi scientifiche.
Due progetti recenti cercano di giustificare la propria esistenza facendo ricorso alla genetica: il
Great Ape Project, che propugna l’allargamento dei diritti umani alle grandi scimmie basandosi
sulla nostra parentela genetica, e lo Human Genome Diversity Project, che propone la fondazione
di un museo genetico dei popoli isolati e a rischio di estinzione in tutto il pianeta. Entrambe
queste proposte possono essere meglio comprese unendo i relativi elementi scientifici e umanisti.
Per concludere, prenderò in esame in maniera più generale come il sapere tecnico e culturale si
intreccino nel classico conflitto tra scienza e religione, allargando così la visuale dallo studio
umanistico dell’ereditarietà per arrivare a uno studio culturalmente aggiornato e socialmente
attuale del ruolo della scienza.
In fin dei conti, l’antropologia molecolare è solo questo: l’incrociarsi di corpi chimici, corpi
umani e corpi di sapere, e il loro reciproco arricchimento. L’antropologia molecolare funge da
mediatore fra la genetica riduzionista e l’antropologia olistica, tra il sapere formale e l’ideologia,
tra i fatti naturali e quelli prodotti dalle autorità, tra quel che la scienza può fare e quel che
dovrebbero fare gli scienziati, e soprattutto tra uomo e animale. Naturalmente sono tutti termini
carichi di significati, e nessuno di essi può essere preso per oro colato.
Ed è questo il bello.