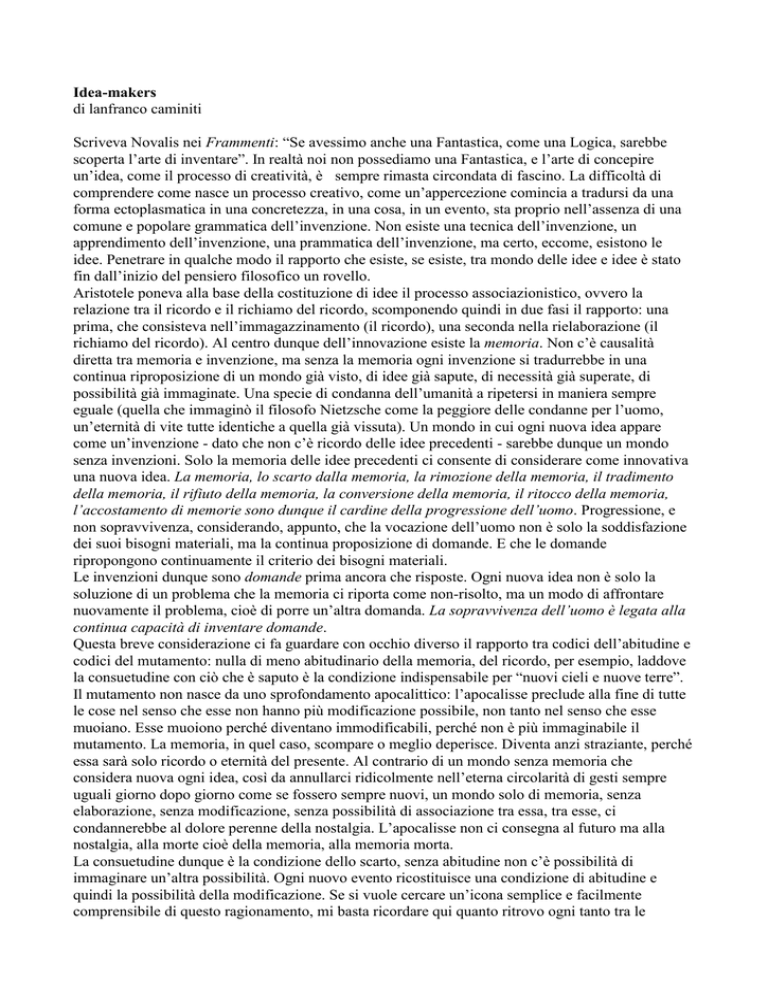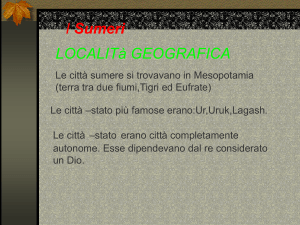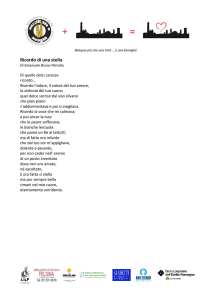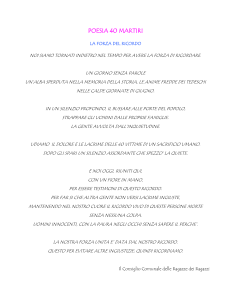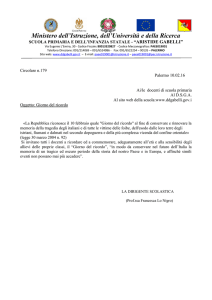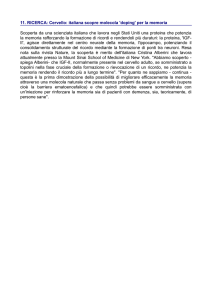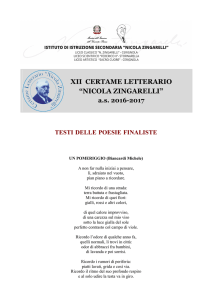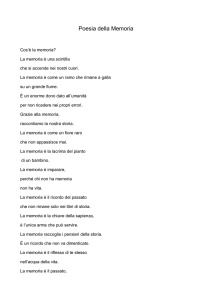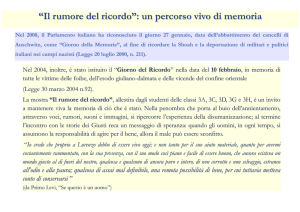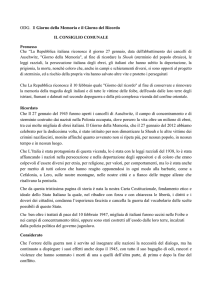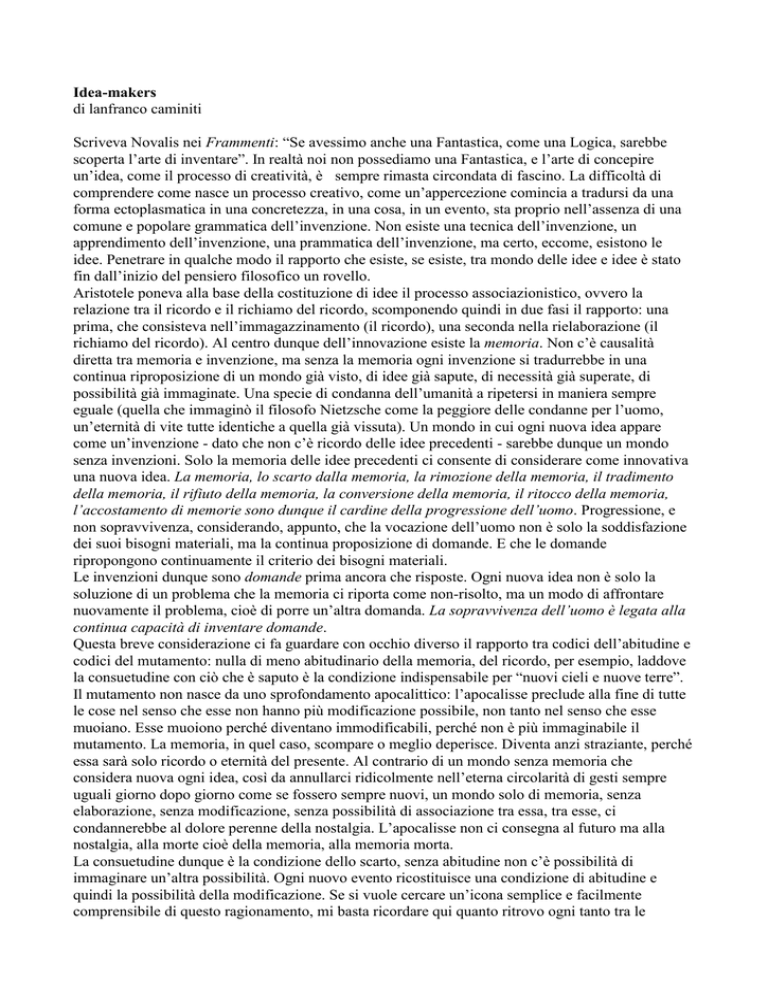
Idea-makers
di lanfranco caminiti
Scriveva Novalis nei Frammenti: “Se avessimo anche una Fantastica, come una Logica, sarebbe
scoperta l’arte di inventare”. In realtà noi non possediamo una Fantastica, e l’arte di concepire
un’idea, come il processo di creatività, è sempre rimasta circondata di fascino. La difficoltà di
comprendere come nasce un processo creativo, come un’appercezione comincia a tradursi da una
forma ectoplasmatica in una concretezza, in una cosa, in un evento, sta proprio nell’assenza di una
comune e popolare grammatica dell’invenzione. Non esiste una tecnica dell’invenzione, un
apprendimento dell’invenzione, una prammatica dell’invenzione, ma certo, eccome, esistono le
idee. Penetrare in qualche modo il rapporto che esiste, se esiste, tra mondo delle idee e idee è stato
fin dall’inizio del pensiero filosofico un rovello.
Aristotele poneva alla base della costituzione di idee il processo associazionistico, ovvero la
relazione tra il ricordo e il richiamo del ricordo, scomponendo quindi in due fasi il rapporto: una
prima, che consisteva nell’immagazzinamento (il ricordo), una seconda nella rielaborazione (il
richiamo del ricordo). Al centro dunque dell’innovazione esiste la memoria. Non c’è causalità
diretta tra memoria e invenzione, ma senza la memoria ogni invenzione si tradurrebbe in una
continua riproposizione di un mondo già visto, di idee già sapute, di necessità già superate, di
possibilità già immaginate. Una specie di condanna dell’umanità a ripetersi in maniera sempre
eguale (quella che immaginò il filosofo Nietzsche come la peggiore delle condanne per l’uomo,
un’eternità di vite tutte identiche a quella già vissuta). Un mondo in cui ogni nuova idea appare
come un’invenzione - dato che non c’è ricordo delle idee precedenti - sarebbe dunque un mondo
senza invenzioni. Solo la memoria delle idee precedenti ci consente di considerare come innovativa
una nuova idea. La memoria, lo scarto dalla memoria, la rimozione della memoria, il tradimento
della memoria, il rifiuto della memoria, la conversione della memoria, il ritocco della memoria,
l’accostamento di memorie sono dunque il cardine della progressione dell’uomo. Progressione, e
non sopravvivenza, considerando, appunto, che la vocazione dell’uomo non è solo la soddisfazione
dei suoi bisogni materiali, ma la continua proposizione di domande. E che le domande
ripropongono continuamente il criterio dei bisogni materiali.
Le invenzioni dunque sono domande prima ancora che risposte. Ogni nuova idea non è solo la
soluzione di un problema che la memoria ci riporta come non-risolto, ma un modo di affrontare
nuovamente il problema, cioè di porre un’altra domanda. La sopravvivenza dell’uomo è legata alla
continua capacità di inventare domande.
Questa breve considerazione ci fa guardare con occhio diverso il rapporto tra codici dell’abitudine e
codici del mutamento: nulla di meno abitudinario della memoria, del ricordo, per esempio, laddove
la consuetudine con ciò che è saputo è la condizione indispensabile per “nuovi cieli e nuove terre”.
Il mutamento non nasce da uno sprofondamento apocalittico: l’apocalisse preclude alla fine di tutte
le cose nel senso che esse non hanno più modificazione possibile, non tanto nel senso che esse
muoiano. Esse muoiono perché diventano immodificabili, perché non è più immaginabile il
mutamento. La memoria, in quel caso, scompare o meglio deperisce. Diventa anzi straziante, perché
essa sarà solo ricordo o eternità del presente. Al contrario di un mondo senza memoria che
considera nuova ogni idea, così da annullarci ridicolmente nell’eterna circolarità di gesti sempre
uguali giorno dopo giorno come se fossero sempre nuovi, un mondo solo di memoria, senza
elaborazione, senza modificazione, senza possibilità di associazione tra essa, tra esse, ci
condannerebbe al dolore perenne della nostalgia. L’apocalisse non ci consegna al futuro ma alla
nostalgia, alla morte cioè della memoria, alla memoria morta.
La consuetudine dunque è la condizione dello scarto, senza abitudine non c’è possibilità di
immaginare un’altra possibilità. Ogni nuovo evento ricostituisce una condizione di abitudine e
quindi la possibilità della modificazione. Se si vuole cercare un’icona semplice e facilmente
comprensibile di questo ragionamento, mi basta ricordare qui quanto ritrovo ogni tanto tra le
didascalie e i disegnini esplicativi della rubrica “Forse non tutti sanno che” della “Settimana
Engimistica”: il filosofo Kant usciva tutti i giorni per le strade della sua amata Königsberg alla
stessa ora, ed era talmente puntuale che si sarebbe potuto regolare sulla sua passeggiata il campanile
della cittadina, che lui puntualmente controllava. Ben più che maniacalità ossessiva (se qualcuno ha
proprio voglia di documentarsene allora può passare allo stadio successivo di apprendimento
culturale, che è il delizioso e tremendo libricino Gli ultimi giorni di Kant di De Quincey) questo
episodio riporta sull’avventura delle idee un dato essenziale: la stanzialità e non la frenesia è la
condizione perché nella maglia delle nostre intuizioni resti acchiappata qualcosa che poi saremo in
grado di trasformare, di elaborare. Come diceva Gianni Rodari, che di fantasia se ne intendeva: “le
ipotesi sono reti; tu getti una rete e prima o poi qualcosa ci trovi”. La consuetudine è la condizione
necessaria per potere gettare delle reti. Come ben sanno i cacciatori di folaghe o di anatre, la
postazione fissa è indispensabile per ben riempire il proprio carniere colpendo nei fugaci passaggi di
volo, così come questa attitudine è la chiave dei pescatori di lucci; e i cercatori di funghi o di tartufi
sono gelosissimi dei loro luoghi stabili, tanto da tramandarli per via familiare. Tutto ciò, soprattutto,
è noto ai pescatori di perle (come la Arendt definiva Benjamin) e a quelli di anime.
I sacerdoti e i ciarlatani
Il rapporto, quindi, più intrigante è quello che indubbiamente esiste tra l’accumulazione dei dati - di
qualunque generi di dati - e l’elemento intuitivo. Nel senso che l’accumulazione di dati è una
conditio sine qua non ma, nello stesso tempo, non ci dice assolutamente nulla sulla capacità
intuitiva e sul processo creativo. Tra i due elementi possono inserirsi le linee di precipitazione della
casualità. Questo è storicamente il processo di costituzione delle invenzioni scientifiche (mediche,
fisiche, chimiche), almeno dal momento in cui la scienza è diventata un procedimento di esperienze
e non più una sofia. Buona parte delle scoperte scientifiche (particolarmente quelle farmaceutiche)
sono dovute alla casualità, al recupero di un dato in un contesto completamente differente, al
rovesciamento logico dei procedimenti tecnici usati fino a quel momento, a uno scivolone.
Contemporaneamente, nel momento stesso in cui una scoperta ci fa rendere conto dell’insensatezza
dei processi di accumulazione degli esperimenti condotti fino ad allora, ci dice che senza quel lungo
lavorio infinito non ci sarebbe mai stata probabilmente questa scoperta. E’ questo intreccio che
costruisce soprattutto la rispettabilità della comunità scientifica e la sua impermeabilità all’inventore
autodidatta: aprire le porte, un solo spiraglio all’idea che le invenzioni sono determinate o solo dal
caso o solo dall’esperienza, significherebbe mettere definitivamente in crisi la sacralità della
scienza. La quale sacralità riposa sui suoi sacerdoti - e non l’incontrario. Per i sacerdoti
dell’invenzione il caso non esiste, o esiste solo se è prodotto all’interno della loro comunità. Così
come per loro non esiste la ferrea determinazione all’accumulazione dei dati per giungere
all’invenzione, perché in questo caso mancherebbe appunto l’aura sacrale che sola è data dall’essere
officiante del rito della ricerca scientifica.
Eppure, una giovane coppia, colpita dalla maledizione di una malattia, inventa, attraverso la tenacia
e l’amore, l’olio di Lorenzo. Tra tanti ciarlatani si annidano spesso uomini capaci di rovesciare il
senso comune delle cose e di farci intravedere nuovi spiragli, nuove domande.
Il mondo d’oggi è pieno di ciarlatani, di vecchi doc in giro per la frontiera su carri dissestati che
vendono le loro pozioni miracolose contro la caduta dei capelli, il male ai calli, le punture di insetti
e le vesciche al culo per il lungo stare sulle selle. Essi offrono idee, essi offrono miracoli. Al
modico prezzo di venticinque cent. Ci avviciniamo al loro carro, una piccola folla, sapendo che il
primo che sarà entusiasta delle parole del ciarlatano è il suo compare, con un misto di disillusione,
di desiderio di magia e di disincanto. Quello che vogliamo non è un rimedio ai nostri guai - il
rimedio ai nostri guai passa per altre strade, per la nostra determinazione a vivere, a cambiare, a
batterci, a mettere le cose secondo il verso giusto. Quello che vogliamo è un’idea, una associazione
di idee, una combinazione di pensieri messi in un modo talmente strano, qualcosa a cui forse
avevamo già pensato senza considerarlo plausibile. Ci serve, per la nostra determinazione, per
irridere questa idea o per trovarne piacere, per distrarci o per concentrarci, per ritrovare fiducia in
noi stessi, nelle nostre possibilità e capacità individuali e in quelle del nostro vicino.
Le idee, dunque, una volta venivano dai filosofi e dagli scienziati - raramente dai religiosi, a meno
di non intendere per questi gli uomini di fede, così spesso eretici. Essi dissipavano le ombre della
nostra ignoranza, gettavano coni di luce sulla realtà, mostrandocela nella sua crudezza, nella sua
durezza. In un certo senso essi erano delegati a questo, come se nella grande famiglia dell’uomo si
fosse deciso di mandare qualche figlio a studiare in seminario, ché sarebbe tornato sempre utile.
Attorno ai lumi della loro sapienza ci stringevamo per trovare conforto, per trarre motivazione a
riscaldare con quelle deboli fiammelle una vita senza senso. La produzione di idee era un
procedimento misterioso, qualcosa che solo determinati uomini - segnati da un destino divino e
crudele nello stesso tempo, ché essi erano così diversi da noi - potevano penetrare e padroneggiare.
Non v’erano scuole, non v’erano tecniche di invenzione: laddove esistevano esse consentivano solo
la riproduzione di un’idea primigenia, la trasformazione dell’idea in tecnica, ma non la continua
fioritura di innovazioni (la scuola socratica che metteva a fondamento dell’idea la costituzione del
dubbio viene travolta dalle urgenze del potere, che si fonda sempre sulla fede cieca nell’autorità in
quanto tale). Consentivano, cioè, che un’idea si depositasse, disponesse del tempo necessario per
trasformarsi in luogo comune, in nuova sensibilità, in assodata percezione universale. Lo scarto era
troppo ampio tra l’improvviso emergere di un’intuizione e la lenta assimilazione della gente
qualunque.
E' tempo di godere delle idee
A colmare questo scarto, a chiudere la divaricazione di questa forbice, a irrompere sulla scena del
desiderio delle idee, del piacere della produzione di idee si mosse la gente qualunque, convinta che
tutto passasse per il possesso del sapere. Alla conquista del sapere, inteso come chiave di volta,
pozzo sacro, scrigno inesauribile, tesoro immenso nella grotta di Alì Babà, mosse la gente
qualunque. Contemporaneamente al muoversi verso la libertà dalla schiavitù del bisogno, dalla
schiavitù della fatica disumana, da bestie, senza rispetto e dignità. Questo comune e coevo
mobilitarsi verso un’intierezza di figura umana sciente e dignitoso (che fondava la propria dignità su
schegge di sapere, perché era l’ignoranza la bestia che faceva accettare la bestialità della vita)
accade con la trasformazione d’ogni sapere in tecnica. Accade con la trasformazione d’ogni sapere
in riproducibilità. E’ un percorso lungo quanto la formazione della borghesia e del proletariato,
lungo quanto l’uscita dal Medio Evo, un arco temporale che va dallo stampatore Gutenberg alla
macchina a vapore di Stevenson, in cui dunque i saperi si trasformano in tecniche e il potere delle
tecniche significa il potere sull’organizzazione degli uomini. Le invenzioni, le idee acquistano
progressivamente valore solo se possono consustanziarsi in tecniche; il resto, tutto il resto - tutte le
idee che non sono oggetti in potenza - entra nella dimensione spirituale, estetica, artistica.
Ma la , la progressiva liberazione dell’uomo dal dolore e dalla fatica, si stravolge in
un’esistenza autonoma e indipendente, in una richiesta d’essere onnipotente e onnipervasiva, in una
volontà di potenza che passa anzitutto per l’assoggettamento dell’uomo. E’ in questo scorcio di
secolo nient’affatto breve - non foss’altro che per la sua straordinaria e terribile capacità di
concentrare in un cumulo di eventi tutto il percorso dell’umanità, di metterla di fronte alle domande
essenziali (come è stato per il Mille, come è stato per il Quattrocento, come è stato per il Seicento,
come non è stato per altri secoli) e per il trovarsi a snodo della convenzione del tempo che ci fa
aspettare il Duemila, obbligandoci (ma ci sembra con poca convinzione ancora) a fare due conti -, è
in questo scorcio di secolo, dunque, che si ritorna a guardare alla produzione di idee svincolandola
dall’obbligo al reale.
Le idee sono macchine inutili, alambicchi degli uomini che non distillano un accidenti, giocattoli
complicati e luminescenti, arabeschi tracciati sulla sabbia in un giorno in cui soffia il ghibli,
palloncini colorati a cui si tira a segno. Le idee non sono merce di scambio, non vengono barattate
in qualche mercato delle pulci, non subiscono le flessioni dei tassi di cambio. Le idee non
producono eventi, sono esse stesse eventi, sono fatti senza alcuna necessità di opinioni separate. Le
idee non sono sacre, e non perché esse sono tutte buone, in una sorta di collezione di punti scaduti,
ma, al contrario, perché le idee sono deperibili come il latte fresco di giornata, non aspirano
all’eternità e non rivendicano radici, ché queste e quella appartengono alle religioni e alle
ideologie. Le idee sono effimere, ovvero la loro durevolezza è pari alla loro necessità biologica,
quindi sono conficcate realisticamente nella durezza della vita. Passa per questa consapevolezza il
desiderio, la fame di idee che si afferma oggi. Se la conoscenza delle cose che Adamo afferra
attraverso l’invito del serpente e la convinzione di Eva si traduce nella perdita della felicità; se la
conoscenza di Prometeo, nel rubare il fuoco agli dei per confortare gli uomini, si traduce nella
sofferenza, nella condanna; se la conoscenza che l’uomo ha del mondo attraverso la scienza si
traduce nel cacciare dio dal mondo, nell’assenza, chiudendo così il cerchio, è tempo forse di deporre
l’ansia di conoscere, di rallentarla, di metterci a riposo. E’ tempo, invece, di godere delle idee, di
produrle per il piacere di produrle.
Liberi dalla memoria
Chi sono dunque oggi i produttori di idee, i facitori di idee, i costruttori di idee, gli idea-makers? In
un mondo che sembra girare attorno le immagini, in un mondo il cui imprinting primordiale è
costituito da immagini, in cui la visualizzazione è il criterio di costituzione delle idee, che forma
hanno queste? Paradossalmente, sembra di tornare al Platone contro le ombre proiettate nella grotta
per ridare corpo invece al giusto , alla giusta idea, alla giusta forma.
Forse è opportuno chiedersi prima ancora cosa intendiamo per idea, magari cominciando col dire
cosa non intendiamo. Intanto non consideriamo un’idea quella che è sottoponibile al processo di
verità. La falsificazione di un’idea, la verificabilità di un’idea sono procedimenti che rinviano al
codice sperimentale della scoperta scientifica, al codice linguistico della comunità scientifica. Così
come alla pertinenza del linguaggio (alla riduzione di un’idea a problema linguistico) rimanda la
comprensione logica di ogni nuova idea. Le idee a cui pensiamo noi sono invece impertinenti e come nel bel titolo della serie televisiva - “ai confini della realtà”. Sono anzitutto immagini mentali
che un’abilità creativa individuale traduce in linguaggio ovvero in un processo comprensibile agli
altri ma che, nello stesso tempo, lo innova introducendovi degli scarti, delle associazioni. Questo
elemento del rapporto tra creatività individuale e fruizione collettiva ci pare sia il cuore della
questione, nel senso che il ruolo aristotelico del ricordo, ovvero dell’accumulazione preesistente dei
dati, ci pare possa individuarsi invece in una sorta di memoria collettiva, di sapere generale. Non è
quindi una questione macchinica, anzi è proprio l’opposto; nel momento in cui progressivamente la
macchina generale (il complesso di macchine inventato dall’uomo) assolve una funzione
inimmaginabile di sostituzione della memoria (e sostanzialmente impossibile per l’uomo) essa ci
solleva dalla fatica del ricordo, proiettandoci immediatamente verso l’elaborazione. Per fare un
esempio che suona apparentemente macabro: la memoria dei morti che la Chiesa dell’avvento dei
santi dell’ultimo giorno pratica nel suo mostruoso elaboratore nello Utah mormonico, in una sorta di
aspirazione generale a scrivere i nomi di tutti i morti o - il che è lo stesso - di tutti coloro che sono
stati vivi, quasi una sostituzione o una contabile traduzione del giorno del giudizio universale, ci
libera finalmente dalla parte fisiologica del lutto, dagli obblighi minuti e anagrafici, facendoci
slittare verso una nuova dimensione, tutta finalmente spirituale e tutta immediatamente universale. I
nostri morti stanno tra i milioni, i miliardi di altri già vivi, in una protezione del loro ricordo che
esubera certamente la nostra stessa vita e le nostre stesse deboli forze; noi pure saremo scritti là, ed
è un conforto certamente maggiore dell’affidarci ai nostri amici, ai nostri cari, alle nostre iniziative.
Siamo già eterni attraverso la macchina, e lo siamo tutti. Questa possibilità di dimenticarci della
morte, di non doverci affannare del ricordo è la straordinaria possibilità offertaci dalla macchina:
siamo liberi di costruire altre associazioni del dolore, altre idee della morte e del lutto.
Così, la macchina, tutte le macchine ci stanno liberando dal dovere della memoria, dal lavoro della
memoria, guidandoci immediatamente verso la felicità creativa, sgombrando quelle zone del nostro
cervello che erano affaticate, impegnate, sovraccaricate dall’impegno del ricordo come
precondizione dell’elaborazione. Questo superamento del limite delle nostre facoltà è la strada verso
un potenziamento delle nostre capacità. L’invenzione come limite significa la capacità di
concretizzare in limiti la nostra creatività. Dimenticare gli aspetti formali dei linguaggi, dei codici,
accantonare le questioni limitative della memoria ci consente di sublimarci verso la produzione di
idee.
Il principio di felicità
Cosa sono, quindi, le idee alle quali noi pensiamo? Sono quelle che ci parlano di una società
creativa, del piacere e della forza che ne derivano. E’ questo il vero “pasto gratis” che si ritrova una
società ereditando i progressi di quella precedente. Una società in ebollizione, piena di fermenti, di
linee di fuga, di soprassalti, di sassi continuamente gettati nello stagno è l’unica cosa che possiamo
augurarci di tramandare a coloro che verranno dopo di noi. Le idee non sono quindi tecnologia, anzi
tendono a farci dimenticare della tecnica, a farci - come diceva Totò - soprassedere. Se esiste una
teoria della path dependency, cioè del sentiero progressivo dove si accumulano i risultati delle
scoperte precedenti dalle quali non ci si può allontanare, quasi fosse un destino, ecco, le idee non
c’entrano niente, esse sono - ancora una citazione di Totò - a prescindere.
Ribaltare il vincolo della serialità, è questa la forza dirompente di un’idea. La creatività a cui
pensiamo non ha esiti tecnologici, così come non ha tensioni esclusivamente estetico-religiose. E’
una commistione, un frammischiamento, un imbastardimento, uno scompigliare all’aria le carte. Il
vero supporto all’elaborazione, al richiamo della memoria non è dunque la macchina ma la
cooperazione umana al ricordo. Le idee non sono mai produzione di un singolo, ma pluralità di
risposte a un bisogno diffuso. Più persone cercano di dare risposte a questo bisogno, ovvero cercano
di formulare in più modi la stessa domanda. Per questo esse sono piantate nel tempo in cui vengono
formulate, anche quando appaiono eccessivamente anticipatorie o irrimediabilmente ritardatarie,
perché momento sincretico d’una diffusa sensibilità. Poi, all’improvviso, l’idea nuova si fa strada;
essa, dunque, non è la lampadina di Archimede pitagorico, il frutto della genialità d’un singolo, o
almeno lo è in quanto è presupposta dalla fluorescenza del pensare collettivo.
Ma un’altra questione si presenta: perché esistono società più creative e altre meno creative? e,
prima ancora, cosa intendiamo per creatività? Dovrebbe essere evidente, a questo punto, che per
creatività sociale non si intende qui solo l’elemento produttivo, non si intende qui l’accumulazione
di tecniche per la produzione di maggiori quantità di beni materiali. E non perché questo non sia
uno degli elementi della creatività. Eppure troppo forte è ormai il dubbio che la linea dritta del
progresso sappia bene dove stia dirigendosi. Senza essere catastrofisti e senza gli estremismi furiosi
come una religione del “ritorno alla natura” (quella, per intenderci, alla Unabomber), pure ci
attanaglia qualche dubbio quando salta in aria Mururoa o quando le catene di montaggio delle
scarpette Nike costringono a forme di schiavitù, terribili quanto la loro fame, bambini indiani o
filippini. Per società creativa intendiamo soprattutto una società capace di costruire elementi di
libertà attraverso la comunicazione.
Le idee dunque sono essenzialmente comunicazione e i facitori di idee sono fondamentalmente dei
comunicatori. Comunicatori non tanto di uno specifico segnale (una volta si sarebbe detto di uno
specifico “messaggio”), quanto del processo stesso di comunicazione, della necessità stessa della
comunicazione come elemento che esubera la produttività, anche se la comunicazione è fatta di
eventi, di oggetti, di merci, di dati, di cifre. Abbiamo quindi spostato progressivamente il tiro dalla
capacità inventiva alla capacità ideativa e comunicativa, perché la prima era troppo intrisa di olio
dei macchinari. Lo slittamento verso l’immaterialità della produzione ci porta a quello che è il dato
dominante della società d’adesso, post-produttiva, post-macchinica, post-industriale, post-moderna.
Il margine di libertà - non tanto di libertà dal bisogno, ma di libertà creativa, di piacere creativo,
tanto quando non è finalizzato ad alcunché, tanto quando è strettamente legato a una fattualità - che
i facitori di idee hanno, è possibile che alluda a un futuro processo collettivo?
E' possibile liberarsi dal principio di necessità, è possibile rovesciare la necessità in creatività? Una
società rigida e intollerante è una società povera cioè poco inventiva, senza fortuna, senza sfida al
deterioramento, all’invecchiamento, alla morte che passa attraverso l’intuizione - forse narcisista,
forse infantile, forse esibizionista. Fare idee è uno straordinario principio di felicità. E’ possibile
che questo straordinario principio venga restituito alla società intera? Non perché i facitori di idee
siano defraudatori, ma tutt’al contrario perché essi sono boe, segnali luminosi, piccolo mucchio di
pietre, messaggio cifrato d’una mappa che indica quale immenso giacimento di creatività stia sotto
d’essi.
Tra gli scompensi di un breve testo che non ha tesi ma si presenta come un divertito tentativo di
inseguire un’idea, si fa strada l’ipotesi d’una felicità nel quotidiano che accompagni con la felicità
del processo creativo la continua determinazione a essere più liberi, e rischiararla.
(Postfazione per Idea makers, una raccolta di interviste fra creativi italiani - fumetto, moda,
fotografia, informatica - che doveva essere edito da Castelvecchi)
Roma, settembre 1996