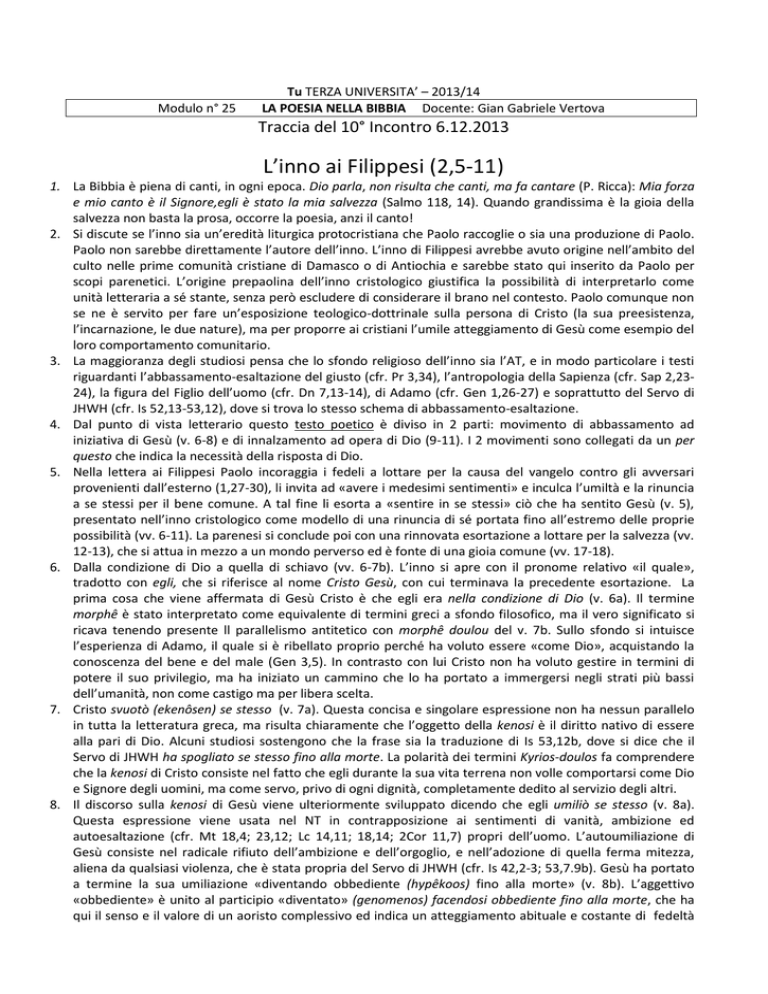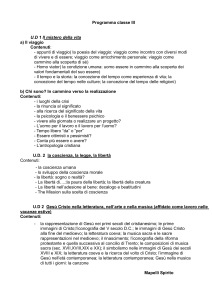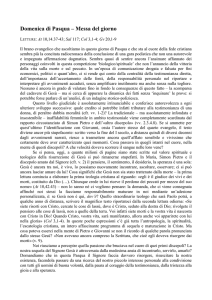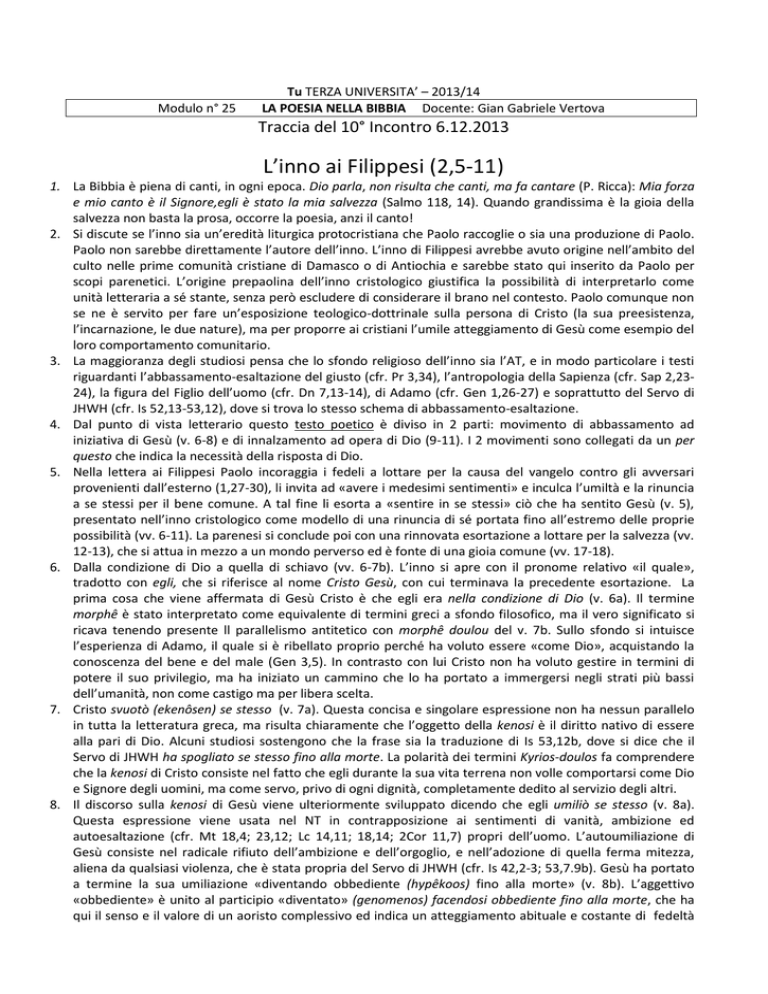
Modulo n° 25
Tu TERZA UNIVERSITA’ – 2013/14
LA POESIA NELLA BIBBIA Docente: Gian Gabriele Vertova
Traccia del 10° Incontro 6.12.2013
L’inno ai Filippesi (2,5-11)
1. La Bibbia è piena di canti, in ogni epoca. Dio parla, non risulta che canti, ma fa cantare (P. Ricca): Mia forza
e mio canto è il Signore,egli è stato la mia salvezza (Salmo 118, 14). Quando grandissima è la gioia della
salvezza non basta la prosa, occorre la poesia, anzi il canto!
2. Si discute se l’inno sia un’eredità liturgica protocristiana che Paolo raccoglie o sia una produzione di Paolo.
Paolo non sarebbe direttamente l’autore dell’inno. L’inno di Filippesi avrebbe avuto origine nell’ambito del
culto nelle prime comunità cristiane di Damasco o di Antiochia e sarebbe stato qui inserito da Paolo per
scopi parenetici. L’origine prepaolina dell’inno cristologico giustifica la possibilità di interpretarlo come
unità letteraria a sé stante, senza però escludere di considerare il brano nel contesto. Paolo comunque non
se ne è servito per fare un’esposizione teologico-dottrinale sulla persona di Cristo (la sua preesistenza,
l’incarnazione, le due nature), ma per proporre ai cristiani l’umile atteggiamento di Gesù come esempio del
loro comportamento comunitario.
3. La maggioranza degli studiosi pensa che lo sfondo religioso dell’inno sia l’AT, e in modo particolare i testi
riguardanti l’abbassamento-esaltazione del giusto (cfr. Pr 3,34), l’antropologia della Sapienza (cfr. Sap 2,2324), la figura del Figlio dell’uomo (cfr. Dn 7,13-14), di Adamo (cfr. Gen 1,26-27) e soprattutto del Servo di
JHWH (cfr. Is 52,13-53,12), dove si trova lo stesso schema di abbassamento-esaltazione.
4. Dal punto di vista letterario questo testo poetico è diviso in 2 parti: movimento di abbassamento ad
iniziativa di Gesù (v. 6-8) e di innalzamento ad opera di Dio (9-11). I 2 movimenti sono collegati da un per
questo che indica la necessità della risposta di Dio.
5. Nella lettera ai Filippesi Paolo incoraggia i fedeli a lottare per la causa del vangelo contro gli avversari
provenienti dall’esterno (1,27-30), li invita ad «avere i medesimi sentimenti» e inculca l’umiltà e la rinuncia
a se stessi per il bene comune. A tal fine li esorta a «sentire in se stessi» ciò che ha sentito Gesù (v. 5),
presentato nell’inno cristologico come modello di una rinuncia di sé portata fino all’estremo delle proprie
possibilità (vv. 6-11). La parenesi si conclude poi con una rinnovata esortazione a lottare per la salvezza (vv.
12-13), che si attua in mezzo a un mondo perverso ed è fonte di una gioia comune (vv. 17-18).
6. Dalla condizione di Dio a quella di schiavo (vv. 6-7b). L’inno si apre con il pronome relativo «il quale»,
tradotto con egli, che si riferisce al nome Cristo Gesù, con cui terminava la precedente esortazione. La
prima cosa che viene affermata di Gesù Cristo è che egli era nella condizione di Dio (v. 6a). Il termine
morphê è stato interpretato come equivalente di termini greci a sfondo filosofico, ma il vero significato si
ricava tenendo presente ll parallelismo antitetico con morphê doulou del v. 7b. Sullo sfondo si intuisce
l’esperienza di Adamo, il quale si è ribellato proprio perché ha voluto essere «come Dio», acquistando la
conoscenza del bene e del male (Gen 3,5). In contrasto con lui Cristo non ha voluto gestire in termini di
potere il suo privilegio, ma ha iniziato un cammino che lo ha portato a immergersi negli strati più bassi
dell’umanità, non come castigo ma per libera scelta.
7. Cristo svuotò (ekenôsen) se stesso (v. 7a). Questa concisa e singolare espressione non ha nessun parallelo
in tutta la letteratura greca, ma risulta chiaramente che l’oggetto della kenosi è il diritto nativo di essere
alla pari di Dio. Alcuni studiosi sostengono che la frase sia la traduzione di Is 53,12b, dove si dice che il
Servo di JHWH ha spogliato se stesso fino alla morte. La polarità dei termini Kyrios-doulos fa comprendere
che la kenosi di Cristo consiste nel fatto che egli durante la sua vita terrena non volle comportarsi come Dio
e Signore degli uomini, ma come servo, privo di ogni dignità, completamente dedito al servizio degli altri.
8. Il discorso sulla kenosi di Gesù viene ulteriormente sviluppato dicendo che egli umiliò se stesso (v. 8a).
Questa espressione viene usata nel NT in contrapposizione ai sentimenti di vanità, ambizione ed
autoesaltazione (cfr. Mt 18,4; 23,12; Lc 14,11; 18,14; 2Cor 11,7) propri dell’uomo. L’autoumiliazione di
Gesù consiste nel radicale rifiuto dell’ambizione e dell’orgoglio, e nell’adozione di quella ferma mitezza,
aliena da qualsiasi violenza, che è stata propria del Servo di JHWH (cfr. Is 42,2-3; 53,7.9b). Gesù ha portato
a termine la sua umiliazione «diventando obbediente (hypêkoos) fino alla morte» (v. 8b). L’aggettivo
«obbediente» è unito al participio «diventato» (genomenos) facendosi obbediente fino alla morte, che ha
qui il senso e il valore di un aoristo complessivo ed indica un atteggiamento abituale e costante di fedeltà
9.
10.
11.
12.
totale alla volontà di Dio. L’espressione fino alla morte significa che l’obbedienza del Cristo che non cede
davanti al sacrificio personale, compreso a quello supremo della propria vita.
L’autore infine commenta: e a una morte di croce (staurou) (v. 8c). Questa espressione, che rappresenta il
climax dell’inno, può considerarsi come una anadiplosi (ripetizione retorica) che mette in rilievo l’estremo
grado di umiliazione a cui Gesù è andato incontro.
Il Cristo esaltato (vv. 9-11) Il nuovo brano inizia con la descrizione degli effetti che ha avuto l’umiliazione di
Cristo: Per questo Dio lo esaltò (yper-ypsôsen: lett.: lo sopraesaltò) (v. 9a). L’espressione «per questo»
sottolinea come la radicalità della svolta che interessa la persona di Gesù ha uno stretto collegamento con
ciò che è capitato precedentemente. L’esaltazione che gli è conferita appare come un esempio del modo di
agire di Dio, enunciato da Gesù stesso nei vangeli (cfr. Lc 14,11; 18,14b //Mt 23,12). Il verbo ypsoô,
«esaltare», è utilizzato nel quarto Vangelo per indicare la morte di Cristo in croce, in quanto però essa
implica già la sua risurrezione e ascensione (cfr. Gv 3,14; 8,28; 12,32.34). L’intervento divino viene
ulteriormente precisato con questa affermazione: Egli «lo gratificò (echarisato) con il nome che è al di sopra
di ogni nome» (v. 9b). Questo è l’unico passo nel NT in cui si parla di un atto di grazia (charis) concesso a
Cristo. Dal contesto (cfr. v. 11b) si ricava che «il nome» attribuito a Gesù è il nome stesso di Dio, JHWH, che
in greco è stato tradotto Kyrios. Proprio quel Gesù, che durante la sua esistenza terrena non aveva voluto
avvalersi a proprio vantaggio del suo «essere alla pari di Dio», viene ora esaltato in sommo grado,
ricevendo in dono da Dio la dignità suprema propria di Dio stesso: ciò a cui aveva liberamente e
volontariamente rinunciato come diritto lo ottiene ora come dono gratuito.
Lo scopo dell’esaltazione di Cristo viene poi descritto in questi termini: 10perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra,11e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre. Il «nome di Gesù» è quello che gli appartiene perché gli è stato dato da Dio (genitivo
possessivo), e indica la sua signoria universale. Perciò in esso, cioè in segno di profonda adorazione nei suoi
confronti, «si piega ogni ginocchio... e ogni lingua confessa»: questa espressione è ricavata da Is 45,23
(citato secondo la traduzione dei LXX), dove indica l’adorazione che un giorno tutte le creature presteranno
a JHWH. L’autore dell’inno aggiunge «degli esseri celesti, terrestri e sotterranei» per esplicitare il carattere
universale di tale adorazione: ad essa prendono parte tutti gli esseri creati capaci di adorazione, e cioè gli
spiriti nel cielo, i viventi sulla terra ed i morti nello sheol. L’inno cristologico raggiunge la sua conclusione
quando rivela che tutto il cosmo confessa che «Signore [è] Cristo Gesù» (v. 11b). Nel NT questa confessione
si ritrova solo un’altra volta (Col 2,6), mentre altrove essa ricorre nella sua forma più breve Gesù è Signore
(cfr. 1Cor 12,3; Rm 10,9a). Con questa formula l’autore vuole affermare che Gesù Cristo non è un signore
qualunque, ma il KYRIOS per antonomasia. L’inno termina con l’espressione «a gloria di Dio Padre» (v. 11c).
Con queste parole l’autore vuole affermare che Gesù non è il sostituto né il concorrente di Dio, in quanto la
confessione della sua signoria torna in ultima analisi a gloria di Dio Padre.
Nel corso dei secoli l’inno cristologico è stato interpretato in due modi sostanzialmente diversi. I Padri Greci
e quelli Latini fino ad Ambrogio hanno visto come soggetto del brano il Verbo nella sua realtà umana
concreta, cioè Gesù nella sua vita terrena. Per combattere l’arianesimo invece Ambrogio e i Padri Latini
posteriori hanno invece adottato un’altra interpretazione che vede come protagonista dell’inno il Verbo
preesistente nel sua esistenza presso il Padre e nel processo che lo ha portato a scendere in questo mondo
e a prendere la natura umana. Da qui il sistema dottrinale che, in linea con l’insegnamento dei Concili di
Nicea e di Calcedonia, pone l’accento sul Verbo preesistente, sulle sue due nature e sull’incarnazione. Oggi
si pensa che l'inno voglia far vedere nell'uomo Gesù crocifisso il Salvatore e il Signore, così come lo
riconosce la fede cristiana. Gesù Cristo in questo testo impersona la logica che presiede il progetto salvifico
di Dio e che deve reggere anche l'agire della comunità credente. L’inno non predica la morale ai corinzi né
rivendica i valori non negoziabili, ma semplicemente predica Cristo Signore.
INNO ALL’AGAPE (1 Corinzi 13)
1. Le divisioni nella comunità di Corinto spingono Paolo a proporre una teoria della comunità e della sua
organizzazione, affermando nello stesso tempo il primato assoluto dell’agape (I Corinzi, 12,4 – 13), l’amore
così come l’ha proposto Gesù, che va oltre all’eros e alla filìa. (Cfr Mc. 9, 31-38; Col. 3, 12-17 )
2. E’ stato sostenuto che anche questo testo sarebbe una composizione preesistente che Paolo ha inserito qui
perché si adattava al contesto. Ma i riferimenti che esso contiene ai carismi enumerati nel capitolo
3.
4.
5.
6.
precedente sono così espliciti da far concludere che sia stato composto in funzione del tema che sta
svolgendo. Il brano, più che un inno, si avvicina al modello ellenistico dell’«encomio», che consiste
nell’elogio del valore supremo o della virtù più grande, o ad alcune pagine della letteratura biblica
sapienziale in cui la sapienza viene esaltata o esalta se stessa (cfr. Pr 8,4-36; Sir 24,3-21; Sap 7,22-30).
L’inno all’amore si divide senza difficoltà in tre parti: amore e carismi (vv. 1-3); le caratteristiche del vero
amore (vv. 4-7); la superiorità dell’amore (vv. 8-13). L’apostolo mostra anzitutto in tre frasi condizionali
l’inutilità di una pratica dei carismi disgiunta dall’amore. Egli allude solo ad alcuni dei carismi elencati
precedentemente, senza seguire un ordine preciso, ma citando anzitutto proprio la glossolalia, che prima
era stata posta al termine dell’elenco (cfr. 12,10.28): essa non sarebbe paragonabile ad altro che a un
fracasso senza melodia, se non fosse ispirata dall’amore . Questo termine è apparso già due volte nella
lettera (4,21; 8,1), mentre altre due volte è stato usato il verbo agapaô (2,9; 8,3): l’amore designa nell’AT il
motivo profondo per cui Dio ha scelto Israele donandogli l’alleanza (Dt 7,7-8), e di riflesso la lealtà del
popolo nei confronti di Dio (Dt 6,5) e del prossimo (Lv 19,18). Paolo passa poi a esaminare altri due carismi,
quello della profezia e quello della fede. Anche colui che è capace di esercitare questi importanti carismi
nella loro massima potenzialità, se non ha l’amore, non vale nulla. Infine Paolo prende in considerazione
due gesti ricollegati al carisma di assistenza (cfr. 12,28): La distribuzione dei propri beni è fatta senza
dubbio a favore dei poveri e dei bisognosi (cfr. At 4,36). La stessa cosa si può dire del dono del proprio
corpo: esso infatti non indica probabilmente il martirio, ma piuttosto la pratica, descritta da Clemente
Romano, di vendersi come schiavi allo scopo di venire incontro, con il ricavato, alle necessità dei poveri: in
questo caso l’espressione «per essere bruciato» potrebbe indicare il marchio impresso a fuoco sul corpo di
colui che si è venduto come schiavo. In molti antichi manoscritti però si legge, al posto di «per essere
bruciato», l’espressione per trarne vanto: Paolo sottolineerebbe allora che anche il massimo dei servizi resi
ai più poveri potrebbe essere ispirato dall’orgoglio, e allora non avrebbe alcuna utilità.
Prerogative dell’amore (13,4-7): la pazienza fa sì che uno sappia sopportare le ingiustizie senza lasciarsi
prendere dall’ira e dallo scoraggiamento; la benignità indica la bontà e la delicatezza d’animo. L’amore si
distingue principalmente per il rifiuto della violenza, anche verbale, propria di chi è preoccupato anzitutto
dei suoi diritti. Segue poi una lista di atteggiamenti negativi che l’amore porta spontaneamente ad evitare.
Concludono la lista quattro affermazioni positive: la carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto
sopporta (v. 7). Con questi verbi l’apostolo non vuole indicare l’ingenua mancanza di senso critico nel
valutare le azioni altrui, ma piuttosto la capacità di perdonare, di credere negli altri, di dare loro fiducia e di
sopportare qualunque sofferenza per il sopravvento del bene.
L’amore dura per sempre (13,8-13). Il pensiero di Paolo è qui orientato alla venuta finale del regno di Dio,
che considera imminente (cfr. 15,51). Alla fine non solo un carisma secondario come la glossolalia, ma
anche gli altri più importanti, come la profezia e la conoscenza, scompariranno; l’amore invece non verrà
mai meno. La stessa riflessione viene riproposta in due frasi parallele, mediante il ricorso a un’altra
immagine: in questa fase terrena abbiamo un’esperienza (di Dio) piuttosto «confusa» analoga alla visione
che si ha quando si guarda in uno specchio (gli specchi greci avevano un carattere rudimentale; è possibile
però che qui si faccia allusione al costume di usare uno specchio per conoscere il futuro (specchio magico).
Un giorno invece vedremo Dio faccia a faccia: questa espressione proviene da Es 33,11, dove indica il
rapporto diretto che Dio aveva con Mosè, a differenza di tutti gli altri profeti. Un giorno avremo di Dio una
conoscenza perfetta, simile a quella che Dio stesso ha di noi (cfr. 8,3; Gal 4,9).
L’inno all’amore si conclude con queste parole: «Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la
speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!» (v. 13). Paolo vuole affermare che l’amore è
l’unica realtà che non verrà meno neppure quando questo mondo scomparirà e ad esso subentrerà il nuovo
mondo promesso da Dio. Esso dunque anticipa già in questo mondo la perfezione propria della salvezza
finale. Tutte le altre realtà umane sono in se stesse imperfette e caduche, e ricevono una dimensione di
eternità solo se sono ispirate dall’amore.