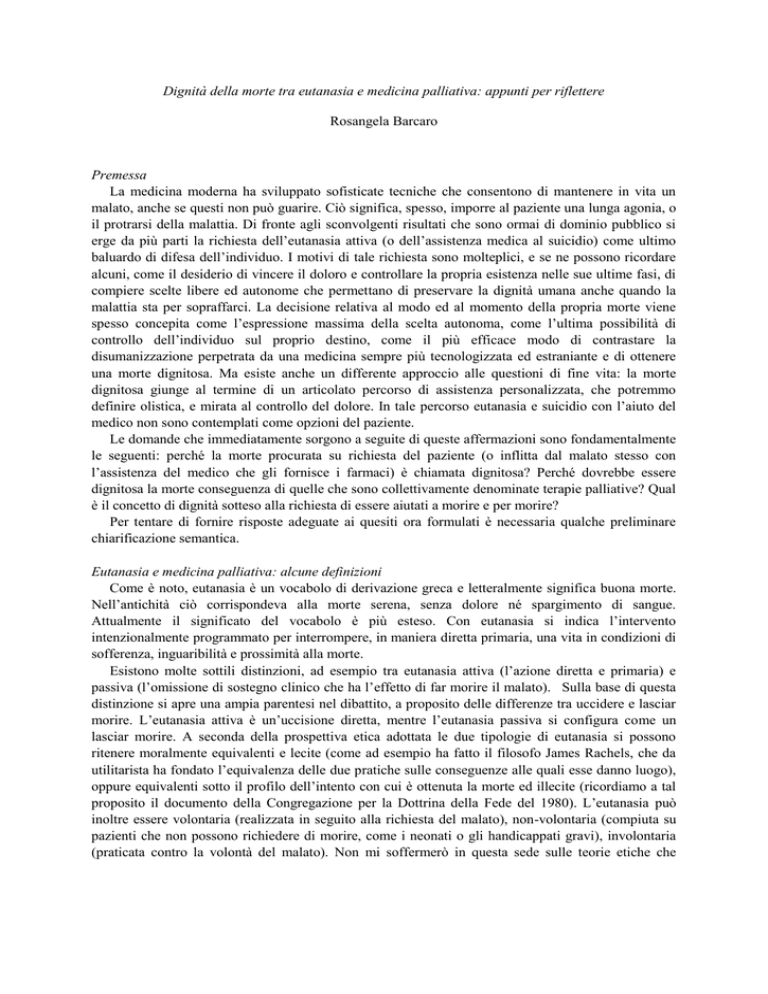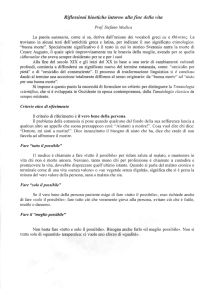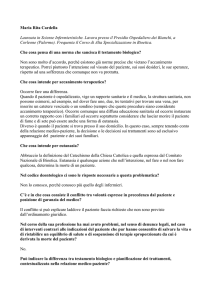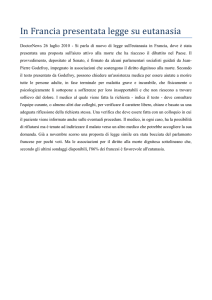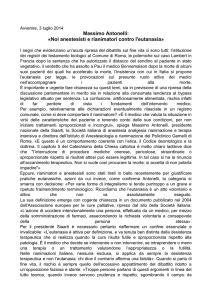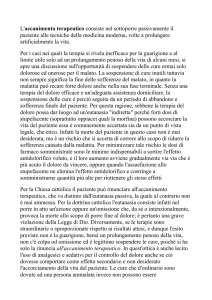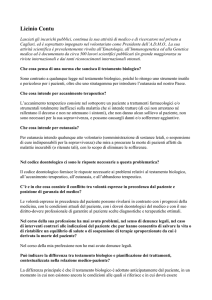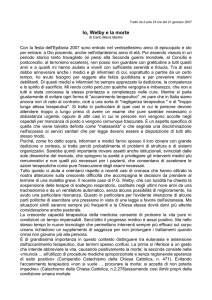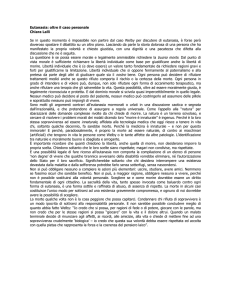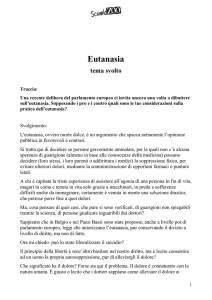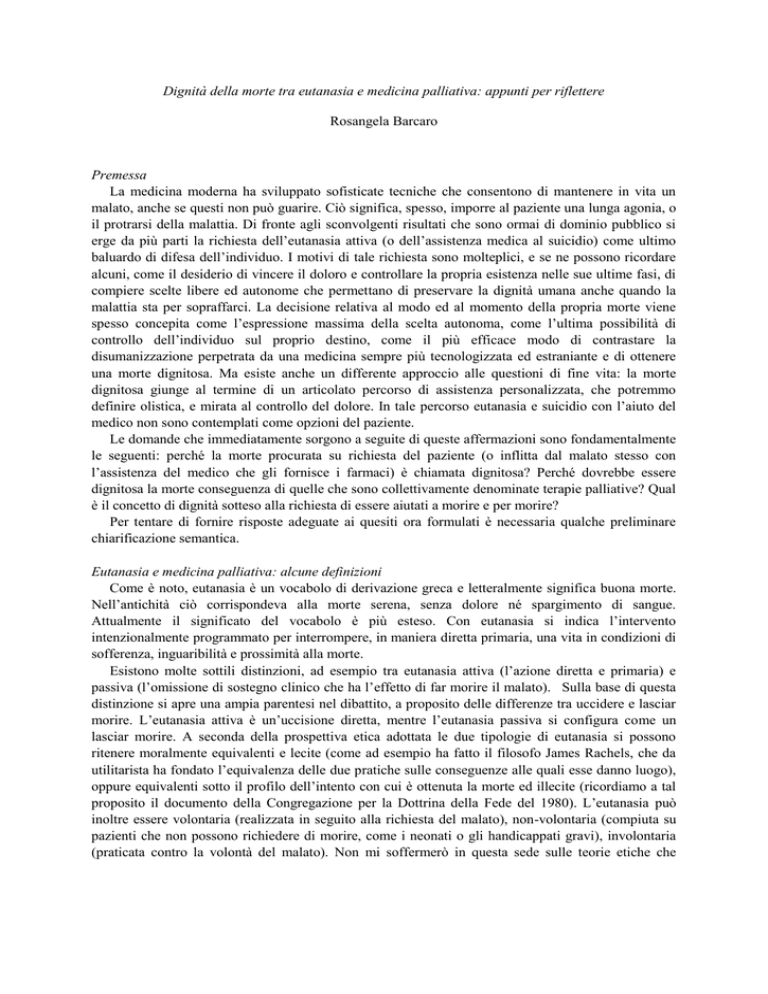
Dignità della morte tra eutanasia e medicina palliativa: appunti per riflettere
Rosangela Barcaro
Premessa
La medicina moderna ha sviluppato sofisticate tecniche che consentono di mantenere in vita un
malato, anche se questi non può guarire. Ciò significa, spesso, imporre al paziente una lunga agonia, o
il protrarsi della malattia. Di fronte agli sconvolgenti risultati che sono ormai di dominio pubblico si
erge da più parti la richiesta dell’eutanasia attiva (o dell’assistenza medica al suicidio) come ultimo
baluardo di difesa dell’individuo. I motivi di tale richiesta sono molteplici, e se ne possono ricordare
alcuni, come il desiderio di vincere il doloro e controllare la propria esistenza nelle sue ultime fasi, di
compiere scelte libere ed autonome che permettano di preservare la dignità umana anche quando la
malattia sta per sopraffarci. La decisione relativa al modo ed al momento della propria morte viene
spesso concepita come l’espressione massima della scelta autonoma, come l’ultima possibilità di
controllo dell’individuo sul proprio destino, come il più efficace modo di contrastare la
disumanizzazione perpetrata da una medicina sempre più tecnologizzata ed estraniante e di ottenere
una morte dignitosa. Ma esiste anche un differente approccio alle questioni di fine vita: la morte
dignitosa giunge al termine di un articolato percorso di assistenza personalizzata, che potremmo
definire olistica, e mirata al controllo del dolore. In tale percorso eutanasia e suicidio con l’aiuto del
medico non sono contemplati come opzioni del paziente.
Le domande che immediatamente sorgono a seguite di queste affermazioni sono fondamentalmente
le seguenti: perché la morte procurata su richiesta del paziente (o inflitta dal malato stesso con
l’assistenza del medico che gli fornisce i farmaci) è chiamata dignitosa? Perché dovrebbe essere
dignitosa la morte conseguenza di quelle che sono collettivamente denominate terapie palliative? Qual
è il concetto di dignità sotteso alla richiesta di essere aiutati a morire e per morire?
Per tentare di fornire risposte adeguate ai quesiti ora formulati è necessaria qualche preliminare
chiarificazione semantica.
Eutanasia e medicina palliativa: alcune definizioni
Come è noto, eutanasia è un vocabolo di derivazione greca e letteralmente significa buona morte.
Nell’antichità ciò corrispondeva alla morte serena, senza dolore né spargimento di sangue.
Attualmente il significato del vocabolo è più esteso. Con eutanasia si indica l’intervento
intenzionalmente programmato per interrompere, in maniera diretta primaria, una vita in condizioni di
sofferenza, inguaribilità e prossimità alla morte.
Esistono molte sottili distinzioni, ad esempio tra eutanasia attiva (l’azione diretta e primaria) e
passiva (l’omissione di sostegno clinico che ha l’effetto di far morire il malato). Sulla base di questa
distinzione si apre una ampia parentesi nel dibattito, a proposito delle differenze tra uccidere e lasciar
morire. L’eutanasia attiva è un’uccisione diretta, mentre l’eutanasia passiva si configura come un
lasciar morire. A seconda della prospettiva etica adottata le due tipologie di eutanasia si possono
ritenere moralmente equivalenti e lecite (come ad esempio ha fatto il filosofo James Rachels, che da
utilitarista ha fondato l’equivalenza delle due pratiche sulle conseguenze alle quali esse danno luogo),
oppure equivalenti sotto il profilo dell’intento con cui è ottenuta la morte ed illecite (ricordiamo a tal
proposito il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1980). L’eutanasia può
inoltre essere volontaria (realizzata in seguito alla richiesta del malato), non-volontaria (compiuta su
pazienti che non possono richiedere di morire, come i neonati o gli handicappati gravi), involontaria
(praticata contro la volontà del malato). Non mi soffermerò in questa sede sulle teorie etiche che
pretendono di giustificare l’eutanasia nelle sue tipologie ora accennate.1 Mi limiterò soltanto ad alcuni
rapidi cenni ‘propedeutici’ al discorso sulla medicina palliativa.
Nel dibattito sull’eutanasia e le decisioni di fine vita si incontra spesso l’espressione ‘morire con
dignità’, ma raramente è chiaro ciò che si vuole indicare quando la si utilizza. La morte con dignità è
identificata – in modo non sempre trasparente – con l’eutanasia, con il rifiuto delle cure inutili e
dell’accanimento terapeutico, con la finalità realizzata dalla medicina palliativa.
Nel caso dell’eutanasia o del suicidio assistito dal medico la morte voluta dal paziente sarebbe
dignitosa in quanto espressione di un’esistenza libera ed autonoma che tale resta fino all’ultimo,
nonostante le difficoltà contingenti prodotte dalla malattia.
Per quanto concerne i casi del rifiuto delle cure inutili e della medicina palliativa occorrono alcune
notazioni.
Per accanimento terapeutico si intende l’insieme di terapie ed atti medici che comportano
sofferenza e isolamento di pazienti prossimi alla fine, interventi che hanno lo scopo di prolungare la
vita per breve tempo, in modo macchinoso e a prezzo di sofferenze fisiche e psicologiche per il malato
e per la sua famiglia.
L’espressione cure palliative (o medicina palliativa, più in generale) indica un insieme di
trattamenti (chirurgici, farmacologici, psicoterapeutici) applicati in associazione tra loro con la finalità
di eliminare dolori e sintomi che accompagnano alcune patologie - in special modo quelle neoplastiche
allo stadio terminale, per le quali non risulta più possibile operare in vista della guarigione del malato e di migliorare la qualità della vita residua del paziente terminale.
Affermare che l’eutanasia, il rifiuto dell’accanimento terapeutico e le terapie palliative tentino di
eliminare il dolore e la sofferenza di un malato terminale per consentirgli di morire il più serenamente
possibile, e che per questa ragione tali pratiche perseguano la finalità di una morte dignitosa, significa
creare una confusione di fondo che non tiene conto delle differenze negli approcci e nelle modalità di
intervento. Il rischio è quello di banalizzare il dibattito sulle decisioni di fine vita e creare un
appiattimento delle diverse proposte etiche che in tale dibattito sono avanzate.
Quale contesto per le decisioni di fine vita?
Perché si assiste alla rivendicazione della scelta del momento della propria morte, se non
addirittura di un ‘diritto di morire’? Per comprendere i motivi della richiesta è utile delineare il
contesto entro il quale essa è formulata. Tale contesto – a mio modo di vedere – è caratterizzato dal
almeno quattro elementi:
1.
la medicina è una impresa che contrasta la morte; ciò può talvolta spingere ad impiegare
tutti i mezzi possibili in vista della realizzazione di tale finalità, anche qualora tali mezzi si rivelino
inefficaci;
2.
esiste una estrema specializzazione delle diverse branche della medicina: si assiste dunque
alla perdita del carattere personale della malattia, vista sempre più come qualcosa che accade agli
organi di una persona e non alla persona tout court;
3.
si è diffuso un nuovo modello di rapporto tra medico e paziente, non sempre basato sulla
fiducia reciproca. Questo modo di impostare il rapporto spinge il medico a tentare tutte le terapie
possibili, anche quando non c’è più niente da fare, è chiaro che esse sono superflue, ma sono
comunque messe in atto per evitare potenziali accuse di insufficiente attenzione verso il paziente;
4.
la sperimentazione di nuove terapie sui pazienti terminali può essere una forte tentazione,
propugnata in nome di benefici che potranno essere ottenuti per futuri pazienti. Ciò significa
1
Per un esame in questo senso si rimanda ad esempio alle seguenti opere: R. Barcaro, Dignità della morte,
accanimento terapeutico ed eutanasia, Napoli 2001; P. Becchi, Questioni vitali. Eutanasia e clonazione
nell’attuale dibattito etico, Napoli 2001; P. Borsellino, Bioetica tra autonomia e diritto, Milano 1999; M.
Reichlin, L’etica e la buona morte, Torino 2002; S. Spinsanti, F. Petrelli, Scelte etiche ed eutanasia, Milano
2003.
2
sottoporre pazienti già fisicamente e psicologicamente fragili ad un imponente onere, fatto di
somministrazioni di farmaci, controlli, false speranze.
Un substrato culturale profondamente mutato si trova sullo sfondo dello scenario ora presentato: la
vita umana non è più unanimemente considerata come un bene in sé, essa è concepita come un bene
secondario, che non ha valore in se stesso ma soltanto nella misura in cui consente di realizzare le
finalità che ciascuno si propone, ed è totalmente disponibile. L’aver accolto questa prospettiva ha fatto
scomparire – in molti casi, anche se non in tutti – il significato di cui nell’ambito del cristianesimo
dolore, sofferenza e morte erano dotati; per molti non c’è più la promessa di una vita oltre la morte,
esiste soltanto l’hic et nunc, il paradiso artificiale creato dalla scienza e dalla tecnologia in risposta ad
ogni immaginabile bisogno.
Per coloro che condividono questa visione la pretesa di stabilire il modo ed il momento della
propria morte rientra, come caso estremo, nelle possibilità offerte dalla medicina. Che dire invece a
proposito di quanti escludono l’ipotesi della disponibilità della vita umana? Con tale interrogativo
entriamo nel vivo della questione.
Proporzionalità degli interventi medici
Ritenere che la vita sia un bene indisponibile all’uomo non esclude che il paziente possa disporre la
sospensione delle cure superflue e l’impiego delle terapie palliative. Questa affermazione può trovare
fondamento in una distinzione molto conosciuta che si fa risalire a Papa Pio XII.
Nel 1957, durante un’allocuzione rivolta ad un gruppo di medici anestesisti e rianimatori riuniti a
congresso a Roma, in risposta ad alcuni quesiti sulla doverosità dell’impiego di certi interventi,
inusuali per l’epoca, il Pontefice aveva articolato la distinzione tra mezzi ordinari di cura, sempre
obbligatori, e mezzi straordinari, in genere facoltativi.
Pio XII aveva fornito alcune precisazioni a proposito dei mezzi ordinari di cura, considerati tali in
rapporto alle “circostanze di persone, di luoghi, di tempo, di cultura”2. La straordinarietà del mezzo
terapeutico era invece fondata su alcune circostanze contingenti ed in particolare, risulta dal discorso,
essa consisteva nella rarità e novità dell’intervento terapeutico. L’esempio al quale il Pontefice faceva
riferimento riguarda la ventilazione artificiale, che in quegli anni era ancora scarsamente diffusa negli
ospedali e per questo motivo era considerata un mezzo straordinario. Oggi, il carattere di
straordinarietà degli strumenti per la respirazione artificiale si è attenuato e la distinzione tra mezzi
ordinari e straordinari di cura è stata superata da quella più rigorosa fondata sulla proporzionalità
dell’intervento terapeutico rispetto al caso clinico al quale esso si rivolge. È stata la diffusione di certi
strumenti ed interventi a sfumare la connotazione della loro straordinarietà e a richiedere una
distinzione articolata sulla proporzionalità delle terapie che devono essere applicate in casi specifici.
Ecco allora che un mezzo ordinario, secondo la distinzione del Pontefice, potrebbe essere
sproporzionato al risultato che da esso ci si attende, soprattutto quando rivolto a pazienti ormai
prossimi alla fine della vita (è ad esempio il caso della somministrazione di chemioterapici a pazienti
oncologici con ridottissima aspettativa di vita, o l’impiego della rianimazione in quegli stessi
pazienti).3
Un altro riferimento si impone, e riguarda l’impiego dell’analgesia. Nel 1956 Pio XII era
intervenuto sul tema,4 affermando la liceità del ricorso agli analgesici e agli anestetici durante gli
interventi chirurgici. La giustificazione per il loro impiego è fondata sulla capacità dell’anestesiologia
di combattere effetti nocivi di ostacolo al raggiungimento di un bene più grande. Questi mezzi messi a
disposizione della scienza non sono in se stessi immorali. La frase più significativa è la seguente: “Il
Cfr. Pio XII, Risposte ad alcuni importanti quesiti sulla ‘rianimazione’, in Discorsi ai medici, Roma 1959, pp.
608-618: p. 612.
3
Per la distinzione tra mezzi terapeutici proporzionati e sproporzionati cfr. E. Sgreccia, Manuale di bioetica,
Milano 19942, p. 651.
4
Cfr. Pio XII, Tre quesiti religiosi e morali concernenti l’analgesia, in Discorsi ai medici, Roma, Edizioni
Orizzonte Medico, 1959, pp. 551-581.
2
3
dovere di rinuncia e di purificazione interiore, che incombe ai cristiani, non è un ostacolo all’impiego
dell’anestesia, perché si può compierlo in altro modo”.5 Ma il Pontefice aveva anche affermato che la
morale naturale e lo spirito del Vangelo non sono contrari alla narcosi che comporti una diminuzione o
soppressione della coscienza, purché ciò sia fatto nel rispetto di alcune condizioni. In particolare entra
qui in gioco la cosiddetta dottrina del duplice effetto, che riassumiamo brevemente. Affinché
un’azione con un duplice effetto, uno positivo ed un negativo, sia lecita è necessario che l’intenzione
del soggetto che compie l’azione deve essere quella di perseguire un effetto positivo per l’ottenimento
del quale non esistono mezzi alternativi a quelli scelti; l’effetto negativo non deve essere
intenzionalmente perseguito come fine dell’azione; deve esistere proporzione tra effetto positivo ed
effetto negativo.
Sulla scorta di queste osservazioni affrontiamo ora la riflessione sulla medicina palliativa.
La lunga strada verso il controllo del dolore
La necessità di tenere sotto controllo il dolore ed i sintomi che lo accompagnano si è manifestata
con vigore in tempi relativamente recenti. Esistono molteplici fattori che possono aver determinato
l’atteggiamento dei medici (e, di riflesso, dei pazienti) nei confronti del dolore e in qualche modo aver
a lungo ostacolato l’impiego di analgesici.
Tra tali fattori si possono menzionare:
1) La tendenza del medico a considerare il dolore come un elemento trascurabile, e comunque
destinato a scomparire con la guarigione del paziente. La lotta contro il dolore era quindi secondaria
rispetto allo sforzo finalizzato al recupero della salute. Questa visione del dolore ha rivelato
conseguenze nefaste nei casi di patologie per le quali la guarigione risultava impossibile - il caso della
malattia neoplastica terminale è in tal senso emblematico - e ha prodotto due diversi atteggiamenti del
personale sanitario nei confronti del paziente ‘senza speranze’: l’abbandono (“Non c’è niente altro da
fare”) - il paziente è lasciato solo con la propria malattia ed il dolore, in attesa che giunga la fine - e,
per contro, l’accanimento terapeutico.
2) Il ruolo positivo assegnato al dolore da certe tradizioni religiose. Si deve innanzitutto precisare
che è vero che la teologia cristiana valorizza il dolore, in special modo quello della fase terminale della
vita, carico di significato salvifico, ma è anche vero che, almeno secondo una dottrina esplicitata in
tempi piuttosto recenti, il dolore non acquista un valore elevato al punto di impedire il ricorso ai
farmaci per calmarlo. Il Pontefice Pio XII, nel già citato discorso rivolto agli anestesisti riuniti in
congresso a Roma nel 1957, aveva riconosciuto che il dolore può impedire il raggiungimento di beni
ed interessi superiori. Ed anche il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 ha fatto propria questa
visione, ammettendo la possibilità dell’uso di analgesici per alleviare la sofferenza del moribondo,
anche qualora ciò possa comportare un accorciamento del tempo che gli resta da vivere, purché la
morte non sia voluta né come fine, né come mezzo, ma sia soltanto prevista e tollerata come
ineliminabile. È questa la cosiddetta dottrina del duplice effetto.
3) I pregiudizi contro il ricorso alla morfina e suoi derivati. Il pericolo di assuefazione che può
derivare dall’uso di certi preparati utilizzati per alleviare il dolore ha costituito un forte ostacolo nel
garantire al paziente un adeguato trattamento del dolore. Tale ostacolo, ancora oggi, non sembra del
tutto rimosso ed anzi molto solido nel nostro Paese, secondo le statistiche europee relative all’uso di
morfina nell’ambito delle cure palliative.
4) L’atteggiamento di scarsa attenzione, se non di trascuratezza, che il personale sanitario ha
riservato ad una branca della medicina - talvolta giudicata come minore - che non si occupa della
guarigione dei malati, ma dell’accompagnamento verso la morte. Il pregiudizio nei confronti della
medicina palliativa si può facilmente osservare anche in ambiente non medico: i professionisti della
salute che operano in settori altamente specialistici della medicina (cardiochirurgia o trapianto degli
5
Ivi, p. 564-565.
4
organi, soltanto per fare due esempi) suscitano attenzione, ammirazione e rispetto perché salvano vite,
combattono e momentaneamente sconfiggono la morte. Davanti a tali successi, il medico che invece
accompagna un morente verso la fine della vita suscita un sentimento di sconfitta e frustrazione.
Ben si comprende allora come la strada verso un cambiamento culturale ed etico nei confronti
dell’eliminazione del dolore e della sofferenza sia stata lunga ed irta di difficoltà. Il passo più
significativo di questo processo è rappresentato dalla fondazione del primo hospice, il St.
Christopher’s Hospice: nel 1967 a Londra Dame Cicely Saunders, facendo tesoro di anni di esperienza
personale maturata nell’assistenza di pazienti terminali, creò un luogo in cui affrontare in modo
“rivoluzionario” i problemi del malato terminale. Sotto il profilo organizzativo generale l’hospice è
differente dall’ospedale e dalle case di cura e non rappresenta soltanto un luogo destinato ad ospitare
ed assistere morenti; capacità e conoscenze mediche specifiche di medici, infermieri, psicologi ed
operatori sanitari in generale sono combinate con attività prestate da figure non professionali
(assistenti spirituali e sociali, volontari, amici e familiari del paziente). L’assistenza offerta dallo
hospice si estende alla famiglia del malato, mediante il supporto psicologico fornito durante le fasi
della malattia del congiunto e dopo il suo decesso.
Questa idea rivoluzionaria di affrontare i diversi problemi, non soltanto strettamente medici,
generati dalla malattia terminale ha costituito il nucleo del cosiddetto hospice movement, il quale, in
uno spazio di tempo relativamente breve - circa venticinque anni -, ha diffuso a livello internazionale
il modello delle cure palliative.
La sfida delle cure palliative
Dall’esperienza di Dame Saunders è scaturito un modello di assistenza che può essere erogato
nell’hospice, oppure - se le circostanze lo permettono - presso il domicilio del paziente, o il reparto
ospedaliero in cui questi dovesse essere ricoverato: cambiano i luoghi, ma resta salda la necessità di
rispondere al dolore totale (total pain) del paziente con un piano di assistenza totale (total care) offerta
da una équipe preparata. ‘Dolore totale’ è un’espressione utilizzata da Dame Saunders per indicare una
condizione di dolore che coinvolge il malato in tutte le sue dimensioni: fisica, psicologica, spirituale,
relazionale. La risposta a tale condizione è possibile soltanto mediante un approccio olistico al dolore
(questo è appunto ciò che, in concreto, il total care prevede), un intervento personalizzato, nel senso di
creato su misura per il paziente, che assume un ruolo centrale nel rapporto con i componenti
dell’équipe; questi cooperano con il malato e la sua famiglia in vista del raggiungimento di un fine
ultimo: la morte serena del paziente, attraverso l’eliminazione del dolore e della sofferenza.
Nella letteratura dedicata al tema, con una certa frequenza si può leggere che le cure palliative
rappresentano una sfida al modello tradizionale della medicina, per l’importanza attribuita al dolore e
alla sofferenza, nonché al paziente che deve ricevere i trattamenti, chiamato a discuterne l’efficacia
con l’équipe che lo assiste. Le cure palliative sono però una sfida anche in un altro senso. Nel contesto
di un’etica medica improntata al paternalismo, giunta a noi da una tradizione secolare, il medico era
l’unico soggetto in grado di compiere scelte per il bene del paziente e questo “bene” è sempre stato la
salute: il medico sapeva ciò che il malato doveva fare per riacquistare la salute e il malato sapeva che
per questa ragione doveva obbedire agli ordini del medico. Tale visione ha a lungo condizionato il
rapporto tra il medico ed il paziente e tra il medico e il personale incaricato dell’assistenza
infermieristica, ma ha iniziato ad incrinarsi quando è divenuto chiaro che esistono patologie di fronte
alle quali il medico è impotente e la guarigione impossibile. In tali situazioni, in vista di che cosa potrà
operare il medico?
Per la medicina palliativa, il malato inguaribile non è una sconfitta, alla quale si risponde con
l’abbandono o con l’accanimento terapeutico, ma una sfida: attraverso una sinergia tra paziente e
soggetti coinvolti nell’assistenza, si opera per ottenere il miglioramento della qualità della vita nella
fase conclusiva dell’esistenza. Sarà il malato a stabilire, in base ai propri valori e credenze, quale
livello di qualità della vita ritiene adeguato e, di conseguenza, ad orientare l’équipe nella scelta dei
5
trattamenti. Il rispetto della dignità del paziente, un individuo con valori e bisogni personali, diventa
fondamentale nel contesto di applicazione delle cure palliative.
Nel quadro ora sinteticamente descritto, sembrerebbero non esistere conflitti o contrasti di natura
etica: il rispetto della dignità umana e una relazione basata sulla comunicazione tra malato e chi
condivide con lui l’esperienza della malattia terminale producono l’impressione di armonia di intenti
in vista del raggiungimento di un fine.
In realtà, le cure palliative danno luogo a complessi quesiti morali. La terapia del dolore genera
effetti collaterali, come l’accelerazione del processo di morte, o l’ottundimento della coscienza del
malato, conseguenti alla necessità di incrementare il dosaggio di analgesici; talvolta, per evitare che il
paziente continui a percepire dolore, può essere necessario ricorrere alla sedazione, che accompagna il
malato fino alla fine della vita. Si può sostenere che tali procedure sono moralmente lecite? Il dovere
di lenire il dolore si può spingere fino al punto di produrre così significativi effetti collaterali?
Il ricorso alla dottrina del duplice effetto e al consenso informato prestato dal paziente possono
fornire una possibile risposta. La dottrina del duplice effetto è frutto di una distinzione teorica la quale
sta ad indicare che, quando un’azione, definibile come buona in rapporto al suo oggetto, può
raggiungere un effetto buono solo causando un danno incidentale ma inevitabile, l’atto è lecito e può
essere realizzato a condizione che il danno non sia né il mezzo per raggiungere l’effetto buono, né il
fine dell’azione. La distinzione tra ciò che si produce come effetto collaterale di una azione
intenzionale e lo scopo primario dell’azione è dunque fondamentale per valutare la liceità dell’azione
in questione. Un esempio può essere di aiuto: alleviare il dolore (l’oggetto dell’azione) è in sé
moralmente lecito e a tale scopo si possono utilizzare farmaci che hanno effetti benefici. Tuttavia tali
effetti sono accompagnati da altri negativi ineliminabili (l’accelerazione del processo di morte). Se gli
effetti negativi non sono intenzionalmente perseguiti, non costituiscono né il mezzo per il controllo del
dolore, né il fine dell’azione, allora quell’azione è moralmente lecita.
E’ facilmente intuibile che la dottrina del duplice effetto può essere bersaglio di critiche, dal
momento che è arduo stabilire l’intenzione con cui è compiuta l’azione, se per alleviare il dolore o
accelerare il processo di morte. Per questo motivo, con sempre maggiore frequenza, soprattutto nella
letteratura statunitense, si ricorre alla nozione di consenso del paziente per affrontare il tema della
liceità di certi trattamenti palliativi. Il consenso informato all’atto medico, emerso da un
cambiamento dei presupposti sui quali si fondava la relazione tra medico e paziente, ha acquistato la
funzione di strumento di tutela del malato e rivela in pieno la propria importanza nel contesto delle
cure palliative. In tale ambito, il consenso del paziente scaturisce al termine di un processo decisionale
durante il quale l’équipe ha esposto e discusso diverse modalità di controllo del dolore con le relative
implicazioni, il malato e la sua famiglia le hanno messe a confronto con i valori e le necessità del
momento, e tutti insieme hanno raggiunto un accordo sui procedimenti da mettere in atto.
Le cure palliative e l’eutanasia
Si è detto che le cure palliative possono rappresentare un’alternativa all’abbandono e
all’accanimento terapeutico, ma come possono essere pensate in rapporto all’eutanasia (ci riferiamo di
seguito al caso dell’eutanasia attiva volontaria)? Dall’analisi della letteratura bioetica emerge che le
cure palliative possono essere:
1) un’efficace alternativa alla ricerca dell’aiuto per morire;
2) un momento importante di un piano di assistenza che però non esclude l’eutanasia;
3) una risposta ai bisogni di alcuni pazienti, che però non elimina del tutto il problema
dell’eutanasia, soprattutto se quest’ultima è concepita come un’espressione dell’autonomia individuale
del malato.
La prima risposta proviene dai sostenitori delle cure palliative, esponenti dell’hospice movement e
pensatori di ispirazione religiosa e no; per essi la finalità intrinseca delle cure palliative è tale da
escludere la possibilità dell’eutanasia, soprattutto in ragione del fatto che la domanda di aiuto a
concludere la propria esistenza per sfuggire al dolore e al disagio complessivo che lo accompagna è
6
formulata da malati non adeguatamente assistiti, ed essa viene meno quando sono rimosse le cause che
l’hanno provocata. Ci sono poi alcuni casi di pazienti che decidono di togliersi la vita seppure
ricevano terapie palliative efficaci. È ad esempio riportato in una ben documentata tesi6 che talvolta
alcuni pazienti decidono in questo senso per cercare di controllare la propria vita o quello che ne resta.
Per ciò che concerne il secondo punto, è invece interessante notare come gli Stati che l’hanno
disciplinata (i Paesi Bassi sono un esempio), ammettono l’eutanasia quando le cure palliative mostrano
di aver fallito il loro scopo: in tali Stati sono state approvate leggi che contengono linee guida alle
quali il medico si deve attenere per dare seguito alla richiesta del malato di essere aiutato a morire.
Il terzo punto è più complesso ed in genere si riferisce al caso specifico di un malato che decide di
rifiutare i trattamenti palliativi, chiede di morire e pretende l’aiuto del medico per porre fine alla
propria vita. Si può accettare la sua richiesta? Il tentativo di risposta deve passare attraverso il vaglio
dell’analisi etica e di quella giuridica. Sotto il profilo etico esistono differenti teorie che, in modo quasi
paradossale in nome degli stessi principi, ad esempio il rispetto dell’autonomia personale, rifiutano o
ammettono la liceità dell’atto eutanasico, la quale pertanto non si può dare per scontata. Una differente
concezione della vita umana, ritenuta un bene intangibile ed indisponibile o, al contrario, un bene di
cui l’essere umano può disporre a piacimento, contribuisce in parte a spiegare i differenti esiti
raggiunti. Il discorso è comunque assai complesso.
In conclusione possiamo sottolineare alcuni elementi che riteniamo degni di nota. In nome del
rispetto dell’autonomia personale, alcuni pensatori ritengono che l’influenza del contesto in cui è
formulata la domanda di essere aiutati a morire non sia marginale, e meriti più attenzione di quanta,
solitamente, si presta a questo aspetto del problema: l’insufficienza o l’inadeguatezza degli interventi
palliativi; l’invalidità prodotta da patologie croniche che potrebbe rendere gravoso al paziente chiedere
il sostegno economico, emotivo, psicologico della propria famiglia; l’estrema indigenza ed
emarginazione. Si tratta di fattori che potrebbero influenzare le decisioni del malato ed impedire la
realizzazione di una scelta autenticamente autonoma alla fine della vita. Il soggetto deciderebbe di non
continuare a vivere perché non trova altro modo per sfuggire alle circostanze in cui si trova: ha una
sola possibilità e tale possibilità è costituita dall’eutanasia.7
La riflessione bioetica non sempre dà adeguata importanza al contesto in cui è presa una decisione,
in nome di una separazione tra problema etico e problema sociale. Se la bioetica, per sua natura,
intende affrontare i problemi di fine vita in modo multidisciplinare, non può certo prescindere da una
riflessione su aspetti sociali, culturali, o di politica sanitaria, sottesi alla domanda di essere aiutati a
morire.
Se le risposte etiche alla domanda sulla liceità dell’eutanasia sono molteplici, sotto il profilo
giuridico almeno in Italia, la situazione è invece più netta: nel nostro Paese l’omicidio del
consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio, le fattispecie previste dal codice penale rispettivamente
agli articoli 579 e 580 e traducibili con le bene note espressioni “assistenza (medica) al suicidio” e
“eutanasia attiva volontaria”, sono vietati e perseguibili con sanzioni che prevedono la reclusione.
Cfr. C. Moretti, Competenze infermieristiche nell’accompagnamento del paziente morente, Tesi di diploma in
scienze infermieristiche, Università degli Studi di Torino, a.a. 2000/2001. L’autrice dà notizia di alcuni casi di
suicidio verificatisi tra pazienti terminali sottoposti a cure palliative e seguiti da una équipe della Lega per la
Lotta contro i Tumori della provincia di Sanremo in Liguria.
7
È questa la tesi di una pensatrice statunitense, Susan Wolf: cfr. in merito S. Wolf, Gender, Feminism, and
Death. Physician-Assisted Suicide and Euthanasia, in S. Wolf (ed.), Feminism and Bioethics: Beyond
Reproduction, New York-Oxford 1996, pp. 282-317 e l’analisi che di esso è proposta nell’articolo di R. Barcaro,
P. Becchi, Differenza di genere, differenza di cura?, in “Annali di Studi Religiosi”, 4, 2003, pp. 23-41.
L’incidenza di morte a seguito di eutanasia o assistenza al suicidio di pazienti di sesso femminile di età superiore
a 55 anni, colpite da cancro o malattie croniche e rivoltesi al tristemente noto Jack Kevorkian (lo statunitense
Dottor Morte), è stata oggetto di uno studio che ha dimostrato come trattamenti inadeguati per il controllo del
dolore, isolamento e disperazione prodotta dalla solitudine siano stati fattori determinanti nella decisione di porre
termine alla vita: cfr. L.A. Roscoe et al., Antecedents of Euthanasia and Suicide Among Older Women, in
“Journal of the American Medical Women’s Association”, 58, 2003, pp. 44-48.
6
7
Questa risposta introduce una nuova domanda: si dovrebbe procedere all’approvazione di una legge
che garantisca l’opzione dell’eutanasia a quanti la chiedano, nel rispetto di linee guida simili o
identiche a quelle contenute in legislazioni attualmente vigenti, come ad esempio quella dei Paesi
Bassi, che ammette l’eutanasia come extrema ratio dopo il fallimento delle cure palliative? Non si può
esaurire la questione in poco spazio. Tuttavia siamo del parere che una legge di tale genere non
aiuterebbe i malati terminali, o almeno non tutti, dal momento che l’opzione eutanasica potrebbe
essere accolta come scorciatoia (magari subdolamente) dettata ed imposta dal razionamento delle
risorse sanitarie o dalle “necessità” familiari e sociali quotidiane.
Il divario tra ciò che si potrebbe fare per alleviare il dolore e ciò che in realtà viene fatto è ancora
troppo ampio, e rischia di diventare incolmabile se non si attuano interventi, ad esempio, per
potenziare le prestazioni di medicina palliativa, incrementare la formazione del personale preposto alla
loro erogazione e dare ai cittadini le informazioni necessarie per ottenere tale tipo di assistenza. Da
tempo gli operatori di cure palliative stanno lavorando in questa direzione: lo testimoniano l’attività di
fondazioni ed associazioni diffuse sul territorio nazionale (purtroppo con una maggiore concentrazione
al Centro-Nord), ed anche il Comitato Nazionale per la Bioetica, in più occasioni discutendo le
questioni di fine vita (in particolare con i documenti del 1995 e del 2001), ha recepito l’importanza
morale di alleviare dolore e sofferenza in nome della dignità dell’essere umano e di rendere
gratuitamente disponibili le terapie antalgiche ai pazienti morenti.
La scelta di questa via è sicuramente più faticosa, più dispendiosa sotto il profilo economico,
sociale, politico, ma può dare luogo ad un approccio diverso alle questioni di fine vita, autenticamente
rispettoso di valori e visioni culturali e religiose differenti che si incarnano nell’esistenza di ogni
essere umano.
Bibliografia
R. Barcaro, Dignità della morte, accanimento terapeutico ed eutanasia, Napoli 2001
R. Barcaro, P. Becchi, Differenza di genere, differenza di cura?, in “Annali di Studi Religiosi”, 4,
2003, pp. 23-41
P. Becchi, Questioni vitali. Eutanasia e clonazione nell’attuale dibattito etico, Napoli 2001
P. Borsellino, Bioetica tra autonomia e diritto, Milano 1999
Comitato Nazionale per la Bioetica, Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Roma, 14 luglio 1995
Id., La terapia del dolore: orientamenti bioetici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 30
marzo 2001
Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione sull’eutanasia (5.5.1980), in P. Verspieren (a
cura di), Biologia, medicina ed etica. Testi del Magistero Cattolico, Brescia 1990, pp. 476-483
Pio XII, Discorsi ai medici, Roma 1959
M. Reichlin, L’etica e la buona morte, Torino 2002
L.A. Roscoe et al., Antecedents of Euthanasia and Suicide Among Older Women, in “Journal of the
American Medical Women’s Association”, 58, 2003, pp. 44-48
E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Milano 19942
S. Spinsanti, La terapia del dolore e l’etica della sofferenza, in L. Battaglia, G. Macellari, Bioetica
chirurgica e medica, Noceto (PR) 2002, pp. 105-116.
S. Spinsanti, F. Petrelli, Scelte etiche ed eutanasia, Milano 2003
S. Wolf, Gender, Feminism, and Death. Physician-Assisted Suicide and Euthanasia, in S. Wolf (ed.),
Feminism and Bioethics: Beyond Reproduction, New York-Oxford 1996, pp. 282-317
8