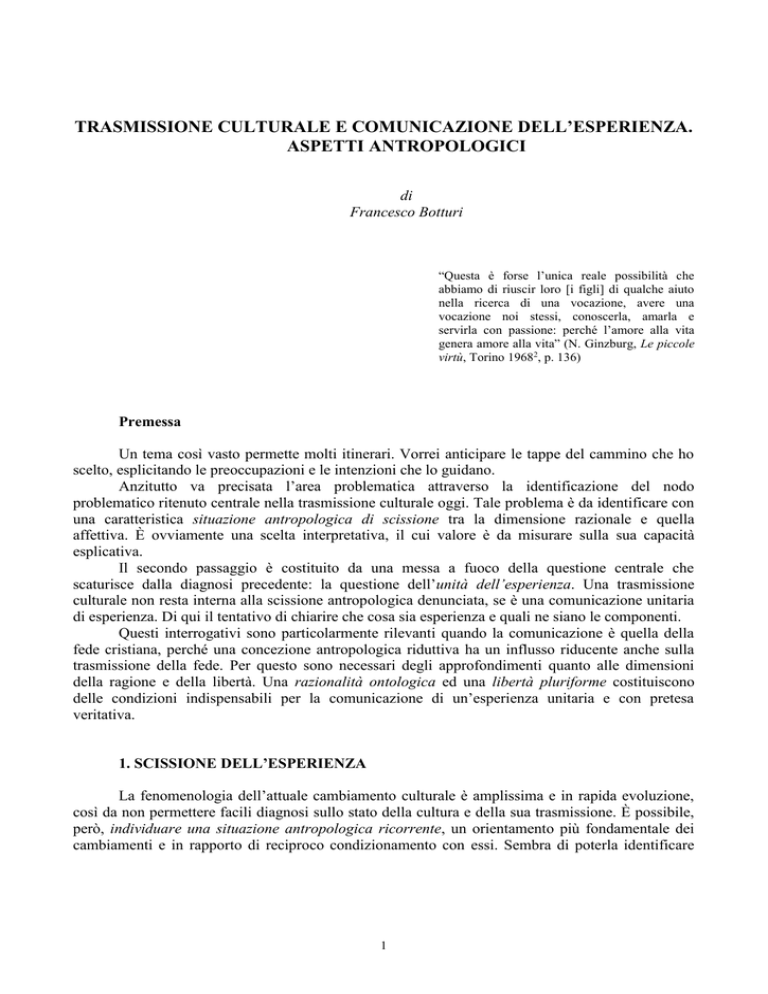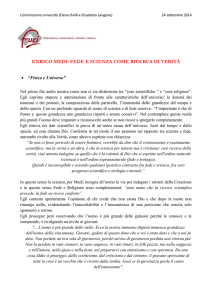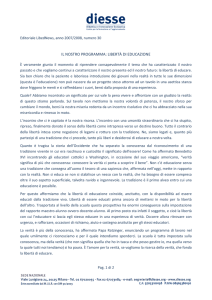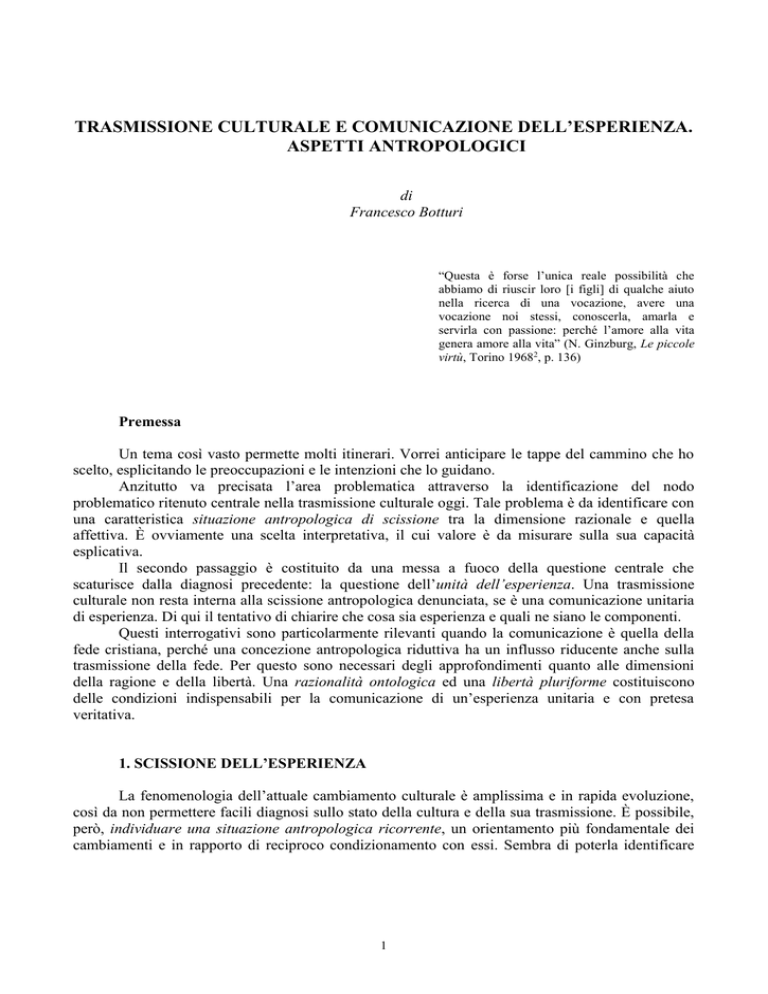
TRASMISSIONE CULTURALE E COMUNICAZIONE DELL’ESPERIENZA.
ASPETTI ANTROPOLOGICI
di
Francesco Botturi
“Questa è forse l’unica reale possibilità che
abbiamo di riuscir loro [i figli] di qualche aiuto
nella ricerca di una vocazione, avere una
vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e
servirla con passione: perché l’amore alla vita
genera amore alla vita” (N. Ginzburg, Le piccole
virtù, Torino 19682, p. 136)
Premessa
Un tema così vasto permette molti itinerari. Vorrei anticipare le tappe del cammino che ho
scelto, esplicitando le preoccupazioni e le intenzioni che lo guidano.
Anzitutto va precisata l’area problematica attraverso la identificazione del nodo
problematico ritenuto centrale nella trasmissione culturale oggi. Tale problema è da identificare con
una caratteristica situazione antropologica di scissione tra la dimensione razionale e quella
affettiva. È ovviamente una scelta interpretativa, il cui valore è da misurare sulla sua capacità
esplicativa.
Il secondo passaggio è costituito da una messa a fuoco della questione centrale che
scaturisce dalla diagnosi precedente: la questione dell’unità dell’esperienza. Una trasmissione
culturale non resta interna alla scissione antropologica denunciata, se è una comunicazione unitaria
di esperienza. Di qui il tentativo di chiarire che cosa sia esperienza e quali ne siano le componenti.
Questi interrogativi sono particolarmente rilevanti quando la comunicazione è quella della
fede cristiana, perché una concezione antropologica riduttiva ha un influsso riducente anche sulla
trasmissione della fede. Per questo sono necessari degli approfondimenti quanto alle dimensioni
della ragione e della libertà. Una razionalità ontologica ed una libertà pluriforme costituiscono
delle condizioni indispensabili per la comunicazione di un’esperienza unitaria e con pretesa
veritativa.
1. SCISSIONE DELL’ESPERIENZA
La fenomenologia dell’attuale cambiamento culturale è amplissima e in rapida evoluzione,
così da non permettere facili diagnosi sullo stato della cultura e della sua trasmissione. È possibile,
però, individuare una situazione antropologica ricorrente, un orientamento più fondamentale dei
cambiamenti e in rapporto di reciproco condizionamento con essi. Sembra di poterla identificare
1
con un tipo umano sempre più caratterizzato dalla scissione tra la sua razionalità calcolante
(tecnologico-scientifica) e il suo vissuto affettivo ed emotivo.
Si tratta di una frattura che si configura diversamente, secondo i diversi livelli sociali e
culturali, ma che ormai caratterizza universalmente l’esperienza comune ed è particolarmente
visibile nello stile di vita giovanile. Basti pensare a quanto sono consuete nella mentalità corrente
opposizioni e compensazioni come oggettivo/soggettivo; pubblico/privato; razionale/religioso;
funzionale/affettivo; calcolabile/emotivo; rigoroso/erotico; ecc. 1 Molte situazioni esprimono
qualcosa di questa situazione: l’organizzazione tecnologica della vita schiaccia e mortifica l’attesa
affettiva della gente (solitudine ed emarginazione); ma anche, il desiderio della privata
soddisfazione piega a sé la potenza tecnologica: la tecnologia diviene allora la dea realizzatrice di
tutti i desideri (come appaiono - ad esempio - le biotecnologie nell’immaginario collettivo);
l’esistenza lavorativa è vissuta come cosa opaca, oppressiva e senza gusto, mentre la vita affettiva è
concepita come sua immagine speculare e quindi mondo raffinato senza regola, nomade e
gratificante oppure erotismo volgare nella forma dello sfogo compensatorio e del commercio di
massa; ecc.
Da questo punto di vista la recente ricerca di F. Garelli sulla sessualità giovanile2 offre dei
dati molto significativi, che non vanno interpretati anzitutto in termini morali, ma appunto
antropologici. La rivoluzione sessuale rispetto al costume tradizionale è ormai un fatto compiuto: ha
portato a uno spostamento generalizzato dei confini del lecito riconosciuto, ma non per questo
comporta libertinismo e sregolatezza come tali. La sessualità è comunque vissuta anche come
ricerca dell’affetto e dell’amore solidale. Ma ciò che a mio parere impressiona è che questo mondo
del sesso e degli affetti è vissuto e concepito come un regno il cui sovrano assoluto è il sentimento.
Sentire, sentirsi, sentire l’altro, provare certe emozioni, accedere ad una certa intensità di sensazioni
e di empatia sono i criteri dominanti. Più volte l’Autore osserva che l’intesa ideale, la condivisione
di una qualche visione della vita non sono elementi rilevanti ai fini dell’intesa tra i sessi, anche per
coloro che hanno come aspirazione la stabilità del vincolo affettivo. Molto significativa diventa
allora la contrapposizione, che emerge dalle interviste, tra lo spontaneismo vissuto e fortemente
ricercato nella relazione erotica e la programmazione preoccupata e oculata della
paternità/maternità. In altri termini, la vita sessuale è consegnata ad una spontaneità senza ragione;
la ragione appartiene ad un registro vitale diverso e separato e quando interviene, ha la figura di una
razionalità calcolante e programmatrice. A queste condizioni le conseguenze sulla stabilità dei
rapporti affettivi sono facilmente immaginabili, ma anche quelle sul vissuto della generazione e
della famiglia, giustapposto a quello della sessualità come oggetto di una sorta di ponderazione
tecnologica. Dunque, se ci sono spontaneità e gratuità, si accompagnano a irragionevolezza e
irrazionalità; se ci sono razionalità e responsabilità, vuol dire che c’è calcolo.
Altri due esempi simmetrici possono aiutarci a comprendere intuitivamente il problema: la
questione sociale dell’AIDS e la questione istituzionale del matrimonio (e quindi della famiglia).
Si può sorprendere la denuncia di questa condizione culturale di sfondo, ad esempio, nell’idea di “sistema di
complementarità dell’ideologia occidentale” di K.O. APEL, che vede appunto come caratteristica della nostra
situazione culturale e filosofica una “combinazione [di ascendenza weberiana] d’indagine avalutativo-razionale delle
conseguenze e di decisione irrazionale di valore”, che pone la razionalità avalutativa scientifico-tecnologica come
paradigma del sapere e riduce ogni ambito valutativo (atti esistenziali, morale, religione) a faccenda privata (Il
problema della fondazione di un’etica della responsabilità nell’epoca della scienza, in E. BERTI (a cura di), Tradizione
e attualità della filosofia pratica, Marietti, Genova 1988, pp. 18 e 21. Oppure all’analisi che A. MACINTYRE fa nei
primi tre capitoli di Dopo la virtù. Saggio di teoria morale (tr. it. Feltrinelli, Milano 1988) dell’“emotivismo”
contemporaneo come residuo antropologico della razionalità pubblica tecnico-scientifica.
2
F. GARELLI, I giovani, il sesso, l’amore, Il Mulino, Bologna 2000 (la ricerca è stata svolta nel 1997).
1
2
Nel primo caso è di macroscopica evidenza che il suo problema sociale è costituito dal
comportamento e dalla sua regolazione di natura morale: la possibilità biologica del contagio esiste,
ma la sua realtà epidemiologica dipende dal comportamento sessuale (così come altre malattie
infettive sono state epidemiologicamente rilevanti a motivo di certi comportamenti, ambientale,
igienico, alimentare, ecc.). Un’elementare deduzione vorrebbe che se ne combattesse la diffusione
attraverso il mutamento dei comportamenti (come è stato per altre malattie infettive, come la TBC);
eppure le uniche strategie “pubblicizzate” - cioè oggetto di dibattito pubblico accettato - sono di
tipo tecnico-scientifico (contraccezione e terapie). Il motivo è semplice: la questione
comportamentale riguarda un vissuto privato in-discutibile e un patrimonio emotivo sottratto a
regole e criteri oggettivabili. Simmetricamente, il matrimonio ha evidentemente rilevanza sociale e
implicazione istituzionale e questo dà obiettivamente alla famiglia fondata sul matrimonio un
significato pubblico specifico (indipendente dalle motivazioni soggettive); eppure il livello
etico-giuridico fatica ad essere oggetto di discussione pubblica, mentre l’unico argomento
continuamente “pubblicizzato” è quello dei sentimenti soggettivi, presentati come la materia che
pretende comunque riconoscimento giuridico e protezione legale senza possibilità di discussione dei
valori sociali implicati.
Tutto ciò significa che la razionalità è concepita come un freddo potere analitico e
organizzatore, mentre l’affettività (vissuta sempre più a livello emotivo: sentire e sentirsi) è
avvertita come la relazione calda con gli altri e con il mondo, ma al di fuori dell’orizzonte della
ragione 3 . Insomma, l’organizzazione tecnologica del mondo ha come sua compensazione il
massimo spontaneismo affettivo e una sorta di culto dell’intensità (che facilmente passa all’eccesso
delirante o criminoso).
Una cultura cosiffatta è sintomaticamente in difficoltà ad affrontare le sfide morali del nostro
tempo con teorie etiche sufficientemente comprensive. Ancor più è una cultura che è
necessariamente muta sui grandi significati dell’esistenza umana (nascita ed educazione, amore e
lavoro, sofferenza e morte), perché non è in grado di affrontarli in una visione ragionevolmente
unitaria. Così, su ciò che più conta ciascuno è abbandonato alla sua spontaneità, cioè in realtà alla
solitudine e al conformismo. In sostanza si tratta di una cultura che è inevitabilmente nichilista,
indipendentemente e prima delle teorizzazioni nichiliste degli intellettuali, perché fondata sul puro
divenire dell’attività tecnologica e dei processi affettivi, al massimo tentata di trovare sintesi in un
ideale di potenza.
Il risultato antropologico non può essere che la frantumazione dell’esperienza e la difficoltà
della sua ricomposizione. L’identità soggettiva degli individui in queste condizioni è incerta,
fragile, sofferente oppure parziale e aggressiva e le relazioni sono instabili, idolatrate e odiate
insieme. Ciò è risentito particolarmente dal ceto giovanile e crea specifici problemi di trasmissione
di una tradizione culturale, famigliare, religiosa, ecc. Infatti, la scissione di cui stiamo parlando ha
come conseguenza l’impossibilità di offrire valori ampiamente comprensivi dell’esistenza, confini
certi tra i livelli della vita, regole ragionevoli di comportamento e di passaggio tra gli ambiti
dell’esperienza. Se le dimensioni antropologiche sono giustapposte e non comunicanti, è ben
difficile trasmettere, ricevere ed elaborare immagini unitarie dell’esperienza che la orientino con
stabile costruttività. Ma questa incertezza dei profili ha effetti deleteri sulla costituzione
dell’identità psichica, morale e spirituale di un giovane. È tipico che un giovane oggi “soffra” di un
3
Per una riflessione sul mondo degli affetti e la sua ermeneutica contemporanea mi permetto rinviare a F. BOTTURI,
Innamoramento e amore, in AA.VV., Alla ricerca delle parole perdute. La famiglia e il problema educativo, Piemme,
Casale Monferrato 2000, pp. 54-76.
3
permissivismo (quanto a proposte, direttive, limiti) che lo disorienta e che perciò sia indotto a
riprodurre e perpetuare con il suo comportamento quello stato di scissione di cui già è vittima.
2. POSTMODERNITÀ E DEREALIZZAZIONE
Non c’è da meravigliarsi che questo sia il problema centrale della cultura della modernità
avanzata e della postmodernità, a motivo del prevalere in essa del potere tecnologico come
principio di organizzazione della vita collettiva. La tecnostruttura infatti induce socialmente la
rappresentazione della razionalità tecnico-scientifica come paradigma della razionalità, mentre per
contraccolpo tende a rinchiudere in un mondo a parte, per definizione a-razionale, tutto ciò che non
le appartiene. Si delinea così un mondo - quello degli “affetti” in senso lato - che ha caratteri
opposti a quello della tecnostruttura, ma che proprio per la sua contrarietà fa sistema con l’altro e gli
è complementare; offrendo a chi ha adeguati strumenti di potere di gestire ampiamente mente e
cuore delle gente: divide (mentes et corda) et impera!4
Questo rende comprensibile perché il quadro complessivo della cosiddetta società
postmoderna appare caratterizzato sociologicamente da una anomia cronica, cioè da uno stato di
diffuso disorientamento circa i riferimenti essenziali dell’esistenza individuale e della convivenza
sociale, che spiega anche il risorgere di fenomeni di segno contrario, quali l’integralismo religioso o
nazionalistico oppure arroccamenti particolaristici, localistici o settari. Tutte forme reattive, in cui si
esprime una ricerca di assolutizzazione e di rassicurazione altrimenti mancanti5.
Questa deficienza di riferimenti unificanti porta con sé un fenomeno di sfondo altamente
significativo per la nostra riflessione, quella che è stata chiamata la “de-realizzazione
dell’esperienza”6. Non si tratta solo dell’effetto sull’esistenza dell’invasione da parte dei mezzi di
comunicazione sociale, che abituano a scambiare per realtà effettuale un mondo immaginario
artefatto, cioè a sostituire “simulacri” di esperienza all’esperienza effettiva 7 . La derealizzazione
4
Per aggravare il senso del problema mi permetto di suggerire anche un inconsueto punto di riferimento, il nazismo.
Ritengo che esso sia stato la coscienza massima di questo problema della modernità avanzata. In questo senso il
nazismo fu un lucido progetto di soluzione del rapporto di “tecnologia” e “affetti”: il regime nazionalsocialista si fondò
sulla promozione di una tecnologia avanzatissima e di forte impatto sociale e insieme sulla suscitazione di energie
vitalistiche e telluriche, da stringere nel cerchio di ferro e di fuoco della totalità politica, sostenuta a sua volta
dall’ideologia razzista. Ma è chiaro che l’irrazionalità della sua ideologia fu copertura della lucida e spietata razionalità
del progetto fondamentale (va riletta in questo senso l’opera di E. Jünger). Perciò caduto il regime politico totalitario,
resta di perfetta attualità il problema sociale e culturale che il nazismo volle risolvere. In che misura le società
democratiche lo hanno risolto a loro volta? Gestendo la tecnostruttura e lasciando allo sbando il mondo degli affetti?
Gestendo con subdola complementarità l’in-coerenza tra i due mondi? Le culture dei paesi democratici dell’occidente
hanno saputo elaborare risposte adeguate a fronteggiare culturalmente l’antiumanesimo totalitario sconfitto
militarmente e politicamente? O si sono legittimate a questo livello per il solo motivo (tautologico) di essere
democratiche? Fino a che questo problema non sarà veramente affrontato, non ci si potrà meravigliare che germi
totalitari circolino nella cultura occidentale e nelle viscere della sua sempre più potente tecnostruttura.
5
Cfr. ad esempio F. CRESPI, Evento e struttura. Per una teoria del mutamento sociale, Il Mulino, Bologna 1993.
6
Cfr. S. MARTELLI, Sociologia dei processi culturali. Lineamenti e prospettive, La Scuola, Brescia 1999, p. 146. La
“de-realizzazione dell’esperienza” significa “liquidazione della realtà come referente della comunicazione” (p. 217) e insieme con la “de-secolarizzarione” (o ritorno distorsivo al sacro) e la “de-politicizzazione” - costituisce uno dei
caratteri fondamentali, secondo l’Autore, dei processi sociali e culturali della società postmoderna.
7
Come dice M. PERNIOLA, un “simulacro” è “un’effettività sociale priva di origine” (La società dei simulacri,
Cappelli, Bologna 1983, p. 53) e la società postmoderna si caratterizza per la sua capacità (tecnica e ideologica) di
trasformare le immagini in simulacri che producono effetti non perché siano rivelative di una realtà che le trascende, ma
con il loro solo esistere.
4
dell’esperienza è qualcosa di più profondo, perché è conseguenza della precarietà dell’identità
psicologica e culturale degli individui, incapaci di essere centro più che emotivo di unificazione
della propria esistenza e di essere veri soggetti del loro vivere piuttosto che di “essere vissuti” da
processi e standards sociali esterni. Ciò che è in gioco è perciò la capacità di compiere realmente
esperienza e per questo la trasmissione culturale oggi fa problema (come mostrano in modo
paradigmatico le questioni aperte dell’educazione e della scuola). Infatti, se per “cultura” si intende
un sistema interpretativo della realtà, allora è la stessa ermeneutica contemporanea a ricordarci che,
perché un simile processo avvenga, non basta una trasmissione di un contenuto informativo e
neppure quella di un complesso dottrinale, ma anche la suscitazione e la condivisione di un intero
orientamento antropologico, di sensibilità affettive, di capacità immaginative e intellettuali, di
attitudini pratiche. In altri termini, c’è trasmissione culturale, quando c’è un coinvolgimento
antropologico complessivo, razionale ed affettivo, e quindi sono messi in gioco modi antropologici
multipli (informazione e dialogo, insegnamento e narrazione, gesto ed ethos, ecc.). In sintesi, la
trasmissione culturale esige, per essere veramente tale, eventi e processi di comunicazione, che dal
punto di vista antropologico significa appunto “communis actio”, interazione, legame, scambio.
Più precisamente, nell’attuale situazione di divisione culturale tra ragione ed emozione, non
si può dire che non avvenga una trasmissione culturale. Anzi, il coinvolgimento antropologico è
fortemente perseguito, soprattutto dai mezzi della comunicazione di massa (tanto da mettere in crisi,
appunto, le cosiddette agenzie tradizionali della trasmissione culturale e dell’educazione, famiglia e
scuola). Il problema è che si tratta di una cultura della divisione e quindi di una trasmissione di una
rappresentazione scissa dell’uomo che distrugge l’unità dell’esperienza e le sue condizioni e che
chiede una partecipazione comunicativa coinvolgente ma anche escludente tutto ciò che non le è
funzionale (eros arazionale o ragione tecnico-scientifica senza valori).
3. TRASMISSIONE E RICOMPOSIZIONE DELL’ESPERIENZA
Questa lunga diagnosi è stata necessaria per entrare con sufficiente senso drammatico nel
nostro problema e per rendersi più conto di quanto sia impegnativo oggi avviare processi di
trasmissione culturale che siano comunicazione di un’esperienza diversa e alternativa da quella
postmoderna nichilista. Evidentemente bisogna praticare e far appello ad un’antropologia d’altro
orientamento, in cui permanere con chiarezza e decisione, pena l’essere riassorbiti, anche contro le
migliori intenzioni, dal regime culturale prevalente. Questo è oggi particolarmente vero per la
comprensibilità della fede e per la vicenda formativa che ne scaturisce.
Se, infatti, è vero che questa situazione antropologica di sfondo costituisce nel nostro tempo
il problema culturale principale, essa rappresenta anche la questione pastorale centrale, perché
decide del modo in cui l’annuncio è compreso e quindi può operare nella vita. È chiaro infatti che
questa condizione culturale coinvolge tutto e tutto condiziona. Anche la fede può essere recepita
all’interno di quella scissione, che predispone a percepirla o come astratta dottrina dogmatica o
morale (una specie di scienza o di tecnologia religiose della vita) oppure come emozione,
sentimento religioso, senso senza verità8. Allora il problema pastorale (e teologico) si configura con
Cfr. la critica (interessata) di FLORES D’ARCAIS Dio esiste?, in MicroMega 2 (2000): le fedi ridotte ad esperienza
soggettiva non sono niente di più che un “dado di senso per il brodo dell’esistenza” (p. 28). D’altra parte la stessa
enciclica Fides et ratio è mossa dalla preoccupazione per una concezione della fede senza verità, cioè di una
comprensione della fede depauperata delle sue implicazioni ontologiche (da cui l’attenzione dell’enciclica al ruolo della
filosofia).
8
5
una duplice difficoltà: se si segue la sensibilità culturale contemporanea, la fede trasmessa pare
ammissibile solo per qualche suo aspetto particolare (tipicamente quello etico o sociale); se invece
si dice la fede nella sua integrità totalizzante, sembra non essere più intelligibile, appunto perché la
percezione contemporanea dell’esistenza non è secondo il tutto, ma secondo il frammento.
Sembra, dunque, di essere in un vicolo cieco. Ma forse è possibile fare di necessità virtù,
cioè rendere la difficoltà un punto di forza. Le considerazioni che abbiamo introdotto ci vengono a
dire che la fede è culturalmente debole e incerta di fronte alla profonda trasformazione
antropologica contemporanea, nella misura in cui non è abbastanza consapevole della portata
antropologica e ontologica del suo contenuto. Che la fede annunci la verità significa che dice
dell’uomo la sua verità, la sua situazione ontologica reale, il come egli è veramente, entro ed oltre le
sue configurazioni storico-culturali, le sue fratture, le sue opposizioni, ecc. La fede porta un
giudizio sulla realtà umana che enuncia la verità, cioè che pretende dire all’uomo “come stanno
davvero le cose” e in particolare le “sue” cose. Il sapere della fede implica l’affermazione di
determinate strutture antropologiche, che sono anche filosoficamente intelligibili e che la fede
stessa coimplica e custodisce, tali che, sottratte, la privano del suo interlocutore e destinatario.
Queste dimensioni umane sono oggi in gran parte nascoste o, per così dire, trafugate, anche se non
per questo inattive nell’esperienza comune. Una loro forte consapevolezza è perciò indispensabile
per far fronte all’attuale situazione di dissipazione dell’esistenza9.
Aperto questo scenario, riempirlo tutto significherebbe delineare un intero trattato di
antropologia. È possibile qui indicare alcuni presupposti strategici di un processo di trasmissione
culturale cristiana, cioè la figura dell’esperienza, il senso della libertà e l’idea di ragione.
Al centro della nostra indagine sta dunque la figura dell’esperienza e ciò che la costituisce.
Esperienza significa fare esperienza, non nel senso d’essere complemento oggetto di un certo fare,
ma in quello d’essere una certa qualità dell’agire umano, che dipende dal soggetto che la compie.
D’altra parte fare esperienza non significa sperimentalismo, né nel senso razionalistico di fare
esperimenti controllabili, né in quello irrazionalistico di provare emotivamente, di accumulare senza
discernimento “esperienze”. Nella situazione antropologica scissa di cui si diceva risulta ovvio,
invece, che questi due siano i significati dell’esperienza, con la pretesa a volte che la loro somma
dia la figura completa dell’esperienza umana. Ideale della vita (come nella figura dell’uomo di
successo della corrente pubblicità) potrebbe essere perciò un lucido e distaccato sperimentalismo
che si concede a lato esperienze emotive coinvolgenti.
L’esperienza umana coincide invece con la vita stessa in quanto unificata e dotata di senso.
L’esperienza è il vissuto in quanto tale e in quanto significativo, cioè il vissuto in quanto presenta i
caratteri di una totalità unificata e dinamica, perché dotata di un principio di unificazione e di
apertura. Ma l’unità e l’apertura sono rese possibili dall’iniziativa di un criterio di senso capace di
9
Mi permetto un esempio che spero non risulti irriverente, ma piuttosto efficace. Se non vengono risvegliate certe
dimensioni antropologiche (prima come esperienza e poi come coscienza critica), il lavoro pastorale, pur ritenendosi
una gara di corsa in bicicletta, si limita ad essere, invece, un esercizio di “cyclette”: il veicolo è identico in tutto, meno
che nelle ruote, ovvero in ciò che facendo presa sul terreno permette un reale spostamento. Fuor di metafora, il
problema è far presa sull’umano, aderendovi perché possa prodursi in esso la comprensione della fede e il cambiamento
della conversione. Naturalmente, “far presa” non significa qui “far colpo”, ma intersecare l’umano e interagire con esso,
non così come limitativamente esso si percepisce, ma per quello che esso veramente è. D’altra parte questa evocazione
dell’umano autentico è già un primo momento della sua chiamata dalle “tenebre” alla “luce”.
L’alternativa - che non è raro purtroppo veder praticata - è una trasmissione tradizionale, fedele al contenuto letterale
della fede, ma non interpretato nella sua pertinenza antropologica e quindi estranea all’esistenza reale; oppure una
trasmissione “aggiornata” (oggi soprattutto su temi etici), ma dipendente da categorie esterne a quelle fondamentali
esigite dalla fede stessa.
6
ricongiungere attivamente ogni nuovo contenuto al già acquisito e capace anche di attendere un
sempre rinnovato compimento del senso. Quel criterio di senso è il medesimo della ragione e
perciò la ragione è condizione del costituirsi stesso dell’esperienza.
Se l’esperienza nel suo significato compiuto è dunque un vissuto sapiente e un sapere
vissuto, qual è il rapporto di esperienza e pensiero?
Si può sintetizzare il rapporto con tre figure. Anzitutto, tra esperienza e ragione vi è sempre
implicazione. Non si dà (possibilità di) esperienza senza pensiero e viceversa. L’idea di
un’esperienza che si costituisca senza l’intervento del pensiero ridurrebbe il vissuto a vitalismo, a
reazione meccanica, a emozione anomica. D’altra parte, il pensiero non può formularsi senza un
costante riferimento all’esperienza già costituita, che possiede una complessità di elementi
sensoriali e immaginativi, affettivi ed emotivi, linguistici e culturali che la ragione non si dà, ma di
cui ha bisogno per esercitarsi come tale. La reciproca implicazione dà luogo all’ulteriore figura
della circolazione tra ragione ed esperienza: quella è condizione di questa, ma questa induce quella.
La visione totalizzante del pensiero permette all’esperienza di strutturarsi, ma l’esperienza
strutturata sollecita il pensiero a domandare ulteriormente e quindi ad aprire nuovi spazi
all’esperienza stessa. In questo rapporto è implicita anche la reciproca trascendenza: la ragione è
sempre più dell’esperienza già acquisita e quindi ne costituisce anche la coscienza critica, mentre
l’esperienza è a sua volta un concreto che la ragione non può mai adeguare del tutto risolvendolo in
sé.
In sintesi, mentre l’empirismo materialistico vorrebbe fare del pensiero una appendice o una
semplice espressione dell’esperienza e l’idealismo sogna di poter possedere totalmente l’esperienza
con il pensiero e quindi in certo modo di risolverla in sé, vi è tra i due una dualità insuperabile al
modo di una feconda circolarità ermeneutica, che costituisce la normalità della condizione umana.
Infatti l’arresto di quella circolazione coincide con una condizione malata, come quando ci si blocca
in un pensiero fisso che non si lascia più mettere in discussione dall’esperienza oppure come
quando l’esperienza si abitua a ripetere se stessa senza più pensarsi.
Si fa esperienza, dunque, quando è possibile ricondurre ad unità di senso ciò a cui si va
incontro, ma si fa esperienza anche nella misura in cui è “mia” esperienza, quando cioè è implicata
l’identità e la coscienza di “chi” fa esperienza. La competenza di far esperienza e di esercitare il
pensiero non sono qualcosa che venga attribuito al soggetto, ma lo de-finiscono originariamente, nel
duplice senso di questo verbo. Il soggetto è insieme capacità originaria di far esperienza e di
pensarla, è cioè come tale capace di identità e di unità ed insieme è delimitato dal suo fare
esperienza, che è sempre finita e circoscritta. In altri termini c’è soggetto, perché c’è la potenza di
fare esperienza, ma non per questo c’è signoria sulla propria esperienza da parte del soggetto, che è
anche as-soggettato ad essa, perché non può non compiere esperienza (benché possa farla in modi
qualitativamente diversi) ed è vincolato ai suoi limiti. Si è dunque allo stesso tempo soggetti
dell’esperienza e soggetti all’esperienza.
Questa duplicità risulta ben visibile, se si considera il linguaggio dell’esperienza. Essa si
costituisce in interiore hominis, ma si compie veramente nel suo racconto. Innanzitutto e
fondamentalmente un’esperienza non la si dimostra dialetticamente, ma la si testimonia
raccontandola e il suo racconto è l’atto stesso con cui l’esperienza si costituisce compiutamente. Il
racconto, infatti, è un discorso che dà unità e coerenza di senso ad eventi e che fornisce un’identità
al soggetto che narrandola si narra in essa, come dice P. Ricoeur10. Il racconto tesse così la trama
complessiva dell’esperienza e ne fa prendere coscienza, così che l’esperienza esiste veramente
10
Cfr. P. RICOEUR, Tempo e racconto, voll. 3, tr. it. Jaca Book, Milano 1986-1988.
7
quando si racconta e il segno che qualcosa è diventato esperienza è appunto che è divenuto
raccontabile. Solo successivamente l’esperienza può essere analizzata e discussa, cioè essere fatto
oggetto di esplicito pensiero critico, ma all’origine deve esservi il suo racconto.
Però, quando un racconto è costituito forma una (piccola o grande) tradizione, cioè un
vincolo che predispone e condiziona l’ulteriore possibile esperienza. La storia del racconto è così
decisiva per la vita dell’esperienza, tanto più che in realtà un racconto non è mai isolato, ma
appartiene sempre per sua natura ad una storia, ad una tradizione di racconti. Prima che inizi un
nostro racconto, siamo stati già raccontati da altri. In concreto, il nostro raccontare è da sempre stato
preceduto dal racconto di chi ci ha portato in grembo e di coloro che si sono presi cura di noi. Il
nostro stesso nome è stato raccontato prima che noi venissimo all’esistenza ed esso è parte di un
racconto familiare. A loro volta i racconti familiari sono stati preceduti da altri racconti e tutti sono
parte di un racconto culturale più vasto, in cui vengono a collocarsi storicamente, e così via
indefinitamente.
Questo significa che nessuna esperienza inizia con un’originalità assoluta, bensì in qualche
misura all’interno di una tradizione di racconti antecedenti, che ne costituisce la condizione
strutturale e l’avvio concreto. Il bambino struttura la sua esperienza a partire dal racconto che di lui
fanno i suoi genitori e poi via via le figure adulte importanti. Così la fortissima inventiva del
bambino è messa in movimento dal racconto che la anticipa e vi si combina. Come L. Pareyson dice
della libertà umana, così si può dire anche dell’esperienza di ciascuno, che non è mai né pura
ripetizione d’altri, né pura novità, ma è sempre una “iniziativa iniziata”.
Per questo si diventa soggetti di esperienza attraverso un certo assoggettamento
all’esperienza altrui, cioè essendo accolti e accogliendo un racconto d’altri. Purché, naturalmente,
tale racconto non sia fatto perversamente in modo tale da aggiogare chi lo riceve, ma ne promuova
la libertà. Il buon racconto infatti predispone e muove le capacità di fare a propria volta esperienza.
Esso “fa vedere” il prender senso di eventi e il costituirsi dell’identità di chi narra, anche attraverso
la connessione che esso inevitabilmente stabilisce con più ampi racconti, i “grandi racconti”
culturali entro cui si inscrivono le esperienze di singoli e collettività. Anche a questo livello è
decisivo ovviamente il valore posseduto dai grandi racconti, il loro effettivo spessore culturale, la
concezione dell’umano che trasmettono, ai fini della qualità dell’esperienza che suscitano e
sollecitano. Si può appartenere al racconto di una grande tradizione culturale oppure, come avviene
nella “condizione postmoderna”, a vischiosi racconti massmediatici, a meschini racconti
generazionali, a frammenti di un disperato racconto metropolitano, ecc.
Il fare esperienza ha, dunque, un complesso di componenti, che devono essere attive e che
possono essere favorite ed educate oppure sfavorite e sottratte. L’esperienza è in rapporto vivo con
il pensiero, ha la sua formulazione compiuta nella narrazione, porta con sé l’appartenenza ad una
tradizione.
4. APPARTENENZA E LIBERTÀ
Se questo è lo statuto dell’esperienza umana, ne traiamo due insegnamenti e due
interrogativi. Gli insegnamenti sono che la competenza di fare esperienza è originaria del soggetto
umano e di un soggetto gettato e impegnato con l’unità di senso del suo vivere. Questo è di
densissimo significato antropologico, perché dice della centralità del soggetto umano contro ogni
tentativo di defraudarlo della sua capacità e della sua responsabilità di fare esperienza. E quindi dice
anche dell’orientamento ultimo di ogni comunicazione culturale, nel senso che abbiamo indicato,
8
cioè la sollecitazione del destinatario a fare esperienza in prima persona, a rendersi protagonista
della sua irriducibile esperienza.
Bisogna però interrogarsi ancora un poco sulle condizioni di questo fare esperienza. Essa
infatti necessita l’impegno di una ragione forte, cioè capace di operare sintesi e di offrire un senso
unificante, e insieme comporta l’appartenenza a una qualche tradizione in cui si gioca la libertà del
soggetto. Si tratta, allora, di comprendere meglio quale ragione sia in grado di far fare esperienza
all’uomo e quale tipo di appartenenza - di cui si diceva poco fa - sia condizione per il farsi libero
dell’esperienza.
Conviene ripartire dal tema dell’appartenenza, perché essa costituisce l’inizio concreto del
far esperienza. Infatti, come siamo arrivati a dire, l’esperienza di ciascuno prende corpo e
fisionomia sempre all’interno della partecipazione a tradizioni di esperienza antecedenti. Però
l’appartenenza può essere condizione favorevole del fare esperienza, se e solo se contenendo il
soggetto ne promuove insieme la libertà. Ma quale natura deve avere la libertà per poter coesistere
con l’appartenenza, anzi per esserne favorita e promossa?11
Se la libertà fosse solo libertà di scelta, vi sarebbe eterogeneità in radice tra libertà e
appartenenza e facilmente anche conflitto. Infatti, la libertà solo come energia di scelta implica
effettivamente il non poter dipendere da criteri che non siano interni alla stessa capacità di
autodeterminazione. Di conseguenza ogni appartenenza, sia come condizione d’origine
dell’esperienza, sia come risultato di una trasmissione culturale coinvolgente, è avvertita dalla
libertà come realtà estrinseca e non come valore rilevante per essa. In realtà questa concezione della
libertà (tipica dell’alternativa illuministica tra libertà e tradizione) è ampiamente insufficiente ed è
compito (oltre che condizione) di un evento comunicativo denso il rendere percepibile un più ampio
orizzonte della libertà.
L’esaltazione della libertà come arbitrio misconosce, infatti, il vincolo che la libertà di un
essere finito come l’uomo ha da sempre e anzitutto con il bisogno. L’autosoddisfazione prodotta
dalla capacità di determinarsi è ingannevole e si deforma narcisisticamente, se perde la coscienza
della sua funzionalità alla soddisfazione dei bisogni del soggetto. In realtà nessuno sceglie per
scegliere, ma l’autonomia - in sé abissale e vertiginosa - della scelta, deve però fare i conti con la
limitatezza delle possibilità e con le esigenze, che costituiscono un vincolo realistico alla potenza
della libertà e alla sua ebbrezza romantica (ma anche idealistica ed esistenzialistica).
Ma questo non è l’unico vincolo della libertà, perché un altro e precedente ne accompagna il
sorgere e lo sviluppo. Tra i bisogni dell’uomo ve ne è uno che dal punto di vista strutturale e
funzionale precede ogni altro, essendo condizione costante della qualità umana d’ogni
soddisfazione. Si tratta del bisogno di riconoscimento da parte di un altro soggetto, sul cui
fondamento qui non possiamo intrattenerci, ma che consta in modo ineludibile nell’esperienza
umana. In quel bisogno prende forma il rapporto intersoggettivo come tale, che non consiste tanto
nell’instaurazione di qualche relazione operativa tra soggetti (di natura linguistica, conoscitiva,
affettiva) - che piuttosto ne è espressione -, ma è un rapporto di ospitalità attiva, per cui l’uno è
presente nel pensiero (immaginazione e affezione, intelligenza e volontà) dell’altro ed è per ciò
stesso attivato nella sua propria capacità di pensiero. Come è evidente nel rapporto genitoriale e in
particolare materno, nel quale il bimbo generato attende di essere riconosciuto, cioè di essere fatto
nascere di nuovo ad altro livello, quello della relazione intenzionale (e quindi, di conseguenza,
Per una più ampia considerazione dell’argomento cfr. F. BOTTURI, Formazione della coscienza morale: un
problema di libertà, in AA.VV., Per una libertà responsabile, a cura di G.L. Brena e R. Presilla, Ed. Messaggero,
Padova 2000, pp. 73-95.
11
9
anche della relazione giuridica e societaria). Tale riconoscimento si esprime tipicamente nel
divenire oggetto di racconto, come già si diceva.
C’è un’attesa di riconoscimento, perché questo è condizione indispensabile affinché
vengano attivate le competenze del soggetto stesso. Anche a questo livello nessuno “si muove” da
sé, ma ha bisogno di “essere mosso”, di esser posto in movimento, cioè di essere messo in grado di
esercitare quelle capacità che gli sono pur congenite: un piccolo d’uomo assolutamente
abbandonato, se pur sopravvive, non raggiungerebbe mai una condizione di vita propriamente
umana.
Non qualunque riconoscimento, però, risponde al bisogno, ma - di per sé - solo quello che
fosse in grado di accoglierne perfettamente l’esigenza. Il riconoscimento autentico è infatti quello
che viene dato gratuitamente, cioè come affermazione della libertà dell’altro e quindi come
cooperazione all’attivazione dell’altrui libertà e infine come consegna della libertà a se stessa. Cosa
probabilmente impossibile all’uomo, cui risulta così difficile lasciare totalmente spazio ad un’altra
libertà 12 , eppure ideale normativo ineludibile, se si vuole mantenere attivo un concreto senso
dell’altro.
Sotto questo profilo, dunque, la libertà è anche essenzialmente relazione all’altra libertà, al
modo dell’attesa di un rapporto gratuito da parte di un’altra libertà. La libertà agisce gratuitamente
quando va alla ricerca di un’altra libertà per se stessa, mossa dall’interesse per e dall’apprezzamento
dell’altra libertà come tale (come avviene nell’amore autentico, e perciò raro e preziosissimo)13. La
libertà di ciascuno riceve infatti da questo tipo di rapporto il bene inestimabile della propria
attivazione, che non significa fondazione (che metterebbe un uomo a disposizione dell’altro), ma
sollecitazione e promozione (comunque indispensabili alla vita della libertà). Di conseguenza, è in
questo rapporto che il soggetto sperimenta il primo bene valido per sé, paradigma di ogni altro
bene. D’altra parte ogni altra soddisfazione sarebbe carente, se non addirittura nociva, se non fosse
accompagnata e sostenuta da questo tipo di corrispondenza, per cui l’attesa di un riconoscimento
liberante non vale solo per la prima età dell’uomo, ma accompagna e condiziona analogicamente
tutto il corso della vita umana, attraverso tutti i rapporti significativi che tessono un’esistenza.
Tutto ciò significa, dunque, che l’appartenenza è una dimensione interna della libertà
stessa. Ma questo è anche il cuore dell’autentica affettività. Il riconoscimento è infatti la logica di
ogni amore e il riconoscimento fondato sull’accoglienza dell’altrui libertà è la garanzia della
ragionevolezza di ogni affetto, cioè della sua consistenza più che sentimentale ed emotiva.
Se dunque l’esperienza della relazione ad un’altra libertà sta all’inizio (cronologico e logico)
dell’avventura della libertà, allora questa va concepita come un complesso e vivente organismo di
relazione-appartenenza, tendenza al bene, scelta, che mantiene la sua identità e matura il suo
equilibrio nella misura in cui si sviluppa in tutte le sue direzioni. Risulta ora più chiaro che una
trasmissione culturale è anche una comunicazione d’esperienza nella misura in cui sollecita la
libertà secondo tutte le sue dimensioni, a partire dal riproporsi di un rapporto di riconoscimento in
cui si offra un legame benefico e un’indicazione di bene possibile, quali contesti di senso della
scelta stessa. Per questo una trasmissione di questo tipo ha sempre bisogno, immediatamente o
mediatamente, del rapporto personale in cui solamente l’intero della libertà può trovare spazio.
È questo uno dei paradossi dell’esistenza umana, che sembra impossibilitata ad eseguire ciò che pure le sarebbe così
necessario. Si potrebbe parlare con Jaspers di situazione limite in cui appare una “cifra” dell’umano e della sua
ragionevole connessione con una forza superiore che gli permetta di realizzare se stesso.
13
Di cui si può dire come afferma il Siracide dell’amico fedele: “un amico fedele è una protezione potente, chi lo trova,
trova un tesoro. Per un amico fedele non c’è prezzo, non c’è prezzo per il suo valore. Un amico fedele è un balsamo di
vita” (6, 14-16a).
12
10
5. RAGIONE COME DOMANDA, DIALOGO E GIUDIZIO
L’altra condizione del fare esperienza è - come si diceva - un esercizio di una ragione non
meramente calcolante, ma capace di sintesi di tutto il vissuto e perciò dotata dei suoi movimenti
fondamentali: la capacità di domandare e quella di giudicare.
L’interrogazione è la forma originale della ragione. Per essa l’uomo manifesta quella sua
capacità di trascendenza rispetto alla sua esperienza e al suo stesso sapere, di cui già si diceva.
L’energia del domandare infatti è all’origine del sapere e non è mai suo prodotto: tutto l’accumulo
delle conoscenze non è di per sé in grado di formulare una sola domanda (ed è per questo che
l’erudizione di per sé non fa cultura). Nel suo potere interrogativo il soggetto esprime invece
l’indeducibile originalità e l’identità inderivata del suo essere razionale.
Il domandare implica una previa fiducia della ragione nell’intelligibilità della realtà, cioè
nella verità. L’interrogare come tale manifesta il costitutivo rapporto fiduciale della ragione nei
confronti della verità dell’essere. Secondo una formula cara a H.U. von Balthasar, alla radice della
ragione sta un’“accordatura” (“Einstimmung”) con l’essere, che dà orientamento a tutto il
movimento della sua ricerca. In questo senso il pensiero è sempre nella verità: se il pensiero non
fosse già da sempre spalancato all’essere intelligibile, cioè alla verità (trascendentale), mai potrebbe
porre nessuna domanda su una qualunque particolare verità (categoriale).
Se la ragione non fosse in questa condizione di previo accordo con la verità, lo scetticismo
avrebbe ragione, potendo sempre far valere l’insuperabile problematicità dei nostri giudizi
particolari. Ma lo scetticismo ha torto, perché non potrebbe essere posto problema alcuno, se il
senso della verità non fosse sempre già attivo. Possiamo errare nella determinazione particolare del
vero, ma non possiamo mai fuoriuscire dalla manifestazione dell’essere (la verità), senza fuoriuscire
anche dal pensare.
Ma se domandare è già pensare nella verità, allora la domanda è da sempre in dialettica con
la risposta. “La stessa capacità di cercare la verità e di porre domande - afferma lucidamente
l’enciclica Fides et ratio - implica già una prima risposta. L’uomo non inizierebbe a cercare ciò che
ignorasse del tutto o stimasse assolutamente irraggiungibile. Solo la prospettiva di poter arrivare ad
una risposta può indurlo a muovere il primo passo”14. Certamente esistono false domande cui non è
possibile dare risposta, perché in realtà nascondono un controsenso che ne annulla il valore. Ma il
movimento del domandare come tale non è contraddittorio, perché non se ne spiegherebbe neppure
l’esistenza senza un termine di diritto. Non solo, ma se l’interrogare già implica l’affermazione
della verità dell’essere, necessariamente esso rinvia alla sua ulteriore sempre possibile
manifestazione, alla risposta secondo verità. La logica della domanda include perciò l’attesa della
risposta, così come ogni innamoramento è in essenziale attesa di cor-rispondenza: l’innamorato
disinteressato ad essere corrisposto sarebbe in una contraddizione che farebbe dubitare della realtà
del suo amore o, meglio, dovrebbe far pensare allo stato morboso di Narciso, che ama più l’amare
dell’amato. Anche la ragione può ammalarsi, come dimostra il Nathan di Lessing, amando più il
suo ricercare che non la risposta soddisfacente la sua attesa. La ragione interrogativa è allora anche
necessariamente dialogica. Se infatti la domanda è attesa di risposta, allora essa sarà interessata
all’interlocuzione e al dialogo con chi potrebbe soddisfarne in qualche misura l’attesa.
14
Fides et ratio, n. 29.
11
L’affermazione d’essere che è implicita nel domandare diventa esplicita in quell’atto della
ragione che è l’affermazione del giudizio. Il giudizio è l’altro movimento fondamentale della
ragione, anzitutto perché è l’atto di sintesi che la ragione fa dei contenuti dell’esperienza,
costituendone la condizione elementare.
Ma in questa sua funzione logica fondamentale il giudizio è anche capacità di affermazione
ontologica da parte del soggetto e manifestazione della sua partecipazione all’Essere eterno 15 .
Fondamentale è comunque il riconoscimento della capacità del giudizio umano di raggiungere
l’essere e la verità e di impegnare l’uomo nel suo rapporto conoscitivo con la realtà.
Infatti, la rinuncia a questa capacità umana di affermazione vera dell’essere delle cose
comporta quella “derealizzazione” dell’esperienza - di cui già si diceva -, che in ultima istanza
minaccia la possibilità stessa dell’esperienza. Ma oggi è proprio la razionalità ontologica ad essere
in discussione. La sua negazione è il primo assioma del pensiero debole, che travolge
necessariamente il senso della verità. Ma l’interrogazione senza riferimento alla verità diventa
scettica e il dialogo scambio inconcludente di pareri. Senza la stabilità della verità l’interrogazione e
il dialogo divengono esercizi fragili, consegnati solo all’opinione e la comunicazione culturale non
può superare i limiti di una pretesa soggettivistica, senza mai giungere a indicare un senso
impegnativo.
D’altra parte, il giudizio umano non può pretendere d’essere sapere assoluto e quindi ogni
giudizio pur veritativo si pone, a sua volta, anche come domanda e ricerca di ulteriore verità. Così,
se la comunicazione autentica non si ferma al domandare fine a se stesso e allo scambio di pareri,
ma procede fino all’affermazione possibile della verità, nello stesso tempo è consapevole della
strutturale disequazione umana rispetto alla totalità dell’essere e del vero. Perciò la trasmissione
autentica di cultura è tale, anzitutto se rispetta e asseconda lo spontaneo movimento interrogativo
della ragione e quindi non si impone con la forza dell’autorità o con la persuasione astuta, ma lavora
sugli interrogativi che muovono il suo stesso sapere ed è sempre disposta a riaprire il ciclo della
curiosità interrogativa, della fatica dialogica e della responsabilità affermativa.
In conclusione, come la messa in gioco del complesso della libertà (di appartenenza, di bene
e di scelta) è condizione perché si dia una trasmissione culturale umanamente autentica, così è
decisiva la figura della ragione che vi è impegnata. Anche qui la cosa più importante è il recupero
della poliedricità, cioè della pluridimensionalità della ragione, che è principio di esperienza e di
15
Non è qui il luogo di una dimostrazione di questi assunti, che dovrebbe avere il seguente andamento. Nel giudizio,
mentre l‘uomo pone le determinazioni secondo la loro finitezza (S è P), ne afferma anche l’essere (S è P), come attualità
che sempre le trascende e come orizzonte che tutte le contiene. Nell’affermare che “qualcosa è” il giudizio dice la cosa
e insieme manifesta la sua effettività ontologica. Nel giudizio appare così sia il darsi dell’essere di qualcosa, sia la
differenza tra il qualcosa in quanto qualcosa determinato il suo darsi. Nel giudizio l’essere appare ad un tempo come
essere determinato e come essere trascendente ogni determinazione: in quanto l’essere è l’accadere di ogni
determinazione, è più dell’accadere di ogni determinazione. La struttura del giudizio è così articolazione interna della
trascendenza dell’atto d’essere, cioè dell’essere in quanto atto. Nell’ è del giudizio appare il movimento della
trascendenza insieme gnoseologica e ontologica rispetto a ogni determinazione.
In quanto atto umano per eccellenza, il giudizio struttura l’esistenza. Se il giudizio è il luogo della coniugazione
(categoriale) delle determinazioni e della manifestazione (trascendentale) dell’essere, allora l’uomo dimora
necessariamente nella “differenza ontologica”, in cui dispone tutta la sua esistenza. Il soggetto non può non viversi
gettato e impegnato nella tensione tra la sua apertura trascendentale e la sua natura determinata. L’uomo vive così nella
strutturale disequazione tra la limitatezza della sua natura e l’illimitatezza della sua capacità giudicativa, appunto tra
limitatezza entitativa e illimitatezza intenzionale. Esattamente in questa sproporzione prende forma il desiderio
dell’uomo di giungere ad una condizione dell’esistenza in cui quella sproporzione, che lo fa soffrire, giunga alla sua
conciliazione.
12
comunicazione perché è interrogativa, capace di illimitata apertura, e quindi dialogicamente
impegnata alla scoperta del vero, ma anche giudicativa e perciò affermativa del senso. La ragione
umana capace di comporre il tessuto dell’esperienza è dunque una (misteriosa) forza, che per un
verso è infinita apertura interrogativa, ma per un altro è certezza della verità e capacità di
affermazione dell’essere. Essa è perciò insieme inquietudine e saldezza, la cui separazione produce
rispettivamente la patologia dello scetticismo o quella del dogmatismo, forme entrambi di
immaturità o di stasi della ragione.
6. RIFLESSIONE SINTETICA: RAGIONE, AFFEZIONE, GENERAZIONE
Un’autentica trasmissione culturale è una comunicazione di esperienza; ma perché sia tale è
necessario che tutto il complesso antropologico dell’esperienza e, in essa, della ragione e della
libertà sia attivato e sia messo al lavoro.
Nell’unità organica dell’esperienza ragione e affettività trovano la loro composizione.
Anzitutto la razionalità mostra la sua natura non meramente analitica e calcolatrice, ma sintetica e
ontologica, in quanto capacità di illimitata apertura, onnicomprensiva e impegnata con il problema
di senso d’ogni realtà. Corrispettivamente l’affettività non è anzitutto sentimento ed emozione, ma
desiderio e adesione a ciò che si manifesta alla ragione, in quanto mostra anche il suo senso
benefico per l’uomo. L’affettività non è così chiusa nel circolo emotivo del lasciarsi impressionare e
del cercare di possedere, ma riconosce una corrispondenza con un bene che resta tale solo se è
rispettato nelle sue esigenze ed è trattato con responsabilità. La differenza tra l’amore e l’emozione,
infatti, è che il primo è una risposta, la seconda è una reazione; questa è del tutto soggettiva e quindi
egocentrica (e tanto più tale, quanto più intensa e “speciale”), quella invece è adesione a qualcosa
(meglio, qualcuno), di cui la ragione mostra l’autonoma consistenza e verità. In sintesi, con una
formula heideggeriana, si potrebbe dire sinteticamente che “ogni esperienza è in se stessa un
incontro, e cioè un incontro in e per una cura”16: in forza della ragione l’uomo è capace di incontro,
che affettivamente significa anche un rapporto nel modo del prendersi cura dell’altro.
La trasmissione di una cultura non divisa non potrà essere quindi un asettico passaggio di
informazioni e di nozioni, ma dovrà coinvolgere il mondo degli affetti, cioè la logica degli affetti
intese non come emozioni errabonde, ma come un sentire intriso di razionalità pratica ovvero di
libertà. A sua volta l’affezione pratica della libertà non si riduce a sentimentalismo, nella misura in
cui innervata dai motivi intelligibili della ragione propositiva e critica. In questo senso tra
razionalità e affezione esiste una circolarità che è possibile accogliere e promuovere come
principio e forma dell’unità dell’esperienza e della sua comunicazione.
Ma appunto l’organismo dell’esperienza, che si è cercato di delineare, mostra una continua
interazione di ragione e affettività, e quindi la loro reintegrazione. Come s’è visto, infatti, l’opera
della ragione nasce sempre all’interno di un’appartenenza affettivamente impegnativa, in cui prende
forma anche la libertà con il suo vettore di desiderio, la sua tensione di attesa, il suo sentimento di
apprezzamento, la sua esperienza di soddisfazione o di insoddisfazione. La ragione persegue il suo
lavoro attraverso il domandare e il dialogare, che sono movimenti possibili - come è stato notato solo se sono attivi desiderio della verità, fiducia nella sua possibile manifestazione e credito alla
dimensione veritativa di altri. Infine il giudizio, in quanto si impegna con la verità, riapre il ciclo
della libertà e della sua affettività, costituendo per queste la proposta di un impegno.
16
M. HEIDEGGER, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, tr. it. Guida, Napoli 1990, p. 123 (corsivo mio).
13
Da questo punto di vista integrato si può dire che una comunicazione riesce quando produce
sia persuasione sia convinzione, cioè sia un’adesione affettiva libera e quindi una comprensione
della cosa di cui si sappia giudicare per esperienza (“per connaturalità”, direbbe s. Tommaso), sia
una giustificazione critica, cioè argomentata. Una buona trasmissione culturale è dunque fonte di
una buona certezza, cioè di una certezza che non è né sentimentale, né dogmatica (due facce della
stessa unilateralità), ma partecipe e critica.
Viene spontaneo concludere con una domanda: quale potrebbe essere il punto di partenza di
un rinnovato processo di trasmissione culturale. L’impresa ha tale evidente complessità da
richiedere senz’altro un’iniziativa distribuita su più fronti. Un’importanza particolare ha - a mio
avviso - una modalità culturale per il fatto di essere la forma tipica della sintesi vivente di ragione e
affezione: sto parlando dell’“immaginazione poetica”, nel senso lato del termine,
dell’immaginazione creativa di forme che sono insieme significative di senso e affettivamente
coinvolgenti. La capacità di una cultura di attivare l’immaginazione poetica è, infatti, il sintomo
certo della sua vitalità ed è il modo concreto della sua affermazione storica. Dobbiamo pensare che
non casualmente la civiltà cristiana ha disseminato la cultura occidentale di forme belle di ogni tipo,
di prodotti immaginativi di immediata ed efficace comunicazione, di sintesi poetiche di universale
significato. Se, nonostante tutto, non si vuol restare chiusi in una mentalità intellettualistica, bisogna
comprendere che la questione dell’immaginazione poetica e creativa non è una faccenda del settore
“estetico” dell’esistenza, ma è la chiave di volta di un’antropologia riconciliata al di là di
razionalismo ed empirismo, di tecnicismo ed emozionalismo17. È l’immaginazione infatti il luogo in
cui la comunicazione culturale ha il suo luogo di normale e fondamentale realizzazione, perché è
questo il livello in cui la dimensione sensibile affettiva e quella intellettuale si danno convegno e
trovano la loro sinergia produttiva e dunque l’esperienza umana trova le sue prime e insostituibili
forme. Una cultura vitale18 non può non dar luogo anzitutto ad una cultura dell’immagine (non solo
visiva ovviamente), come cultura della sua sintesi d’esperienza e della sua trasmissione.
Ma, se è vero che l’attuale crisi dell’“esperienza” ha tutta l’implicazione antropologica che
abbiamo cercato di portare alla luce, non è ipotizzabile che si possano avviare processi di
rinnovamento senza che si diano eventi di sintesi esperienziale. E questa è la risultanza maggiore di
tutta la nostra riflessione. L’unità dell’esperienza, infatti, non è qualcosa che possa essere raggiunta
a posteriori, per sommatoria o per composizione di elementi, ma, proprio come l’opera artistica,
l’esperienza è tale se è dotata di una “forma” unitaria e unificante all’origine. Sarà necessario
senz’altro un processo - anche lungo e complesso - di sviluppo e di raffinamento, ma se la “forma”
non è data all’inizio, come principio vitale e direttivo, nessuna iniziativa potrà sostituirla.
Non solo, ma - come dice la citazione posta in exergo - solo “l’amore alla vita genera amore
alla vita”: la capacità di fare esperienza è originaria nel soggetto umano, ma allo stesso tempo deve
anche essere attivata. Si è visto infatti che la libertà è anche appartenenza e che la ragione vive in
sinergia con l’affezione. Non è dunque pensabile che l’uomo giunga a “fare esperienza” celebrando
Sull’argomento resta fondamentale a mio avviso il testo di V. MELCHIORRE, L’immaginazione simbolica, Il
Mulino, Bologna 1972; rist. ISU, Milano 1988.
18
Bisognerebbe a questo punto fare un’ulteriore domanda - che risulterebbe purtroppo imbarazzante e inquietante - a
riguardo delle forme immaginative della cultura cristiana odierna. Si pensi alla qualità “poetica” del canto della maggior
parte delle nostre assemblee liturgiche, che per lo più qualificherei di estetismo psicologistico; oppure si noti la
quasi-assenza dalle forme educative cristiane di quell’eccezionale occasione di unificazione e ‘purificazione’
dell’esperienza che è la rappresentazione teatrale (non a caso così importante nella cultura medievale e centrale nella
pedagogia gesuita moderna). Ma il problema si estenderebbe a tutta la questione dell’attuale creatività poetica religiosa,
soprattutto a fronte della cultura emozionalistica contemporanea dotata di tutti i mezzi necessari e sufficienti per
invadere con la sua poetica sensistica e sentimentale l’immaginario collettivo.
17
14
la sua solitudine. Al contrario, il soggetto deve essere in un certo senso “generato” alla sua
esperienza. Credo che il retaggio incomparabilmente più grave della cultura moderna stia nell’aver
cancellato la “generazione” dal novero delle categorie ontologiche e antropologiche fondamentali19.
Se l’identità dell’uomo, infatti, pur non esaurendovisi, è però consegnata alla relazione della libertà,
ciò significa che la libertà ha un essenziale significato generativo: la libertà suscita libertà e quindi
genera l’uomo alla capacità del suo fare esperienza (nel senso denso e complesso che abbiamo
rievocato). Per questo nulla è sostituibile alla capacità attivatrice e comunicativa di una sintesi
vivente dell’esperienza, che si rivolga ad altri perché questi sia messo in grado compiere a sua volta
la propria esperienza. Ogni sintesi vivente è perciò dotata della sua spontanea autorevolezza,
derivante non tanto dalla sua coerenza morale, quanto dalla coerenza interna di forma e contenuto,
di ragione e passione emotiva, dal suo impegno di prima persona con il significato dei suoi stessi
gesti, che testimoniano ad un tempo il valore e la possibilità esperienziale di ciò che viene
comunicato.
In altri termini, l’insostituibile punto di partenza è il carisma di paternità/maternità, che nel
mondo contemporaneo sembra essersi quasi smarrito20 e che invece la Chiesa conserva come sua
forma indispensabile, ma di cui forse non è culturalmente del tutto consapevole; del fatto cioè che
questa è la dote fondamentale necessaria non solo per far fronte alla novità epocale negativa della
scomposizione dell’esperienza, ma molto più per ri-generare l’umano.
È assai significativo che l’idea di generazione sia presente e vigorosa nella filosofia idealistica moderna e
contemporanea nel significato dell’autogenerazione del pensiero.
20
Cfr. AA.VV., La famiglia italiana. Vecchi e nuovi percorsi, a cura di V. Melchiorre, San Paolo, Cinisello B. 2000 (in
particolare i saggi di P.P. Donati, G. Angelini e V. Melchiorre), in cui sono anche dialettizzate le forme di attacco
culturale e speculativo alla relazione generativa e genitoriale.
19
15