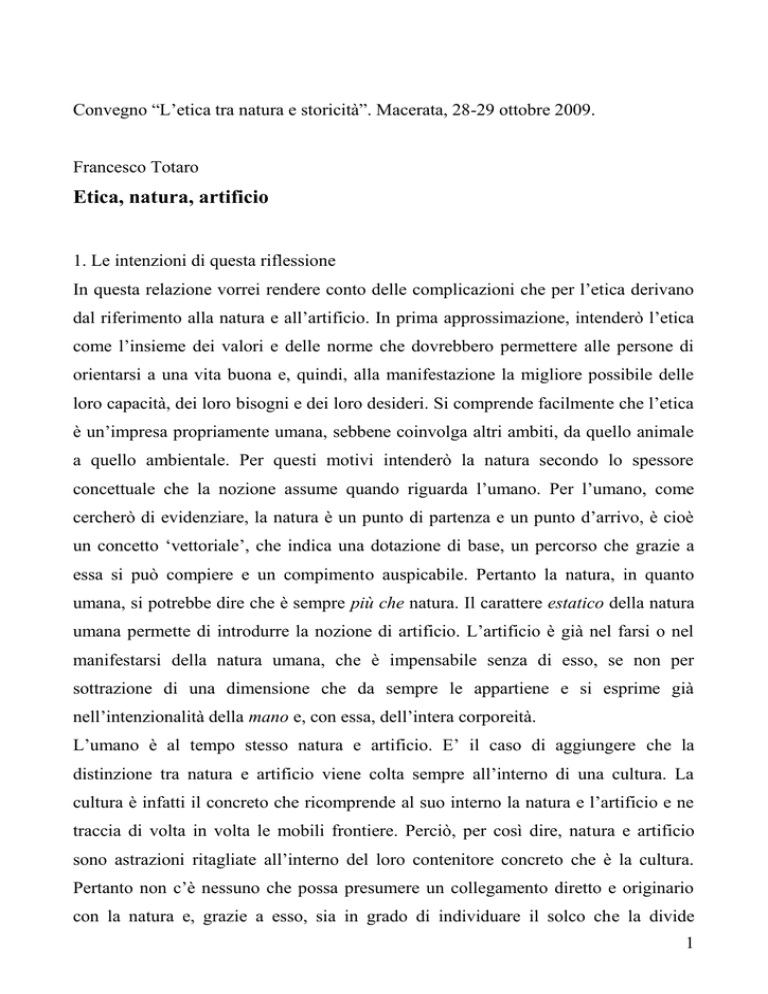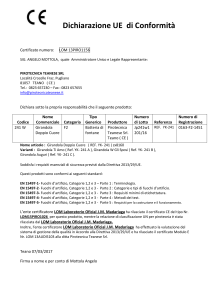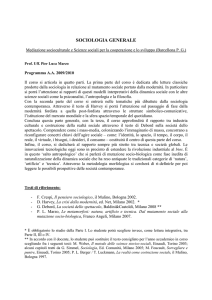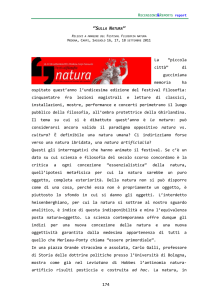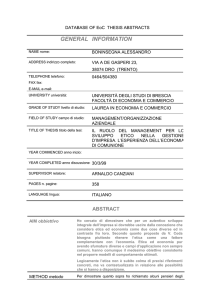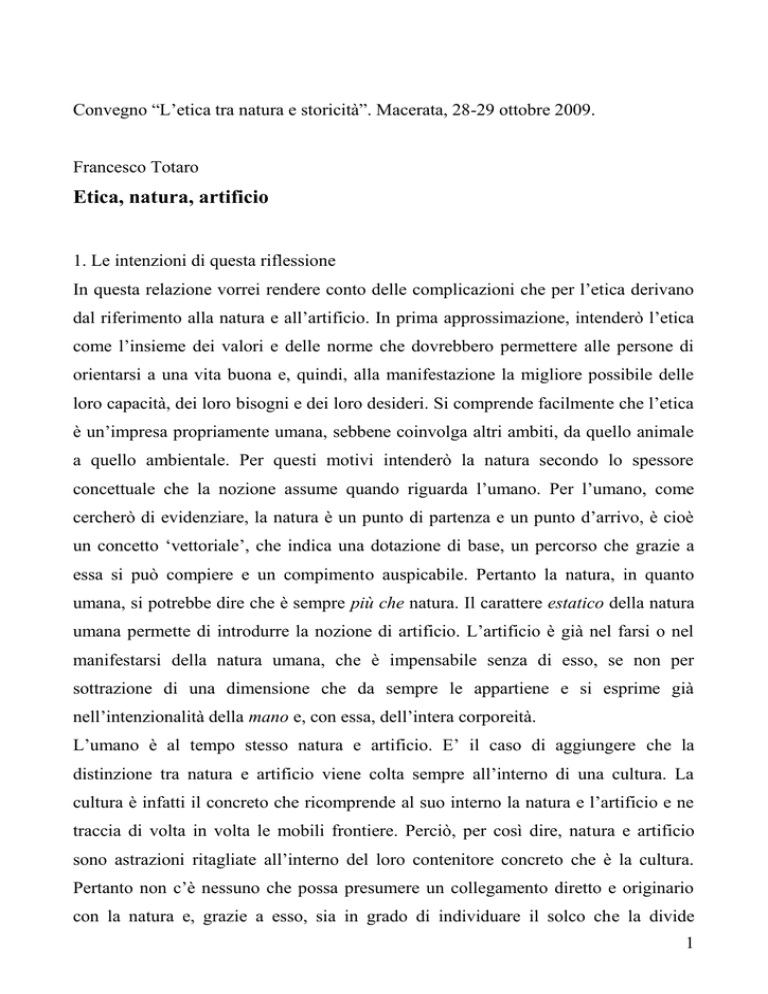
Convegno “L’etica tra natura e storicità”. Macerata, 28-29 ottobre 2009.
Francesco Totaro
Etica, natura, artificio
1. Le intenzioni di questa riflessione
In questa relazione vorrei rendere conto delle complicazioni che per l’etica derivano
dal riferimento alla natura e all’artificio. In prima approssimazione, intenderò l’etica
come l’insieme dei valori e delle norme che dovrebbero permettere alle persone di
orientarsi a una vita buona e, quindi, alla manifestazione la migliore possibile delle
loro capacità, dei loro bisogni e dei loro desideri. Si comprende facilmente che l’etica
è un’impresa propriamente umana, sebbene coinvolga altri ambiti, da quello animale
a quello ambientale. Per questi motivi intenderò la natura secondo lo spessore
concettuale che la nozione assume quando riguarda l’umano. Per l’umano, come
cercherò di evidenziare, la natura è un punto di partenza e un punto d’arrivo, è cioè
un concetto ‘vettoriale’, che indica una dotazione di base, un percorso che grazie a
essa si può compiere e un compimento auspicabile. Pertanto la natura, in quanto
umana, si potrebbe dire che è sempre più che natura. Il carattere estatico della natura
umana permette di introdurre la nozione di artificio. L’artificio è già nel farsi o nel
manifestarsi della natura umana, che è impensabile senza di esso, se non per
sottrazione di una dimensione che da sempre le appartiene e si esprime già
nell’intenzionalità della mano e, con essa, dell’intera corporeità.
L’umano è al tempo stesso natura e artificio. E’ il caso di aggiungere che la
distinzione tra natura e artificio viene colta sempre all’interno di una cultura. La
cultura è infatti il concreto che ricomprende al suo interno la natura e l’artificio e ne
traccia di volta in volta le mobili frontiere. Perciò, per così dire, natura e artificio
sono astrazioni ritagliate all’interno del loro contenitore concreto che è la cultura.
Pertanto non c’è nessuno che possa presumere un collegamento diretto e originario
con la natura e, grazie a esso, sia in grado di individuare il solco che la divide
1
dall’artificio. Aggiungerei che, per questo motivo, ritengo eccessivo il timore che,
partendo dalla sfera della cultura, si cada in un irreparabile relativismo.
Indubbiamente le culture, per quanto il loro raggio sia esteso, sono sempre particolari.
Ma non per questo non sono in grado di proporre, a partire dalla loro particolarità,
significati, valori e norme che possano essere tradotti in altri ambiti culturali. Gli
universali non sono mai già dati, ma sono piuttosto il risultato di un processo più o
meno lungo di universalizzazione. L’importante è che l’universalizzazione non
avvenga a senso unico ma sia disponibile per ogni interlocutore della scena culturale
mondiale, cioè di quella sovracultura nella quale le diverse culture oggi convivono e
si confrontano.
Allora, dovremmo uscire dalla contrapposizione speciosa di natura e cultura (alla
quale si finisce poi per attribuire l’artificio). Siamo tutti figli di una cultura. Ciò che
conta è capire se, nella cultura e non fuori di essa, si possa affermare qualcosa che
valga assiologicamente e normativamente anche oltre il perimetro di partenza.
Cultura non è necessariamente culturalismo deteriore.
Questa avvertenza ci consente di andare a vedere, in una ricostruzione genetica, come
le idee di natura e artificio si sono espresse e sviluppate nell’ambito del pensiero
occidentale e se la loro declinazione sia tale da far luce sull’esperienza umana come
può essere analogicamente – se non identicamente – condivisa anche oltre tale
pensiero. L’unico presupposto di questo modo di procedere è l’attribuzione a ogni
portatore di umanità di una ricerca di senso per la quale ne va del proprio vissuto e
delle coordinate grazie alle quali esso può raggiungere la migliore fioritura possibile.
2. Ciò che è e ciò per cui
Nel ripensamento del concetto di natura1, un ripensamento guidato dall’intento di
uscire da cristallizzazioni definitorie inadeguate, si rimarca la distinzione tra la natura
Cfr. tra gli altri A. Da Re, Percorsi di etica, Il Poligrafo, Padova 2007, pp. 35-54; F. Viola, L’universalità dei diritti
umani: un’analisi concettuale, in F. Botturi-F. Totaro, Universalismo ed etica pubblica, “Annuario di etica”, 3, Vita e
Pensiero, Milano 2006, pp. 155-187; Idem (con M. Mangini), Diritto naturale e liberalismo, Giappichelli, Torino 2009.
La riflessione di Viola ha alle spalle J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford 1992,
1
2
come fatto e la natura come essenza. La natura come fatto è il ciò che è. La natura
come essenza è il ciò per cui o, meglio, è il ciò per cui in ciò che è. La ripresa di tale
distinzione, che rinvia alla visione aristotelica della physis, è guidata dalla giusta
preoccupazione di ripensare in modo dinamico il concetto di natura, sottraendolo
anche alla staticità che deriverebbe dal suo appiattimento su un registro ristrettamente
fattuale-biologico. Bisogna dire subito che questa dinamicizzazione è credibile a
patto che l’essenza si configuri come apertura a un telos di compimenti possibili, a
partire da ciò che è già dato, e non come una struttura assolutamente indeformabile.
Altrimenti l’essenza si risolverebbe essa stessa nell’ordine di quella fattualità che
intende invece superare. Occorre inoltre riconoscere che proprio la ricerca svolta in
campo biologico ha avuto non pochi meriti – e ne avrà forse sempre di più in futuro –
nella fluidificazione di rappresentazioni fissiste della natura. Anche grazie ad essa
non possiamo riproporre oggi un essenzialismo preordinato astrattamente rispetto alla
mobilità che risulta dallo studio sempre in progress dei fatti.
La distinzione tra natura fattuale e natura essenziale, che a tutta prima appare
descrittiva, ha già in sé implicazioni speculative consistenti. Indica infatti una
condizione ontologica segnata dalla finitezza e dal limite. Se ci fosse una sintesi
perfetta tra ciò che è e ciò per cui, ogni distanza tra fatto ed essenza verrebbe meno.
Ci troveremmo, a ben vedere, nella perfetta e compiuta coincidenza di esistenza ed
essenza, cioè nella condizione del divino.
E’ la disequazione di esistenza ed essenza (e non importa stabilire qui se la prima
preceda la seconda o viceversa) a fare in modo che ciò che è sia sempre in un
rapporto di divaricazione con ciò per cui. Questa medesima divaricazione rende
inquieto il ciò che è, mettendolo in tensione incessante con il ciò per cui.
3. Lo spazio dell’artificio
tr. it. di F. Di Blasi con Introduzione di F. Viola, Legge naturale e diritti naturali, Giappichelli, Torino 1996. Vedi pure
G. Azzoni, Lex aeterna e lex naturalis: attualità di una distinzione concettuale, in F. Di Blasi-P. Heritier, La vitalità del
diritto naturale, Phronesis, Palermo 2008, pp. 159-209; A. Campodonico, Radicalismo liberale e riscoperta della
natura umana, in F. Botturi (a cura di), Soggetto e libertà nella condizione postmoderna, Vita e Pensiero, Milano 2003,
pp. 17-40; R. Mordacci, Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la bioetica, Feltrinelli, Milano 2003.
3
Allora, la distinzione tra natura come fatto e natura come essenza, lungi dal
rappresentare la risoluzione di un problema, apre piuttosto il campo del
‘dispiegamento’ del problema stesso. Infatti, è in quella distinzione che si istituisce la
struttura problematica del concetto di natura. La non coincidenza di essere o essente
(natura come fatto) e dover essere (natura come essenza), è la premessa fondamentale
di ciò che consideriamo come artificio. L’artificio, nella sua struttura costitutiva, è
l’intervento sulla natura come fatto in vista della natura come essenza o, in altre
parole, della natura come è in vista della natura come dovrebbe essere. Nella
dimensione dell’artificiale la natura così come è viene destabilizzata in vista della
nostra idea di natura.
Noi abbiamo metabolizzato questo intervento destabilizzante con il concetto di
seconda natura, quasi a voler sottolineare la continuità nella discontinuità. In realtà, il
concetto di seconda natura è un modo per dire che è la cultura la natura propria
dell’umano. Con questa affermazione si vuol dire che l’umano – più che qualsiasi
altro animale – è predisposto a vivere come essere culturale, quale che sia poi la
giustificazione antropologica di tale predisposizione: la condizione deficitaria rispetto
all’animalità2 oppure, al contrario, la vocazione trasformatrice insita già nella
plasticità funzionale della mano3
4. La simbiosi di naturale e artificiale
2
Cfr. le note posizioni di Arnold Gehlen e seguaci, fino a Umberto Galimberti, il quale, peraltro, risolve la cultura nella
tecnica come essenza dell’uomo, poiché è grazie alla tecnica che l’uomo raggiunge «culturalmente» la selettività e
stabilità che l’animale possiede «per natura» (v. specialmente Psiche e techne. L’uomo nell’età delle tecnica,
Feltrinelli, Milano 1999, p. 34).
3
Cfr. per es. Heinrich Popitz, Der Aufbruch zur artifiziellen Gesellschaft, Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1995, tr.it.
di G. Auletta con Prefazione di F. Ferrarotti, Verso una società artificiale (1995),Editori Riuniti, Roma 1996 e altri, tra
i quali gli attuali sostenitori dell’antropologia post-umana, che molto si giovano della ricca riflessione di Roberto
Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino 2002. Quest’ultimo non intende
rinunciare alla «natura umana», bensì metterne a fuoco la «ridondanza» rispetto al modello «totalmente autocontenuto e
autoreferenziale» della sua definizione; della ridondanza antropologica è costitutiva «la tendenza a realizzare ponti
coniugativi con l’alterità non-umana» (ibi, pp. 46-47). Sul nesso tra mano e linguaggio cfr. M.C. Corballis, Dalla mano
alla bocca. Le origini del linguaggio, Raffaello Cortina, Milano 2008.
4
Con l’artificio la fattualità della natura viene modificata4 a vantaggio di ciò che la
natura dovrebbe essere. L’intervento dell’artificio, in quanto considerato come
elemento di connessione tra natura come fatto e natura come essenza, non ha
comportato problemi morali di natura radicale. Anzi, il ricorso all’artificio è andato al
di là del suo statuto facoltativo ed è diventato moralmente obbligante: esso è
doveroso tutte le volte che si ritiene possa sostenere la natura di fatto indebolita o
ridotta ai suoi minimi termini. La cosa non manca di aspetti paradossali. E’ diventato
infatti moralmente non lecito – per alludere a casi di recente attualità – rinunciare
all’uso delle tecnologie artificiali quando è proprio tale uso a garantire la non
interruzione della vita naturale. In tal modo diventa “principio non negoziabile” non
soltanto la non interruzione del processo vitale ma altresì la non interruzione del
trattamento artificiale. La vita “naturale” diventa quella che è resa possibile dal
funzionamento dell’artificio e, poiché l’artificio è di fatto “a tempo indeterminato”,
anche la vita naturale condivide la sua artificiale indeterminatezza. L’osmosi di vita e
artificio diviene indisgiungibile. Alla vita naturale si attribuisce così un diritto “a
durare” che solo la tecnologia rende possibile.
A meno di non voler attribuire a chicchessia posizioni indifendibili di positivismo
biologico estremo o persino di disumanizzante feticismo fisicistico, il fondamento
della prescrizione della perseveranza nelle cure ordinarie (è il caso della
alimentazione e della idratazione artificiali, cioè mediate da un apparato strumentale)
in soccorso all’attività vitale minimale sta nella persuasione di doverosa
4
Su questi processi di cambiamento, e sulle loro incidenze etiche, vedi M. Fimiani-V. Gessa Kuroschka-E. Pulcini,
Umano post-umano. Potere, sapere, etica nell’età globale, Editori Riuniti, Roma 2004; nella parte II, I saperi del
vivente, contiene tra gli altri contributi di S. Tagliagambe, Mente e cervello. Un rapporto problematico, pp. 157-194 e
A. Oliverio, Mito e realtà delle neuroscienze, pp. 137-156, con un confronto stretto con la teoria del «darwinismo
neurale» proposta dal biologo Gerald M. Edelman nel volume di ampia risonanza Second Nature. Brain Science and
Human Knowledge, Yale University Press, New Haven 2006, tr.it. di S. Frediani, Seconda natura. Scienza del cervello
e conoscenza umana, Raffaello Cortina 2007. Di notevole rilievo i contributi agli Atti del LIX Convegno del Centro
Studi Filosofici di Gallarate, in P.G. Grassi-A. Aguti (a cura di), La natura dell’uomo. Neuroscienze e filosofia a
confronto, Vita e Pensiero, Milano 2008. Per una riflessione di più ampio raggio, ma sempre con riferimento alle sfide
della tecnica all’etica, uno scandaglio interessante in L. Tundo Ferente (a cura di), Etica della vita: le nuove frontiere,
Dedalo, Bari 2006 e in parecchi contributi, alcuni su aspetti specifici, presenti in C. Vigna-S. Zanardo, Etica di
frontiera. Nuove forme del bene e del male, Vita e Pensiero, Milano 2008 (sulla inscindibilità della «dignità umana»
dalla sua «naturalità» importante il saggio di R. Spaemann, ‘Naturale’ e ‘innaturale’ sono concetti moralmente
rilevanti?, pp. 85-98).
5
inseparabilità del naturale dall’artificio che lo rende possibile nella sua durata. E ciò
nonostante il naturale integrato dall’artificio sembri ormai appartenere a un ordine
della mera attualità, cioè di una fattualità di cui appare fortemente improbabile la
connessione, anche futura, con l’orientamento teleologico che dovrebbe animarla. In
tal modo l’intervento dell’artificio non è più integrativo di una natura in condizioni di
difficoltà nel recupero delle proprie funzioni, assume piuttosto un ruolo pienamente
sostitutivo delle stesse funzioni naturali. Si tratta di un esito che non manca di
paradossalità.
5. Artificio e arbitrio
In ogni caso, l’artificio finalizzato all’ordine naturale non ha suscitato problemi di
illegittimità morale o di caduta nel ‘relativismo’. I problemi sono sorti allorché a
comandare l’intervento dell’artificio non è stata l’idea di ciò che la natura dovrebbe
essere in continuità con ciò che la natura di fatto è, ma piuttosto l’idea di ciò che si
vorrebbe che la natura sia o diventi. In questo caso sembra che la natura sia assunta
come elemento materiale di una forma dipendente dalla potenza del volere.
Quest’ultimo disporrebbe di conoscenze e procedure operative in grado di dare
seguito al proprio progetto o, come si insinua, a qualsiasi progetto. Se la natura
diventa oggetto di un arbitrio che è legge a se stesso, la volontà di intervento a mezzo
dell’artificio non si limita, per così dire, a fare da ponte tra i due profili di natura, ma
si ritiene legittimata a mutare il suo pilastro iniziale e il suo pilastro finale, cioè il
punto di partenza e il punto di arrivo del processo naturale.
Cerchiamo di articolare meglio i caratteri di una posizione nella quale la natura
diventa relativa all’atto del volere. In tale posizione, la stessa dimensione fattuale
della natura passa attraverso la possibilità che essa sia voluta. Il fatto non voluto o
non suscettibile di essere voluto non obbliga alla sua accettazione e può essere quindi
legittimamente modificato in modo da essere voluto; nel caso estremo di non
convertibilità con il voluto può essere legittimamente rifiutato.
6
Per concludere, in tale contesto, grazie all’artificio, ci si ritiene autorizzati a
modificare sia le condizioni iniziali sia le condizioni terminali delle dinamiche di
sviluppo della natura.
6. La natura umana come interpretabile
Verrebbe ora da chiedersi: quali sono le condizioni di possibilità delle due visioni
dell’artificio che sopra abbiamo tracciato? Ci sono anzitutto condizioni che
riguardano il rapporto stesso tra l’umano e ciò che può essere considerato come (sua)
natura. Possiamo dire che la natura non copre l’intero dell’umano e tanto meno, in
quanto voglia costituirsi come legge, copre la irriducibile molteplicità degli atti
umani presi nella loro concretezza individuale. Ciò sembra tanto più vero quanto più
si va oltre quelli che Tommaso d’Aquino, nella celebre quaestio 94 della Iª-II della
Summa Theologiae5, considera i praecepta communissima omnibus nota per
raggiungere il terreno dei secundaria praecepta magis propria che riguardano il
particulare operabile. Nel campo della ratio practica non è concesso concludere in
modo lineare dal generale al particolare, dal momento che «ratio practica negotiatur
circa contingentia, in quibus sunt operationes humanae». La cosa, nel medesimo
contesto, viene argomentata anche in positivo con riferimento agli atti che possiamo
considerare come virtuosi. Questi ultimi, nella loro specificità, non sono tutti
derivabili dalla lex naturae: «Multa enim secundum virtutem fiunt, ad quae natura
non primo inclinat; sed per rationis inquisitionem ea homines adinvenerunt, quasi
utilia ad bene vivendum». Si tratta di atti virtuosi che dipendono dall’esercizio della
ragione inventrice dell’artificio (ars adinvenit) in vista delle condizioni di una “vita
buona”, dove contano le differenze individuali e dove vale l’applicazione congiunta
5
Sancti Thomae de Aquino Summa Theologiae prima pars secundae partis quaestio XCIV, Textum Leoninum Romae
1892 editum. Sulla specificità della ragione pratica in Tommaso vedi M. Rhonheimer, Thomas von Aquin: das Ewige
und das Natürliche (Summa theologiae, I-II q. 90, 91, 94) Einführung, in R. Spaemann-W. Schweidler (a cura di), Ethik
- Lehr - und Lesebuch. Texte - Fragen - Antworten, Klett-Cotta, Stuttgart 2007³, pp. 68-76; Id., Praktische Vernunft und
Vernünftigkeit der Praxis. Handlungstheorie bei Thomas von Aquin in ihrer Entstehung aus dem Problemkontext der
aristotelischen Ethik, Akademie Verlag, Berlin 1994; Id., Natur als Grundlage der Moral. Die personale Struktur des
Naturgesetzes bei Thomas von Aquin: eine Auseinandersetzung mit autonomer und teleologischer Ethik, TyroliaVerlag, Innsbruck-Wien 1987, tr. it. di E. Babini, Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell’autonomia
morale, Armando, Roma 2001.
7
dei principi generali della razionalità pratica e dei criteri di convenienza e
proporzione. Qui la virtù degli atti è relativa: «[…] propter diversas hominum
conditiones, contingit quod aliqui actus sunt aliquibus virtuosi, tanquam eis
proportionati et convenientes, qui tamen sunt aliis vitiosi, tanquam eis non
proportionati».
In Tommaso la diversità inerente all’espressione della razionalità umana riguarda
la sfera della ragione pratica come luogo di realizzazione molteplice e relativa
dell’inclinazione “naturale” al bene, la quale è tanto meno codificabile a priori
«quanto magis ad propria descenditur» (e non solo, mi pare, a motivo della
concupiscenza o dell’influsso di altre passioni). Oggi possiamo dire che una tale
opacità (o limite di trasparenza) investe lo stesso concetto di natura a livello di
investigazione della sua struttura e di autorappresentazione conoscitiva. Nonostante
la biologia molecolare e l’ingegneria genetica tendano ad acquisire e padroneggiare
una mappa il più possibile esaustiva della costituzione umana, quest’ultima non viene
saturata dalla oggettività scientifica. Infatti, alla analisi oggettivante sfugge l’atto di
autorappresentazione conoscitiva e di proiezione operativa che, nel suo concreto
esercizio individuale, declassa sempre il contenuto della oggettivazione da fattore
causale di tipo deterministico a condizione suscettibile sia di trasgressione sia di
integrazione nel contesto relazionale e ambientale. Ciò comporta che la natura non sia
inclusiva dell’intera consistenza dell’umano; ogni costituzione oggettiva è sempre
mediata da una spontaneità soggettiva in rapporto con altre soggettività. Si può dire
che, oltre la natura come insieme delle oggettivazioni scientifiche, sporge una natura
come dimensione di intenzionalità spontanea e automotrice, e questa rinvia a una
molteplicità di strati teorico-operativi degradanti verso l’ineffabile. Pertanto la natura
è per l’umano non solo un explanandum ma altresì un interpretandum o, meglio, un
interpretabile. In questo senso il concetto di natura (umana) assume la valenza di un
concetto-soglia: è un dato che allude a un passaggio ad altro non iscritto a priori nel
suo codice e frutto di una capacità di incremento autonomo o, se si vuole, creativo.
8
7. Physis e normalità
Questo giro di considerazioni dovrebbe rendere meno perentorio l’uso apodittico
che del concetto di natura si fa e propiziare maggiore disponibilità alle revisioni del
suo significato. Occorrerebbe rispettare i due fuochi che sono entrambi coinvolti nella
incessante impresa interpretativa della natura umana. Il primo è quello per cui è
costante, nell’autoriflessione dell’umano, il riferimento a qualcosa che permane e
che, nel permanere, accomuna. Il secondo è quello per cui i resoconti delle
espressioni di umanità sono mutevoli sia in relazione al tempo sia in relazione allo
spazio, fino alla irriducibilità di ogni singola individualizzazione, che nel dare forma
alla propria autointerpretazione diventa principio autonomo di libera declinazione
nella conformità e nella difformità rispetto alla natura come insieme delle condizioni
già date. E allora la natura propria dell’umano è la capacità di dare forma individuale
a ciò che è comune.
Ritorna calzante la definizione aristotelica di physis come «principio del
movimento e della quiete in una cosa». Sul punto è prezioso il commento di Robert
Spaemann: «Fin dall’origine, nella filosofia greca, physis non significa […] la pura
oggettività di una materia passiva quanto un essere sussistente, pensato in analogia
all’esperienza di sé propria dell’uomo: e cioè nel senso di una distinzione di un essere
naturale da tutti gli altri, di un sistema vivente, come si direbbe oggi, da un ambiente,
inteso come limitazione attiva, come autoaffermazione e autorealizzazione
spontanea. Physis, natura, è secondo Aristotele l’essenza delle cose che hanno il
principio, l’inizio del movimento in se stesse. In questo senso physis è certamente un
concetto che fin dall’origine serve alla distinzione»6.
La natura non viene però annullata dalla logica della individualizzazione. Essa è
proponibile come quello zoccolo di normalità basilare delle funzioni umane senza
del quale la differenziazione individuale non sarebbe possibile. Garantire per tutti e
per ciascuno una tale normalità diventa normativo, sia in rapporto ai diritti e ai doveri
dei singoli sia in rapporto alle istituzioni in cui le loro relazioni acquistano possibilità
6
R. Spaemann, ‘Naturale’ e ‘innaturale’…, p. 88.
9
di durata e di permanenza. Sotto questo profilo natura è l’insieme delle funzioni
condivise con la specie, da quelle fisiche a quelle mentali senza soluzione di
continuità, grazie alle quali si può scrivere una storia individuale nei suoi ritmi di
autorelazione e di eterorelazione.
8. Rovesciamento del rapporto tra physis e poiesis
La normalità del naturale è però integrata, nell’umano, dalla potenza (Macht)
dell’incremento delle condizioni già date. Riprendendo il tema dell’artificio da questo
angolo visuale, diciamo che, nello spazio dell’incremento delle condizioni già date,
l’artificio si dispiega come il campo dell’operare umano e dei suoi risultati. L’essere
umano è infatti comprensibile come dualità indisgiungibile di genesis e di poiesis,
(usando liberamente una coppia concettuale che mi viene suggerita da Jean
Ladriére7). La genesis è un processo di manifestazione dell’essere secondo principi
interni; la poiesis è un processo ontologico che ha il suo principio nella techne di un
artefice.
L’espansione della tecnica come apparato tecnologico sistematico e pervasivo ha
portato a due conseguenze. La prima è che la tecnologia è diventata la via maestra
della soddisfazione della normalità del vissuto, fino a rendere marginale la normalità
naturale. Ciò dà conto della qualificazione parossistica della nostra civiltà (da
Heidegger in giù fino a Severino) come dominata dall’essenza della tecnica. Dominio
della tecnica significa che la normalità tecnologica si fa normativa: adeguarsi alle
procedure della tecnica non è soltanto un habitus del vivere ma è anche la norma cui
il vivere deve adeguarsi, la sua concreta legge morale.
La seconda conseguenza è che la poiesis tecnologica si è allargata al punto tale da
entrare in circolo con la genesis. La potenza della poiesis può aspirare a farsi potenza
generativa, rompendo gli argini che distinguevano la poiesis, pur sempre vincolata
all’uso degli elementi generati dalla physis, dalla genesis. La tecnica non ritorna alla
J. Ladrière, Sur le rôle de l’idée de nature en éthique, in S. Bateman-Novaes, R. Ogien, Ph. Faro (eds.), Raison
pratique et sociologie de l’éthique, CNRS Édition, Paris 2000.
7
10
natura, dopo aver adempiuto al compito di correggerne le deficienze o di esaltarne le
prestazioni, ma può essere essa stessa naturans. Allora la domanda: una poiesis
naturans è ancora governabile secondo un’idea di permanenza della natura umana,
cioè secondo una teleologia essenziale capace di orientarla e di vincolarla, oppure si
può rendere irresponsabile nei suoi confronti? E’ questo il senso di una partita che
oggi viene giocata anzitutto sul mobile terreno della corporeità umana, e non soltanto
nei diversi modi di intervenire (o non intervenire) sulle fasi iniziale e finale della sua
manifestazione, ma anche nella gestione dei suoi stati mediani e delle sue prestazioni
quotidiane.
Il problema, nell’umano tecnologizzato, è capire quale debba essere il rapporto tra
la sfera del generare e quella del produrre, dal momento che l’attività poietica può
surclassare l’attività generativa fino a un esito di non ritorno. L’attività produttiva,
pur inizialmente insediata nell’umano, è in grado di sganciarsi dalla sua matrice
originaria e di porsi come attività sibi permissa. Può allora la natura come dinamismo
della generazione mantenere il suo controllo normativo sul produrre? Oppure, in una
relazione rovesciata, la generazione si riduce a mezzo delle finalità produttive che
declassano l’umano a momento provvisorio della operatività produttiva? E con quali
credenziali contrastare un tale declassamento?
9. L’etica a rischio
Di fronte a questa piega delle cose i concetti etici tradizionali non diventerebbero
patetici o illusori? L’esito sarebbe allora non tanto il relativismo etico quanto
piuttosto la destrutturazione delle codificazioni etiche dell’esperienza antropologica
alle nostre spalle e la condanna all’insignificanza del vocabolario morale. Finora la
persuasione che ha guidato l’umanità, e in modo eminente l’umanità occidentale, è
stata quella della insuperabilità dell’essere umano nel compimento degli atti che lo
riguardano. Considerare kantianamente l’umanità, sia nella propria persona sia nella
persona altrui, sempre anche come fine e mai come semplice mezzo è una
prescrizione comprensibile soltanto se l’essere umano deve rimanere il terminale di
11
ogni azione e non può diventare il tramite di un essere che è altro dallo stesso essere
umano. Dignità della persona, diritti dell’uomo e analoghi concetti “non negoziabili”
stanno in piedi soltanto se sostenuti da una tale persuasione. Anche nei messaggi di
salvezza religiosa il trascendimento dell’umano è pur sempre per l’umano. E, su
un’altra
sponda,
la
figura
nietzschiana
del
superuomo
non
si
risolve
nell’annullamento dell’umano, bensì ne propone il potenziamento al fine di sottrarlo
all’«orrida casualità» e alla mutilazione di uno sviluppo unilaterale.
10. Una linea di difesa
Non basta però additare le conseguenze spiacevoli. L’espansione dell’artificio
tecnologico ci porta a chiederci come possa essere giustificata la persuasione di
un’eidetica umana intrascendibile (per inciso, una persuasione che è stata condivisa
anche dallo storicismo). Michel Foucault aveva parlato dell’umano – allotropo
empirico-trascendentale8 – come di un volto disegnato sulla sabbia che può essere
cancellato dall’onda incalzante. Con quali credenziali possiamo sostenere una volontà
di umanità che non sia nostalgica velleità? Siamo attualmente nella condizione di
dover esibire i titoli della nostra capacità di continuare a essere soggetti consapevoli,
moralmente responsabili e dotati del discernimento tra il bene da fare e il male da
evitare.
Nella convinzione che l’umano ereditato sia anche l’umano da perpetuare,
possiamo fare riferimento alla tradizione antropologica e individuare delle linee di
difesa: a) non tutto ciò che si può fare deve essere fatto; b) i cambiamenti non
debbono essere fini a se stessi; c) dobbiamo garantire a chi viene dopo di noi almeno
le stesse opportunità di scelta di cui noi abbiamo goduto; d) dobbiamo contrastare la
riduzione dell’umano, in ogni uomo, a semplice materiale per un principio formale
estrinseco; e) non dobbiamo permettere che alcun individuo umano diventi un puro
mezzo per fini che non gli appartengono; f) dobbiamo consentire in ognuno
8
M. Foucault, Les mot set les choses, Gallimard, Paris 1966 ; tr. it. di E. Panaitescu, Le parole e le cose, Rizzoli,
Milano 1970³, p. 343.
12
l’espressione di ciascuna delle sue facoltà e dell’insieme delle sue facoltà. Il catalogo
può continuare.
Ma come dare fondamento a queste protezioni antropologiche che ci sono
suggerite dall’autocomprensione tradizionale dell’umano? Mettendo tra parentesi
l’aggancio al messaggio religioso, ci manteniamo di proposito nello spazio di
autonomia della riflessione razionale. E pertanto: la dignità dell’umano nei confronti
della riduzione strumentale può essere sostenuta come vincolo e come compito della
ragione?
11. Intenzionalità dell’intero e artificialità
La questione non si presta a una risposta semplice. Sul piano della descrizione
empirica, non solo non è facile riconoscere all’umano una potenza di perpetuazione
della sua natura essenziale, ma nemmeno della sua stessa esistenza. Rimanendo nei
limiti dell’esperienza, non sembra contraddittoria la prospettiva del venir meno
dell’umano. Sia le singole esperienze, sia l’esperienza dell’umano in quanto tale sono
esposte a un destino di morte. L’umano è però custode di una intenzionalità radicale
che è l’intenzionalità dell’intero9.
Ora, nell’orizzonte dell’intero ciò che si lascia mettere a tema come in pari con la
sua apertura interale è la positività dell’essere incondizionato10. Incondizionato
rispetto a che cosa? Rispetto a ogni possibilità di venir prodotto. L’essere
incondizionato è l’essere che si sottrae alla producibilità. Non è il risultato di un agire
strumentale ad opera di altri o di altro. Oltre che non essere prodotto, l’essere
Una ricca ricognizione sul tema dell’intenzionalità in A. Voltolini-C. Calabi, I problemi dell’intenzionalità, Einaudi,
Torino 2009. Impegnati nella proposta di un’antropologia complessiva sono F. Bosio, natura, mente e persona. La sfida
dell’intelligenza artificiale, Il Poligrafo, Padova 2006; A. Campodonico, Chi è l’uomo? Un approccio integrale
all’antropologia filosofica, Rubbettino, Soneria Mannelli 2007. Importante V. Melchiorre, Essere persona. Natura e
struttura, Fondazione Achille e Giulia Boroli, Novara 2007.
10
Di esso è formulazione insuperata la dizione parmenidea, secondo la quale “l’essere non può non essere”. Da questa
formulazione incondizionata dell’essere trae luce anche l’affermazione: “lo stesso è pensare e pensare che è”, se il
pensare è anzitutto intenzionalità dell’intero che trova saturazione in una positività d’essere senza limiti. Per questo
motivo l’intenzionalità interale di Parmenide non abbraccia le determinazioni molteplici. Il guadagno successivo sta
proprio nell’aggiungere che l’essere va detto pure delle molteplici determinazioni dell’intero, e ciò nonostante non sia
attualmente manifesto il modo di stare delle determinazioni nell’intero, e quindi non appaia la loro concreta
appartenenza all’intero. L’essere delle determinazioni, per la loro opacità rispetto all’intero, differisce dall’essere
dell’intero.
9
13
incondizionato è quindi improducibile. Ciò non vuol dire che deve essere inteso come
staticità e assenza di dinamismo.
Se l’essere incondizionato si dà come non producibile dalla potenza produttiva
dell’umano o, detto al contrario, la potenza produttiva dell’umano non ha potere
sull’essere incondizionato, scaturisce di riflesso la domanda sulla condizione
dell’umano in quanto soggetto produttore che è esposto al rischio di essere ridotto a
oggetto di produzione. C’è un rapporto intrinseco tra l’essere incondizionato e
l’essere condizionato che è l’ente umano? Un rapporto che sottragga quest’ultimo
all’esito di producibilità al quale è esposto dall’eccesso di artificialità? In altri
termini: come l’essere dell’umano può godere di uno statuto di irriducibile
incondizionatezza pur essendo sempre condizionato? All’ente condizionato può
essere attribuita l’incondizionatezza (una certa incondizionatezza) grazie a un
rapporto di partecipazione. L’incondizionatezza dell’ente condizionato scaturisce
dalla partecipazione all’incondizionatezza dell’essere posto come assoluto.
12. Una conclusione in forma di problema
In questa partecipazione la dignità ontologica dell’ente può poggiare su un saldo
fondamento. Come l’essere illimitato non può essere sottomesso alla logica della
produzione a opera di altri o di altro, analogamente l’essere limitato, l’umano, non
può essere ridotto alla logica della producibilità. Quindi anche l’essere umano è
principio in sé e va rispettato come tale. Non può diventare senza residui un oggetto
di produzione. Ci ricolleghiamo allora al concetto di natura come genesis o physis,
per ribadire un plesso semantico che dice la non riducibilità alla logica della
produzione, dell’essere prodotti da altro. Ed è questo il nocciolo ontologico delle
protezioni antropologiche di cui sopra si è parlato.
In definitiva: l’idea di essere come pienezza dell’umano che partecipa dell’essere
incondizionato – una pienezza inscritta nella sua natura e insieme sempre aperta a un
compimento non ancora dato – può caricarsi di valenze normative rispetto alla logica
di manipolazione e di riduzione strumentale che può condurre alla sua negazione. Se
14
per l’umano vale il riconoscimento del diritto-di-essere e del diritto-di-con-essere, su
questa base di dignità ontologica si può sostenere una normatività etica che contrasti
l’onnipotenza dell’artificio e le sue involuzioni distruttive. La dignità dell’ente, in
quanto radicata nell’essere, non può essere oscurata dalle pretese
pervasive
dell’artificio; essa diventa anzi principio di critica delle situazioni in cui l’ipertrofia
strumentale si dovesse espandere come normalità esistenziale. L’antidoto degli
antidoti consiste nella capacità di tener fermo il rapporto con l’essere. Questa capacità
esclude che l’artificio, con la sua logica di produzione strumentale, possa diventare la
totalità dell’esperienza dell’ente finito. Da essa scaturisce l’avere a cura che
l’artificio non superi i confini propri di una dimensione parziale dell’esistenza.
Il “successo” di un’etica, che attinga al principio della dignità d’essere
riconosciuta universalisticamente, deve affidarsi alla maturità delle coscienze capaci
di discernimento tra il produrre manifestativo, aperto al compimento dell’essere, e il
produrre di asservimento alla strumentalità, che da esso allontana. Questo
discernimento, se condiviso, è la condizione prima di possibilità di ogni buona
formulazione di codici e di regolamenti, e fornisce la misura di ogni scelta da
compiere nella puntualità delle situazioni e delle circostanze contingenti, mai prive di
opacità e incertezza oltre che di rischio.
Muniti di questa tutela ontologica, possiamo valorizzare la potenza dell’artificio
senza renderla devastante. Non si tratta, infatti, di coltivare la “paura dell’artificiale”
su cui Mounier rovesciava la sua caustica ironia antiborghese11; ma di fare
dell’artificio l’alleato di una superiore ominizzazione o, se si preferisce,
umanizzazione. Con queste garanzie, ci è concesso di guardare al post-umano come
potenziamento dell’umano e, quindi, della sua vita buona.
11
E. Mounier, La petite peur du XX siècle, Éditions du Seuil, Paris 1949, tr. it. a cura e con un saggio introduttivo di F.
Riva, La paura dell’artificiale. Progresso, catastrofe, angoscia, Città Aperta, Troina 2007.
15