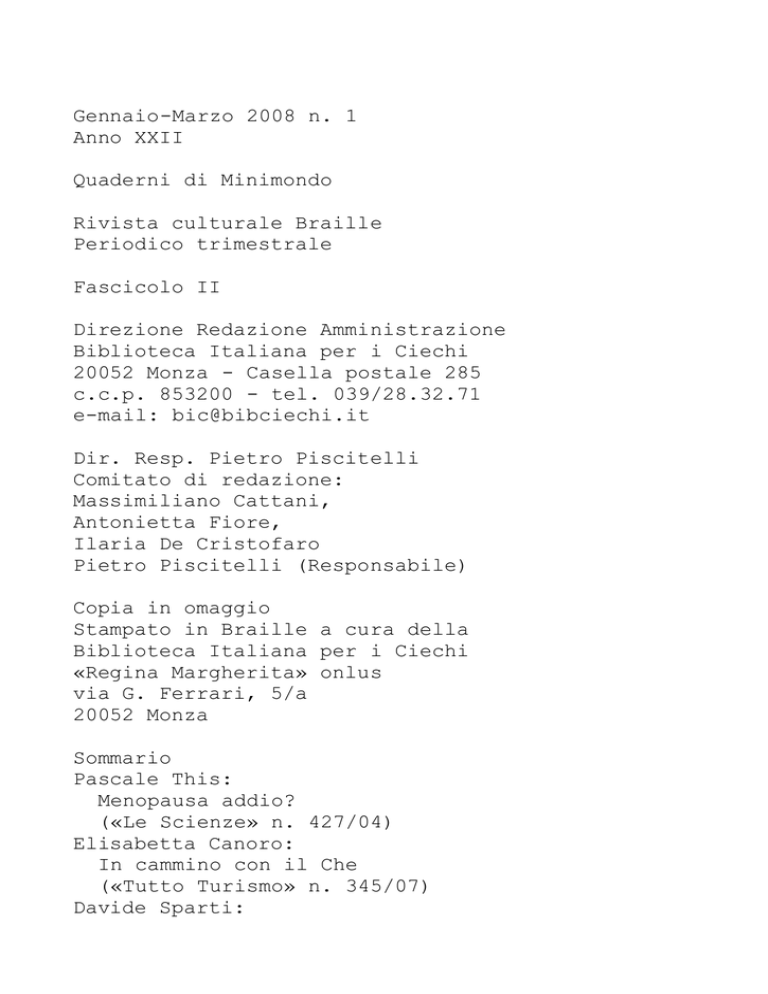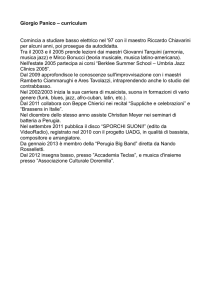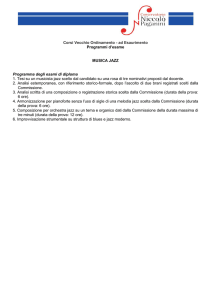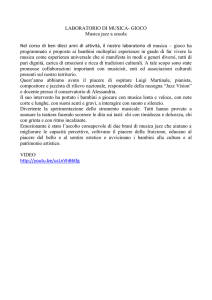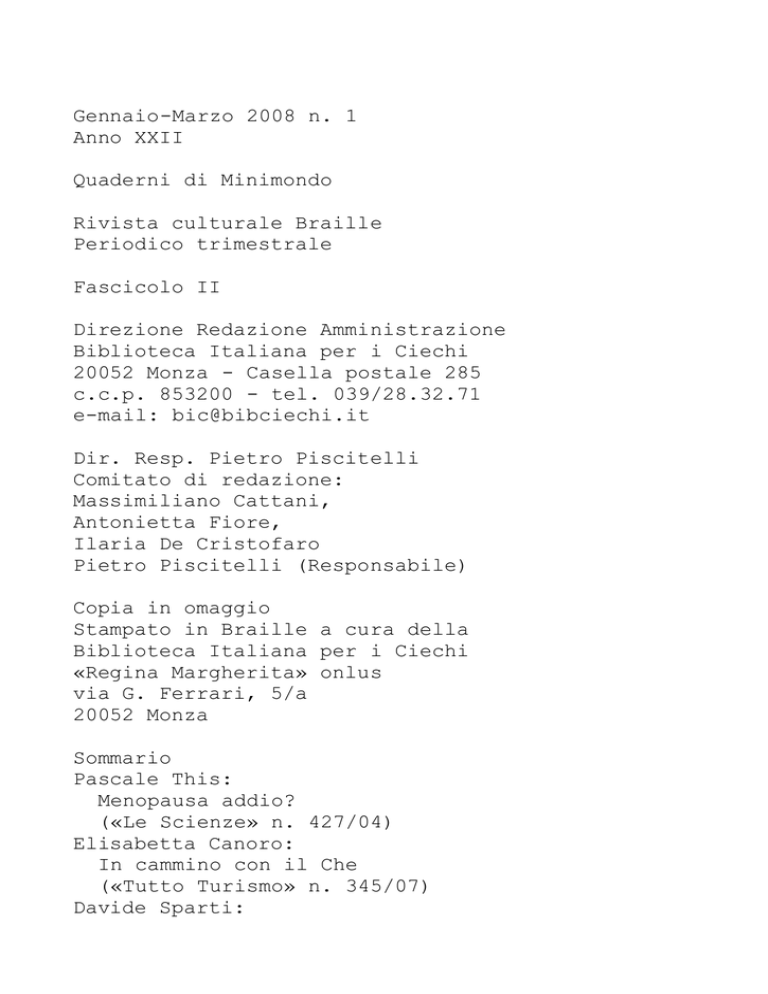
Gennaio-Marzo 2008 n. 1
Anno XXII
Quaderni di Minimondo
Rivista culturale Braille
Periodico trimestrale
Fascicolo II
Direzione Redazione Amministrazione
Biblioteca Italiana per i Ciechi
20052 Monza - Casella postale 285
c.c.p. 853200 - tel. 039/28.32.71
e-mail: [email protected]
Dir. Resp. Pietro Piscitelli
Comitato di redazione:
Massimiliano Cattani,
Antonietta Fiore,
Ilaria De Cristofaro
Pietro Piscitelli (Responsabile)
Copia in omaggio
Stampato in Braille a cura della
Biblioteca Italiana per i Ciechi
«Regina Margherita» onlus
via G. Ferrari, 5/a
20052 Monza
Sommario
Pascale This:
Menopausa addio?
(«Le Scienze» n. 427/04)
Elisabetta Canoro:
In cammino con il Che
(«Tutto Turismo» n. 345/07)
Davide Sparti:
Jazz: dalle piantagioni alle metropoli
(«Prometeo» n.100/07)
Menopausa addio?
- I trattamenti ormonali della menopausa
migliorano la qualità di vita e prevengono
l'osteoporosi, ma aumentano leggermente il rischio
di cancro del seno. Il medico deve valutare
benefici e svantaggi per prescrivere terapie
calibrate su ciascuna donna. L'obiettivo delle terapie sostitutive a base di
estrogeni per le donne in menopausa è la riduzione
degli effetti indesiderati dell'arresto di
produzione degli ormoni femminili, ma da qualche
tempo i risultati di due studi anglosassoni hanno
riportato al centro del dibattito la loro
eventuale pericolosità e il ruolo che possono
svolgere nella vita delle donne. I cicli mestruali
ritmano l'esistenza femminile dalla pubertà alla
menopausa. Le ovaie liberano un ovocita pronto a
essere fecondato da uno spermatozoo, e immettono
nel circolo sanguigno gli ormoni femminili,
estrogeni e progesterone, che predispongono la
matrice uterina all'eventuale gravidanza. Alla
fine di ogni ciclo, il calo delle concentrazioni
ormonali dà il via alle mestruazioni. La menopausa
corrisponde all'estinzione delle due funzioni
delle ovaie femminili, vale a dire l'ovulazione e
la secrezione ormonale. Ne consegue una perdita di
fertilità accompagnata da deficit di estrogeni e
progesterone: una carenza che spesso ha effetti
spiacevoli.
Nel breve periodo possono subentrare vampate di
calore, accompagnate a volte da malessere e
palpitazioni cardiache. Il sonno può essere
turbato da episodi di sudorazione notturna che
impediscono un riposo soddisfacente, causando una
spossatezza che può portare all'irritabilità. I
medici parlano di sintomi del «climaterio», che
significa «periodo critico». Un'altra conseguenza
della menopausa riguarda la sessualità: private
dell'azione nutritiva degli estrogeni, le mucose
genitali sono soggette a secchezza, che può
rendere dolorosi i rapporti sessuali. Altri
sintomi, come la depressione, la stanchezza o
l'aumento di peso, sono meno specifici: non è
sempre possibile distinguere con chiarezza se
siano dovuti alla carenza di estrogeni e non,
piuttosto, ai molti sconvolgimenti che si
verificano nella vita delle donne attorno alla
cinquantina. La carenza ormonale comporta poi, a
lungo termine, la demineralizzazione e
l'infragilimento delle ossa, che rischiano di
fratturarsi al minimo urto: è l'osteoporosi. Verso
i settant'anni, possono verificarsi assestamenti
delle vertebre lombari (la statura diminuisce di
alcuni centimetri) e fratture del polso. E, verso
gli ottant'anni, fratture del collo del femore.
Tra i clinici, esistono due visioni contrapposte
della menopausa. Per alcuni si tratta di una
malattia di carenza che richiede una terapia di
sostituzione, esattamente come accade ai malati di
insufficienza funzionale della tiroide o delle
ghiandole surrenali, a cui vengono somministrate
terapie ormonali sostitutive. Altri medici vedono
invece la menopausa come uno dei vari elementi di
un processo generale di invecchiamento, da
considerare nella sua globalità.
Per molto tempo, la menopausa non ha
rappresentato un grosso problema: i parti o le
malattie (in particolare quelle infettive)
uccidevano un gran numero di donne ben prima che
compissero cinquant'anni. Inoltre, le donne che
arrivavano alla cinquantina avevano vissuto in
condizioni molto diverse da quelle attuali: a
cinquant'anni, spesso si era già nonne, se non
addirittura bisnonne, e una donna non aveva
davanti a sé la stessa aspettativa di vita di cui
gode oggi. La svolta è avvenuta negli anni
sessanta, quando un medico statunitense, Robert
Wilson, si propose di restituire alle donne in
menopausa gli ormoni che le loro ovaie non
producono più. Dal momento che le donne in
menopausa soffrono di sintomi di carenza di
estrogeni, Wilson raccomanda un trattamento di
sostituzione: il suo libro Feminine for ever, del
1965, fu un immenso successo.
«Le donne non saranno realmente emancipate
finché non saranno soppresse le costrizioni
imposte dalle carenze ormonali. Solo allora
potranno realizzarsi pienamente, senza
interrompere la ricerca di una salute mentale e
fisica duratura», si legge nella prefazione del
libro, firmata da un altro specialista della
menopausa, R.B. Greenblatt.
Elisir di giovinezza?
Milioni di donne americane, sedotte da questa
possibilità, decisero di assumere estrogeni,
ottenendo un miglioramento della qualità della
loro vita: le vampate di calore scompaiono, le
mucose ritrovano la loro elasticità, il sonno
torna a essere ristoratore. Qualche anno più
tardi, però, gli epidemiologi iniziarono a
riscontrare nelle donne in cura con estrogeni una
maggiore incidenza di cancro dell'endometrio (la
mucosa che riveste l'utero): si scoprì allora che
è indispensabile accoppiare gli estrogeni con il
progesterone (l'altro ormone femminile) al fine di
scongiurare il pericolo.
Nel frattempo, le terapie ormonali sostitutive
avevano attraversato l'Atlantico, diffondendosi
tra le donne europee; parallelamente, i progressi
dell'industria farmaceutica permisero la sintesi
di estrogeni e di prodotti «progestinici» (che
hanno una certa parentela con il progesterone).
Alcuni di essi assomigliano sempre di più agli
ormoni naturali, e alcune terapie vengono proposte
per via cutanea, sotto forma di gel da spalmare, o
di cerotti da applicare, sulla pelle. Oggi, gran
parte dei medici privilegia i trattamenti più
simili agli ormoni naturali, e la via non orale
per gli estrogeni (evitando così un primo
passaggio dei composti attraverso il fegato e
l'attivazione di certi metaboliti indesiderabili),
che consente di imitare al meglio la natura,
riproducendo artificialmente il ciclo.
Il successo della terapia sostitutiva è legato
al miglioramento della qualità della vita
garantito dagli ormoni (specialmente all'inizio
della menopausa, quando i sintomi del climaterio
sono particolarmente sgradevoli) e, probabilmente,
a una migliore accettazione della menopausa
stessa: malgrado la perdita ineluttabile della
fertilità, le donne che seguono una terapia
ormonale conservano un buon livello di estrogeni e
una sessualità attiva. Oggi, le donne sulla
cinquantina sono professionalmente attive, e
spesso hanno figli non ancora adolescenti, perché
hanno ritardato la maternità fino a 40 anni;
l'immagine della nonna rotondetta e paciosa è un
ricordo del passato. In realtà, gli inconvenienti
della menopausa sono però solo rinviati, e saranno
destinati a riapparire al termine del trattamento,
sebbene la demineralizzazione delle ossa venga
notevolmente ritardata.
L'introduzione delle terapie ormonali
sostitutive è stata quindi quasi fortuita. La
storia della medicina è ricca di scoperte fatte
per caso o per necessità, nella solitudine di uno
studio medico o su un bancone di laboratorio, e
che hanno salvato moltissime vite. Al giorno
d'oggi, tuttavia, la messa a punto dei farmaci si
basa su una serie di studi, inizialmente in
laboratorio, poi su animali e infine su volontari
umani, nel corso dei quali si valuta il meccanismo
di azione dei composti, il loro profilo
farmacologico, la loro tossicità e la loro
efficacia. Spesso, ci vogliono parecchi anni prima
che una terapia sia messa in commercio (con i
vincoli attuali, certi «vecchi» farmaci non
avrebbero mai potuto ottenere l'autorizzazione
alla commercializzazione). Resta comunque un
problema: come valutare gli effetti a lunghissimo
termine di un composto in relazione al rischio di
comparsa di malattie come le patologie coronariche
o l'osteoporosi, o ancora di tumori a lento
sviluppo?
Una soluzione è osservare l'effetto di queste
terapie su popolazioni, valutando la frequenza di
una data malattia tra le persone trattate e in
quelle che non assumono il trattamento: i
cosiddetti studi osservazionali. A partire dagli
anni ottanta, sono stati pubblicati numerosi studi
di questo tipo sulle terapie ormonali per la
menopausa, studi che, nell'insieme, fornivano un
quadro piuttosto roseo della situazione: un certo
numero di essi confermava che le donne sottoposte
a terapia sostitutiva erano meno soggette a
malattie cardiovascolari (angina pectoris e
infarto del miocardio) di quelle che non seguivano
la stessa terapia. Anche la mortalità risultava
diminuita rispetto a quella delle donne non
trattate, la densità del tessuto osseo più elevata
e il rischio di fratture del collo del femore e di
assestamento delle vertebre lombari era ridotto. A
questi elementi positivi si aggiungeva il fatto
che le terapie sostitutive miglioravano la qualità
della vita di coloro che, nelle prime fasi della
menopausa, soffrivano dei sintomi del climaterio:
insomma, grazie a questi trattamenti, le donne
avevano trovato uno strumento per spostare in
avanti i limiti dell'età.
Ma in questo quadro idilliaco c'era un'ombra:
tra le donne che seguivano la terapia l'incidenza
del tumore del seno risultava leggermente più
alta, e il rischio sembrava aumentare con la
durata del trattamento. Tuttavia, questo lieve
incremento sembrava compensato dal fatto che
queste donne, sorvegliate in modo particolarmente
attento con screening mammografico, presentavano
tumori del seno di piccole dimensioni, perché
scoperti precocemente, e quindi avevano una buona
prognosi.
L'inizio degli anni novanta corrisponde all'età
dell'oro delle terapie sostitutive per la
menopausa. Una rassegna molto importante degli
studi riguardanti i benefici e i rischi di questi
trattamenti fu pubblicata nel 1992 sugli «Annals
of Internal Medicine» da D. Grady, illustre
epidemiologo. Il titolo dell'articolo rispecchia
bene l'attitudine del decennio: I trattamenti
ormonali per prevenire le malattie e prolungare la
vita delle donne in menopausa.
I primi motivi di inquietudine
Alcuni epidemiologi manifestavano però delle
riserve: anche se gli studi osservazionali sono
interessanti, comportano l'eventualità di errori
di interpretazione. In effetti, le donne che
scelgono una terapia di sostituzione ormonale sono
un po' diverse dalle altre: per esempio,
generalmente sono più snelle e appartengono a un
ambiente socio-economico più agiato. La stessa
scelta di sottoporsi a un trattamento prolungato
seleziona le donne più inclini a curare la propria
salute, che vanno spesso dal medico, stanno
attente all'alimentazione, e così via.
Per evidenziare i possibili errori sistematici
nell'interpretazione dei dati vi era una sola
soluzione: bisognava realizzare studi
sperimentali. In questo secondo genere di indagini
sono i ricercatori che intervengono attivamente,
definendo sia il profilo delle donne che saranno
coinvolte nello studio sia i trattamenti che
saranno valutati, che sono confrontati con un
trattamento neutro, un cosiddetto placebo, per
eliminare il fattore psicologico legato
all'assunzione del farmaco. Il trattamento attivo
e il placebo, infine, sono assegnati a sorte: né i
pazienti né i medici conoscono la natura delle
terapie assegnate, e si parla per questo di
sperimentazioni in «doppio cieco». Soddisfacendo
tutte queste condizioni, si cerca di mettere a
confronto gruppi che differiscono solo rispetto al
trattamento studiato.
In materia di menopausa, esistono poi ulteriori
problemi: da una parte, le sperimentazioni
terapeutiche riguardano più comunemente donne già
avanti nell'età, che non soffrono più dei sintomi
del climaterio (è difficile immaginare che una
donna afflitta dalle vampate sia disposta ad
assumere un placebo per anni!). D'altro canto, è
impossibile rispettare il doppio cieco quando
basta la comparsa delle perdite periodiche di
sangue per sapere con certezza che si sta
ricevendo un principio attivo. Infine, queste
sperimentazioni sono assai costose e il loro
finanziamento è talvolta difficile.
A partire dal 1993, negli Stati Uniti è stato
varato un grande programma per studiare i benefici
e i rischi di differenti strategie di prevenzione
delle malattie cardiovascolari, dei tumori del
seno e del colon, e dell'osteoporosi nelle donne
in menopausa. Tra il 1993 e il 1998, più di
160.000 donne hanno partecipato a sperimentazioni
terapeutiche diverse, che riguardavano l'effetto
delle diete povere di grassi, delle integrazioni
di calcio e vitamina D, e delle terapie ormonali
sostitutive. In particolare, è stato varato lo
studio WHI (Womens' Health Initiative), una
ricerca di prevenzione cosiddetta «primaria», vale
a dire condotta su soggetti sani; queste donne
assumevano sia una terapia sostitutiva molto
utilizzata negli Stati Uniti (estrogeni equini con
un progestinico di sintesi chiamato MPA), sia un
placebo. L'obiettivo principale dei medici era
valutare il rischio di malattie cardiovascolari e
di cancro del seno legato al trattamento, ma
veniva registrato anche il sopravvenire di altri
eventi (tumori del colon, fratture del collo del
femore o attacchi vascolari cerebrali).
Nel corso di ogni sperimentazione terapeutica,
un comitato di sorveglianza indipendente si
riunisce regolarmente per confrontare il numero di
eventi nei due gruppi. Se in uno di essi appare un
effetto positivo o negativo, e se questi effetti
sono ritenuti «significativi» (cioè non possono
essere spiegati semplicemente dal caso), la
sperimentazione viene interrotta per non recare
svantaggio a un gruppo o all'altro. Progettando lo
studio WHI, a cui hanno partecipato migliaia di
donne americane, i clinici erano convinti che le
terapie sostitutive proteggessero le donne dalle
malattie coronariche, e quindi sarebbero state più
efficaci del placebo nel diminuire il rischio di
contrarre queste patologie. Ma nel luglio del
2002, poco più di cinque anni dopo l'inizio, lo
studio è stato interrotto: non solo i casi di
tumori del seno tra le donne che assumevano ormoni
superavano il limite fissato dagli organizzatori
della sperimentazione, ma tra le volontarie che
assumevano il placebo si notava un'incidenza
lievemente inferiore di attacchi vascolari
cerebrali, malattie coronariche ed embolie
polmonari. In compenso, tra le donne a cui veniva
somministrato il principio attivo si registravano
meno casi di tumori del colon e di fratture del
collo del femore, mentre non c'erano cambiamenti
nel rischio di cancro dell'utero. L'interruzione
(inevitabile) dello studio WHI è stata ampiamente
ripresa dai mass media, e il consumo di ormoni
sostitutivi è notevolmente calato, specialmente
negli Stati Uniti.
Tuttavia, a dispetto della sua eccellente
progettazione, lo studio aveva dei limiti: le
partecipanti erano più anziane, obese e ipertese
della media della popolazione femminile. Inoltre
gli effetti negativi registrati, particolarmente a
livello vascolare, potrebbero essere attribuiti
alla natura e al dosaggio dei composti sintetici
utilizzati nello studio. Purtroppo non esistono
studi analoghi condotti con formulazioni usate in
altri paesi, più simili agli ormoni naturali.
Il tumore del seno al centro del dibattito
Lo studio WHI ha indicato che la terapia
ormonale sostitutiva, e, nella fattispecie, quella
a base di estrogeni equini e di MPA, aumenta il
rischio di cancro del seno. Trattandosi di uno
studio sperimentale, dove le donne erano seguite
clinicamente in modo analogo in entrambi i gruppi,
esiste ormai un argomento forte per pensare a un
rapporto causale tra l'assunzione di questo tipo
di terapia ormonale e l'aumento di incidenza del
tumore del seno. Certo, si tratta di un aumento
lieve, ma che va inquadrato in un contesto: il
cancro del seno è il primo fra i tumori maligni
femminili. In Italia si ammalano ogni anno circa
33.000 donne, corrispondenti al 20-25 per cento di
tutti i tumori che colpiscono le donne, e nei 15
paesi dell'Unione Europea vengono diagnosticati
oltre 210.000 nuovi casi ogni anno. Inoltre,
l'incidenza della patologia sta aumentando a un
ritmo dell'uno per cento circa all'anno. Perché
questo aumento? Le risposte sono varie, e
riguardano sia una maggiore capacità di diagnosi
sia l'influenza degli stili di vita. Oggi, per una
donna «standard» (cioè senza particolari fattori
di rischio), il rischio di cancro del seno nel
corso della vita è circa del 10 per cento, ma
aumenta con l'età: a 50 anni, il rischio di avere
un cancro del seno nei 10 anni successivi è del
2,5 per cento.
Esistono situazioni in cui il rischio è più
marcato: è il caso delle donne di cui almeno due o
tre familiari abbiano avuto un cancro del seno,
soprattutto se si tratta di parenti di primo grado
(madre, sorelle o figlie). In alcuni casi, questo
rischio supplementare è legato alla presenza in
ambito familiare di una mutazione genetica che
predispone al cancro del seno, e in queste
situazioni il rischio è circa da otto a 10 volte
superiore a quello della popolazione generale.
Alcune patologie della mammella, come il carcinoma
lobulare in situ o l'iperplasia atipica, sono
anch'esse associate a un incremento del rischio,
che diventa da quattro a otto volte superiore alla
media. Ai tre principali fattori di rischio (età,
precedenti familiari e patologie del seno) se ne
potrebbe poi aggiungere un quarto, attualmente
allo studio, vale a dire una maggiore densità
mammografica del seno (che all'analisi risulta
molto «bianco»).
Il rischio ormonale è stato separato da questi
fattori. In effetti, vi sono situazioni che, in
rapporto all'assunzione di ormoni, sembrano
associate a una maggiore incidenza del tumore del
seno: le donne che hanno avuto un menarca precoce
(prima dei 12 anni), una menopausa tardiva (dopo
55 anni), una prima gravidanza tardiva (dopo 30
anni) presentano un rischio di cancro del seno un
po' più elevato (da 1,2 a 2 volte) delle altre.
Ormoni e anti-ormoni
A seconda degli studi, dei composti (soli
estrogeni o associazione di estrogeni e
progestinici) e della durata della terapia, il
rischio di cancro del seno nelle donne che
assumono una terapia ormonale sostitutiva appare
moltiplicato per un fattore che va da 1,2 a 1,4, a
volte a 1,8, quindi un rischio esiguo, se
confrontato con quello derivato, per esempio, da
una predisposizione genetica, che viene di
conseguenza definito «rischio relativo».
Il rischio supplementare legato alla terapia
sostitutiva è legato agli ormoni. Alcuni studi
hanno dimostrato che una donna di 55 anni non
ancora in menopausa ha lo stesso rischio di cancro
del seno di una sua coetanea che segue il
trattamento da cinque anni, ma superiore a quello
di una donna della stessa età entrata in menopausa
a 50 anni, che però non ha assunto ormoni
sostitutivi. L'elemento decisivo sembra quindi la
durata dell'esposizione agli estrogeni: più lungo
è il periodo più aumenta il rischio.
Un punto interessante rilevato dagli studi è che
il rischio diminuisce molto rapidamente al termine
della terapia e a poco più di un anno dalla
cessazione del trattamento, torna identico a
quello di chi non ha seguito la terapia. Questo è
perfettamente coerente con ciò che si sa del
tumore del seno, che gli oncologi definiscono
ormoni-dipendente, poiché, nella maggior parte dei
casi, le cellule tumorali presentano recettori per
gli estrogeni destinati a fissare l'ormone. Il
seno è controllato dagli ormoni, e le cellule
destinate a recepirli sono sensibili agli effetti
positivi, ma anche negativi, di queste sostanze.
D'altronde, i clinici hanno notato che la
soppressione dell'attività delle ovaie permette la
regressione dei tumori del seno già estesi e
diminuisce il rischio di recidiva. Attualmente, la
terapia dei tumori della mammella in fase precoce
si basa quasi sempre sull'associazione di un
trattamento locale (chirurgia o radioterapia) e di
un trattamento generale che tende a ridurre
l'eventualità di recidiva della malattia
eliminando eventuali cellule cancerose residue per
mezzo di chemioterapia o di un trattamento antiormonale. A questa seconda categoria appartiene il
composto tamoxifene, che impedisce agli estrogeni
di fissarsi ai propri recettori, contrastando così
la loro azione. Altri composti, gli inibitori
dell'aromatasi, fanno invece diminuire la
produzione di estrogeni.
Alcuni di questi trattamenti sono utilizzati
anche nelle donne in menopausa, poiché, benché le
loro ovaie non producano più direttamente
estrogeni, ne esiste tuttavia una produzione
indiretta, dovuta ad alcuni enzimi (appunto, le
aromatasi), in grado di trasformare in estrogeni
gli ormoni androgenici prodotti nelle ovaie o
nelle ghiandole surrenali. In definitiva, oggi
gran parte della lotta contro il cancro del seno
consiste in una lotta contro gli estrogeni.
Contemporaneamente all'aumento delle conoscenze
sugli effetti delle terapie ormonali sostitutive,
hanno cominciato a essere sviluppati alcuni
trattamenti per la menopausa non basati su
estrogeni. Per esempio, un anti-ipertensivo (la
clonidina) e un anti-depressivo (la venfalaxina)
attenuano alcuni dei sintomi più fastidiosi del
climaterio, come le vampate, mentre la secchezza
delle mucose genitali può essere affrontata con
prodotti ad applicazione locale contenenti
derivati degli estrogeni (il promestriene).
Per quel che riguarda la prevenzione delle
malattie coronariche, una delle armi principali
riguarda lo stile di vita. Uno studio
epidemiologico su vasta scala ha mostrato che le
donne snelle, non fumatrici, che praticano 30
minuti di attività fisica al giorno, bevono poco
alcool e seguono una dieta ricca in fibre e povera
in grassi saturi, sono ben protette dalle malattie
coronariche. Per le donne con concentrazione
elevata di colesterolo, o che mostrano un rischio
aumentato di malattie coronariche, c'è una classe
particolare di farmaci, le statine, che ha
un'efficace azione preventiva. Contro
l'osteoporosi, disponiamo di farmaci della classe
dei bifosfonati (aledronato e risedronato), che
fanno aumentare la densità ossea.
Un altro composto che presenta proprietà
interessanti è il raloxifene che, come il
tamoxifene, appartiene alla classe dei SERM
(Selective Estrogen Receptor Modulator, modulatori
selettivi del recettore per gli estrogeni). Questo
composto presenta un'affinità per il recettore
degli estrogeni, sul quale va a fissarsi. La sua
azione finisce così col riprodurre (effetto
agonista) o viceversa col contrastare (effetto
antagonista) l'azione degli estrogeni a seconda
dei tessuti. E raloxifene è un agonista degli
estrogeni sul tessuto osseo, quindi migliora la
densità ossea. Sul tessuto mammario, il raloxifene
si comporta al contrario come un anti-estrogeno:
uno studio statunitense basato su donne affette da
osteoporosi ha dimostrato che le donne in terapia
con raloxifene avevano un'incidenza nettamente
inferiore di cancro del seno rispetto a quelle che
assumevano il placebo. Contrariamente al
tamoxifene, il raloxifene non ha effetti di
stimolazione sull'utero - il che è un vantaggio ma non ha neppure effetti sui sintomi del
climaterio, e in particolare sulle vampate di
calore, che tendono anzi ad aumentare.
Le nuove regole del gioco
La vicenda delle terapie ormonali per la
menopausa è un esempio efficace di come alcune
pratiche cliniche (in questo caso, la vasta
prescrizione dei trattamenti sostitutivi) si
possano affermare a partire da nozioni intuitive
(la sostituzione degli ormoni ovarici) e da
esigenze sociali (il cambiamento di status della
donna in menopausa). Per confermare o meno le
certezze su cui si fondavano le prescrizioni dei
medici è stato necessario un grande studio
epidemiologico. Ma oggi emergono nuove regole, che
riguardano l'analisi dei dati scientifici secondo
il concetto della «medicina fondata sulle prove»,
le strategie basate sulla valutazione del rapporto
costi/benefici, l'informazione ai pazienti e il
processo della decisione terapeutica.
Il primo a formalizzare il concetto di «medicina
fondata sulle prove» è stato, nel 1980,
l'epidemiologo americano David Sackett: di fronte
a un problema clinico, i medici formulano
chiaramente una domanda, passano in rassegna la
letteratura relativa, ne valutano la qualità e
l'applicabilità delle conclusioni e, solo a questo
punto, decidono una linea di condotta.
Come abbiamo visto, un grande studio
«randomizzato» in doppio cieco avrà un livello di
prova elevato, vale a dire che i medici
assegneranno a esso un peso notevole. Lo stesso
vale per una meta-analisi, che è una sorta di
sintesi delle ricerche che sono state effettuate.
Gli studi osservazionali, come gli studi di coorte
o gli studi caso-controllo, hanno invece un valore
di prova inferiore, poiché possono presentare
errori sistematici. Gli studi descrittivi (su
serie di pazienti) vengono ancora dopo, seguiti a
loro volta dalle opinioni dei comitati di esperti
e infine dalle esperienze individuali.
Oggi, gli approcci clinici (per esempio per il
trattamento dei tumori del seno in fase iniziale)
sono definiti da esperti di differenti specialità,
in funzione delle conoscenze mediche attuali,
classificate per livello di valore probante.
Quando una terapia ha dato chiaramente prova della
propria superiorità, o della sua efficacia nel
trattamento di una malattia, diviene il
trattamento standard; in compenso, quando non è
possibile scegliere perché ciascun trattamento
presenta rischi e benefici, il medico sceglierà
una delle opzioni terapeutiche in base alle
caratteristiche individuali di ogni paziente e
alla valutazione del rapporto rischi/benefici. Nel
caso specifico, la prescrizione di una terapia
sostitutiva ormonale a breve termine
(miglioramento della qualità della vita) e a lungo
termine (prevenzione dell'osteoporosi) sarà
soppesata con i rischi correlati (aumento del
rischio di cancro del seno o di malattie
cardiovascolari).
Scelta condivisa o soluzione ideale?
È probabile che, in futuro, ogni donna avrà la
possibilità di scegliere, assieme al proprio
medico, se astenersi del tutto dalla terapia o se
seguire trattamenti differenti (ormonali o no) in
funzione dei propri sintomi e del proprio profilo
di rischio. Ma lo sviluppo di composti specifici
permetterà forse di uscire da questo dilemma,
proponendo alle donne il trattamento ideale,
efficace al contempo sui sintomi del climaterio e
per la prevenzione dell'osteoporosi, ma senza
provocare un aumento di rischio del cancro del
seno.
Tuttavia, poiché come l'etica delle
sperimentazioni terapeutiche ne prevede
l'interruzione quando uno dei due gruppi di
pazienti risulti chiaramente svantaggiato, è
facile immaginare che sarà molto difficile
allestire grandi studi di lunga durata basati su
migliaia di donne e su criteri di giudizio
multipli. Per contenere il problema, gli
epidemiologi oggi iniziano a ricorrere alle
simulazioni informatiche. Per esempio, se si cerca
di confrontare l'effetto di un trattamento A e di
un trattamento B in 10.000 donne aventi un profilo
ad alto rischio di cancro del seno, è il computer,
tenendo conto dei dati esistenti in letteratura, a
determinare per mezzo di particolari algoritmi il
numero di eventi favorevoli e sfavorevoli indotti,
calcolando il beneficio netto di ciascun
approccio. Purtroppo, questo metodo presenta degli
inconvenienti, visto che il computer non fa che
utilizzare i dati forniti dai ricercatori, dati
che potrebbero essere viziati da errori, oppure
insufficienti. Nel campo delle terapie per la
menopausa, per esempio, mancano studi rigorosi che
prendano in considerazione anche la qualità della
vita. Questo parametro, del resto poco
quantificabile, viene dunque incluso molto
raramente nelle analisi rischi/benefici, mentre
spesso si amplifica una visione allarmista dei
rischi di cancro.
L'applicazione cieca e tirannica di queste
strategie non ha quindi molto senso nella pratica
quotidiana, ma le scelte dei medici non possono
nemmeno fondarsi solo su convinzioni ed esperienze
personali. Cosa può fare allora il medico, per
aiutare una donna che si avvicina alla menopausa?
Anzitutto, informarla sui dati attualmente
disponibili in merito alle terapie di sostituzione
ormonale, e segnalare le altre possibili opzioni
terapeutiche. Ma, anche se questa informazione è
assolutamente necessaria, occorre che venga
trasmessa nell'ambito di un dialogo tra la donna e
il medico: l'informazione e la scelta sono
separate da un lungo percorso, e l'informazione in
sé e per sé, avulsa dai problemi specifici della
donna che chiede aiuto, è di scarso interesse.
L'atteggiamento migliore, e più utile, sarà quindi
quello che chiama in causa, al di là di tutti i
progressi scientifici, l'«arte» del medico, che
dovrà essere capace di aiutare la donna, in
funzione delle priorità da lei poste, e dei suoi
valori, a scegliere con piena cognizione di causa,
la strada migliore per vivere la menopausa.
Pascale This
(«Le Scienze» n. 427/04)
In cammino con il Che
- Per scoprire i luoghi dove ha vissuto e
combattuto il più amato paladino della libertà. E
per cogliere i frutti della sua Revolución. «Da bambina era soprattutto l'affetto delle
persone per papà che mi ricordava di essere la
figlia del Che».
Aleida Guevara aveva sei anni quando suo padre
morì, l'8 ottobre 1967. Di lui non ricorda il
combattente, ma la tenerezza dei rari momenti
strappati alla storia e trascorsi insieme. Ci
accoglie nella piccola anticamera della casa
dell'Avana che per ultima, a Cuba, ospitò il Che.
«Aleidita», come viene soprannominata, è fiera e
risoluta come suo padre, nei suoi occhi c'è lo
stesso sguardo ipnotico, anche se sostiene: «Non
gli somiglio per niente».
Ci apre le porte del Centro de Estudios Che
Guevara che, in fase di completamento, è frutto di
un progetto per sostenere i bambini bisognosi.
Disposto su due piani, ospiterà, tra l'altro, una
mostra permanente sulle imprese del Comandante e
rassegne temporanee che approfondiranno singole
fasi della sua vita.
Ernesto Guevara de la Serna è l'emblema di ogni
movimento di liberazione perché, come disse egli
stesso, «sarei pronto a dare la vita per la
liberazione di un qualunque Paese latinoamericano,
senza chiedere nulla a nessuno, senza pretendere
nulla...». Di Cuba, però, fece la sua seconda
patria: «Sono nato in Argentina, non è un segreto
per nessuno», disse. Ma aggiunse: «Sono cubano e
sono anche argetino...».
Il Che è l'emblema dell'Eroico Guerrigliero,
modello di virtù, simbolo dell'amore
disinteressato, dello spirito di sacrificio
estremo, archetipo sottratto alla storia per
diventare, come scrive Giovanni Sole in Che
Guevara. Il sogno rivoluzionario, un «eroe
solitario, un cavaliere errante che sogna di
cambiare il mondo e se stesso». Proprio come Don
Chisciotte, folle mito letterario del romanzo di
Miguel de Cervantes che il Che lesse ben sette
volte.
A 40 anni dalla sua morte la forza del ricordo
di Che Guevara e di quello che ha rappresentato
per intere generazioni è ancora viva. Ed è per
tornare alle origini del mito e ritrovarlo là dove
questo si è costruito che siamo andati sulle sue
tracce. Abbiamo attraversato Cuba ripercorrendo il
suo camino rivoluzionario, spingendoci nei boschi
della Sierra Maestra e dell'Escambray, dove i
ribelli si nascosero per organizzare la lotta
armata. Con loro siamo entrati vittoriosi a Santa
Clara e abbiamo proseguito la lunga marcia fino a
L'Avana e poi ancora oltre... Per scoprire che
cosa è cambiato e cosa c'è da cambiare, quello che
del loro sogno è rimasto e ciò che deve ancora
avverarsi.
L'Avana, capitale della revolución
Dall'ultimo piano dell'Hotel Habana Libre si
gode una delle migliori panoramiche sulla
capitale. La vista sorvola i palazzi e accarezza
le onde che s'infrangono sul muraglione del
Malecón, il lungomare che costeggia la città per
sette chilometri dal Castello de la Punta alla
foce dell'Almendares. E ancora oltre, fino al
porto, al Castello el Morro e, quando il cielo è
terso, anche fino a Miami, lontana ma vicina.
Battezzato Habana Libre dai ribelli che lo
occuparono dopo el triunfo de la Revolución, l'ex
Havana Hotel è uno dei simboli della Cuba del dopo
Batista da quell'8 gennaio 1959 quando Fidel
Castro entrò vittorioso in città. Il suo ufficio
si trovava alle spalle del Memorial José Martí,
eroe nazionale, che domina la maestosa plaza de la
Revolución, palcoscenico delle adunate nel corso
delle quali Castro ha infiammato centinaia di
migliaia di cubani. A L'Avana, Guevara era entrato
qualche giorno prima, il 2 gennaio 1959, su ordine
del Comandante in capo e aveva occupato la
Fortaleza de La Cabaña, la fortezza spagnola posta
a guardia del porto, per farne il suo quartier
generale. Addentrandosi per le vie del centro
storico, l'Habana Vieja, oggi dichiarato
dall'Unesco «patrimonio dell'umanità», il volto
del Che si ritrova ovunque: sulle cartoline, i
dipinti e le magliette in vendita nel colorato
mercado artigianale. Sulle copertine dei libri
esposti nel mercatino dei libri usati di plaza de
las Armas, la più antica piazza cittadina. Sui
murales insieme al volto sorridente, la famosa
sonrisa, di Camilo Cienfuegos, inseparabile amico
e compagno di battaglia, accanto all'immagine di
Fidel e degli altri protagonisti della Revolución.
Del Che parla con orgoglio la gente che
s'incontra per strada. «Se ci fosse stato il Che
questo non sarebbe successo», si sente spesso
dire. «Per capire che cosa rappresenti davvero mio
padre per la nostra gente bisogna entrare nelle
loro case e ascoltare la loro musica», ci aveva
spiegato Aleida Guevara. I cubani, infatti, lo
ricordano nelle loro canzoni e non c'è
appartamento senza un ritratto del Generale. Lo
amano perché era uno di loro, che con il popolo ha
sofferto e lottato. Fino alla fine. «Hasta la
victoria siempre, patria o muerte».
Rotta su Cuba
È nelle sale del Museo de la Revolución, a
L'Avana e, in modo ancor più dettagliato, nel
Museo de la Lucha Clandestina, a Santiago de Cuba,
che si può ripassare la storia della rivoluzione
cubana da quel 26 luglio del 1953, quando un
gruppo di 119 ribelli attacca il Cuartel Moncada,
una base militare a Santiago de Cuba. L'agguato
fallisce. Arrestati e condannati, i sopravvissuti
- tra questi anche Fidel Castro e il fratello Raul
- vengono liberati nel 1955 ed esiliati in
Messico, dove si riorganizzano. Il 25 novembre
1956 82 rivoluzionari condotti da Castro salpano
da Tuxpàn a bordo dello yacht Granma. Tra di loro
c'è anche il Che, arruolato come medico di
spedizione. Il 2 dicembre sbarcano sulla costa
sudorientale di Cuba, ma sulla spiaggia Las
Coloradas vengono sorpresi e sconfitti. I 12
sopravvissuti si rifugiano sui monti della Sierra
Maestra: un muro impenetrabile di verde e rocce
che durante la lotta armata divenne il quartier
generale di Fidel.
Oggi il Granma è custodito (con altri reperti di
guerra) a L'Avana, nell'involucro in ferro e vetro
del Memorial Granma, alle spalle del Museo de la
Revolución. Quegli inaccessibili rilievi montuosi
che hanno nascosto i ribelli costituiscono,
invece, il Gran Parque Nacional de la Sierra
Maestra, dove si trova anche il Pico Turquino, che
con i suoi 1974 metri è la più elevata vetta del
Paese.
Anche le pinete della Sierra del Escambray
offrirono riparo ai rivoluzionari. La seconda
catena di Cuba prende slancio dalla costa
orientale di Cienfuegos, «la perla del Sud». In
questi boschi, dove l'aria è umida e fresca e i
pini e gli eucalipti sono ricoperti di muschio,
Guevara recluta il Secondo Fronte rivoluzionario.
Qui conosce e s'innamora di Aleida March, che di
quel periodo ricorda: «Così, semplicemente, entrai
nella lotta armata. Davanti ai miei occhi prendeva
forma un mondo nuovo, inimmaginabile, che
significò per me una seconda nascita».
Oggi queste regioni sono abitate soprattutto da
contadini e sono fuori dalle rotte del turismo
(inutile cercare un segnale stradale, per
esempio). I campesinos distendono il riso
sull'asfalto per farlo essiccare al sole, proprio
come si faceva una volta, quando era la terra
battuta a disegnare la strada. Nei campi si lavora
la terra con l'aratro trainato da buoi. Di tanto
in tanto attraversiamo dei batei, piccoli e
tranquilli villaggi sorti presso gli antichi
zuccherifici e circondati da verdissime distese
coltivate a canna da zucchero.
A Santa Clara, il giorno della vittoria
Percorriamo l'Autopista Nacional fino a Santa
Clara. I momenti decisivi della battaglia del 29
dicembre 1958 rivivono nel museo allestito nei
resti delle carrozze ferroviarie deragliate, oggi
spettacolare fulcro del Monumento al Tren
Blindado.
Sulla facciata dell'Hotel Santa Clara rendono
ancora viva quella lotta i fori lasciati dai colpi
tirati dai rivoluzionari contro la milizia
nazionale. In Plaza de la Revolución, all'angolo
di Avenida de los Desfiles, si spalanca il
complesso monumentale dedicato a Ernesto Che
Guevara. È dominato dalla gigantesca statua in
bronzo del Che che porta un fucile, opera
dell'artista José Delarra, eretta nel 1987 in
occasione del ventennale della sua morte. Appena
dietro si trovano il museo, con documenti,
ricordi, fotografie sulla vita del Comandante, e
il mausoleo con le sue spoglie, poste accanto a
quelle dei suoi compagni rivoluzionari. Tra le
altre, anche quelle di Tamara Bunke, meglio nota
come Tania, coraggiosa compagna morta in
battaglia.
Alla baia dei Porci trionfa la pace
Coccodrilli e fenicotteri popolano numerosi il
Parque Nacional Ciénaga de Zapata, la vasta palude
a forma triangolare dichiarata Riserva della
Biosfera. È un regno intricato di mangrovie,
boscaglia di marabú e lagune cristalline. Vi si
trova il complesso turistico Boca de Guamà che
ospita, tra l'altro, il criadero de cocodrilos, un
allevamento con oltre 6 mila esemplari di
coccodrilli cubani endemici. A breve distanza
corre il Río Jatigüanico che si risale a bordo di
comode lance: avvoltoi, falchi e decine di altre
specie si svelano senza timori in un autentico
paradiso del birdwatching dove si sente cantare
anche il tocororo (Trogone di Cuba, Priotelurus
temnurus), l'uccello diventato simbolo nazionale
per il suo piumaggio rosso, bianco e azzurro come
la bandiera cubana.
La carretera raggiunge il mare a Playa Larga,
luogo d'approdo della cosiddetta invasione della
Baia dei Porci (Bahía de Cochinos) del 17 aprile
1961 a opera di esiliati cubani che, supportati
dagli Stati Uniti, tentarono di riprendersi
l'isola. La guida ci indica alcuni dei 161
obelischi eretti in onore dei caduti durante la
battaglia, disseminati lungo la strada nel punto
dove furono rinvenuti i corpi. Un alto muro di
cemento costruito direttamente in mare nega,
purtroppo, allo sguardo la vista dell'orizzonte.
In questa parte di Cuba il turismo non è arrivato
e i cenagueros (abitanti delle paludi) versano
ancora in povertà.
L'autopista prosegue fino a Playa Girón, 35
chilometri a sud di Playa Larga. Qui il Museo
Storico Playa Girón racconta la battaglia del 1961
con fotografie, cartine, reperti e toccanti
testimonianze. Non lontano spicca lo scheletro
dello zuccherificio Australia, dove si era
installato lo stesso Castro durante quei giorni.
Pinar del Río, giardino di Cuba
Distese di terra rossa coltivate a tabacco e
piantagioni di caffè ricoprono la Cordillera de
Guaniguanico. Divisa in Sierra del Rosario e
Sierra de los Organos, la barriera attraversa
interamente la provincia di Pinar del Río, terza
per estensione dell'isola, 50 chilometri a ovest
dell'Avana. Case basse color pastello in stile
neoclassico caratterizzano Pinar del Río, il
capoluogo. Lungo calle Martí, il viale principale,
il susseguirsi dei negozi «privati» allestiti
nelle verande delle case e autorizzati dallo Stato
testimonia la capacità dei cubani di reinventarsi
di continuo.
Lungo le strade piene di buche che tagliano le
vegas, le fertili vallate che disegnano la
regione, Chevrolet e Buick arrancano. È da queste
parti che i guajiros coltivano il miglior tabacco
del mondo. Si riconoscono per i tipici cappelli in
paglia, gli immancabili baffi e la pelle bruciata
dal sole. «Le foglie da utilizzare per fare i
sigari non devono essere né troppo umide né troppo
secche», spiega Gustavo, uno di loro, in una
tipica casa de tabaco, interamente costruita con
materiale vegetale, dove avviene il processo di
fermentazione naturale del tabacco.
Dai punti panoramici disseminati lungo il
tragitto la vista spazia sull'incantevole Valle de
Viñales. La vasta pianura dal terreno carsico
taglia la Sierra de los Organos, nel Parque
Nacional Viñales, dichiarato «paesaggio culturale
dell'umanità». La terra roja (rossa) ricca di
minerali crea un forte contrasto cromatico con il
verde tierno (verde tenero) della palma real (la
pianta nazionale), del bambù, della yucca e della
malanga, tipica di qui. È un paesaggio unico
sull'isola. Enormi massi rocciosi punteggiano la
valle. Sono i mogotes, alture coniche dalla punta
arrotondata larghe fino a 800 metri e alte fino a
600. Appena oltre, al di là dei «giganti di
roccia», nella fitta vegetazione che riveste i
rilievi montuosi, visse per qualche tempo il Che
prima di partire per la Bolivia, nel 1966.
La via ecosostenibile allo sviluppo
Ci spingiamo fino alla cittadina di Viñales,
tagliata da un lungo viale alberato. Oggi
l'estremo ovest dell'isola è tra le aree
maggiormente investite dal programma di
ricostruzione e riorganizzazione della società e
del territorio avviato dal governo Castro che ha
ottenuto, per la più grande isola dei Caraibi, sei
riserve della Biosfera e otto siti dichiarati
«patrimonio dell'umanità».
Nel 1978, inoltre, per rimediare a 400 anni di
deforestazione e distruzione degli habitat
naturali, è stato istituito il Comitato nazionale
per la protezione e la conservazione delle risorse
naturali e dell'ambiente (Comarna). Protagonista
dell'ambizioso progetto è la Sierra del Rosario:
un parco di 25 mila ettari, dal 1985 riserva della
Biosfera. I pendii montuosi sono coperti di pinete
popolate da 98 specie di uccelli come il colibrì
zunzunito (Mellisuga helenae), il più piccolo al
mondo con i suoi due grammi di peso, cervi e
jutìas (Capromys pilorides), un roditore simile a
un grosso criceto tipico di quest'area. Nel 1967 è
stato avviato un programma di rimboschimento. Sono
state impiantate 900 specie di piante e costruiti
1500 chilometri di terrazzamenti. Il Complejo Las
Terrazas, il primo esempio di progetto di
ecoturismo e turismo sostenibile del Paese, ha
coinvolto una sessantina di famiglie che vivevano
in condizioni di estremo disagio. Costruito nel
1971 sulle rive del lago San Juan, si raggiunge
percorrendo una strada asfaltata una ventina di
anni fa. Prima di allora, nel 1962, il Che guidava
in queste vallate le truppe della zona occidentale
durante la crisi missilistica tra Cuba e Stati
Uniti.
In una vecchia capanna indios diroccata (bohios)
Aleido, un anziano contadino, vive solo coltivando
la terra e allevando polli, agnelli e guineos
(sorta di tacchini). Il suo terreno è immerso nel
verde, l'aria è pulita e il silenzio è rotto solo
dalla vivacità di Payaso, il suo cane. «Di qui non
me ne vado», confida. Il motivo lo capiamo dai
suoi occhi. Perché Cuba è meravigliosa e allegra,
perché non ha dimenticato il suo passato e, se
ancora non ha costruito il suo futuro, sa di
potercela fare. Perché oggi come ieri Cuba vive
una nuova rivoluzione: aprirsi al mondo e rimanere
se stessa. E nessun cubano rinuncerà alla sfida.
Fino alla fine. «Hasta la victoria siempre, patria
o muerte».
Elisabetta Canoro
(«Tutto Turismo» n. 345/07)
Jazz: dalle piantagioni alle metropoli
- Questa forma artistica ha permesso agli
afroamericani di sopravvivere, avere un'identità,
essere riconosciuti capaci di creare qualcosa di
nuovo. Premessa
La tesi di fondo che vorrei difendere riguarda
la necessità del jazz (per gli afroamericani). Lo
sfondo storico della deportazione, della
schiavitù, della discriminazione e della
segregazione rappresenta una «interruzione» di
quelle fonti di riconoscimento mediante le quali
gli africani potevano prestarsi reciprocamente
un'identità. Volendo dare un nome a ciò che nasce,
per l'individuo, nella relazione sociale, ebbene
si tratta proprio del riconoscimento della sua
identità. Spogliato di quei riferimenti durevoli
(lingua, ruoli, proprietà, passato) che permettono
di formare e riprodurre un'identità, la domanda
diventa: come fu possibile per gli afroamericani
sopravvivere, almeno culturalmente? Sosterrò che
la musica, ambito espressivo ritenuto irrilevante
dai piantatori americani (o forse ritenuto utile
per incrementare la produttività degli schiavi
nelle piantagioni), rappresenta il contesto
all'interno del quale è stato possibile
ristabilire relazioni sociali e dunque ricostruire
(o costruire) un'identità, uscendo da una
situazione di isolamento. Il jazz diventa allora
dimora, lingua comune e memoria, un dispositivo
identitario per umanizzare e riscattare
l'esperienza subita. Chiarirò come la natura di
questa tesi non vada confusa con la posizione
essenzialista (solo gli afroamericani hanno
contribuito alla fioritura del jazz; solo loro
hanno il diritto di suonarla): il jazz è musica
ibrida formatasi per disseminazioni e diffusasi a
prescindere dalle partiture scritte, investendo la
comunità allargata di coloro che non si vedono ma
si ascoltano reciprocamente per mezzo dei dischi.
Tuttavia, il legame fra jazz e musica
afroamericana è costitutivo, non a causa della
pelle ma in virtù dell'esperienza condivisa dagli
afroamericani: la dislocazione imprevista, la
coazione ad affrontare l'ignoto, la presenza della
morte e la capacità di appropriarsi di quello che
viene imposto (o che si trova a disposizione),
sono tutte caratteristiche che trapassano nella
musica e vengono sublimate esteticamente nella
pratica dell'improvvisazione. Il jazz non è certo
un paradiso razziale, eppure è grazie a esso che
gli afroamericani ottengono una definizione
differente da quella loro imposta (sono
riconosciuti come capaci di dare inizio a qualcosa
di nuovo).
Cosa discende da questa tesi sulla necessità
culturale del jazz? Un assunto metodologico: non
si può affrontare il jazz da una prospettiva solo
«internalista», focalizzandosi esclusivamente
sulle note, o sugli stili, o sui singoli
musicisti. La portata del jazz è più ampia investe l'identità. Ma poiché l'identità non è
scelta, coincidendo invece con il prodotto
dell'insieme degli atti di un attore riconosciuti
da una cerchia sociale, bisognerà chiedersi: come
viene riconosciuta l'identità che gli
afroamericani proiettano grazie al jazz? Come è
stato percepito, quali reazioni ha suscitato il
jazz nelle comunità di ricezione che a esso sono
state esposte? Analizzando tali effetti culturali
del jazz, invece di rinchiuderlo in una
definizione univoca, emerge un ritratto al plurale
della musica ma anche di coloro che l'hanno
generata.
Lo sfondo storico
Come è noto, gli individui deportati dalle coste
occidentali dell'Africa verso le piantagioni
americane, furono privati delle condizioni per
riconoscersi come si definivano prima della
dislocazione. Ad approdare nel nuovo mondo non
sono gruppi coesi, tanto meno comunità, ma tenendo conto della separazione forzata aggregati eterogenei nei quali l'unica cosa
condivisa è la schiavitù. Nelle cosiddette Indie
occidentali e in Brasile gli schiavi si trovano in
una situazione diversa: intanto sono in numero
nettamente maggiore che non i padroni (francesi e
inglesi). In secondo luogo, gli schiavi possono
vivere gli uni con gli altri. Per questo insieme
di ragioni hanno meno contatti con la cultura di
derivazione europea (e comunque non con quella
protestante e anglo-celtica, quanto con quella
iberico-cattolica). Queste differenze fra gruppi
afro-diasporici, probabilmente, spiegano come mai
il jazz, musica dell'improvvisazione, sia stato
generato dagli afroamericani piuttosto che,
poniamo, dagli afrobrasiliani. Gli schiavi
afroamericani, non quelli afrobrasiliani, sono
dovuti ricorrere al double-talk, il linguaggio
cifrato, la parafrasi e il riferimento obliquo
attraverso il quale eludere i controlli dei
piantatori, nonché alla pratica del signifying (la
capacità di riprendere quanto imposto, a partire
dagli inni protestanti, «facendoli significare» in
modo distintivo), modalità che costituiscono il
cuore stesso del jazz.
Torniamo alle conseguenze della deportazione. In
America le lingue africane furono inibite,
l'inglese imposto era minimale e finalizzato
all'operatività. Gli unici ruoli assegnati erano
quelli di schiavo o, talvolta, di servitore
domestico. Nessuna proprietà era concessa. Lo
schiavo fu deprivato anche di memoria: poiché il
suo passato non ha più valore nel contesto
presente, la memoria si fa più velata, lontana e
sostituita da una diversa sequenza di ricordi
immediati e più duri. Le roots, radici, sono
routes, percorsi di trasferimento, di migrazione
forzata, deportazione appunto. L'afroamericano è
così spogliato di proprietà, lingua, ruoli,
passato, ma anche di nomi, vestiti e ornamenti,
ossia dei riferimenti durevoli che normalmente
funzionano da spunto o segnale attraverso il quale
il riconoscimento si può effettuare
quotidianamente, permettendo di collocare gli
individui in molteplici relazioni sociali, entro
le quali emerge un'identità. Le fonti di
riconoscimento subiscono una sorta di sospensione,
o interruzione, un po' come un titolo elargito per
meriti da una società che poi viene dissolta e
rimpiazzata da un'altra in cui nessuno riconosce
più quel titolo (e il prestigio a esso
attribuito), o come una moneta fuori corso: non ha
più valore, non è né cumulabile, né scambiabile
con altre. In breve, l'afroamericano si trova come
denudato da ciò che pensava costituisse la sua più
accertabile identità sociale. In fondo la
blackness può essere interpretata anche come
l'angoscia derivante dall'approdo in una «terra di
nessuno» priva di ogni punto di riferimento
stabile. Non vorrei essere frainteso. È sbagliato
sostenere che gli africani deportati nelle
Americhe fossero privi di identità. Il punto è che
l'identità conta solo se convertibile in socialità
(sia quella vissuta nelle cerchie informali che
quella condivisa in contesti istituzionali e
professionali), e l'identità dello schiavo è
appunto spogliata di tale valore.
Dato il «difetto d'origine» della schiavitù,
peraltro, il colore della pelle viene collegato a
un segno di inferiorità. I neri non hanno la
«pelle giusta» per essere riconosciuti come
persone. Non è perché la pelle è nera che si è
schiavizzati, ma è perché si è stati (costretti a
essere) schiavi che il colore diventa rilevante.
La «razza nera» non è un dato immediato; ha il suo
luogo di incubazione in questo particolare
esercizio di potere. L'essere stati prelevati come
forza-lavoro da un continente «vecchio» e
«primitivo» rende il razzismo un sottoprodotto
dell'origine geo-culturale e fa della schiavitù la
precondizione per la configurazione di un campo di
visibilità attraverso il quale il colore della
pelle acquista il ruolo di piastrina di
riconoscimento. D'altra parte, la schiavitù reca
in sé una componente culturale: il ricorso a
schemi di riconoscimento denigranti piuttosto che
avvaloranti. La sostituzione del termine «schiavo»
con «negro», allora, è tutt'altro che innocua. I
due termini non sono equivalenti, ma per effetto
di questa vicenda storica il secondo termine si
«porta dentro» la connotazione negativa del primo.
E poiché tale matrice è invisibile e sospesa nel
passato, crea l'illusione che il nero appartenga
agli esseri inferiori per via naturale e a
prescindere dal suo comportamento (la
caratteristica del pregiudizio è proprio quella di
trasformare giudizi che non provengono dai fatti
in fatti che impongono un giudizio). La pelle,
peraltro, è uno di quegli aspetti che mi definisce
e anzi mi costituisce, al punto che - in quanto
parte della mia stessa corporeità (e dunque della
mia vita) - non posso sbarazzarmene: nessuno può
adottare la mia carnagione per me, al posto mio.
Ma neppure posso averne un controllo. La
«superficie» del corpo è il primo strato a imporsi
agli occhi e a essere marchiato, riconducendo ogni
individuo a specimen di un tipo (l'attributo
«nero» si riferisce a una intera classe di
individui ritenuti equivalenti e dunque
sostituibili), secondo un processo contrario a
quello che ci differenzia e ci singolarizza.
Questa «derealizzazione» della dimensione
individuale, ricondotta unilateralmente a un'unità
collettiva, fa sì che i neri subiscano una delle
condanne più crudeli: il divenire indistinguibili
(agli occhi del bianco). Come se si coprisse quel
numero di serie che è il volto delle persone l'aspetto che più le individualizza - rivelando
solo i polpacci o i gomiti. Come se si
raggruppassero tutte le persone che hanno i
capelli castani, quali che siano la loro lingua,
la loro storia, e le loro pratiche culturali.
Su questo sfondo storico il jazz diventa la
prestazione specifica che permette di riprodurre
socialità e cercare le condizioni per realizzare
la riconoscibilità duratura degli afroamericani,
nonché di ottenere una definizione di natura
diversa rispetto allo stigma offensivo. Nelle
parole del contrabbassista Ron Carter, «La musica,
oltre al lavoro coatto, è l'unico contributo dei
neri agli Stati Uniti» (Taylor, 1992, p. 61).
Detto questo, il mondo del jazz non è certo un
paradiso razziale, al contrario, è fin dal suo
sorgere segnato da operazioni di white washing
(negli anni Venti Paul Whiteman, nome assai
eloquente, viene incoronato King of swing, benché,
come ha detto una volta il batterista Art Blakey,
l'unico modo in cui Whiteman sapesse «oscillare»
era appeso a una corda (Enstice, 1992, p. 23). Il
pianista Dave Brubeck (Enstice, 1992, p. 87)
racconta come nella seconda metà degli anni
Cinquanta Ellington potesse esibirsi, anche in
televisione, con una all-black orchestra, ma il
contrabbassista nero di Brubeck non poteva
comparire negli show pubblicamente rilevanti:
poteva continuare a suonare, ma nascosto, in modo
tale che si sentisse ma non si vedesse, non si
vedesse insieme ai bianchi (solo nel 1968 Sidney
Poitier è il primo nero a legarsi romanticamente a
una donna in una produzione hollywoodiana, Who's
coming to dinner). Il trombonista e big band
leader Tommy Dorsey, che ammirava Dizzie
Gillespie, gli si avvicina dicendogli: «Boy, I'd
love to have you in my band, but you're so dark.
If you were sort of white...» (Enstice, 1992, p.
178). Ancora nel 1982, nel corso del New Music
American Festival a Chicago (sede del collettivo
musicale e culturale Association for the
Advancement of Creative Music e città al 40%
nera), si organizza un dibattito sul tema, «New
music and our changing culture», e tutti e sette i
partecipanti invitati sono bianchi.
Eppure, nonostante le discriminazioni, la musica
ha seguito un suo corso, colpendo gli ascoltatori
e modellando i corpi di chi danza, rivelandosi un
luogo tutto sommato inclusivo (anche ballare il
jazz è un segno di coinvolgimento, e di
sincronia). E poi dove altro, se non nella musica
(e nello sport), è stato riconosciuto - per quanto
in modi parziali - il contributo dei neri? Dunque
nel complesso è plausibile affermare che in virtù
del jazz gli afroamericani hanno finito per essere
percepiti non solo come vittime ma come attori
creativi (l'improvvisazione è collegata alla
dimensione inventiva, al far nascere qualcosa di
nuovo), contrassegnati - per usare la terminologia
di Hannah Arendt - dalla capacità di azione comune
e dal «dare inizio» a qualcosa di nuovo, dalla
potenza del cominciare. Che il jazz assolva questa
funzione extra-musicale viene sottolineato in vari
modi dagli stessi musicisti, per esempio
enfatizzando l'analogia fra il jazz e la metafora
della dimora.
Jazz e identità
Un po' come la musica permette al giovane di
«cambiare stanza», così il jazz ha offerto un
luogo dove entrare e abitare creativamente, a
molti afroamericani. Lo esprime bene John
Coltrane: il jazz «is a matter of being at home»
(cfr. Kofsky, 1997, p. 436). Lo ribadisce il
pianista e band leader Sun Ra: «suonavo perché lo
trovavo edificante e piacevole in un contesto,
quello americano, in cui l'essere neri era
tutt'altro che piacevole. Dovevo avere qualcosa, e
quel qualcosa consisteva nel creare ciò che nessun
altro avesse eccetto noi. Sono venuto così a
disporre di una casa del tesoro musicale, una casa
che nessun altro possiede» (Szwed, 1997, p. 88). E
lo sottolinea infine il pianista sudafricano
Abdullah Ibrahim (cit. in Pareles 1990): «Il
vantaggio di essere un artista è che in ogni caso
non sei mai veramente mandato via da casa» (lo
stesso gruppo di Ibrahim si chiamava proprio
Ekaja, ossia casa in lingua sudafricana). Il jazz
non solo allontana dalle pressioni della vita
quotidiana, fungendo da scudo contro l'insicurezza
di uno spazio urbano spesso disprezzato e
abbandonato. In contrasto con questo ambiente
ostile e incerto, offre un luogo dove ridiventa
possibile stabilire rapporti sociali negati
all'esterno, riappropriandosi simbolicamente - per
sé e per l'intera cultura afroamericana - di
quello spazio che era stato negato.
Una seconda figura in cui si condensa l'immagine
del jazz è quella della lingua comune, una lingua
franca attraverso la quale articolare un ideale di
società fondato sul mutuo riconoscimento. Si dirà
che a differenza di una lingua naturale la musica,
pur disponendo di un sistema fonologico, non
dispone di un lessico, né può contare sulla
funzione referenziale. Eppure, anche se la musica
non «dice» qualcosa, una musica generata
collettivamente nel suo svolgersi come il jazz
rende tangibile l'intreccio originario
dell'essere-con-l'altro, precondizione di ogni
comunicazione determinata. Che il jazz possa
dunque, nonostante tutto, essere pensato come
surrogato di una lingua lo suggeriscono pure le
seguenti caratteristiche. Al pari del parlato, la
performance musicale improvvisata è un processo
orale che si svolge nel tempo (cfr. Sparti 2007b).
Al pari del parlato, l'improvvisazione collettiva
del jazz è una forma di interazione,
contrassegnata da chiamate e risposte, ma anche da
una capacità di dialogo che, come in una
conversazione, può trascinare là dove non ci
saremmo immaginati di poter andare (si ascolti lo
straordinario «dialogo» musicale fra Eric Dolphy
al clarinetto basso e Charles Mingus al
contrabbasso, a partire dall'ottavo minuto del
brano «What love», inciso il 20 ottobre del 1960).
Infine, come il parlato, il jazz dispone di indizi
semiotici come la citazione, mediante la quale,
nel corso di un brano che si svolge nel tempo
attuale, il musicista si riferisce
intertestualmente a un brano appartenente a un
tempo precedente. A proposito del nesso fra jazz e
linguaggio, non è neppure un caso che le
espressioni utilizzate dall'uditorio per
descrivere un assolo (riuscito) comprendano
termini quali storytelling e testfying (ma anche
shouting, preaching, telling it like it is). Detto
fra parentesi, oltre a essere pensabile come un
surrogato di lingua, il jazz è stato di fatto
rivestito di parole, e non soltanto da critici e
interpreti. Per fare un esempio, come racconta
l'arrangiatore canadese Gil Evans,
l'appartamentino seminterrato dove egli viveva a
New York era accessibile 24 ore su 24: la porta
era aperta, c'erano un giradischi, un registratore
e un pianoforte, e i musicisti, come altri
esponenti della jazz community, entravano e
uscivano, ascoltavano ma anche parlavano e
discutevano di musica, in continuazione (cfr.
Enstice, 1992, p. 154).
In terzo luogo, il jazz assolve una funzione
identitaria rielaborando la memoria del passato,
non il passato africano ma la vicenda dello
schiavismo e della discriminazione subita, un
passato che non passa, che continua a
ripresentarsi ossessivamente, come un fantasma. A
questo proposito si possono ascoltare un brano
come Freedom, di Charles Mingus, registrato il 12
ottobre del 1962, o Alabama, di Coltrane, inciso
il 18 novembre del 1963, poche settimane dopo
l'attentato dinamitardo alla Sixteenth Street
Baptist Church di Birmingham (Alabama, appunto).
In quest'ultimo caso il lutto e il dolore per
l'assenza delle bambine uccise viene ricreato
musicalmente. L'effetto di brani come questi è
quello di portare una collettività a riconoscersi
radicata in una continuità e in un tempo proprio,
per quanto doloroso. Il jazz diventa così
produttore della coscienza di una continuità,
conferma di una identità che perdura nel tempo.
Naturalmente il jazz è stato anche, e forse
prima di ogni altra cosa, un mestiere, più o meno
remunerato e prestigioso, a seconda dei luoghi e
dei tempi. È qui che si inserisce la critica del
francofortese Th.W. Adorno, che consiste nel
mostrare vari indizi dell'assoggettamento del jazz
allo show business (per esempio l'obbligo di
suonare certi brani ripetitivi, preconfezionati
dall'industria delle canzoni e riproposti alla
radio quanto ai jukebox). In un'epoca, la nostra,
in cui il jazz serve come musica di sottofondo per
la pubblicità e in cui persino le automobili
adottano il suo nome, non ci si può appellare
unilateralmente all'innocenza o al potenziale
sovversivo del jazz, facendo finta che Adorno non
sia «passato», per quante riserve si possano
avere. Per Adorno le sole opere musicali
autentiche sono quelle che si misurano con le
forme più estreme dell'orrore, eludendo
quell'incubo di un mondo totalmente amministrato
di cui i prodotti dell'industria culturale
sarebbero già il preludio: «La verità [della]
musica appare esaltata [quando] essa smentisce
(...) il senso della società organizzata che essa
ripudia, piuttosto che per il fatto di essere di
per se stessa capace di un significato positivo.
Nelle condizioni attuali essa è tenuta alla
negazione determinata» (Adorno, 1959, p. 25). Uno
dei limiti di Adorno, però, è che non ha saputo
cogliere il lato «oscuro» del jazz. Senza
disturbare Mingus o Coltrane, vi sono canzoni i
cui temi non riguardano affatto le coppiette
innamorate. Gloomy Sunday, per esempio, parla di
suicidio, e Strange fruit, di linciaggio. Come ha
detto una volta Sun Ra (tracciando una piccola
apologia dell'urto sonoro che sarebbe dovuto
piacere ad Adorno): «A me piacciono i suoni che
mettono a disagio la gente, perché la gente è
troppo compiaciuta, e vedi, devi scioccarla per
scacciarla da quello stato, affinché prenda atto
del fatto che questo mondo è molto brutto. Devi
svegliare la gente in modo che possa vedere il
mondo per quello che è; poi, forse, farà qualcosa
per porvi rimedio».
Ibridazione musicale
Vorrei chiarire la natura della tesi qui
tracciata. Essa non va confusa con una forma di
essenzialismo (solo i neri hanno contribuito a
sviluppare il jazz, e solo loro godono del diritto
di suonarlo). Certo, vi sono dispositivi musicali
presenti sia nel jazz che in molte culture
musicali africane, per esempio la poliritmia,
l'articolazione della musica per chiamate e
risposte, la vocalizzazione del timbro e l'uso
strumentale della voce. Neppure bisogna
misconoscere la presenza tematica dell'Africa (le
composizioni jazz dedicate al continente africano
sono moltissime - e non si tratta solo di titoli
estemporanei). Ma i deportati non discesero dalle
navi negriere suonando il jazz, e l'Africa dei
jazzisti corrisponde più a una sua immagine o
versione retorica che non a un fattore che si è
riprodotto strutturalmente nella musica. Lo
scrittore Richard White scrive del proprio
disappunto nell'ascoltare il coro di una chiesa in
Ghana, che non richiamava in alcun modo la
tradizione canora del gospel afroamericano. In
alcuni stati africani oggi si suona del jazz,
certo. Si presti tuttavia attenzione agli scambi
nell'altro senso: a partire dagli anni Trenta i
dischi e i film americani, così come la radio e il
giradischi, ebbero un impatto enorme su musica,
danza e moda africane, soprattutto in Sudafrica,
in Nigeria e in Ghana. In Senegal, per esempio, il
jazz si è diffuso in seguito alla presenza di Duke
Ellington (invitato da Senghor) al festival
panafricano delle arti negre svoltosi a Dakar nel
1966. Vi è stato qualche - isolato - musicista
africano che si è inserito creativamente nella
jazz community americana. Abbiamo già menzionato
Abdullah Ibrahim. Il percussionista Michael
Olatunji è un altro nome. Yoruba nigeriano venuto
a New York con una borsa di studio, ha fondato nel
1967 il Center of African Culture in Lexington
Avenue, a Harlem. Ma Olatunij ha trasformato il
proprio stile collaborando prima con il batterista
Max Roach, poi con Coltrane (è grazie all'impegno
- pure finanziario - di Coltrane che Olatunij ha
potuto aprire il suo centro, inaugurato da una
serie di performance domenicali realizzate dal
tenorista, che poco prima di morire vi registrerà
la sua ultima esibizione dal vivo, il cosiddetto
Olatunji concert).
Così come non ha un luogo di nascita, il jazz
non ha neppure una data di compleanno. La New
Orleans dei primi anni del Novecento, dirà
qualcuno, ma non si dimentichi che New Orleans è
città di porto, aperta verso l'America Latina, in
cui confluiscono e convivono molti generi musicali
(inni, marce, blues, ragtime). Il jazz, peraltro,
si forma non solo a New Orleans ma nel corso di
una disseminazione che lo porta a Chicago e a New
York (per limitarsi ai centri più significativi),
ricontestualizzandosi di volta in volta.
Non basta. Gli strumenti del jazz sono di
origine perlopiù europea (nel caso della batteria,
i piatti e i triangoli sono turchi, la grancassa
cinese, il drum-kit americano) e i songwriters del
repertorio da cui derivano la maggior parte dei
cosiddetti standard sono in maggioranza ebrei
(ricordiamo i fratelli Gershwin, Irving Berlin e
Jerome Kern). E poi le razze non suonano, solo gli
individui lo fanno. Gli stessi afroamericani,
peraltro, non rappresentano una collettività
uniforme e omogenea. Black, brown and beige, la
famosa suite di Duke Ellington, riflette
criticamente sui pregiudizi fra neri, che si
distinguono a seconda del tono della pelle (o
dello stile di vita; Ornette Coleman ha detto una
volta di Miles Davis: è certamente nero, ma vive
come un bianco). Come spiega il tenorista Benny
Golson, «la musica, di per sé, non è connotata
etnicamente. Le note sono documenti sonori di una
certa altezza, tutto qua. Ma quello che facciamo
di esse, be', quella è un'altra cosa. È lì che si
trovano i veri eroi» (citato in O'Meally, 2004, p.
51). Quest'ultima indicazione di Golson è
decisiva: ciò che conta è il modo in cui gli
strumenti - o gli standard - sono valorizzati nel
corso della performance. Un'indicazione sfuggita
ad Adorno, il quale non ha saputo cogliere il
ruolo determinante della creatività secondaria.
Charlie Parker o Thelonious Monk effettivamente
suonano e risuonano un numero tutto sommato
circoscritto di brani, un po' come Monet che
affronta innumerevoli volte lo stagno del suo
giardino, o il monte Saint-Victoire dipinto e
ridipinto da Cézanne. Con la differenza, però, che
i jazzisti non stavano cercando di «catturare
l'essenza» di un paesaggio o di una forma, ma di
creare ogni volta le condizioni per una (per
quanto minima) epifania musicale.
Incontriamo qui la pratica del signifying, che
consiste nel prendere le mosse da qualcosa di
imposto o di semplicemente disponibile (una
melodia, un ritmo, un ciclo di accordi, uno
strumento, ma anche un nome, o un modo di dire)
per poi prenderne parzialmente le distanze,
modificarlo e in tal modo appropriarsene. Tale
capacità di coabitare con - e di assimilare universi simbolici in tensione con il proprio è
incardinata nella storia della comunicazione dei
neri in America. Essa ha le sue radici nelle work
songs degli schiavi (che erano al tempo stesso
espressioni indirette a cui ricorrere per eludere
i controlli e nondimeno indicare la disumanità
delle loro condizioni di vita), nonché nelle
pratiche canore e nei sermoni ritmati della chiesa
afrocristiana. Abbiamo visto come il potere dei
nomi possa diventare terribile nella sua
asimmetria e negli effetti che esercita su quanti
vengono sottoposti a uno stigma denigrante (che
peraltro non offende solo me singolo, ma la
collettività che rappresento, un'offesa di
identità): non concede la possibilità di rifiutare
l'identità attribuita, né offre la possibilità di
ottenere una definizione di altra natura rispetto
a quella imposta. Il processo dell'inventare e
acquisire per merito nomi nel corso della vita
(frequentissimo fra i jazzisti) rappresenta
l'antidoto alla spersonalizzazione imposta dalla
schiavitù o dal misnaming (la denominazione
offensiva). Un esempio di signifying esercitato
sul proprio nome ce lo offre il poeta, attivista
politico e critico jazz Leroy Jones, che trasforma
il proprio nome in Le$Roi, il re, per poi
convertirsi all'islamismo e diventare Amiri
Baraka, che può essere pronunciato ameer o amir
baraka in swahili, e che, se letto al contrario,
diviene ak arab, assumendo una connotazione più
marcatamente musulmana.
A proposito del signifying la scrittrice e
antropologa afroamericana Zora Neal Hurston (in
O'Meally, 1998, p. 304) invitava a prestare
attenzione al particolare modo in cui gli
afroamericani si rapportano a quanto acquisito
(the borrowed material): «Pur vivendo in seno a
una civiltà bianca, tutto quello che il nero
sfiora viene re-interpretato per i suoi scopi (reinterpreted for his own use)». Benché usufruissero
della possibilità di fare musica, e di farla in
gruppo, non bisogna dimenticare che agli
afroamericani era spesso negato l'accesso agli
strumenti di qualità, alle scuole musicali più
prestigiose, ai corsi di composizione, alle
orchestre. Hanno dunque dovuto sfruttare quanto
era loro concesso per ricreare qualcosa di
proprio. Sbaglia chi pensa al jazz come
all'espressione spontanea di un individuo o di un
popolo. Suonare e improvvisare significa giocare
con le possibilità di una situazione, il che
presuppone non certo mera emotività quanto la
capacità di valutare il contesto per estenderlo e
trasformarlo. «A contare - osserva lo studioso di
musica afroamericana Albert Murray - non è tanto
quello che i musicisti estraggono da se stessi,
quanto quello che fanno con le convenzioni
esistenti» (Murray, 1976, p. 126).
Collegare la matrice nera del jazz non alla sua
origine, né al colore della pelle, facendone
dunque qualcosa di esclusivo, ma - culturalmente alla necessità di sopravvivere, ci è utile anche
per chiarire il rapporto fra la pratica
organizzata dell'improvvisazione e l'esperienza
afroamericana. Che vi sia un intreccio fra la
dislocazione imprevista (delle persone) e quella
dislocazione imprevista che, nella musica, viene
chiamata improvvisazione (il potere di
sorprendere, lo slittamento inatteso), lo attesta
l'altista Marion Brown: «Essere riusciti a venire
a capo della transizione dall'Africa all'America
senza disporre delle necessarie istituzioni
culturali è segno di un raro potenziale adattivo
nonché un atto di improvvisazione collettiva
[societal improvisation]» (Brown, 1973, p. 15).
Lo stato di transitorietà e la negazione di un
futuro su cui contare (l'interruzione delle fonti
di riconoscimento), l'obbligo di tollerare viaggi
rischiosi - la cui destinazione era difficile da
raffigurare - e di convivere con il rischio di una
situazione mobile e imprevedibile, genera negli
afroamericani il senso del «provvisorio duraturo»
e dell'improvvisazione, due qualità che
sublimeranno musicalmente. Come spiega lo
scrittore Ralph Ellison in uno dei saggi raccolti
nel volume intitolato Going to the territory, «gli
schiavi avevano imparato [...] che per ottenere la
libertà occorreva spostarsi geograficamente, e
rischiare la propria vita affrontando l'ignoto»
(Ellison 1987, p. 131). In quanto dispositivo per
umanizzare il caos e organizzare l'esperienza, il
jazz diventa una forma di sopravvivenza in
condizioni ostili. Nelle parole della scrittrice
Toni Morrison, «i neri hanno sviluppato delle
strategie di sopravvivenza: l'invenzione,
l'improvvisazione» (Marmande, 1994, pp. 34-35).
Non a caso anche Albert Murray considera
l'improvvisazione un corredo estetico vitale
(«aesthetic equipment for living», 1976, p. 58):
«l'improvvisazione non è solo ciò che permette di
convivere con lo strappo [disjunction] e il
mutamento; fornisce una tecnica di sopravvivenza
fondamentale, peraltro compatibile con lo
sradicamento e la discontinuità così tipici
dell'esistenza umana nel mondo contemporaneo».
Conseguenze metodologiche
Cosa discende dalla tesi della necessità
culturale del jazz? Un assunto metodologico: per
comprendere il jazz è rilevante cogliere la
valenza anche socio-antropologica della musica.
Ciò significa affrancarsi da una prospettiva
esile, puramente internalista, che analizza solo
le note (come ha detto una volta Luciano Berio, i
giovani musicologi che abdicano a tale prospettiva
«perdono i migliori anni della loro vita per
spremere una grammatica generativa dall'ascolto di
un minuetto di Mozart», Berio, 2007, p. 16). Ma
significa pure emanciparsi da un'impostazione
centrata solamente sui singoli musicisti; una
sorta di agiografia, con i suoi beati o santi, che
finisce per relegare l'intera vicenda qui narrata
a un effetto di drammatizzazione (finendo pure per
abbracciare un approccio molto americano: il
trionfo dell'individuo solitario che asserisce se
stesso trascendendo esteticamente le
discriminazioni subite). Una prospettiva sul jazz
che ignori o trascuri le vicende storiche e le
implicazioni culturali qui delineate appare non
solo inadeguata a comprendere il fenomeno, ma
anche insultante.
Dalla tesi finora illustrata discende anche un
suggerimento metodologico. Non si tratta di
chiedere: «cosa è» il jazz?, domanda non solo
difficile ma indiscreta, che chiede di tracciare
in due parole il senso di una forma di vita in the
making - per questo i jazzisti reagiscono in modo
recalcitrante o elusivo (Louis Armstrong ha
risposto così a una signora impaziente di sapere
cosa fosse il jazz: «Signora mia, se lo deve
chiedere, non lo saprà mai...», dando a intendere
che il jazz è certamente conoscibile ma non
necessariamente spiegabile con poche parole).
Bisognerà invece chiedersi: come è stato
riconosciuto il jazz? Ossia, in quali modi si è
risposto alla sua presenza? I discorsi e le
rappresentazioni sociali emerse intorno alla
musica, pur non esistendo a prescindere dalla
musica, possono essere analizzati nei loro termini
peculiari (se poi tali codici simbolici abbiano
reso giustizia - agevolato o distorto - chi
generava la musica, è altra questione). L'idea
chiave è che per stabilire il significato di una
pratica occorre ricostruire le reazioni che essa
ha suscitato presso un uditorio o una comunità di
ricezione (in Sparti 2007a illustro quattro dei
campi discorsivi che hanno organizzato la
percezione - e l'ascolto - del jazz). È così che
quanto detto all'inizio sull'identità si
ripresenta in maniera circolare. Il jazz ha
permesso di riprodurre quelle condizioni di
socialità e interazione in virtù delle quali molti
afroamericani hanno potuto configurare una
identità. Ma l'identità non è una proprietà
incapsulata negli individui, quanto piuttosto un
attributo che si rivela in forma retrospettiva
attraverso il riconoscimento. L'identità, lo
abbiamo ricordato, dipende da operazioni in cui
altre persone, sulla base di passate relazioni
sociali con noi, ci giudicano suscettibili di
essere compresi in quanto contrassegnati da
caratteristiche quali la relativa continuità nel
tempo e la distinzione rispetto ad altri individui
o collettività. Per questo capire il jazz
significa ricostruire situazioni di risposta alla
sua presenza che siano rivelatrici dei
riconoscimenti (o misconoscimenti) a cui è andato
incontro. Il jazz diventa infine un osservatorio
privilegiato per illuminare la tensione dinamica
fra identità e riconoscimento.
Davide Sparti
(«Prometeo» n. 100/07)