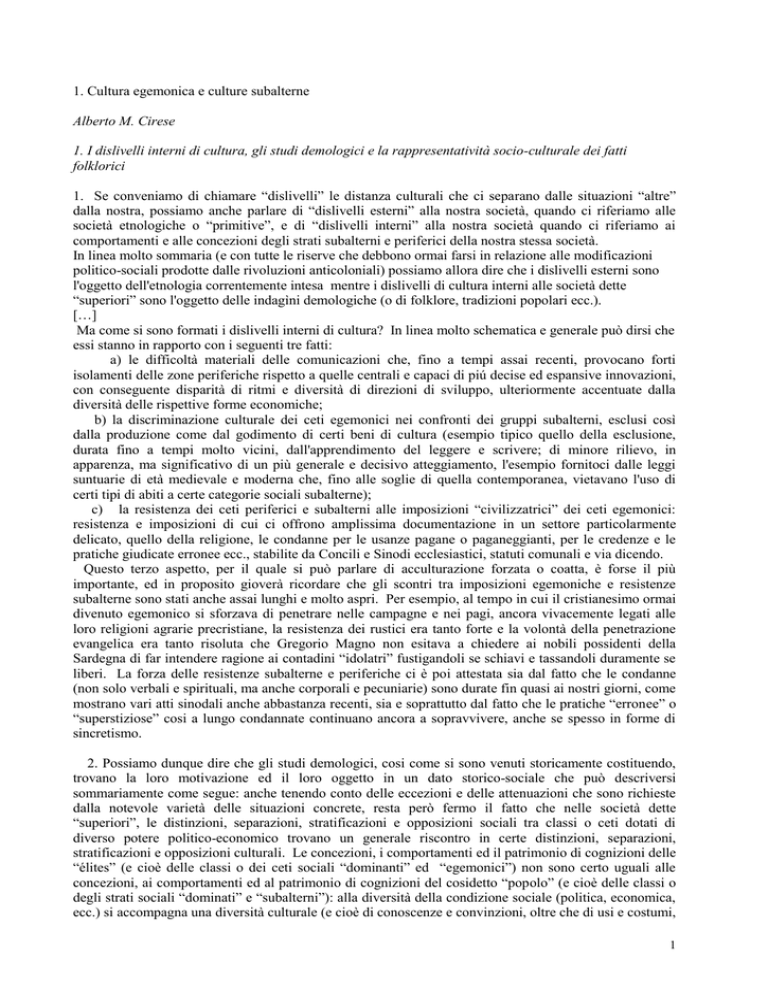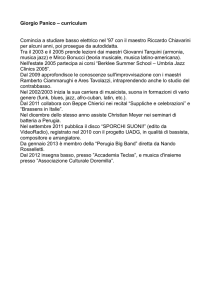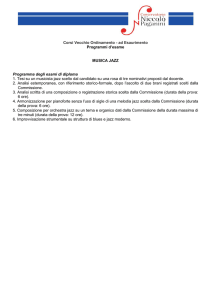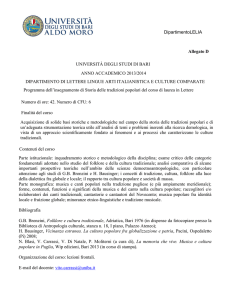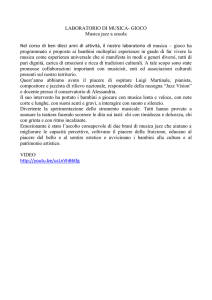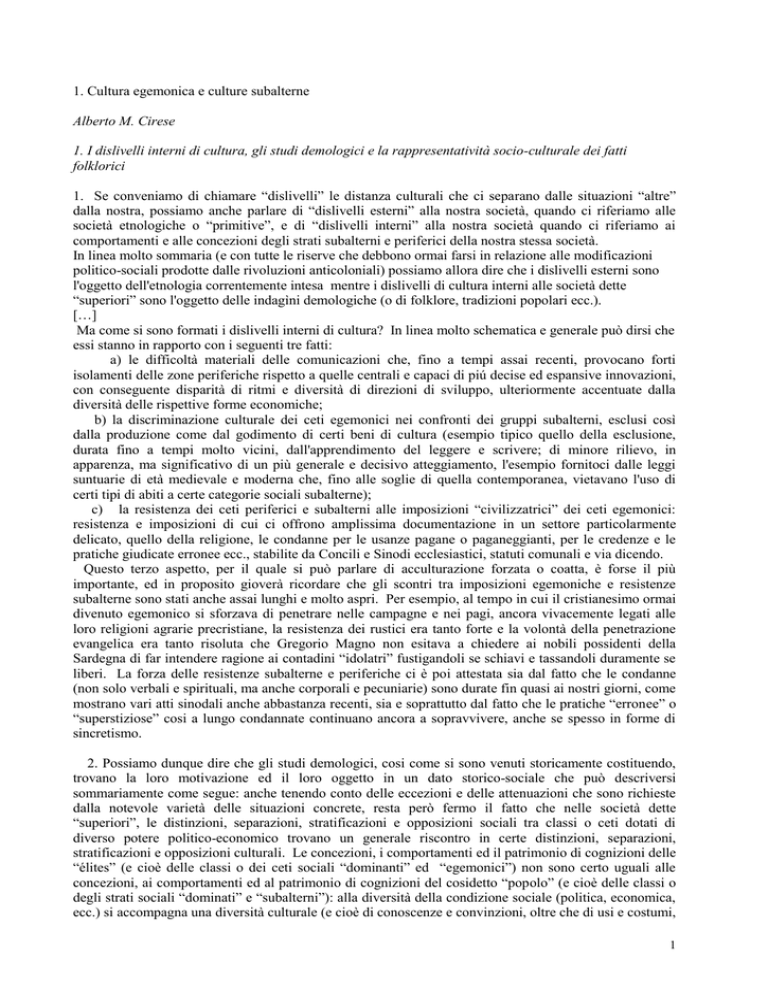
1. Cultura egemonica e culture subalterne
Alberto M. Cirese
1. I dislivelli interni di cultura, gli studi demologici e la rappresentatività socio-culturale dei fatti
folklorici
1. Se conveniamo di chiamare “dislivelli” le distanza culturali che ci separano dalle situazioni “altre”
dalla nostra, possiamo anche parlare di “dislivelli esterni” alla nostra società, quando ci riferiamo alle
società etnologiche o “primitive”, e di “dislivelli interni” alla nostra società quando ci riferiamo ai
comportamenti e alle concezioni degli strati subalterni e periferici della nostra stessa società.
In linea molto sommaria (e con tutte le riserve che debbono ormai farsi in relazione alle modificazioni
politico-sociali prodotte dalle rivoluzioni anticoloniali) possiamo allora dire che i dislivelli esterni sono
l'oggetto dell'etnologia correntemente intesa mentre i dislivelli di cultura interni alle società dette
“superiori” sono l'oggetto delle indagìni demologiche (o di folklore, tradizioni popolari ecc.).
[…]
Ma come si sono formati i dislivelli interni di cultura? In linea molto schematica e generale può dirsi che
essi stanno in rapporto con i seguenti tre fatti:
a) le difficoltà materiali delle comunicazioni che, fino a tempi assai recenti, provocano forti
isolamenti delle zone periferiche rispetto a quelle centrali e capaci di piú decise ed espansive innovazioni,
con conseguente disparità di ritmi e diversità di direzioni di sviluppo, ulteriormente accentuate dalla
diversità delle rispettive forme economiche;
b) la discriminazione culturale dei ceti egemonici nei confronti dei gruppi subalterni, esclusi così
dalla produzione come dal godimento di certi beni di cultura (esempio tipico quello della esclusione,
durata fino a tempi molto vicini, dall'apprendimento del leggere e scrivere; di minore rilievo, in
apparenza, ma significativo di un più generale e decisivo atteggiamento, l'esempio fornitoci dalle leggi
suntuarie di età medievale e moderna che, fino alle soglie di quella contemporanea, vietavano l'uso di
certi tipi di abiti a certe categorie sociali subalterne);
c) la resistenza dei ceti periferici e subalterni alle imposizioni “civilizzatrici” dei ceti egemonici:
resistenza e imposizioni di cui ci offrono amplissima documentazione in un settore particolarmente
delicato, quello della religione, le condanne per le usanze pagane o paganeggianti, per le credenze e le
pratiche giudicate erronee ecc., stabilite da Concili e Sinodi ecclesiastici, statuti comunali e via dicendo.
Questo terzo aspetto, per il quale si può parlare di acculturazione forzata o coatta, è forse il più
importante, ed in proposito gioverà ricordare che gli scontri tra imposizioni egemoniche e resistenze
subalterne sono stati anche assai lunghi e molto aspri. Per esempio, al tempo in cui il cristianesimo ormai
divenuto egemonico si sforzava di penetrare nelle campagne e nei pagi, ancora vivacemente legati alle
loro religioni agrarie precristiane, la resistenza dei rustici era tanto forte e la volontà della penetrazione
evangelica era tanto risoluta che Gregorio Magno non esitava a chiedere ai nobili possidenti della
Sardegna di far intendere ragione ai contadini “idolatri” fustigandoli se schiavi e tassandoli duramente se
liberi. La forza delle resistenze subalterne e periferiche ci è poi attestata sia dal fatto che le condanne
(non solo verbali e spirituali, ma anche corporali e pecuniarie) sono durate fin quasi ai nostri giorni, come
mostrano vari atti sinodali anche abbastanza recenti, sia e soprattutto dal fatto che le pratiche “erronee” o
“superstiziose” cosi a lungo condannate continuano ancora a sopravvivere, anche se spesso in forme di
sincretismo.
2. Possiamo dunque dire che gli studi demologici, cosi come si sono venuti storicamente costituendo,
trovano la loro motivazione ed il loro oggetto in un dato storico-sociale che può descriversi
sommariamente come segue: anche tenendo conto delle eccezioni e delle attenuazioni che sono richieste
dalla notevole varietà delle situazioni concrete, resta però fermo il fatto che nelle società dette
“superiori”, le distinzioni, separazioni, stratificazioni e opposizioni sociali tra classi o ceti dotati di
diverso potere politico-economico trovano un generale riscontro in certe distinzioni, separazioni,
stratificazioni e opposizioni culturali. Le concezioni, i comportamenti ed il patrimonio di cognizioni delle
“élites” (e cioè delle classi o dei ceti sociali “dominanti” ed “egemonici”) non sono certo uguali alle
concezioni, ai comportamenti ed al patrimonio di cognizioni del cosidetto “popolo” (e cioè delle classi o
degli strati sociali “dominati” e “subalterni”): alla diversità della condizione sociale (politica, economica,
ecc.) si accompagna una diversità culturale (e cioè di conoscenze e convinzioni, oltre che di usi e costumi,
1
di osservanze e di gusti, e via dicendo) nella quale si manifesta la disuguale partecipazione dei diversi
strati sociali alla produzione ed alla fruizione dei beni culturali (per la definizione del folklore formulata
da Antonio Gramsci e implicitamente richiamata in quanto si è detto, vedi oltre).
3. In altre parole gli studi demologici si occupano della diversità culturale che si accompagna o
corrisponde alla diversità sociale: tra tutti i comportamenti e le concezioni culturali essi isolano e studiano
quelli che hanno uno specifico legame di “solidarietà” con il “popolo” (in quanto distinto dalle “élites”).
Il termine “solidarietà” che abbiamo introdotto non deve trarre in inganno: nell'uso tecnico esso sta ad
indicare il fatto che due o più fenomeni “vanno insieme”, e cioè il fatto che quando c'è l'uno ci sono anche
l'altro o gli altri.
Nel caso specifico, poi, la “solidarietà” consiste in ciò, che i gruppi sociali considerati come “popolo”
sono portatori di certi comportamenti e di certe concezioni. Il che non significa necessariamente che quei
gruppi sociali ne siano anche gli autori o i produttori: nel senso che correntemente si dà a questi termini,
la cosa è vera in alcuni casi ma non lo è in altri. Dire che certi gruppi sociali “popolari” sono portatori di
certi fatti culturali significa invece dire che essi ne sono o ne sono stati fruitori e utenti in modo specifico
e caratterizzante, e talora addirittura esclusivo, e ciò indipendentemente dalla nascita di quei fatti culturali
negli strati sociali dominanti o in quelli subalterni.
Ed infatti se possiamo parlare, ad esempio, di poesia “popolare” in quanto distinta dalla poesia “d'arte”
o “culta”, ciò avviene appunto perché certi testi, comunque e dovunque nati, vengono fruiti da certe
categorie sociali in certe specifiche modalità che (come si vedrà meglio) sono la trasmissione orale,
l'elaborazione e rielaborazione popolare o comune ecc. Altrettanto vale per gli altri settori demologici:
musica o fiabe, ornamentazione o pratiche mediche, credenze e osservanze religiose o magico-religiose
ecc.
4. Se chiamiamo connotazione l’accennato rapporto di solidarietà tra un fatto culturale e un gruppo
sociale, possiamo allora dire che gli studi demologici si occupano delle attività e dei prodotti culturali che
sono “popolarmente connotati”. Dobbiamo però aggiungere che se ne occupano proprio perché e in
quanto sono popolarmente connotati: li studiano non già perché siano più “validi”, più “veri”, più “belli”
ecc. rispetto ai prodotti e alle attività che hanno connotazioni “elitarie” o “non popolari”, ma
semplicemente perché esprimono, documentano e insomma rappresentano una particolare e specifica
condizione socio-culturale.
Per continuare nell’esempio, se della poesia popolare ci si occupa nel quadro degli interessi esteticoletterari o storico-letterari, si mirerà di solito a stabilire quale posto i testi poetici popolarmente connotati
occupino nella gerarchia dei valori letterari, o quale contributo essi abbiano dato allo sviluppo delle patrie
lettere ecc.: insomma si ricercherà quale sia la loro rappresentatività letteraria con criteri analoghi a
quelli che si adoperano per Dante o almeno per Cenne da la Chitarra.
Se viceversa si affrontano i testi poetici popolari da un punto di vista demologico, allora ciò che ci
importa non è tanto il fatto che quei testi siano più belli o piú brutti di altri, che abbiano contato più o
meno di altri nel cammino delle lettere ecc.; ciò che davvero importa è il fatto che essi rappresentino certi
modi di concepire e di vivere il mondo e la vita che appaiono propri di certi gruppi sociali. Al posto della
rappresentatività puramente letteraria subentra la rappresentatività socio-culturale.
Altrettanto può dirsi, con i necessari adattamenti, per gli altri fatti popolarmente connotati (usi, costumi,
credenze ecc.): ci piacciano o no, siano essi progrediti o arretrati, esprimano slanci verso il futuro o
invece intollerabile attaccamento ad un oscuro passato, essi contano come oggetto di studio perché
documentano una situazione e consentono la identificazione di un orizzonte culturale che, organico o
disorganico che sia, tuttavia è o è stato proprio di certi strati sociali.
2. Popolarità e popolo. Popolare e popolareggiante. Circolazione sociale dei fatti culturali, ascesa e
discesa, folklorizzazione.
1. Quanto si è detto comporta che la “popolarità” di un fenomeno qualsiasi venga concepita come uso e
non come origine, come fatto e non come essenza, come posizione relazionale e non come sostanza.
Allo stesso modo che nella lingua “la popolarità delle parole non dipende dall'origine o dalla forma ma
dall'uso e dall'ambiente” (Santoli), cosi anche nella poesia popolare e negli altri fenomeni demologici la
2
popolarità non dipende dall'origine (che può anche essere culta o aristocratica), né dalla forma (che può
anche non essere peculiare e specifica), e dipende invece dal fatto che quel particolare fenomeno (o
gruppo di fenomeni) è presente (esclusivamente o almeno in modo prevalente e caratterizzante) in un
certo ambito sociale, e non è invece presente (o è presente in modo non caratterizzante) in altri ambiti
sociali che coesistono con i primi.
In altre parole, e per ripetere quel che si è già scritto altrove, ciò che in genere fa la “popolarità” di un
fatto culturale (sia esso un canto o una pratica cerimoniale, una credenza o un racconto) è la relazione
storica di differenza o di contrasto rispetto ad altri fatti culturali coesistenti e compresenti all'interno dello
stesso organismo sociale. Per esempio, la trasmissione orale dei testi letterari è “popolarmente
connotativa” oggi e là dove esista una élite socio-culturale che pratichi essenzialmente o esclusivamente
la tradizione scritta; non lo è (e non lo è stata) nelle società o nelle epoche senza scrittura, nelle quali
dunque non esisteva una distinzione-opposizione fra oralità e scrittura. Ancora: la lamentazione funeraria,
e cioè il pianto rituale per i morti, si colloca tra i fatti demologici oggi e là dove coesista oppositivamente
con altri modi di esprimere il dolore e segnare ritualmente il passaggio ad “altra vita”; non è un fatto
demologico, invece, nella Troia omerica (si ricordi che al lamento sul cadavere di Ettore partecipa tutta
intera la società, dalle regine alle ancelle) e in ogni altra situazione (p. es. tra i “primitivi”) in cui il
cordoglio rituale sui morti è un istituto ufficialmente riconosciuto e praticato dall'intero gruppo.
Insomma la “popolarità” si definisce per differenza: se ne può sensatamente parlare solo nelle situazioni
storiche e sociali in cui coesistono (sono compresenti) fenomeni “non popolari”, “culti”, “aristocratici”
ecc.
2. Questo carattere relazionale e contrappositivo è del resto presente in modo piú o meno netto in tutta
la vicenda della nozione demologica di “popolo”, fìn dalle origini romantiche e romantico-risorgimentali
in cui esso venne concepito da un lato come “spontaneità” che si contrapponeva all'”artificiosità”, e
dall’altro come “anima nazionale” che si opponeva all'”oppressore” e allo “straniero”. Più in generale si
può dire che gran parte della storia degli interessi demologici può ricostruirsi attorno ai tipi di
contrapposizione di volta in volta istituiti.
Anche se le cose sono molto più complesse, per orientarsi riesce tuttavia utile ridurre questi tipi di
contrapposizione a due: uno, per così dire, verticale, ed uno orizzontale.
a) Possiamo dire che le concezioni romantiche e post-romantiche del “popolo-nazione” stabiliscono
una opposizione verticale nel senso che tutta intera la nazione, senza distinzione tra classi e categorie
sociali, viene contrapposta a ciò che alla nazione è estraneo (gli “oppressori” prima e i “nemici” poi).
Qualcosa di simile accade pure con l'ethnos dei positivisti, ed un analogo carattere di opposizione
verticale si può riconoscere nella concezione del “popolo-regione”, presente anch'esso nei nostri studi
ottocenteschi e oltre: in questo caso, infatti è la regione che, senza distinzioni tra classi o categorie sociali,
si contrappone allo “stato” accentratore.
b)
Possiamo dire invece che stabiliscono una opposizione di carattere orizzontale quei modi di
concepire il popolo che distinguono categorie diverse all'interno di una stessa società (nazione o regione
che sia), tagliandola appunto orizzontalmente.
Di questo tipo è la nozione del “popolo-volghi” che è stata spesso usata nel nostro campo di studi e che
contrappone alcuni strati (i volghi) ad altri strati (che volghi non sono). Va però osservato che questo
modo di distinzione orizzontale si è prestato e si presta ad una duplice interpretazione: si possono
concepire i volghi in generici termini sociali (gli “umili”, “incolti” ecc. rispetto ai “potenti” , “colti”
ecc.); ma li si possono concepire anche in termini psicologici o di “mentalità”: il popolo sarebbe, allora, il
complesso di tutti coloro che, al di là di ogni confine sociale, partecipano di una non troppo precisata
“mentalità associativa” o “collettiva”, scarsamente razionale ecc., mentre il “non popolo” o élite si
distinguerebbe, ancora una volta al di là dei confini sociali, solo in forza della sua razionalità e
individualità di pensiero ecc.
Fuori dell'ambiguità, e nettamente sul terreno sociale, si colloca invece la nozione di “popolo-classi
subalterne”, in cui l'opposizione taglia orizzontalmente le società (nazioni, regioni, ecc.) in “classi”
dominanti e “classi” dominate (Gramsci).
3. A complemento di quanto si è detto è opportuno sottolineare in modo esplicito che tra la zona dei fatti
«popolari» e quella dei fatti « culti » se ne riconosce genericamente una terza costituita da formazioni
3
culturali che occupano una posizione intermedia: si accostano più o meno all'una o all'altra delle polarità
estreme (“popolare” e “culto”), ma non coincidono con esse.
L'esempio più tipico e meglio caratterizzato di tali formazioni intermedie ci è offerto da quella che si
suole chiamare la poesia popolareggiante (o anche semi-culta, popolaresca e simili).
Il criterio per distinguere la poesia popolareggiante da quella popolare ci è dato dalla presenza o no di
quel fenomeno della elaborazione popolare o comune cui abbiamo già accennato e di cui torneremo a
discorrere (Q VIII 3 a). Se un testo (comunque e dovunque nato) è divenuto “patrimonio di tutti” ed “ha
subito un processo di libera trasformazione, generatore di varianti infinite e, di solito, di versioni
molteplici”, parleremo allora di “poesia popolare vera e propria”; se invece ci troviamo di fronte a
composizioni “fatte per il popolo”, ed anche divulgate, senza però “che in esse intervenga... l'elaborazione
popolare” (e cioè quel processo di libera trasformazione di cui sopra), parleremo allora di poesia
popolareggiante (cfr. V. Santoli, I canti popolari italiani: ricerche e questioni, Firenze 1968, p. 102; per
le varianti v. oltre).
Oltre che per la poesia, la distinzione tra popolare e popolareggiante viene impiegata anche nel campo
del folklore musicale (cfr. A 3. 6), ma i criteri su cui riposa sono altri: ci si orienta piuttosto verso le
caratteristiche della tonalità, dell'esecuzione o dell'emissione della voce, e di altri modi “interni”, per cosi
dire, delle melodie o dei ritmi.
Riesce più difficile, almeno finora, l'identificazione e la denominazione complessiva delle formazioni
intermedie negli altri settori folklorici. Resta però fermo che in tutti sono riconoscibili fatti e fenomeni
che si distaccano meno di altri dai fatti culti o di élite, e che dunque appaiono “popolarmente connotati”
in grado minore.
4. Da quanto siamo venuti dicendo sulla formazione dei dislivelli interni di cultura, sulle nozioni di
“popolarità” e di “popolo” e sulla esistenza di fenomeni intermedi “popolareggianti” o semiculti, risulta
già abbastanza evidente che lo strato popolare e quello culto, pur se distinti e opposti, sono tuttavia legati
tra loro da una fitta rete di scambi, prestiti, condizionamenti reciproci.
A chiarire meglio questo punto gioverà segnalare che i fatti culturali, oltre alla trasmissione nel tempo o
tradizione ed alla propagazione nello spazio o diffusione, subiscono uno spostamento nella dimensione
sociale che consiste in ciò, che le concezioni e i comportamenti nati in un certo gruppo o strato si
espandono ad altri gruppi e strati che li adottano, più o meno trasformandoli, e che talvolta li conservano
anche quando sono stati abbandonati nello strato o gruppo d'origine.
Tali spostamenti nella dimensione sociale sono di solito indicati con il nome complessivo di circolazione
culturale (o meglio socio-culturale), nome che è da intendersi come abbreviazione dell'espressione
completa ed esatta: circolazione sociale dei fatti culturali.
Lo spostamento nella dimensione sociale dei fatti culturali può avvenire fra ceti di livello gerarchico piú
o meno equivalente: tra contadini e pastori, per esempio.
Più interessano, però, in questa sede gli spostamenti che avvengono fra strati sociali di livello
gerarchico diverso, dotati cioè di diverso potere e di diverso prestigio sociale e culturale: ceti dominanti
da un lato e ceti dominati dall'altro. In questi casi si parla di discesa quando il passaggio avviene dai ceti
dotati di più forte potere e di maggiore prestigio (ossia dall'alto, come abitualmente si dice) verso i ceti
subalterni; si parla poi di processo di ascesa, quando il passaggio avviene in direzione inversa, e cioè a
partire dal basso.
Quando si parla di circolazione sociale dei fatti culturali non bisogna dimenticare che il processo non è
sempre meccanico (o “spontaneo”) e pacifico: nel quadro rientrano anche quelle imposizioni
“civilizzatrici” dei ceti egemonici su quelli subalterni di cui abbiamo già parlato.
I fenomeni di circolazione culturale, meccanica o intenzionale e coatta che sia, possono essere espressi
anche in termini di acculturazione.
Le questioni relative allo strato sociale di nascita dei fatti folklorici ed ai processi di ascesa e discesa
sono stati oggetto di molte discussioni, soprattutto per ciò che riguarda la poesia popolare.
I romantici e molti loro continuatori più o meno attardati hanno sostenuto la tesi dell'origine integrale
dal basso: il “popolo” avrebbe creato il suo patrimonio tradizionale in piena e completa autonomia
rispetto al mondo culto, e le sue “creazioni” sarebbero state anzi la fonte vera delle migliori produzioni
culte, per un processo di ascesa.
Le tesi romantiche sulla poesia popolare furono già messe in crisi, oggettivamente, dalla filologia
positivistica che (per esempio con Alessandro D'Ancona) documentò l'esistenza di numerosi contatti tra
poesia popolare e poesia culta o semiculta, e venne riconoscendo l'esistenza di prodotti originariamente
4
culti e poi discesi dall'alto nel mondo popolare. Soggettivamente, però, i positivisti continuarono in
genere a sostenere la priorità della nascita dal basso e dei processi di ascesa, anche se poi cominciarono a
interpretare in senso conservatore il mito romantico, negando la capacità “creativa” alle classi popolari
moderne, riservando questo privilegio solo al “popolo” delle “origini nazionali”, e rovesciando cosí in
senso conservatore il mito romantico.
Fin dagli inizi del '900, e poi sempre più decisamente nella fase idealistica la tesi romantica, già
corrosa dai documenti positivistici, venne completamente rovesciata. Si dichiarò che non soltanto la
poesia popolare ma anche tutto il resto dei fatti folklorici non era altro che il cascame degradato di
prodotti originariamente culti; e fu posizione non solo di studiosi che negarono ogni rilevanza agli studi
demologici, ma anche di specialisti di folklore quali ad esempio J. Meyer, E. Hoffmann-Krayer, H.
Naumann, i quali parlarono appunto dei fatti folklorici come di “materia colta decaduta” , ed affermarono
pure che “il popolo non produce ma riproduce”, assegnando all'operazione di “riproduzione” un puro
carattere di passività (cfr. G.Vidossi, Saggi e scritti minori di folklore, Torino 1960 pp. 200 sgg.).
Il dibattito tra la concezione romantica e quella idealistica appare oggi invecchiato perché viziato da
almeno un grave errore di fondo, cui non sfuggono neppure le posizioni positivistiche.
L'errore, dal quale deriva anche il carattere apologetico o denigratorio delle opposte tesi, sta nel ritenere
che i fatti demologici siano degni di considerazione scientifica soltanto se “creativi”, “belli”, “autentici”,
e insomma rappresentativi esteticamente, letterariamente, moralmente ecc. Viceversa, come si è già
detto, i fatti demologici meritano attenzione per quella che abbiamo chiamato la loro rappresentatività
socio-culturale, e cioè per il fatto che indicano i modi e le forme con cui certe classi sociali hanno vissuto
la vita culturale in rapporto alle loro reali condizioni di esistenza come classi subalterne.
Ma se lo studio demologico è soprattutto studio della rappresentatività socio-culturale di certe
formazioni - belle o brutte che ci appaiano, autonome o fortemente condizionate che risultino all'analisi
storica e morfologica - allora ciò che conta non è tanto la loro nascita dall'alto o dal basso, né la presenza
o meno di loro antecedenti extra-folklorici, culti o semiculti. Ciò che conta è invece il loro modo di
essere e di vivere nel mondo subalterno in quanto diverso da quello egemonico, e tuttavia ad esso
collegato. Ciò che conta, insomma, non è piú “l'esistenza di fonti esterne al folklore, ma la funzione del
prestito, la scelta e la trasformazione della materia mutuata” (P. Bogatirev - R. Jakobson, “Il folklore
come forma di creazione autonoma”, trad. it. in Strumenti critici, 1, 1967, pp. 223-40 [ed. orig. 1929]).
In altre parole, quando vi siano fonti o antecedenti extra-folklorici, l'attenzione si concentra sul
processo di “folklorizzazione” che esse hanno subito. E per folklorizzazione intendiamo quel complesso
di adattamenti, di modificazioni e più in genere di innovazioni (migliorative o peggiorative che appaiano
ai nostri occhi), con cui a livello popolare o subalterno si interviene su un fatto culto o semiculto per
adottarlo, adattandolo alle proprie esigenze, al proprio orizzonte, al proprio modo di concepire il mondo e
la vita. La folklorizzazione insomma è un processo “popolarmente connotativo” cosi come
“popolarmente connotati” sono i suoi prodotti.
Liberi da tesi pregiudiziali, apologetiche o denigratorie, oggi possiamo tranquillamente riconoscere,
anzi sottolineare, che moltissimi fatti che ci si presentano come popolarmente connotati hanno avuto
chiari antecedenti fuori del folklore: canti che, prima di essere trasformati dalla elaborazione popolare
avevano avuto connotazioni culte o semiculte; cerimonie che, prima di vivere residualmente nel “popolo”,
erano state riti di tutta intera la società o anche soltanto delle sue parti egemoniche; danze che prima di
essere “rustiche” erano state aristocratiche o almeno “cittadine” ecc. Né vi è alcuna difficoltà a
riconoscere che le trasformazioni subite dagli antecedenti extra-folklorici nel loro passaggio al mondo del
folklore possono costituire spesso degli impoverimenti, dei fraintendimenti ecc. Tutto ciò, infatti, non
solo non toglie validità o interesse agli studi demologici seriamente condotti, ma costituisce anzi un dato
essenziale per una loro rigorosa e fruttuosa condotta.
Che nel folklore vi sia molta o moltissima materia culta o semiculta “discesa” esprime appunto il fatto
che i ceti socio-economicamente dominanti non solo hanno più potere e più prestigio di quelli dominati
ma compiono anche quelle operazioni di discriminazione. culturale e di acculturazione forzata di cui
abbiamo già parlato.
Di contro, il fatto che gli antecedenti extra-folklorici spesso siano o appaiano “degradati” dal processo
di folklorizzazione, ci mostra da un lato i modi con cui i ceti subalterni hanno reagito in proprio alle
operazioni di discriminazione e di acculturazione forzata, e dall'altro ci segnala i limiti della capacità
espansiva della cultura egemonica che spesso ha potuto essere quella che è stata solo a prezzo di negare
nei fatti le proprie pretese universalistiche e umanistiche.
5
Quando si tenga ben fermo lo sguardo sia all'esistenza dei processi di circolazione culturale tra ceti
egemoni e ceti subalterni, sia al compito di cogliere il valore di rappresentatività socioculturale dei fatti
popolarmente connotati che spetta agli studi demologici, si è in grado di evitare due errori opposti ed
ugualmente pericolosi.
Si può evitare innanzi tutto l'errore romantico di credere che il folklore sia totalmente autonomo nei
confronti della cultura egemonica: lo si concepisce invece come necessariamente subalterno, allo stesso
modo che sono stati o sono subalterni i ceti sociali che ne furono o ne restano portatori.
Si evita però anche l'errore opposto, individualistico e idealistico. Come una classe socialmente
subalterna non è mai interamente passiva nei confronti dei gruppi che la dominano, cosi anche il folklore
non è riducibile soltanto alla passiva accettazione e degradazione di fatti culti. Anche a prescindere dalla
“attività” che si manifesta nell'accettare o nel rifiutare, nel modificare e nell'adattare, diviene possibile
riconoscere al folklore, senza rischi di ritorni al popolarismo romantico, una sua specificità, pur se nei
limiti della condizione subalterna; ed in linea di fatto è dato ritrovare formazioni folkloriche che appaiono
relativamente autonome rispetto al mondo ufficiale, e che in ogni caso lo limitano e lo condizionano
perché nate “sotto la spinta delle condizioni reali di vita” del popolo-classi subalterne, e generate dallo
“spontaneo confronto tra il modo di essere dei diversi ceti” (A. Gramsci, “Osservazioni sul folklore”, in
Letteratura e vita nazionale, Torino 1950, p. 219).
3. La dinamica culturale e i suoi processi
1. Nascita, trasmissione nel tempo, propagazione nello spazio, spostamento nella dimensione sociale.
Ogni formazione culturale, sia essa demologica o no, “vive” una sua sorta di “vita”: comincia ad
esistere, o “nasce”, in un qualche luogo e momento, e ad opera di qualcuno; dura più o meno a lungo nel
tempo, da una generazione all'altra, e si propaga da un luogo all'altro e dall'uno all'altro strato sociale; in
questi suoi “movimenti” nel tempo, nello spazio e nella società si conserva talvolta inalterata e talvolta
subisce trasformazioni più o meno profonde; infine “muore”, come spesso si dice, e cioè cessa di esistere
nell'uso e di agire negli individui e nei gruppi.
Fuori della metafora biologica, e adottandone una fisica, questa complessiva vicenda temporale,
spaziale e sociale viene di solito detta dinamica culturale; vengono poi chiamati processi i “momenti” o
“movimenti” che la costituiscono.
Come è facile intendere, i diversi processi della dinamica culturale sono strettamente legati l'uno all'altro:
la nascita non è altro che l'inizio di una trasmissione nel tempo, a partire da un certo luogo e da un certo
strato sociale; la propagazione nello spazio o lo spostamento nella dimensione sociale non sono
facilmente separabili dalla trasmissione nel tempo; le modifìcazioni o trasformazioni dipendono
complessivamente da tutti i “movimenti” temporali, spaziali e sociali, ecc.
Per queste ragioni ci è parso opportuno parlare cumulativamente e congiuntamente dei vari “gruppi” di
processi, collegandoli inoltre con le teorie generali e specifiche che ad essi si sono di volta in volta
connesse: lo abbiamo già fatto a proposito della circolazione sociale dei fatti culturali di cui è stato
necessario parlare fin dalle prime pagine del nostro quadro informativo, data l'importanza centrale che
essa assume per la demologia intesa come studio dei dislivelli interni di cultura; e lo faremo anche nei
paragrafi successivi trattando di poligenesi e convergenza, monogenesi e diffusione, tradizione e
innovazione, varianti ed elaborazione, collettività e individualità, 'langue' e 'parole', inculturazione,
acculturazione, sincretismi.
Tuttavia, per un migliore orientamento, qui ci sembra opportuno fornire un quadro più schematico e
sistematico dei singoli processi della dinamica culturale, un quadro che serva da rinvio a quanto in
proposito si è già detto in precedenza o si dirà più oltre; e lo facciamo raggruppando le indicazioni attorno
a quattro “momenti” o “movimenti”: a) la cosidetta nascita; b) la trasmissione nel tempo; c) la
propagazione nello spazio; d) lo spostamento nella dimensione sociale.
a)
La nascita: strato sociale, tempo, luogo, modo individuale o collettivo.
Le questioni che più di frequente si sono poste a proposito della cosidetta nascita dei fatti folklorici
sono quelle relative allo strato sociale, al tempo ed al luogo cui vada assegnato il loro inizio o la loro
origine. Ci si è inoltre chiesti se la nascita dei fatti demologici si debba a singoli individui o invece
alla collettività.
6
In verità le questioni ora accennate (strato sociale, tempo, luogo, individualità o collettività)
risultano spesso più complicate di quanto sarebbe necessario, e talvolta riescono addirittura confuse,
perché non sempre è chiaro se, parlando di nascita, ci si voglia riferire agli antecedenti extra-folklorici
culti o semi-culti, sui quali si è poi esercitata l'opera di folklorizzazione, o se invece ci si riferisca alla
nascita nel folklore, e cioè al momento ed al processo in cui o per cui un fatto compare come
popolarmente connotato, con o senza antecedenti extra-folklorici.
Ora, come è abbastanza evidente, gli interrogativi sullo strato sociale, sul tempo, sul luogo e
sull’individualità o collettività della nascita cambiano a seconda che ci si riferisca agli antecedenti
extra-folklorici o invece ai fatti demologici, siano essi tali fin dall’origine o risultino invece da un
processo di folklorizzazione di fatti culti o semiculti. A chiarire questo punto basti qui un esempio
relativo al tempo.
Se ci chiediamo quando sia nato l'uso della lamentazione funebre che oggi ci si presenta come
istituto folklorico proprio di certi strati contadini meridionali o insulari, abbiamo due possibilità:
possiamo considerare la lamentazione funebre indipendentemente dalle sue connotazioni popolari o
elitarie, o possiamo tenere conto di tali connotazioni.
Nel primo caso, e cioè trascurando gli strati socio-culturali in cui la lamentazione funebre è stata ed
è praticata, possiamo risalire almeno fino ad Omero. Ma in Omero, come abbiamo già notato, la
lamentazione funeraria non appare certo “popolarmente” connotata: è un uso o istituto di tutta intera la
società, dalle regine alle ancelle, e può addirittura darsi che fosse un istituto “aristocraticamente
connotato” e cioè riservato solo ai defunti appartenenti ai ceti egemonici. Risalire ad Omero significa
dunque risalire ad un antecedente extra-folklorico, ben al di là del processo di marginalizzazione per
cui la lamentazione funebre è divenuta un fatto folklorico (e cioè caratteristico dei ceti popolari).
Nel secondo caso, e cioè tenendo conto della connotazione popolare della lamentazione funebre
attuale, il tempo dell'antecedente omerico diviene secondario rispetto al momento in cui la
lamentazione funebre comincia ad apparire popolarmente connotata. Ed abbiamo almeno tre
occasioni documentarie per cogliere questo momento. La prima occasione ci è data da Solone, se è
vero che le sue leggi vietarono “l'uso del graffiarsi e del battersi e il cordoglio nei funerali degli altri”,
considerandoli come “duri usi barbarici”. La seconda occasione documentaria ci è fornita dalle leggi
delle Dodici Tavole che a loro volta vietarono i gesti di lutto più violenti e i lugubri gemiti: Mulieres
genas ne radunto neve lessum funeris ergo habento. La terza occasione, più direttamente collegata
con l'uso popolare attuale, ci è data infine dalle numerosissime condanne spirituali e materiali che il
cristianesimo ha comminato fin dal primi secoli per chi piangesse i morti al modo dei “gentili” o
pagani.
Se dunque guardiamo non agli antecedenti extra-folklorici ma alla folklorizzazione, dobbiamo
considerare non tanto l'età omerica quanto invece questi tre momenti nei quali i ceti egemonici
rifiutano un istituto che in precedenza avevano accettato e praticato, mentre di contro l’uso respinto
dalla cultura dominante continua ostinatamente a vivere, marginalizzato, nei ceti popolari.
[…]
b) La trasmissione nel tempo.
Una volta posti in essere, ossia nati, le concezioni, i comportamenti, gli istituti e i prodotti culturali –
siano essi demologici o no - possono avere varia durata nel tempo. Alcuni hanno vita assai breve, e cioè
cadono rapidamente fuori degli usi e delle abitudini del gruppo: è il caso delle cosidette “mode”. Altri
invece, attraverso un processo di trasmissione nel tempo, permangono attivi nella vita del gruppo per
decenni o secoli, e magari oltre.
Quando la trasmissione nel tempo avviene all'interno di uno o più gruppi socio-culturalmente
omogenei (da contadini e pastori a contadini e pastori, oppure da borghesi a borghesi) il processo
consapevole o inconsapevole attraverso il quale i fatti culturali si tramandano o passano da una
generazione all'altra viene detto tradizione; l'operazione poi con la quale gli individui delle nuove
generazioni vengono integrati nella cultura del gruppo viene chiamata anche inculturazione.
Se invece la trasmissione nel tempo avviene con passaggi da un gruppo socio-culturale ad un altro
diverso dal primo, si ha il fenomeno dello spostamento nella dimensione sociale (vedi oltre) e si parla di
acculturazione (cfr. Q VIII 5).
1 processi di tradizione e le operazioni di inculturazione non sono esclusivi del mondo popolare: si
verificano infatti anche ai livelli culti. Non è perciò possibile assumere la tradizione come un fatto di per
sé popolarmente connotativo. Se mai, in certe condizioni storiche, può essere “popolarmente
7
connotativo” il fatto che l’inculturazione avvenga prevalentemente o esclusivamente in modo
inconsapevole e spontaneo, e che la trasmissione nel tempo si verifichi esclusivamente o prevalentemente
per tramiti orali, con assenza totale o parziale dei tramiti scritti.
Alla trasmissione nel tempo, specialmente se spontanea e orale, si accompagnano assai spesso
modificazioni più o meno profonde della materia trasmessa; perciò al fenomeno della tradizione si
associa strettamente quello che viene detto della innovazione, anche se in verità si hanno innovazioni non
solo in rapporto alla tradizione ma pure in relazione alla propagazione nello spazio e allo spostamento
nelle dimensioni sociali (vedi oltre). Comunque in campo demologico l'innovazione è stata messa
soprattutto in rapporto con la tradizione, ed è stata studiata più specialmente nel settore della poesia
popolare, che con il complesso delle sue varianti ci offre la possibilità di riconoscere quell’importante
processo di conservazione-modificazione che va sotto il nome di elaborazione popolare o comune. Di
tutti gli argomenti accennati converrà dunque tornare a parlare in modo congiunto, ed è quanto facciamo
oltre nel paragrafo dedicato appunto a tradizione e innovazione, varianti ed elaborazione.
c)
La propagazione nello spazio.
Come si è già detto più volte, il processo di propagazione nello spazio dei fatti culturali si è proposto
in modo decisivo all'attenzione degli etnologi e dei demologi solo nel momento in cui alla teoria
poligenetica degli evoluzionisti si è contrapposta quella monogenetica dei diffusionisti. Sarà dunque
opportuno tornare a discorrere della propagazione nello spazio, genericamente detta diffusione,
trattando contemporaneamente la questione della nascita plurima o unica dei fatti culturali: ed è quanto
facciamo nel paragrafo dedicato a poligenesi e convergenza, monogenesi e diffusione.
Qui tuttavia è il caso di ricordare che i processi di propagazione nello spazio sono stati
sostanzialmente accantonati dagli indirizzi funzionalistici.
Segnaleremo inoltre che anche al processo di propagazione nello spazio si accompagnano quelle
modificazione innovative di cui abbiamo già accennato a proposito della trasmissione nel tempo (vedi
sopra) e di cui torneremo a parlare nel paragrafo dedicato a tradizione e innovazione, varianti ed
elaborazione.
Non va infine dimenticato che la propagazione nello spazio può investire anche gruppi culturalmente
diversi tra loro: in questo caso la diffusione viene a configurarsi piuttosto come acculturazione,
genericamente intendendosi per acculturazione l'acquisizione più o meno spontanea di forme culturali
diverse da quelle proprie.
Per le operazioni che utilizzano i dati della distribuzione al fine di ricavarne indicazioni sulla
cronologia dei fatti demologici si vedano le notizie sulle più volte ricordate tecniche storicogeografiche.
d) Lo spostamento nella dimensione sociale.
Come è del tutto evidente, e come abbiamo già sottolineato, lo spostamento nella dimensione sociale
dei fatti culturali assume una importanza centrale negli studi demologici che si applicano appunto ai
rapporti e agli incontri-scontri di diversi livelli di cultura; ed è questa appunto la ragione per cui, come s'è
già detto, dell'argomento abbiamo trattato fin dalle prime pagine del nostro quadro informativo. E perciò,
mentre da un lato ricordiamo la connessione che c'è tra la questione degli spostamento nella dimensione
sociale e la questione dello strato sociale di nascita (vedi sopra), dall'altro rinviamo a quanto si dice oltre
a proposito della circolazione sociale dei fatti culturali, dei processi di ascesa e discesa e della
folklorizzazione.
Qui torneremo tuttavia a ricordare che i fenomeni di spostamento nella dimensione sociale e di
circolazione culturale possono essere anche espressi in termini di acculturazione, e rammenteremo inoltre
che alla circolazione socio-culturale (e più specialmente alla folklorizzazione) si accompagnano quelle
modificazioni innovativi di cui discorriamo nel paragrafo su tradizione e innovazione, varianti ed
elaborazione).
2. Poligenesi e convergenza, monogenesi e diffusione.
a) Quando ci si trova di fronte al fatto che uno stesso fenomeno culturale è presente in due o più
zone geografiche più o meno lontane tra loro (p. es. una identica costumanza in Piemonte e in Sicilia, una
stessa fiaba in Spagna, in Irlanda e in Russia ecc.) si danno teoricamente due possibilità: la prima è che il
fenomeno culturale sia nato indipendentemente in ciascun delle zone in cui si trova presente; la seconda è
8
che il fenomeno sia nato in una delle zone (o in una terza) e di lì sia passato nelle altre. Nel primo caso si
parla di poligenesi, e nel secondo di monogenesi.
Per poligenesi si intende dunque la nascita plurima e indipendente dello stesso elemento culturale in
luoghi e tempi diversi; ed il fatto che un elemento identico esista in più luoghi viene considerato come il
prodotto di una convergenza (e cioè di un naturale convergere delle attività umane verso soluzioni e
risultati identici).
Con monogenesi si intende significare invece che i gruppi di elementi culturali identici hanno un unico
luogo e centro di origine, e che la loro presenza in luoghi anche distanti non è frutto di convergenza, bensì
di rapporti o contatti di cultura che hanno dato origine a spostamenti nello spazio degli elementi culturali,
e cioè al processo di propagazione o diffusione. Come è evidente, monogenesi non significa che tutti gli
elementi culturali siano nati in un solo luogo: i centri di nascita e di irradiazione possono essere, e di fatto
sono, più di uno.
[…].
b) Come è evidente, e come abbiamo segnalato più volte, le teorie poligenetiche non avevano alcun
interesse a rilevare o a utilizzare i dati della distribuzione spaziale dei fenomeni: ai loro occhi, infatti, la
presenza di uno stesso fenomeno in zone o presso gruppi più o meno distanti tra loro non era altro che la
manifestazione del fatto che quelle zone e quei gruppi avevano traversato le stesse fasi evolutive.
Di contro la distribuzione spaziale dei fenomeni assume una importanza centrale per gli indirizzi di tipo
monogenetico. I diffusionisti si pongono infatti il compito di accertare i luoghi e, possibilmente, anche i
tempi di nascita dei vari fenomeni; e poiché le testimonianze dirette sui luoghi e tempi di origine dei fatti
demologici sono estremamente scarse, i diffusionisti si sono serviti della distribuzione spaziale per
ricavarne indicazioni probabili su quei luoghi e quei tempi. In connessione più o meno diretta con la
geografia linguistica sono cosi nate le tecniche storico-geografiche e la geografia folklorica della scuola
finnica e di R. Menéndez Pidal, ed in Italia le applicazioni che Michele Barbi e Vittorio Santoli hanno
fatto al folklore della linguistica areale o spaziale di Matteo Bartoli. Come vedremo meglio a suo luogo
queste tecniche e questi criteri consentono di ricavare dai dati della distribuzione spaziale dei fenomeni
alcune indicazioni abbastanza probabili sulla loro successione temporale, e di determinarne quindi in
certa misura la cronologia relativa.
c) Come già sappiamo, quando la propagazione nello spazio investe gruppi e zone di cultura diversa, più
che di diffusione si tende a parlare di acculturazione, genericamente intesa come acquisizione di forme
culturali diverse da quelle tradizionali del proprio gruppo.
d) Anche la diffusione, sia essa acculturativa o no, provoca modificazioni innovative nella materia
propagata e costituisce un elemento importante nel processo di elaborazione: gioverà quindi il rinvio a
quanto diciamo appena più avanti a proposito di tradizione e innovazione, elaborazione e varianti.
3. Tradizione e innovazione, varianti ed elaborazione.
a)
Precisiamo innanzi tutto che i termini “tradizione” e “ innovazione” vengono usati per indicare
ora i processi ed ora invece i prodotti, nel senso che ora si riferiscono alle operazioni ed ora invece ai loro
risultati. In altre parole, quando si dice “tradizione” si può intendere il complesso degli atti di
trasmissione nel tempo compiuti dai singoli o dai gruppi (insegnamento e apprendimento ecc.), o si può
intendere ciò che quegli atti hanno trasmesso (questo o quel canto ecc.). Altrettanto vale per
“innovazione”, che può designare l'atto con cui si modifica una situazione preesistente introducendovi un
elemento che prima non era stato introdotto, o può invece indicare l'elemento introdotto (v. oltre).
Questo duplice valore dei termini induce a confusioni, che talvolta si cerca di eliminare usando il
singolare (tradizione, innovazione) quando si parla del processo, ed il plurale (tradizioni, innovazioni)
quando ci si vuole riferire ai prodotti. Ma l'espediente non è sempre efficace. Si potrebbe in verità cercar
di rimediare adoperando notazioni come quelle usate nei vocabolari quando si danno i diversi significati
di una parola, scrivendo per esempio tradizione1, o innovazione1, quando si vuole intendere il processo, e
tradizione2 o innovazione2 quando si vuole intendere il prodotto; ma non c'è troppo da sperare che
notazioni analitiche di questo tipo per il momento riescano a incontrare molto favore, dato che
presuppongono un processo di precisazione concettuale che nel nostro campo è appena avviato. Fino a
9
quando non lo si sarà portato abbastanza avanti, le ambiguità continueranno a permanere, e dobbiamo
affidare al contesto la funzione di scioglierle, quando è possibile.
Aggiungiamo che per la tradizione e l'innovazione (e in altri casi analoghi) lo studioso si trova
solitamente di fronte soprattutto ai prodotti e ai risultati, e da questi egli cerca di risalire ai processi ed alle
operazioni che li hanno generati. Ma si può anche cercar di cogliere i processi sul vivo, e cioè nel loro
diretto manifestarsi, ed è questo appunto uno degli aspetti importanti dei rilevamenti e delle inchieste “sul
campo”.
Notiamo infine che mentre per la tradizione ciò che più interessa chiarire in questa sede è il processo,
per l'innovazione converrà fornire qualche informazione tanto sul processo quanto sul prodotto.
b) La tradizione, intesa come processo, è stata a lungo concepita romanticamente in termini quasi mistici;
inoltre spesso se ne è parlato nel nostro campo come di un processo peculiare del folklore (e cioè
“popolarmente connotativo”).
In realtà la tradizione non è altro che la trasmissione nel tempo di certe forme, di certi contenuti, di
certe tecniche, di certi valori ecc., ed è un processo che non si verifica solo a livello popolare o solo in
certi particolari campi di attività (esistono tradizioni letterarie o artistiche “culte”, cosi come esistono
tradizioni filosofiche, scientifiche ecc.). Il processo della trasmissione (che è un processo sociale) è
indubbiamente complesso, ma niente affatto misterioso. Esso infatti può essere prospettato nei termini
delle operazioni consapevoli o inconsapevoli che ogni gruppo compie per integrare le nuove generazioni
entro i propri quadri culturali, e cioè secondo i propri modelli. Nella sua generalità, questo processo, che
viene anche detto di “inculturazione” o di “integrazione nella cultura del gruppo” presenta
sostanzialmente due facce:
α.) Da un lato c'è la pressione che il gruppo esercita sulle nuove leve, tanto a livello di puro e
semplice condizionamento inconsapevole (le abitudini fonetiche dialettali, per esempio, non vengono
“insegnate” in modo diretto ed esplicito ma vengono per cosi dire “impresse” sugli infanti dal puro e
semplice fatto che in quel luogo si parla cosi), quanto a livello di procedimenti educativi consapevoli
(siano poi essi quelli familiari o dell'ambiente, o siano invece quelli della scuola). Questa pressione di
carattere collettivo costituisce il quadro culturale coercitivo di cui si accenna anche più oltre.
β) Dall'altro lato ci sono i diversi tipi di reazione che le nuove generazioni hanno nei confronti della
pressione condizionatrice e dell'azione educativa: i modelli proposti possono venire “ereditati”
inconsapevolmente e in forma sostanzialmente passiva; ce se ne può invece appropriare in modo attivo e
più direttamente consapevole; si possono introdurre innovazioni; si può anche rifiutarli o passare
addirittura alla ribellione.
c) In materia di innovazione, intesa sia come processo sia come prodotto, noteremo anzitutto che si
suole talvolta distinguere tra “innovazione” e “invenzione”: ambedue sono modificazioni della situazione
esistente, ma la prima sarebbe piuttosto una trasformazione parziale di dati preesistenti, e la seconda
invece la introduzione di elementi completamente nuovi. Al limite estremo di questa linea crescente di
novità si colloca la “rivoluzione”, intesa come trasformazione radicale e strutturale dell'intera situazione
data.
Segnaliamo inoltre che di solito l'innovazione viene concepita come una modificazione che è stata
accolta e sanzionata dal gruppo, e le si attribuisce quindi un carattere sociale o collettivo.
E’ opportuno anche avvertire che tecnicamente si parla di innovazione (sia come processo che come
prodotto), indipendentemente dal giudizio sulla “qualità” dei risultati, e cioè tanto che essi ci appaiano
come “miglioramenti” e “progressi”, quanto che ci appaiano invece come “peggioramenti”,
“degradazioni”, “regressi” ecc.
Aggiungiamo infine che, come abbiamo ripetuto più volte, le innovazioni nascono non solo per il
processo di trasmissione nel tempo, o tradizione, ma anche per la propagazione nello spazio o diffusione,
per lo spostamento nella dimensione sociale o circolazione e per il congiunto processo di
folklorizzazione.
α) Passando ora a considerare l'innovazione in quanto processo, ripeteremo quanto già si è detto e
cioè che il termine indica il complesso delle operazioni con cui si interviene su una situazione
preesistente e dunque tradizionale (uno “stato di cultura”, o anche più semplicemente il testo di un
canto o di una fiaba), introducendovi elementi che prima non c'erano, eliminandone qualcuno che c'era,
o facendo ambedue le cose.
β) Le innovazioni intese come prodotto sono ovviamente i risultati delle operazioni innovativi.
10
Un caso particolarmente evidente e frequente di innovazioni-prodotto ci è dato, nel campo della
poesia popolare, dalle varianti che costituiscono appunto il risultato delle operazioni innovativi di cui si
è detto.
Gioverà un esempio. Se incontriamo un canto che incomincia
La vostra casa odora di moscado
Manco se fusse una pizzicaria..
e poi ne incontriamo un altro che incomincia
'Miezzu alla piazza addora de moscato
Come nce fusse 'na speziaria...
ci accorgiamo facilmente che le due coppie di versi sono contemporaneamente simili e diverse: hanno in
comune alcuni elementi o tratti (la forma generale, il riferimento all'odore di moscato ecc.), ma
differiscono per altri (“piazza” e “casa”, “pizzicheria” e “spezieria” ecc.). Poiché le somiglianze sono
forti e le differenze non decisive, possiamo dire di trovarci di fronte a due redazioni dello stesso testo, o
anche a due testi che sono l'uno modificazione parziale o “variante” dell'altro. E perciò quando parliamo
delle varianti di un testo intendiamo il complesso delle redazioni di quel testo che contengono delle
parziali modificazioni o, come anche si dice, delle “innovazioni parziali”. Occorre però far bene
attenzione al fatto che in questo caso “innovazione” non significa in senso stretto “modificazione che
avviene in un tempo successivo” (spesso non sappiamo quale delle redazioni preceda e quale segua), ma
più in generale significa “differenza che intercorre tra due o più testi, di cui ciascuno può essere
considerato come innovativo, e cioè modificato, rispetto all'altro”.
d) Strettamente connesso con le nozioni di tradizione, innovazione e varianti è il concetto di elaborazione
popolare o comune formulato e impiegato soprattutto a proposito della poesia popolare. Per elaborazione
popolare o comune si intende infatti quel processo innovativo che si applica ai testi (per lo più
tradizionalmente trasmessi, ma sovente anche “nuovi”) e li modifica in tutto o in parte per mezzo delle
varianti.
Alla base del processo di elaborazione popolare stanno essenzialmente due fatti: il carattere
esclusivamente o prevalentemente orale della trasmissione o tradizione dei testi; l'atteggiamento di libera
appropriazione con cui i testi vengono quotidianamente “usati” dai loro fruitori. I testi cioè passano,
come si suol dire, “di bocca in bocca”, senza (o quasi senza) tramiti o appoggi scritti; e ad ogni passaggio,
come pure ad ogni nuova ripetizione da parte dello stesso individuo, vengono trattati come cosa di libera
disponibilità, come una sorta di proprietà comune, di tutti e di nessuno, della quale ciascuno può fruire,
adattandola alle proprie esigenze, ai propri gusti, alle proprie capacità, ai propri stati d'animo, al proprio
dialetto, alla varietà delle situazioni esterne ecc.
Il processo di elaborazione popolare o comune si configura come un processo “collettivo”, nel senso
che si vedrà più oltre. Infatti, presi ciascuno per sé, i singoli interventi innovativi sono certamente
individuali; ma contemporaneamente sono tutti culturalmente condizionati, e cioè si muovono entro un
quadro di concezioni, aspirazioni, ideali che non sono e non potrebbero essere soltanto individuali; inoltre
non si ha innovazione reale se questa rimane un fatto privato, non accettato, non divulgato, e cioè se non
vi è un gruppo o sotto-gruppo sociale che l'approvi e la faccia propria. Per queste ragioni si parla di
elaborazione comune, e per queste ragioni (contrariamente a quanto ha sostenuto Croce) il processo della
elaborazione popolare appare “popolarmente connotativo”, cosi come lo sono, del resto, la oralità della
tradizione e la libera appropriazione dei testi. La tradizione orale, infatti, si contrappone alla coeva
tradizione scritta del mondo ufficiale. Quanto poi alla libera appropriazione (che si lega anche alla
quotidianità dell'uso della poesia nel canto e che si contrappone al rigoroso rispetto dei testi d'autore nel
mondo culto) essa configura un atteggiamento per il quale la poesia non è considerata come un affare di
specialisti socialmente separati dal gruppo, ed è invece, nei fatti, affare di tutti, in un comunitario uso o
godimento di cose che sono proprie, perché fatte o fattibili in proprio, e che dunque si usano logorandole
e aggiustandole, ripristinandole e buttandole via. In altre parole “il rapporto tra il testo e il suo utente, che
a livello scritto e culto si concreta nelle interpretazioni che non alterano il testo, a livello di tradizione
orale e di utilizzazione continua e quotidiana si concreta in interventi sul testo che producono non solo
centinaia di varianti ma addirittura redazioni radicalmente diverse”.
11
Per gli autori che più si sono occupati della elaborazione popolare (Menéndez Pidal, Santoli ecc.) v.
oltre. Sull'argomento vedi anche Cirese, Poesia popolare e formazione orale dei testi, in « Ulisse », XI,
1972, fasc. 71, pp. 136-48.
4. Collettività e individualità, langue e parole.
In campo demologico il problema della individualità o della collettività dei processi di formazione (o
nascita) e trasformazione dei fatti culturali si è posto soprattutto in relazione ai fenomeni di tradizione e di
innovazione di cui abbiamo già parlato, e solo in questo senso ne daremo qui rapidissima notizia.
a) La nascita collettiva dei fatti folklorici (e più specialmente della poesia popolare) è stata spesso
affermata in periodo romantico e positivistico in termini molto generici e imprecisi: quando non ci si sia
limitati al semplice ricorso a espressioni ambigue come “anima popolare”, “spirito dei popoli”, “genio
delle nazioni”, “etnos”, “razza” ecc., si è concepito uno stato o stadio psicologico privo di differenziazioni
individuali, e dunque tale che i prodotti di ogni individuo non sono diversi da quelli di ciascun altro: in
tale stato o stadio di indistinzione tra individui, i singoli fatti culturali vengono si prodotti da singoli
individui, ma potrebbero essere prodotti da qualunque altro. E’ questa la formulazione piuttosto tarda
(1922) di H. Naumann (cfr. Vidossi op.cit., pp. 202-203; Bogatiev-Jakobson, op. cit., p. 233), ma ci sono
già lontani antecedenti ottocenteschi non molto dissimili, quali ad esempio quelli di J. Ampère o di
Gaston Paris (1831-32 e 1866: cfr. A.Viscardi, Le origini, Milano 1950, pp. 529-30). E ad una sorta di
stato di trance collettivamente indotto dalla situazione e dai movimenti della danza avevano pensato alla
fine del secolo scorso e agli inizi del nostro F. B. Gummere e la sua scuola detta dei “comunalisti di
Harvard “ che hanno parlato di communal composition, communal poetry, communal mind, sostenendo
che la poesia popolare aveva come suo autore
il popolo, inteso non più secondo l'astrazione romantica ma proprio come una somma di
individui alla quale speciali condizioni ambientali e il movimento ritmico della danza
favorivano uno speciale stato di trance nel quale i versi uscivano identici dalla bocca dei
diversi individui (S. Baldi, Studi sulla poesia popolare d’Inghilterra e di Scozia, Roma 1949,
pp. 44-45; cfr. L.Bodker, Folk Literature (Germanic), Copenaghen 1965, alla voce “Popular
Ballad”).
b) Contro queste formulazioni di tipo sostanzialmente psicologico, e solo lateralmente sociologico o
culturale, erano abbastanza facili e pertinenti le obiezioni mosse da varie parti per negare la esistenza di
stati o fasi di indistinzione psichica, per sottolineare la presenza di distinzioni psicologiche individuali
anche presso i popoli primitivi, e insomma per rivendicare l'individualità non soltanto della nascita dei
singoli fatti culturali, ma anche delle successive modificazioni e innovazioni. E sono le obiezioni
dell'idealismo da un lato, e degli indirizzi diffusionistici e più specialmente di quelli storico-culturali
dall'altro.
c) La questione individualità-collettività è stata però riproposta in termini decisamente nuovi sulla base
dei concetti linguistici di langue e parole formulati da F. de Saussure.
α) Per Saussure la langue è l'insieme delle “convenzioni” e delle “regole” linguistiche che
consentono agli individui componenti un dato gruppo di esprimersi e di intendersi e cioè di comunicare.
Questo insieme (o meglio “sistema”) di regole e di convenzioni non è un fatto psicologico né è un fatto
individuale: è invece un fatto “sociale” (o se si vuole “collettivo”) nel senso che è comune a tutti gli
individui appartenenti ad una stessa comunità linguistica: è un “sistema grammaticale esistente in
ciascun cervello”, dove è stato “depositato” dall'apprendimento, e dalla pratica della lingua. Insomma
la langue è il codice interindividuale senza del quale non potremmo “codificare” i nostri messaggi
(tradurre le nostre idee in parole, facendoci capire, come correntemente si dice), e non potremmo
“decodificare” i messaggi altrui (e cioè non potremmo capire gli altri, traducendo in idee le parole che
essi ci comunicano).
Insomma “la langue è la parte sociale del linguaggio, esterna all'individuo, che da solo non può né
crearla né modificarla; essa esiste solo in virtù d'una sorta di contratto stretto tra i membri della
comunità” (F. Saussure, Corso di linguistica generale, trad.it. Bari 1967, p. 24).
La parole è invece “un atto individuale” con il quale il soggetto parlante “utilizza il codice della
langue” per esprimere il proprio pensiero.
12
Naturalmente non esiste langue senza parole, e cioè non c'è sistema o codice linguistico a carattere
sociale senza le sue realizzazioni individuali, e cioè senza gli atti di parole degli individui; ma non esiste
neppure parole senza langue, dato che è inconcepibile che un individuo possa comunicare il proprio
pensiero e intendere quello di altri senza che egli disponga di un codice interindividuale (o collettivo o
sociale) che stabilisca le regole e le convenzioni della comunicazione linguistica.
Va ancora sottolineato che per Saussure la langue è “un oggetto concreto” non meno della parole: essa
cioè non è un qualcosa che lo studioso ricaverebbe con una sua operazione intellettuale di astrazione dal
complesso degli atti di parole, che sarebbero i soli concreti; viceversa la langue ha una sua esistenza reale
e distinta “a tal punto... che un uomo, privato dell'uso della parole, conserva la langue, purché comprenda
i segni vocali che ascolta”.
β) I concetti di langue e parole sono stati applicati al problema della letteratura orale dal già ricordato
scritto di Piëtr Bogatirëv e Roman Jakobson.
Nel quadro della concezione saussuriana, i due autori stabiliscono uno stretto parallelo tra i fenomeni
linguistici e quelli della letteratura orale.
Nel sistema tradizionale e intersoggettivo della langue il singolo parlante può introdurre delle
“modificazioni personali”, ma queste divengono “fatti della langue” solo dopo che la comunità che ne è
portatrice “li ha sanzionati e accolti come validi per tutti”. In altre parole possiamo parlare di “nascita” di
una “innovazione linguistica” solo a partire dal momento in cui “la comunità linguistica se l'è
appropriata” e cioè solo a partire dal momento in cui essa si pone come un “fatto sociale”.
Analogamente
la vita di un tema folclorico in quanto tale incomincia solo dal momento in cui è stato
accolto da una comunità, e di esso esiste solo quanto questa comunità ha fatto proprio.
Il che significa che l'esistenza di un’ “opera di folclore non può non presupporre un gruppo sociale che
l'accolga e la sanzioni”, ed anzi la comunità esercita una sorta di “censura preventiva”, nel senso che un
fatto di folclore “nasce” solo nel momento in cui viene accolto, e dunque il rifiuto della comunità ne
impedisce “preventivamente” la nascita.
I prodotti della letteratura orale dunque si dispongono sul piano sociale, intersoggettivo, interindividuale
e insomma “collettivo”, della langue, e non su quello individuale della parole, e ciò non solo per quanto
riguarda la loro nascita ma anche per ciò che concerne le modificazioni o “varianti”:
Nel folclore il rapporto tra l'opera d'arte e la sua oggettivazione, ossia le cosidette varianti
dell'opera introdotte dalle diverse persone che la recitano, corrisponde esattamente al
rapporto tra langue e 'parole. L'opera del folclore è extrapersonale come la langue, e vive di
una vita puramente potenziale, non è insomma che un insieme di determinate norme ed
impulsi, un canovaccio di tradizione attuale che i recitanti animano con i loro apporti
individuali, come fanno i creatori della parola rispetto alla langue. Nella misura in cui
queste innovazioni individuali della lingua (o del folclore) rispondono alle esigenze della
comunità e anticipano l'evoluzione regolare della langue (o del folclore), esse vengono
socializzate e diventano fatti della langue (o elementi dell'opera folclorica) (op. cit., p. 228).
In tal modo la “collettività” dei fatti folclorici è concepita non più in termini di stati o stadi
psicologici privi di differenziazioni individuali, ma invece in termini di sistemi di “norme” o di
“convenzioni” culturali, e cioè in termini “sociali”.
d) Più in generale possiamo dire che oggi la questione della “collettività” dei fatti folklorici ci si
propone come serie di interventi e di prodotti di singoli che però vengono realizzati entro (e cioè a partire
da e in vista di) un quadro socio-culturale comune e fortemente determinante. E’ questo infatti il concetto
che si trova anche nella nozione di elaborazione o rielaborazione popolare o comune; ed un analogo
concetto esprime anche Antonio Gramsci quando afferma che la “collettività” del canto popolare è da
ricercare nella “concezione del mondo e della vita” che nei canti si manifesta e che ne fa la “popolarità”.
Il rapporto collettività-individualità è affrontato in termini di “cultura e personalità” dall'indirizzo di
studi statunitensi che porta appunto questo nome.
5. Inculturazione, acculturazione, sincretismi.
13
a)
Con il termine inculturazione (che ricalca l'inglese enculturation) si suole indicare in modo
generale il processo, o meglio il fascio di processi consapevoli e inconsapevoli, spontanei o organizzati,
attraverso il quale i nuovi nati di un dato gruppo socio-culturale vengono integrati nella cultura del
gruppo stesso, e cioè sono portati ad accettarne i valori e i modelli, ad assorbirne le conoscenze, ad
adottarne le concezioni e i comportamenti.
Come è evidente, e come abbiamo già detto altrove, il processo di inculturazione o integrazione nella
cultura del gruppo socioculturale cui si appartiene costituisce il supporto di quella trasmissione nel tempo
dei fatti culturali cui si dà il nome di tradizione.
Dal canto nostro sottolineeremo che in campo demologico, tenendo ben ferma l'attenzione ai dislivelli
interni di cultura che ne costituiscono l'oggetto, la nozione di inculturazione può riuscire fruttuosa solo se
è impiegata nel suo senso più stretto di operazione che si svolge tra individui che hanno gli stessi quadri e
gli stessi interessi socio-culturali: da pastori a pastori, o da contadini a contadini, ad esempio, quando gli
anziani trasmettono ai giovani concezioni e comportamenti tradizionali e “popolarmente connotati”;
oppure, ad altro livello, da cittadini a cittadini, quando insegnanti di estrazione e di concezioni borghesi
operano in scuole dei quartieri “bene” della città.
Non parleremo dunque di inculturazione per l'operazione con cui la scuola pubblica trasmette ai figli dei
pastori o dei contadini concezioni e modelli diversi da quelli “popolarmente connotati” che erano propri
dei gruppi socio-culturali da cui provengono i giovani: in questo caso impiegheremo piuttosto il concetto
di acculturazione.
b) Con il termine acculturazione - che ha avuto particolare fortuna negli studi statunitensi, mentre gli
studiosi inglesi hanno preferito l'espressione culture contact, contatto di culture - si intendono i processi
di scambio che si verificano per il contatto tra culture diverse tra loro.
In verità le definizioni dell'acculturazione sono numerose e controverse. La più celebre, anche se
discussa e contestata perfino dai suoi autori, è forse quella che ne dettero nel 1959 R. Redflield, R. Linton
e M. Herskovits e che suona: “L'acculturazione comprende i fenomeni che risultano dal contatto diretto e
continuo fra gruppi di individui di diverse culture, con conseguenti cambiamenti nei modi culturali di
uno o di ambedue i gruppi”. Ma non seguiremo qui le varie discussioni attorno a questa o ad altre
definizioni; ci limitiamo ad accennare che mentre da un lato in campo etno-antropologico si è giunti
talvolta a considerare addirittura come scientificamente infruttuosa la nozione stessa di acculturazione
dall'altro lato, in campo storico, si è avuto un tentativo di stabilire un contatto più diretto tra storia e
scienze umane proprio attraverso il termine e il concetto di acculturazione: cfr. A. Dupront,
L'acculturazione: storia e scienze umane, Milano 1966. […]
In campo demologico il problema dei contatti, degli scambi e degli scontri tra livelli culturali diversi
è centrale. Il concetto di acculturazione, quindi, pur se nato soprattutto in rapporto ai fatti etnologici (e
cioè ai dislivelli esterni di cultura), può essere fruttuosamente applicato anche ai dislivelli interni.
E’ chiaro infatti che quella circolazione sociale dei fatti culturali o quei processi di ascesa e discesa di cui
abbiamo già parlato più volte possono essere espressi in termini di acculturazione.
Più in particolare potremo distinguere, anche se in modo sommario e schematico, tra una acculturazione
“spontanea” o meglio meccanica, ed una acculturazione intenzionale e coatta.
Considereremo fenomeni di acculturazione meccanica quei casi in cui i quadri e i prodotti culturali
di un ceto sociale passano ad altri ceti di livello gerarchico uguale o diverso per la sola spinta del
prestigio rispettivo dei ceti stessi o di certi loro particolari modi e prodotti di cultura. E’ questo il caso,
ad esempio, della divulgazione e poi della folklorizzazione dei fatti letterari e musicali.
Parleremo invece di acculturazione intenzionale e coatta nel caso di quelle imposizioni
“civilizzatrici” dei ceti egemoni su quelli subalterni di cui abbiamo fatto precedentemente menzione. Ed
i fenomeni di acculturazione intenzionale e coatta si verificano soprattutto nel campo delle religioni, in
cui si assiste da un lato all'operazione acculturante delle religioni “superiori” ormai divenute
egemoniche, e dall'altro alla resistenza delle religioni “etniche” ormai sostanzialmente circoscritte ai ceti
subalterni: una resistenza in molti casi cosi lunga ed ostinata da costituire un serio ostacolo
all'operazione acculturativa, se non addirittura da costringere la cultura egemonica al compromesso.
c)
Tra i prodotti degli incontri-scontri che caratterizzano l'acculturazione, e più specialmente quella
intenzionale e coatta, sono da annoverare i cosidetti sincretismi.
14
Si parla in genere di sincretismo e di fatto sincretistico quando in un qualsiasi elemento culturale comportamento o istituto, concezione o prodotto - coesistono componenti culturali che inizialmente erano
tra loro contrastanti o addirittura inconciliabili.
Anche se di validità generale, la nozione di sincretismo trova le sue più frequenti ed agevoli
applicazioni ed esemplificazioni nel campo dei fatti magico-religiosi. Gli esempi folklorici sono
numerosissimi. Qui basterà ricordare i tanti scongiuri e le tante operazioni “magiche” in cui alla
concezione ed al procedimento, che sono essenzialmente pre-cristiani, si accompagna l'uso di nomi e
simboli dell'universo cristiano: contro il malocchio, oltre all'acqua e all'olio occorrono segni di croce e
simili. Insomma, come correntemente si dice, la “ superstizione” si mescola alla “fede”.
Guardate dall'esterno, e cioè secondo i quadri della nostra “cultura osservante”, i fatti sincretistici a
paiono come insanabili contraddizioni; ma evidentemente, vissute dall'interno della “cultura osservata”,
la contraddizione non esiste o non è percepita: se cosi non fosse' e cioè se il contrasto fosse avvertito ad
un qualche livello di coscienza dai portatori del fatto sincretistico, questi dovrebbero o rifiutarlo o
subirne profonde conseguenze traumatiche. Ciò che dunque appare come contraddittorio dall'esterno
risulta invece coerente dal proprio interno. E questo un esempio delle difficoltà che si pongono quando
ci si applichi a studiare culture o strati culturali diversi o “altri” dal “nostro”, e dei problemi
metodologici che si aprono a proposito del corretto rapporto da stabilire tra i quadri concettuali dello
studioso e i quadri concettuali propri della cultura studiata.
15
4. Identità, modernità, cultura popolare:
per ripensare i dislivelli interni di cultura
Fabio Dei
(
1.
In italiano l'aggettivo “popolare”, applicato alla cultura e alla letteratura, traduce i due termini inglesi
folk e popular, che pure in ambito anglosassone contrassegnano “oggetti” e tradizioni di studio assai
diverse. Il primo fa principalmente riferimento alla cultura rurale tradizionale, studiata dal folklore e
dall'etnografia, il secondo ai moderni prodotti dell'industria culturale, di cui si occupano principalmente i
media e cultural studies (disciplina, quest'ultima, che solo parzialmente corrisponde alla sociologia delle
comunicazioni di massa come è intesa nel nostro paese). Malgrado questa ambiguità semantica, la
tradizione italiana degli studi sulla cultura popolare è quasi esclusivamente volta all'ambito del folk - pur
adottando un concetto di folklore particolarmente sofisticato, che include aspetti della cultura delle classi
subalterne urbane e operaie, ma che si definisce sempre in contrapposizione alla “modernità” e ai prodotti
dell'industria culturale.
Per quanto riguarda la Toscana, oggetto privilegiato delle discipline DEA è stata la cultura contadina
mezzadrile, regno di una tradizione pura demarcata dal grande spartiacque della modernità. Ai confini
della mezzadria, o comunque di forme di lavoro e di vita pre-industriali, lo sguardo antropologico si è
quasi sempre fermato, temendo di inoltrarsi su un terreno malsicuro o magari di altrui proprietà.
Ora, è ovvio che le nostre discipline, se aspirano a comprendere la società contemporanea e non solo a
studiare forme culturali storicamente esaurite, devono superare questi limiti autoimposti. In particolare,
un progetto di rappresentazione in senso lato antropologica delle identità culturali locali, come quello che
sta al centro di questo convegno, non può fare oggi a meno di affrontare la documentazione della
modernità e del popular, oltre che del folk. In particolare, deve fare i conti con una pervasività
dell'industria culturale che non si pone solo come terzo elemento rispetto alla cultura alta e al folklore, ma
“contamina” sistematicamente queste stesse categorie, mettendo così in crisi il modello oppositivo coltopopolare come chiave di comprensione delle differenze culturali all'interno delle società complesse; una
crisi, peraltro, che è accentuata dalla crescente complessità dei rapporti di classe e delle relazioni fra
“capitale economico” e “capitale culturale”, per usare i termini di Bourdieu, nonché, come vedremo, dallo
sviluppo delle tecnologie comunicative.
Meno ovvie sono forse le implicazioni di questa apertura al popular sul piano delle metodologie e degli
strumenti concettuali usati dalle discipline DEA. In questo intervento, vorrei discuterne alcuni aspetti
partendo dal classico problema della demarcazione della cultura popolare, e in particolare dalla nozione di
“dislivelli interni di cultura”, che tanta importanza ha rivestito nella tradizione italiana degli studi.
2.
I recenti studi demologici italiani sono stati dominati da un ampio e importante dibattito sulla natura e i
confini della cultura popolare, che ha avuto probabilmente il suo momento di massima intensità negli anni
'70 ed ha goduto di una certa risonanza anche al di fuori di un ambito strettamente specialistico. Al di là
della differenza anche ampia di posizioni, mi pare che il dibattito si sia articolato attorno a due punti
largamente accettati dalla comunità degli studiosi. In primo luogo, una precisa caratterizzazione
sociologica della nozione di “popolo”, identificata in un'ottica gramsciana con l'ambito delle classi
subalterne - vale a dire, di quei gruppi sociali che non hanno accesso al potere politico ed economico e,
di conseguenza, sono esclusi dai meccanismi di elaborazione e trasmissione dell'alta cultura. In secondo
luogo, la centralità metodologica assegnata al momento della produzione culturale rispetto a quello del
consumo: per classificare ad esempio un tratto culturale come colto o popolare occorre guardare
all'ambito - egemonico o subalterno - della sua creazione e non a quello della sua fruizione o consumo. In
altre parole, è popolare non ciò che è prodotto per il popolo ma ciò che è prodotto dal popolo (anche se in
quest'ultima definizione possono rientrare le rielaborazioni “dal basso” di prodotti colti).
Occorre sottolineare il carattere non essenzialista, ma relazionale e storicista, di questa definizione:
l'ambito dell'egemonico e quello del subalterno si posizionano volta per volta rispetto a determinati
contesti storico-sociali. Come scrive Alberto M. Cirese, il principale teorico di questa concezione dei
dislivelli interni di cultura,
16
ciò che in genere fa la “popolarità” di un fatto culturale ... è la relazione storica di
differenza o di contrasto rispetto ad altri fatti culturali coesistenti e compresenti all'interno
dello stesso organismo sociale. Per esempio, la trasmissione orale dei testi letterari è
“popolarmente connotativa” oggi e là dove esista una élite socio-culturale che pratichi
essenzialmente o esclusivamente la tradizione scritta ... Insomma la “popolarità” si definisce
per differenza: se ne può sensatamente parlare solo nelle situazioni storiche e sociali in cui
coesistono (sono compresenti) fenomeni “non popolari”, “culti”, “aristocratici” ecc. (Cirese
1973: 15-6 ; corsivo nell'originale).
Il popolare-folklorico è dunque definito in modo dinamico ed aperto, ed è potenzialmente in grado di
comprendere la progressiva evoluzione dei fenomeni culturali nella società contemporanea. In questo
modo, almeno in teoria, la moderna demologia prende le distanze da precedenti indirizzi di studio, come
quelli romantici, positivistici e naturalistici, che miravano a caratterizzare una stabile essenza dei fatti
folklorici, identificando ad esempio la letteratura popolare sulla base di caratteristiche formali (come la
modalità orale di trasmissione, o l'origine anonima e collettiva) o di contenuto (la semplicità dei temi,
l'ingenuità e spontaneità dei sentimenti espressi e così via, secondo una diffusa concezione romantica di
“spirito popolare”); oppure, più semplicemente, identificandola in modo residuale rispetto alla letteratura
colta e moderna - come nella formula usata nel 1846 dall'inventore del termine folklore, William John
Thoms, e mai del tutto superata: “the manners, customs, observances, superstitions, ballads, proverbs, etc.
of the olden time” (cit. in Bauman 1992: 29; corsivo aggiunto).
Tuttavia, in pratica, anche la demarcazione relazionale in termini di egemonico e subalterno tende a
identificare la cultura popolare con un ambito tradizionale e residuale, vale a dire in contrapposizione alla
modernità. Per capire il perché, chiediamoci in che modo si formano i dislivelli interni di cultura - vale a
dire, come si passa dal piano delle differenze economiche e sociali a quello delle differenze culturali.
Cirese pone con lucidità questo problema (diversamente da chi, in quegli anni, sosteneva una concezione
quasi mistica della “coscienza di classe”), e fornisce tre spiegazioni in proposito (1973: 11):
a) “le difficoltà materiali delle comunicazioni”, che isolano la periferia rispetto al centro impedendole di
partecipare appieno ai processi di sviluppo;
b) “la discriminazione culturale dei ceti egemoni nei confronti dei gruppi subalterni”, i quali sono
consapevolmente esclusi dai processi educativi, dall'acquisizione di competenze e dal consumo dei beni
culturali alti;
c) “la resistenza dei ceti periferici e subalterni alle imposizioni «civilizzatrici» dei ceti egemonici”.
Si noti che i primi due punti radicano esplicitamente la cultura folklorica in un ritardo o deficienza, in
una incapacità (non importa quanto consapevolmente indotta dalle classi egemoni) di fruire dell'alta
cultura. Il terzo punto riconosce invece un'origine autonoma del folklore in chiave oppositiva; ma è
significativo che Cirese lo illustri con un esempio - quello della persistenza in ambito cristiano di pratiche
religiose “pagane o paganeggianti” legate ad antichi culti agrari (Ibid.: 11-2) - che sottolinea l'elemento di
sopravvivenza o di resistenza passiva, più che quello di una attiva e consapevole creazione culturale.
La teoria dei dislivelli interni di cultura sembra così portarsi dietro un'ambiguità che, come osservava
alla fine degli anni '70 Pietro Clemente, era già presente nelle osservazioni gramsciane sul folklore. Da un
lato, il folklore è visto come insieme di “concezioni del mondo” positivamente contrapposte a quelle
egemoniche, sulla base di quella che potremmo chiamare una relativizzazione storico-sociale del concetto
di cultura (un punto di vista che gli antropologi trovano congeniale, occorre notare, poiché si salda al
concetto relativistico di cultura che la loro disciplina ha elaborato negli studi sulle società non
occidentali). Dall'altro lato, il folklore è visto come l'insieme dei tratti che sono rimasti più lontani dalla
cultura moderna e sono caratterizzati dalla perifericità, dal ritardo, dall'arcaicità (Clemente 1979: 130). Se
il primo aspetto informa profondamente l'analisi e la valutazione dei fatti della cultura popolare, il
secondo resta però prevalente nella loro identificazione e demarcazione. Per cui, come nota ancora
Clemente,
nell'analisi concreta la subalternità tende a mutarsi in “perifericità”, la cultura popolare in
cultura passata più che attuale; il problema delle “ibridazioni”, delle trasformazioni, delle
stratificazioni culturali tende ad essere posposto all'iterativo, al puro, al non modificato...
(Ibid.: 147).
17
Clemente ritiene che questa concezione residuale non sia intrinseca alla teoria dei dislivelli interni, ma
dipenda da analisi che hanno tenuto in scarso conto le modificazioni della struttura di classe e i nuovi
canali di diffusione della cultura tipici della società tardo-capitalistica; assumendo invece a riferimento
“una situazione socio-culturale precedente la 'grande trasformazione' dei rapporti città-campagna e tra le
classi” (Ibid.: 143). A suo parere, si può correggere questa impostazione senza uscire dall'ottica
gramsciano-ciresiana, ad esempio integrando appieno nell'ambito demologico la cultura del proletariato
industriale (ma solo per i suoi aspetti subalterni: vale a dire, escludendo gli atteggiamenti della classe
operaia connessi alle sue aspirazioni egemoniche, come ad esempio le forme di organizzazione politica e
sindacale; Ibid.: 131).
A quasi vent'anni di distanza da queste osservazioni di Clemente, si può nutrire qualche dubbio sul fatto
che l'assunzione ad oggetto di studio della cultura operaia basti ad aggiornare la teoria dei dislivelli
interni: non da ultimo, perché risulta assai poco chiaro in cosa consista e come possa identificarsi una
simile produzione culturale autonoma del proletariato industriale, in quanto distinta dalla cultura di
massa che la classe operaia consuma. Ma al di là di questo, si deve anche notare che l’oggetto moderno
“proletariato industriale urbano” è intrinsecamente indigeribile per la teoria, proprio perché ad esso non si
applicano quei criteri di perifericità, isolamento e conservatorismo che, come abbiamo visto, spiegano la
formazione dei dislivelli culturali.
Allo stesso modo, si può dubitare oggi della possibilità di “salvare” la teoria adattandola alla sempre
maggiore complessità delle relazioni di classe nelle società tardo-industriali (Ibid.: 144): l'impressione è
che un simile adattamento la farebbe somigliare un po' a quelle cosmologie geocentriche immediatamente
precedenti la rivoluzione copernicana, disperatamente impegnate a neutralizzare le crescenti anomalie
osservative rispetto alla semplificazione del modello iniziale. Avendo oggi guadagnato un atteggiamento
più rilassato verso le categorie marxiste dell'analisi sociale, ci è più facile riconoscere il punto oltre il
quale la realtà empirica non è più piegabile alle esigenze del modello; e riconoscere la problematicità di
alcuni assunti sociologici su cui poggiava la teoria dei dislivelli.
Possiamo tentare di identificare approssimativamente almeno due di questi assunti. Il primo è una teoria
dicotomica della struttura di classe della società, che trascura e ritiene inessenziale ogni differenza che
non sia riconducibile a quelle fondamentali tra agrari e contadini, capitalisti e operai. Il secondo è l'idea
della coestensione di classe e cultura; l'ipotesi, per usare le parole di Giulio Angioni, che “le diversità e i
dislivelli di cultura, esistenti dentro le nostre società complesse e di classe, coincidono con certi scarti
strutturali e sovrastrutturali delle nostre formazioni sociali capitalistiche” (1979: 163; corsivo aggiunto).
Non v'è certo bisogno di insistere sulle difficoltà che questi assunti incontrano di fronte agli sviluppi sia
della realtà che della teoria sociale. Quest’ultima è giunta da tempo a mettere in discussione lo stesso
concetto tradizionale di classe, e rappresenta la stratificazione interna alle società a capitalismo avanzato
come una struttura “sempre più complessa ed eterogenea, caratterizzata da una proliferazione se non
addirittura una cacofonia di voci e di interessi” (Ginsborg 1998: 61). Ciò non significa naturalmente che
le differenze sociali scompaiono, ma che si moltiplicano e frantumano, producendo una rete irregolare e
in continua trasformazione di identità collettive.
Non solo, dunque, la concezione dicotomica è messa in crisi dal progressivo ampliamento di una classe
media peraltro fortemente eterogenea e segmentata al suo interno; ciò che più conta, i tradizionali criteri
di identificazione delle classi - il livello economico, la condizione lavorativa, il grado di istruzione etc. vanno sempre meno di pari passo e producono segmentazioni sociali non coincidenti. Al tempo stesso,
fattori come l’istruzione di massa e le nuove tecnologie comunicative (la televisione in primo luogo) si
contrappongono agli elementi di perifericità, discriminazione e resistenza passiva che per Cirese fondano
la coestensione tra condizione subalterna e cultura popolare: il che rende possibile la radicale divergenza
tra capitale economico, culturale e sociale, o, se così vogliamo esprimerci, tra l’identità strutturale e
quella sovrastrutturale. Vi sono ad esempio segmenti di classe media, come i piccoli imprenditori con
basso livello di istruzione tipici della “Terza Italia”, che hanno alto capitale economico e basso capitale
culturale; altri, come gli insegnanti, che hanno al contrario basso capitale economico e alto capitale
culturale. Come collocare l’egemonico e il subalterno in un simile quadro?
3.
Per tornare al problema che più ci interessa, questi assunti sociologici sono strettamente legati al
disconoscimento delle forme della cultura di massa da parte della teoria dei dislivelli. L’industria
culturale è la grande assente in Cultura egemonica e culture subalterne di Cirese (a meno che, forzando
molto, non la si voglia far rientrare nelle nozioni di “popolaresco” o di “folkloristico” - Cirese 1973: 18,
18
63). Così come, per lo più, è assente nell’intero dibattito sulla demarcazione. Si può anzi pensare che
giustificare l’esclusione dei prodotti mass-mediali e delle modalità del loro consumo dall’ambito della
demologia sia stata una delle istanze che hanno mosso e orientato fin dall’inizio il dibattito stesso. E’
proprio rispetto all’invadenza e all’inautenticità dell’industria culturale e dei consumi culturali di massa
che gli studiosi sentivano il bisogno di recintare un ambito del “vero” folklore; a rischio di estinzione ed
oblio, quest’ultimo doveva esser salvato e protetto attraverso la documentazione etnografica, nonché
valorizzato sul piano dei processi creativi che implica e dei significati morali e sociali che esprime.
Naturalmente, più invadente e pervasiva è la cultura di massa, più il concetto di folklore tende a
restringersi in direzione della tradizione e del passato. Questa è forse la maggiore aporia in cui si avvolge
il dibattito di fine anni Settanta, che resta infatti irrisolto e viene progressivamente abbandonato nel
periodo successivo: la concezione sociologica e relazionale di cultura popolare non può esser praticata
fino in fondo, poiché, applicata alla modernità, porta a imbattersi nella inautenticità dell’industria
culturale.
Gli studi folklorici classici, lavorando con una concezione essenzialista di folklore, potevano
convenzionalmente escludere i prodotti mass-mediali dall’ambito dei loro interessi, sulla base di
caratteristiche formali o di modalità di trasmissione: ad esempio, per il fatto di non esser radicati nella
vita di una comunità, di non venir trasmessi in una rete di rapporti faccia-a-faccia e di interazione diretta
tra “autore” e “pubblico”, e di esser legati (al pari delle forme scritte) a un “testo” fisso, senza la
variabilità e fluidità che deriva dalla trasmissione orale (cfr. Bauman 1992: 37). Ma la teoria dei
dislivelli, definendo il popolare in termini sociologici e non formali, non può permettersi una simile
convenzione metodologica. Essa si imbatte necessariamente in quella cultura di massa che investe
integralmente (sia pure con modalità molteplici) le classi subalterne, e in essa resta impigliata.
Da un lato, non può considerarla vera cultura popolare perché non è prodotta dalle classi subalterne ed è
anzi carica dei contrassegni dell’ideologia dominante; dall’altro, tuttavia, appare sempre più chiaro che
una produzione culturale subalterna, autonoma e distinta rispetto al consumo dei prodotti dell’industria
culturale, semplicemente non esiste nell’epoca della “comunicazione generalizzata”, in cui non vigono
più le condizioni ciresiane di isolamento e segregazione. Esattamente come nel campo degli oggetti e dei
beni materiali, la subalternità si esprime in modalità particolari di consumo della produzione industriale
(in funzione della scarsità di risorse, del livello di capitale culturale etc.), e non certo nel permanere di un
ambito artigianale della produzione, non toccato dai meccanismi omologanti dell’industria. Quando un
artigianato con pretese di autenticità si sviluppa, ciò avviene semmai in ambito egemonico, come
espressione di una cultura “alternativa” ed esplicitamente anti-industriale.
Per inciso, quest’ultimo punto suggerisce una ulteriore aporia interna al dibattito sulla demarcazione del
folklore. La valorizzazione del folk, pur presentandosi come un attacco alle pretese elitarie dell’alta
cultura, è a sua volta una mossa profondamente elitaria in quanto si fonda sul contrasto con l’inautenticità
e la volgarità del popular. Se vogliamo praticare la riflessività raccomandata da Bourdieu (1979: 12),
potremmo considerare il dibattito demologico come la più raffinata espressione del “gusto” di un ceto
sociale caratterizzato da basso capitale economico ed alto capitale culturale, che pone in atto una politica
estetica in grado di distinguerlo efficacemente dagli stili grossolani dei consumi di massa, e dunque dai
“nuovi ricchi” non meno che dalle tradizionali aristocrazie culturali organiche alle vecchie classi
dirigenti. I folkloristi di oggi sarebbero dunque le avanguardie di una “strategia della distinzione” che
può garantire spazi sociali elevati in corrispondenza di bassi redditi: quella che ad esempio contrappone
l’architettura delle case coloniche alle palazzine senza identità delle più o meno ricche zone residenziali,
l’arredamento contadino povero alle funzionali e luccicanti cucine componibili, e analogamente i canti
popolari alla musica leggera, le favole tradizionali ai cartoni animati e ai videogiochi, e così via. Una
strategia che “aristocraticamente” vendica la cultura contadina, irrisa e distanziata dalle classi medie e dai
ceti popolari urbanizzati, irridendo e distanziando proprio questi ultimi in quanto privi di autenticità
culturale. Cosicché il concetto demo-antropologico di cultura, nonostante le sue pretese di neutralità,
viene impiegato socialmente in modo valutativo, vale a dire per sostenere la distinzione di gruppi o
segmenti di classi sociali.
Si diceva dunque di un'intima contraddizione della teoria dei dislivelli, che da un lato, definendo il
popolare in termini sociologici, si trova sospinta verso i prodotti dell'industria culturale largamente diffusi
tra le masse “subalterne”; mentre dall'altro rifiuta di assumere a proprio oggetto tali prodotti perché li
ritiene espressione di un'ideologia dominante, imposta dall'esterno sulle classi subalterne. “Aprire”
all'industria culturale rischia, come osservava Clemente, di trasformare la demologia in una brutta copia
della sociologia della cultura e delle comunicazioni di massa; d'altra parte, “chiudere” ad essa significa
19
tornare a una concezione essenzialista e pre-gramsciana del folklore come tradizione, “usi e costumi dei
vecchi tempi”. Una possibile soluzione all’aporia poteva consistere nello spostare l’attenzione dalla
produzione al consumo della cultura : vale a dire, nel rileggere la teoria gramsciana dei rapporti tra classi
e cultura sul piano delle diverse modalità di ricezione e di risposta ai prodotti omologati dei mass-media.
Sarà questa la strada intrapresa dalla tradizione britannica dei cultural studies. Ma nel contesto
continentale degli anni ’60 e ’70 era dominante un clima di critica radicale all’industria culturale, vista
come espansione e trionfo definitivo della cultura dominante, che approfittava delle valenze globali e
totalizzanti dei mezzi comunicativi per togliere ogni spazio, anche minimo, all’alterità. Per questo il
folklore diviene in quel periodo terreno di critica sociale e di lotta politica: “resistenza” rispetto all’
“imperialismo interno” della cultura “borghese” - così come, per alcune concezioni, l'antropologia dei
paesi non occidentali si identificava con una “resistenza” ai meccanismi omologanti e totalizzanti del
capitalismo imperialista. Le varie “teorie critiche” che in quegli anni si occupano dei prodotti
dell’industria culturale (di cui la Scuola di Francoforte è forse la più celebre), lo fanno attraverso
un’analisi testuale che evidenzia il loro contenuto egemonico e conformista, la loro ideologia di supporto
allo status quo, l’effetto alienante e anestetizzante che hanno sulle coscienze. Questo atteggiamento,
sostanzialmente accettato dalle discipline DEA, le portava ad arroccarsi sempre più all’interno della
cittadella della “vera” cultura popolare, lasciando lo studio del popular ad altre discipline (come la
sociologia della cultura o le scienze della comunicazione) e restando prive di strumenti di fronte alle
complesse e mutevoli dinamiche culturali di fine secolo.
4.
In sintesi, a me pare che la teoria dei dislivelli interni di cultura, per coerenza con il suo approccio
relazionale e socio-politico al problema della demarcazione della cultura popolare, non possa
circoscrivere il suo interesse al solo folklore tradizionale e debba invece affrontare a pieno viso lo studio
del popular, della moderna cultura di massa. Mi pare anche che il presupposto centrale della teoria - vale
a dire che il colto e il popolare, l'egemonico e il subalterno, si definiscono l'uno rispetto all'altro all'interno
di determinate relazioni di potere storicamente situate - consenta un simile ampliamento di prospettiva. La
tradizione britannica dei cultural studies, come ho già accennato, è un esempio di tale possibilità esempio che è particolarmente interessante porre a confronto con la tradizione italiana poiché prende le
mosse dal suo medesimo nucleo teorico, vale a dire la teoria gramsciana dell'egemonia culturale. Secondo
l'approccio britannico, in campo culturale il riconoscimento del carattere egemonico o subalterno di un
certo item non può ridursi alla sola questione della sua origine, vale a dire al contesto sociale della sua
produzione: se così fosse, non esistendo nelle società a capitalismo avanzato ambiti separati della
produzione (né di merci né di prodotti culturali), non esisterebbe di fatto nessuna cultura popolare, nessun
margine di resistenza alla massificazione industriale. Eppure, il fatto che in queste società la
massificazione sia la condizione generale della circolazione di ogni merce così come di ogni
informazione, valore o tratto culturale non elimina certo al loro interno le differenze e le conflittualità tra
classi e gruppi di potere; conflittualità che si esercitano proprio attorno alla gestione di quel flusso di
merci e di “significati” che l'industria mette in circolazione. Questo punto è espresso con particolare
efficacia da John Fiske, uno dei più noti (e discussi) esponenti della scuola dei cultural studies:
Viviamo in una società industriale, e naturalmente la nostra cultura popolare è
industrializzata, come lo sono tutte le nostre risorse - e con “risorse” mi riferisco sia a quelle
semiotiche o culturali sia a quelle materiali, alle merci dell'economia culturale come di
quella finanziaria. Con poche e marginali eccezioni, la gente non può produrre, e di fatto non
produce da sola le proprie merci, materiali o culturali, come poteva accadere nelle società
tribali o folk. Nelle società capitalistiche non esiste alcuna autentica cultura folk, in contrasto
alla quale misurare l' “inautenticità” della cultura di massa; dunque, lamentare la perdita
dell'autentico è un infruttuoso esercizio di romanticismo nostalgico (Fiske 1989: 27).
Ma questo flusso di risorse materiali e culturali (“cose” e “parole”, “oggetti” e “segni”) non può esser
semplicemente considerato come il fronte di un'unica cultura (quelle delle classi che controllano
economicamente la produzione industriale) che annulla tutte le altre. Piuttosto, il flusso rappresenta la
materia prima su cui si esercitano le strategie semantiche dei diversi gruppi sociali, nella quale si
20
plasmano le relazioni e i conflitti fra l'egemonico e il subalterno. In questa prospettiva, l'attenzione si
sposta dalla produzione al consumo. Come si esprime Fiske,
il fatto che le persone non producano e non facciano circolare da sole le proprie merci, non
significa che la cultura popolare non esiste [...] La creatività della cultura popolare consiste
non tanto nella produzione di merci, quanto nell'uso produttivo delle merci industriali [...] La
cultura della vita quotidiana consiste nell'uso creativo e discriminante delle risorse che il
capitalismo mette a disposizione (Ibid.: 27-8)
In altre parole, limitarsi a considerare i macro-processi della produzione delle merci culturali, con il loro
carattere globalizzante, omologante, massificato ed “egemonico”, ci offre una prospettiva solo parziale.
L’altro versante è quello dei micro-processi di “resistenza popolare”, come si esprime Fiske, che
“trasformano la merce culturale in una risorsa, pluralizzano i significati e i piaceri che essa offre,
sfuggono o resistono ai suoi sforzi di disciplinamento, spezzano la sua omogeneità e coerenza, compiono
incursioni predatorie sul suo terreno” (Ibid.: 28).
Su questa immagine delle “incursioni”, “raid” o atti di “guerriglia” Fiske insiste spesso per esprimere il
rapporto tra i prodotti finiti dell’industria culturale e le strategie popolari del loro consumo. La stessa
immagine è usata da un autore come de Certeau, nel suo studio degli anni ’80 sulle pratiche della vita
quotidiana (1984). La teoria critica degli anni ’60 e ’70 rappresentava il consumo culturale come un
passivo processo di assimilazione di un’ideologia dominante inscritta dentro la “merce” o il “testo”
(pensiamo ad esempio a un programma televisivo); per cui, un’analisi testuale del prodotto sembrava
sufficiente a chiarire il suo significato sociale. Gli studi più recenti guardano invece al consumo come a
un processo più attivo e selettivo, in grado di “resistere” alla interna coerenza dei prodotti culturali e di
usarli come materia prima per la costruzione di significati sociali che si adattano alle esigenze di individui
e gruppi con peculiari caratteristiche di classe, di genere, di età, di appartenenza etnica etc. Il che
significa fra l’altro che l’analisi testuale, come quella proposta ad esempio dagli approcci strutturalisti,
non è sufficiente e può addirittura risultare fuorviante, se non è accompagnata da quella che potremmo
chiamare una etnografia della lettura.
In questa chiave, il popolare consiste non tanto nella cultura di massa di per sé, ma nelle modalità
eterodosse, non codificate e “antagoniste” (ibid: 169) del suo consumo da parte di gruppi sociali
subalterni. Una prospettiva, come si vede, che recupera il carattere relazionale della nozione di dislivelli
interni di cultura - anche se, per un curioso restringimento di prospettiva, Fiske non riconosce questa
natura oppositiva e antagonista alla cultura folk o tradizionale, che sarebbe, “diversamente dalla cultura
popolare (popular), il prodotto di un ordine sociale relativamente stabile e tradizionale, in cui le
differenze sociali non sono conflittuali, e che è dunque caratterizzato dal consenso piuttosto che dal
conflitto sociale” (Ibid.). Una definizione, questa, che è evidentemente debitrice del concetto
antropologico classico di folk society, e che esagera il grado di interna coesione e omogeneità delle
formazioni sociali pre-moderne.
La differenza, rispetto alla teoria dei dislivelli, consiste semmai nel fatto che la subalternità non è
identificata esclusivamente in termini di classe: essa si definisce invece attraverso una rete complessa di
identità o appartenenze che includono lo status sociale, la condizione economica e lavorativa, il sesso o
gender, l’età, l’origine etnica. Per usare l’espressione di Stuart Hall, uno dei “padri” dei cultural studies,
la subalternità si definisce come tale in contrapposizione a un “blocco-di-potere” che include il dominio
economico, quello razziale, sessuale e così via :
La gente contro il blocco-di-potere: è questa, piuttosto che “classe-contro-classe”, la linea
centrale di contraddizione attorno a cui si polarizza il terreno della cultura. La cultura
popolare, in particolare, si organizza attorno alla contraddizione: forze popolari contro
blocco-di potere (Hall 1981: 238)
In questa prospettiva, che Fiske fa interamente propria, la vita culturale nelle società tardo-industriali è
percorsa da una tensione continua e in ultima analisi irrisolvibile tra, da un lato, le istanze di controllo e di
disciplina promose dal blocco di potere e incorporate dai prodotti dell’industria culturale (quelle istanze
che, per quanto unilateralmente, erano identificate dalle critiche dell’ideologia degli anni ’60 e ’70) ; e,
dall’altro, le micro-resistenze opposte nell’ambito del consumo e della quotidianità dalla “gente”, da
gruppi subalterni che non possono però essere identificati rigidamente nei termini di una teoria delle
21
classi, ma si definiscono volta per volta in quella rete di differenze irriducibili che persistono nelle società
complesse nonostante le strategie globalizzanti e omologanti del tardo capitalismo - differenze che anzi
prosperano e si alimentano per mezzo della stessa materia prima prodotta dall’industria culturale.
Ora, il punto di vista di Stuart Hall e di Fiske presenta numerose debolezze e semplicazioni (se ne veda
una critica durissima, all’interno della stessa tradizione dei cultural studies, in McGuigan 1992: 70-75 e
passim); in particolare, Fiske sembra spesso cadere nella banalità quando identifica le “strategie di
resistenza”, che fa coincidere con semplici letture selettive di testi culturali (p.es., le donne possono
trovare spunti antagonistici nelle soap operas, semplicemente ignorando il messaggio patriarcale che pure
è inscritto nel testo), o in interventi artigianali non approvati (tagliuzzare i jeans è un’operazione
oppositiva rispetto alla disciplina dell’industria della moda, almeno finché quest’ultima non la incorpora
nel proprio stesso discorso). Tuttavia, ho discusso la posizione di Fiske solo come esemplificativa di un
approccio che consente di ampliare verso la modernità lo studio della cultura popolare, e suggerisce lo
sviluppo di una sistematica etnografia della quotidianità, indispensabile per ogni tentativo di affrontare il
problema delle identità culturali nelle società complesse.
In sintesi, le strategie antropologiche suggerite dai cultural studies consentono di recuperare gli aspetti
più produttivi della nozione di “dislivelli interni di cultura”, attraverso uno spostamento dell’attenzione
non solo dalla tradizione alla modernità, ma anche dal momento della produzione a quello del consumo
culturale, dall’analisi testuale all’etnografia delle pratiche di lettura, dai macro-processi sociali, economici
e ideologici ai micro-contesti della quotidianità.
5. Il “ritorno a casa” dell’antropologia1
Vincenzo Cannada Bartoli
1. “Ritorno a casa” dell’antropologia?
Molti, fra cui Appaduraj2, sostengono che, dalla fine dell’Ottocento, l’antropologia sarebbe stata
caratterizzata dal recarsi «somewhere», possibilmente in un luogo remoto - nei diversi sensi dell’espressione
- dal luogo di pensiero dell’antropologo: «la scienza dell’altro è stata inestricabilmente legata al viaggio
altrove»; sicuramente, in seguito alle ricerche di Malinowski e Boas, l’antropologia è stata distinta - e
identificata - con la pratica del fieldwork, della “ricerca sul campo” in situazioni individuate in base a
un’ipotizzata “differenza culturale” rispetto a quelle di appartenenza del ricercatore, spesso proveniente
dall’Europa o dagli Stati Uniti.
Questo non implica che l’antropologia condotta “altrove” abbia coinciso soltanto con un’antropologia
degli “altri”, in quanto non necessariamente ambito di ricerca e ambito di analisi debbono corrispondere:
quando Malinowski, in Argonauti del Pacifico Occidentale, esamina il circuito di scambio degli oggetti del
kula nelle Trobriand, traccia un parallelo fra il processo di attribuzione del loro valore e quello, analogo, per i
gioielli della corona inglese 3; e, quando Mauss, nel Saggio sul dono4, opera un confronto con la nozione
1
Scritto nel 1996, e destinato in origine a un manuale per gli studenti. Sottoposto a revisione e a qualche
integrazione, in particolare da un altro articolo su un argomento affine: Vincenzo CANNADA BARTOLI, 1998,
«Research ‘at home’: periodic surveying and on-site permanence» in European Ethnology Meetings, a cura
di Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli: 95-122. Ringrazio per suggerimenti, revisioni, libri in
prestito, critiche, letture, Maria Federico, Vincenzo Padiglione, Alberto Sobrero.
2
Arjun APPADURAJ, 1986 «Theory in Anthropology: Center and Periphery» in Comparative Studies in
Society and History, 28: 356-61
3
«I gioielli della corona, infatti, troppo preziosi e troppo scomodi da portare, rappresentano la stessa cosa dei
vaygu’a in quanto sono posseduti semplicemente per il piacere di possederli e la proprietà, con la fama che
ne deriva, è la fonte principale del loro valore. Inoltre, sia i cimeli di famiglia sia i vaygu’a sono amati per il
significato storico che hanno assunto. Per quanto brutto, inutile e privo di valore, secondo l’opinione
corrente, possa essere un oggetto, se è apparso sulla scena della storia ed è passato per le mani di personaggi
22
occidentale di moneta, affianca, ai casi etnografici della Melanesia, altri esempi tratti dal mondo greco o
romano, “the alien Other of the model”5 - secondo un metodo già praticato dagli evoluzionisti - e altri ancora,
inerenti all’uso contemporaneo del dono in “Occidente”6. Da questo punto di vista, sembra che all’interesse
per gli “altri” non abbia corrisposto una rimozione del “noi”, ma l’affermazione di una prospettiva, a volte
comparativa, a volte di giustapposizione, incentrata, a seconda degli orientamenti teorici, su criteri diversi,
secondo un procedimento che sembra essere tra i fattori costitutivi dell’antropologia7 .
Tuttavia, appare innegabile che, fino a un certo periodo, siano state le “altre” società, le “altre” culture a
fornire, attraverso la ricerca etnografica, “dati” su cui fondare e in cui inscrivere il confronto, mentre la
“nostra” società veniva assunta come metro, generalmente implicito, sul quale misurare lo scarto della
diversità, direttamente proporzionale alla ricchezza, se non alla “stranezza”, dell’informazione etnografica
‘trovata’: sicché un aspetto ordinario del vivere come la burocrazia8, avrebbe potuto difficilmente essere
accettato come un “terreno” appropriato – e, forse, come un argomento passibile di indagine etnografica fino a non troppi anni fa.
In questo senso, si capisce perché l’idea del “ritorno a casa” dell’antropologia, cioè la ricerca
etnografica condotta direttamente in “Occidente” 9- senza soffermarsi, per il momento, su quanto questo
storici, divenuto un inesauribile veicolo di importanti associazioni sentimentali, non può che essere prezioso
per noi. Questo sentimentalismo storico, che ha una gran parte nel nostro interesse generale per lo studio
degli avvenimenti del passato, esiste anche nei Mari del Sud [...] I gioielli della corona o i cimeli di famiglia
sono insegne di rango e simboli di ricchezza rispettivamente, e, da noi in passato, in Nuova Guinea fino a
pochi anni fa, rango e ricchezza andavano insieme» (Bronislaw MALINOWSKI, Argonauti del Pacifico
Occidentale, Roma, Newton Compton, 1973: 107-108).
4
Marcel MAUSS, 1950 (1925) «Essai sur le don», in Sociologie et anthropologie, Paris: Presses
Universitaires de France
5
James CARRIER 1992 «Occidentalism: the World Turned Upside Down» in American Ethnologist, 19:
195-212
6
In questo modo, Mauss avrebbe dato luogo a una contrapposizione tra “economie del dono” o “economie
della merce”, che proseguirà nel tempo, al pari di altre opposizioni fra società basate sulla parentela e società
basate sulla politica (per quest’ultimo tema, v. in particolare Adam Kuper, The construction of primitive
society: transformation of an illusion, London, New York, Routledge, 1988), secondo una prospettiva che
verrà ‘decostruita’ da James CARRIER, Occidentalism. Images of the West, New York, Oxford University
Press, 1995, nell’ambito di una critica alle generalizzazioni sulle culture.
7
v. Lenclud, op. cit.
8
Denis GUIGO, 1992 «Perspectives anthropologiques dans les organitasions modernes» in L'Homme, 121:
47-65; Michael Herzfeld, The Social Production of indifference: Exploring the Symbolic Roots of Western
Bureaucracy New York & Oxford: Berg Publishers, 1992
9
Mi sembrano possibili due accezioni dell'espressione 'ritorno a casa': la prima presuppone un riferimento
alla situazione storica in cui nasce l'antropologia, e quindi all'assunzione dell'Occidente come terreno di
ricerca; la seconda invece si riferisce alla possibilità di assumere come oggetti di ricerca aspetti che
appartengono alla cultura dell'antropologo: nel primo caso, il ritorno a casa è dell'antropologia nel suo
complesso, nel secondo dell'antropologo, la cui 'casa' potrebbe anche non coincidere con quella
dell'antropologia (ovvero, con le nazioni occidentali), per cui l'antropologia 'a casa' non si riferisce a un'area
particolare, ma al rapporto tra ricercatore e 'cultura' indagata, un rapporto di appartenenza che, in quanto tale,
può riferirsi ad antropologi di ogni parte del mondo.
In uno scritto precedente (Vincenzo Cannada Bartoli, op. cit.) ho utilizzato quest’ultima accezione,
di rapporto – inteso anche in termini di nessi biografici – che lega l’antropologo alla propria cultura e ai
propri luoghi. Qui, invece, faccio riferimento alla prima – cioè alla “riflessività” in toto dell’antropologia: se,
infatti, si considera che l'antropologia, intesa come indagine specializzata sulla cultura, è una pratica
storicamente nata in Occidente, il rapporto di riflessività sembra coniugarsi, in senso stretto, solo per gli
antropologi occidentali che fanno ricerca in Occidente, dal momento che gli antropologi provenienti da altre
'culture' passano, nel corso della loro formazione, per un periodo di apprendistato radicato in modalità
appartenenti a una 'cultura' diversa da quella cui appartengono e quindi, nel momento in cui l'Occidente è il
loro oggetto di studio, utilizzano a loro volta anche concezioni e pratiche nate nella 'cultura' studiata.
Rivedendo il testo, sottolineo la nascita, più che l’appartenenza, perché mi rendo conto del rischio di
sovradimensionare le differenze tra culture, l'uniformità al loro interno e di intendere in termini di eccessiva
23
stesso termine possa contribuire a donare, e a formare, un’impressione di coesione per un insieme eterogeneo
di culture e di pratiche - abbia di volta in volta suscitato entusiasmi di “rifondazione” o dato adito a critiche
improntate all’osservazione del nihil sub sole novi, a seconda che ci si sia soffermati sulla novità del terreno
di indagine o sulla preesistente tradizione di comparazione.
La stessa novità del terreno di indagine, del resto, può essere messa in dubbio, considerando la priorità
cronologica degli studi del folklore, o delle “tradizioni popolari”; anche se a queste ultime impostazioni
possono essere indirizzate accuse, già formulate agli studiosi del “lontano”, di ri-produzione dell’“alterità”10.
Il processo di “ritorno” andrebbe anche posto a confronto con l’influenza, diretta e secondaria,
esercitata sulle discipline limitrofe, e attraverso quest’ultime, per cui lo “sguardo” antropologico è entrato a
far parte, a modo e a titolo diverso, di altri orientamenti, modificandoli e uscendo modificato da questa
interazione11, secondo un processo che può essere incluso tra gli effetti o tra i fattori del “ritorno”12 .
2. I motivi del ritorno e le differenze di attuazione
Diversi autori13 fissano negli anni ’60 l’inizio del processo di “ritorno” – nel senso, specificato
prima, di assunzione dell’ ”Occidente” come terreno di ricerca etnografica –motivandolo con la
concomitanza di diversi fattori: il mutamento della situazione politica nelle ex-colonie, con conseguenti
difficoltà e rifiuti, da parte dei nuovi regimi politici, ansiosi di modernizzazione, di farsi assumere come
“oggetti” di studio, e con le accuse all’antropologia di essere stata “ancella del colonialismo” 14; a queste
motivazioni, provenienti dagli ex-terreni ‘classici’, e sostenute o echeggiate politicamente in “Occidente”, si
legavano altri fattori, provenienti dall’ ”Occidente”, dove, sia per la congiuntura economica, sia per
l’allargamento della base degli studenti in antropologia, sia per la contrazione dei fondi, sia per il venir meno
della rete logistico-amministrativa del sistema coloniale, affrontare come primo terreno un paese lontano
poteva risultare estremamente costoso. Per questo insieme di ragioni, diversi ricercatori, molti dei quali
contrapposizione il rapporto tra culture e modalità differenti di pensiero. In questo senso, un’accezione più
accettabile mi sembra quella che punta sulla storicità del percorso di formazione delle concezioni.
10
«Dal momento che gli antropologi sono in gran parte bianchi, della classe media, con un alto grado di
istruzione, essi sono in grado di poter definire molto altro come alieno. Questa fluidità è resa manifesta dal
fatto che molti antropologi che hanno rivolto la loro attenzione all’Occidente hanno analizzato un nuovo
insieme di alieni, più vicini a casa del Bororo, ma ancora diversi. La loro diversità può consistere nel fatto di
essere isolati socialmente, come i contadini del Mediterraneo o i montanari degli Appalachi. Allo stesso
modo, possono essere diversi perché mancano di importanti caratteristiche sociali o culturali, come gli
appartenenti alla working- class Philadelphia, i quali ignorano le moderne concezioni mediche, o gli abitanti
di una città del Montana che ignora la propria storia» (CARRIER, op. cit.: 6).
11
A questo proposito, e soprattutto rispetto al rapporto con la storia e con gli storici, difficili vicini di casa in
Francia - e ancor più difficili condomini all’École des hautes études en sciences sociales - v. Marc AUGÉ,
Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Aubier, 1994: 9-29.
12
Uno dei campi in cui questo processo è stato più avvertibile è stato quello dello studio della parentela,
dove, a differenza che nelle società “lontane”, spesso prive di tradizione scritta, gli antropologi hanno potuto
- e dovuto - utilizzare una serie di dati scritti, con profondità anche di secoli, e confluenze con la prospettiva
storica. V. in proposito il libro di Jack GOODY, Famiglia e matrimonio in Europa: origini e sviluppi di
modelli familiari dell’Occidente, Milano, Angeli, 1984 [1983], e, per l’Italia, quello di Gerard DÉLILLE,
Famiglia e proprietà nel Regno di napoli. XV-XIX secolo Torino, Einaudi, 1988 [1985]. Sulla problematicità
di importare, o di criticare, nozioni come quelle di lignaggio in Europa, un articolo denso, e ricco di
riferimenti bibliografici, è quello di Dino PALUMBO, 1994, «"Tu per sette generazioni...". Alcune riflessioni
su discendenza e parentela in Europa» in L'Uomo, VII n.s., 1-2: 235-302.
13
V., tra gli altri, John W. COLE, 1977, «Anthropology comes part-way home: community studies in
Europe» in Annual Review of Anthropology, 6: 349-78; Agar, op. cit.
14
«Sostenere che l’antropologia abbia servito il colonialismo sarebbe ingiusto e falso; ma essa ne ha
beneficiato, si è sviluppata nella sua ombra: sul piano epistemologico, il suo sforzo di studiare l’uomo nel
modo più obiettivo riflette, ch’essa lo voglia o meno, uno stato di cose nel quale una parte dell’umanità
giaceva a disposizione dell’altra» (Claude LÉVI STRAUSS, 1975 «Anthropologie structurale» in Diogène, XC:
3-30). Altre posizioni più radicali (Robert JAULIN (a cura di) Le livre blanc de l'ethnocide en Amerique.
Paris, Fayard Jaulin, 1972) accusano l’antropologia di ”etnocidio” delle culture “altre”. L’argomento si è
esteso negli ultimi anni, in relazione alla ri-considerazione più generale della ricerca etnografica: v. Talal
ASAD, Anthropology and the colonial encounter, Atlantic Highlands, Humanities Press, 1973
24
formatisi in terreni lontani, avrebbero cominciato a rivolgersi all’ “Occidente”, interessandosi in particolare
all’area del Mediterraneo.
Questo tipo di ricostruzione sembra accordare un peso eccessivo a pur innegabili fattori materiali, e,
soprattutto, sembra tralasciare diversi aspetti: non prende in considerazione il rapporto con le ricerche già
condotte in precedenza nell’area del folklore; instaura un’eccessiva continuità tra la costituzione di oggetti di
studio differenti, come quello dei primi studi sul Mediterraneo15 e altri, di anni più recenti, in cui verrà
criticata fortemente la tendenza “esotizzante” propria di questi ultimi studi; individua una continuità di tipo
sequenziale, ma non di tipo tematico, relativamente ad argomenti che potevano essersi costituiti
principalmente “altrove” - ad esempio, lo studio della parentela, o del rituale16- , ma che erano stati,
successivamente, reimportati, con tutte le differenziazioni comportate da questa operazione.
Resta, poi, da aggiungere che questo processo non si è attuato uniformemente nei diversi paesi, a
seconda delle tradizioni di studio: negli Stati Uniti già negli anni ‘30 si avevano ricerche di antropologia
urbana17 - e sull’impresa; in Francia, sia per la forte presenza di una tradizione di studi folklorici, sia per
un’attenzione degli stessi fondatori francesi dell’antropologia, le ricerche etnografiche in loco cominciavano
negli anni ‘5018; mentre l’Inghilterra può essere considerata, tra queste tre nazioni più importanti per
l’antropologia, quella più lenta a rivolgere su sé stessa le ricerche etnografiche19; in Germania lo studio del
folklore, o la Volkskunde, implicata nell’esaltazione della “cultura originaria”, era giunta a fornire, negli anni
del nazismo, una base “scientifica” non facilmente separabile da ideologie e responsabilità politiche, e che,
successivamente, sarebbe risultata d’ostacolo a una riconversione delle ricerche verso la contemporaneità,
intesa in un’accezione più ampia20, così come nei paesi scandinavi21.
15
Julian Alfred PITT RIVERS, The people of the Sierra, Chicago, London: Weidenfeld and Nicolson, 1954;
Péristiany, Jean G., Honour and Shame: the values of Mediterranean Society, Chicago, Chicago University
Press, 1966; John Campbell, Honour, Family and Patronage, Oxford, Oxford University Press, 1974.
16
La parentela o il rituale sono forse gli argomenti più prettamente antropologici, di cui – soprattutto per
quanto riguarda la parentela – gli antropologi sembrano aver avuto l’esclusività, quantomeno fino a qualche
tempo fa, per quanto riguarda la pratica di studio. Senza dimenticare, naturalmente, che uno dei testi
fondamentali, Le forme elementari della vita religiosa, è di uno dei “padri fondatori” della sociologia, Emile
Durkheim (Milano: Edizioni di Comunità,1963 [1912]).
Per entrambi gli argomenti, l’origine degli studi è radicata in un doppio “altrove”: un’alterità nello
spazio, rispetto ai popoli ‘altri’ studiati, e una nel tempo, per il costante riferimento all’antichità. Si pensi alla
centralità, per gli esordi della discussione sulla parentela, del tentativo di porre a confronto termini e
categorie provenienti dal diritto romano (in particolare, la gens) con situazioni etnografiche coeve al tempo
dei primi studi (la matrilinearità degli Irochesi). Questo anche perché alcuni tra i “padri fondatori”
dell’antropologia, e in particolare quelli che avevano rivolto, in modo diverso, l’attenzione alla parentela
(Morgan, Maine, Mc Lennan) erano, in gran parte, di formazione giuridica: un aspetto forse non considerato
debitamente per quanto riguarda la prevalenza di quello che si potrebbe chiamare il “normativismo” in
antropologia.
Per quanto riguarda il rituale, invece, lo studio di Robertson SMITH (Lectures on the religion of the
Semites, London, A.&C. Black, 1889), citato spesso come data d’inizio del filone, e ritenuto ispiratore anche
delle teorie frazeriane – v. Fabio Dei, La discesa agli inferi, Lecce, Argo, 1999 – trovava il suo punto di
riferimento nell’antichità del Vicino Oriente.
17
V. Ulf HANNERZ, Antropologia urbana, Bologna, Il Mulino, 1992; A. Bagnasco, Introduzione, in
HANNERZ, op. cit.
18
Le considerazioni sulla Francia sono tratte da un’intervista, ancora inedita, a Daniel Fabre, sul “ritorno a
casa” dell’antropologia in Francia.
19
V. Anthony P. COHEN 1989 «La tradition britannique et la question de l'autre» in SEGALEN, op. cit.;
Anthony Paul COHEN, «L'anthropologie rurale de la Grande-Bretagne» in Villages anglais, écossais,
irlandais: la communauté villageoise dans les iles britanniques, Toulouse, Mirail, 1993.
20
Herman BAUSINGER, Volkskunde, ou l'ethnologie allemande, Paris, Editions de la Maison des Sciences de
l'Homme, 1993 [1971]; CHIVA Isaac, Utz JEGGLE (eds.) Ethnologies en miroir. La France et les pays de
langue allemande Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme.
21
Per le differenti tradizioni di studio, v. il numero della rivista Ethnos (1982, 1-2). dedicato a questo
argomento, curato da Thomas Gerholm e Ulf Hannerz, Anthropology and the shaping of national traditions.
25
3.La situazione italiana
In Italia lo studio dell’ “altrove” non è mai stato fortemente radicato, per diversi motivi: il ritardo nella
formazione degli studi antropologici, la brevità del periodo coloniale, la presenza di una scuola folklorica
predominante, connessa, almeno fino al secondo dopoguerra, alla critica letteraria e agli studi di poesia
popolare, anche per la dominanza dell’indirizzo crociano, e a una conseguente egemonia, anche sul piano
accademico, della componente storico-letteraria; il forte squilibrio tra Nord e Sud, e tra città e comunità più
isolate, per cui il Meridione è stato assunto spesso come terreno ‘esotico’, o come banco di “differenza
culturale” più a portata di mano, o di macchina, sia da parte di ricercatori stranieri (il cui esempio più noto,
contestabile, e contestato, può forse essere quello del “familismo amorale” di Banfield22), sia da parte dei
ricercatori italiani.
Del resto, con De Martino - «il precursore dell'antropologia sociale in Italia», secondo I. Lewis23 - la
ricerca etnografica italiana condotta in Italia si afferma, sin dall'inizio, in riferimento al principale “dislivello
interno di cultura”, localizzabile nel Meridione, e con modalità diverse da quelle, già allora invalse nel
panorama internazionale, dell'antropologo solitario che compie un soggiorno prolungato in posti lontani: un
libro come La terra del rimorso24 si basa su un periodo di permanenza in loco che, in base a criteri di
valutazione improntati alla permanenza prolungata, potrebbe essere giudicato breve - circa venti giorni. Ma,
a fronte di questa brevità, bisogna tener conto della complessità di rapporti e di esperienze che De Martino
aveva con il Meridione, per nascita, per formazione e per la militanza politica, capace di retroagire sulla
stessa concezione dell'etnologia. Questo fa sì che la valutazione del rapporto con il terreno non possa
esaurirsi esclusivamente nella fase della spedizione o del soggiorno, come per altri tipi di etnografie,
condotte presso 'altri' lontani. Questo mi sembra, fra l'altro, uno degli aspetti capaci di differenziare le
ricerche condotte 'a casa' da quelle 'altrove', in quanto il rapporto con futuri temi e luoghi di ricerca non inizia
- e non prosegue - necessariamente soltanto in qualità di studiosi25 ma, più in generale, in qualità di attori
sociali26 - e, quindi, diventa possibile inscrivere nell'ambito di studio anche la relazione tra questo rapporto di
appartenenza a una dimensione sociale e le eventuali sovrapposizioni o sostituzioni con il secondo rapporto
tra ricercatore e ‘ricercati’.
Questo spiega anche come, nello studio dei terreni ‘a casa’ – soprattutto in Italia - abbia spesso
prevalso una ‘pratica’ di ricerca basata, più che su soggiorni prolungati, su spedizioni, su visite, se non su
episodici rilevamenti27. Si può allora ipotizzare che, mentre da una parte l'opera di De Martino 'autorizzava'
questa dimensione di ricerca non vincolata a una residenza prolungata in loco, dall'altra, nel prosieguo della
tradizione italiana di studi, il venir meno della prospettiva storicista abbia favorito, se non obbligato, il
confronto con altre tradizioni di ricerca empirica e, in particolare, con i canoni di derivazione anglosassone,
incentrati sulla residenza in loco. Sempre sotto questo aspetto, allora, alla base della pratica di ricerca
dell'etnografia italiana condotta in Italia conviverebbero tre filoni di approccio etnografico - anche se questo
aggettivo non calza nella stessa misura - variamente intersecati tra loro: il primo avrebbe come ambito di
22
Banfield, Una comunità del Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino, 1961 [1954]
Ioan M. LEWIS, 1991 «The spider and the pangolin» in Man, XXVI, n.3 : 513-525
24
Ernesto De Martino, La terra del rimorso, Milano, Il Saggiatore, 1961.
25
«[...] Eppure proprio per entro l'impegno politico di trasformare il presente in una realtà migliore, cominciò
a prendere rilievo un impegno di natura diversa, quello della migliore conoscenza del presente da
trasformare. In questa prospettiva la stessa ricerca etnologica cominciò a configurarsi in una dimensione
nuova» (Ernesto DE MARTINO, 1962, «Promesse e minacce dell'etnologia» in Furore, simbolo, valore
Milano: Il Saggiatore: 71-72). V., a questo proposito, la ricostruzione di Clara GALLINI, 1995, «La ricerca, la
scrittura» in Ernesto DE MARTINO 1995 Note di campo. Spedizione in Lucania, 30 sett.- 31 ott. 1952.
Edizione critica a cura di Clara Gallini, Lecce, Argo, testo che presenta anche una delle più recenti
bibliografie su De Martino.
26
«Questo articolo nasce dalle complessità e dalle contraddizioni della mia vita, essendo sia pescatore che
antropologo». Così Charles Menzies, 1994, «Stories from home: first nations, land claims, and EuroCanadians» in American Ethnologist, XXI, 4: 776-91, inizia il suo articolo dedicato ai conflitti tra pescatori
canadesi e pescatori indiani in Canada. A questa doppia identità di attività lavorativa Menzies aggiunge
anche «le complessità della mia identità etnica, non essendo né completamente Indiano né Euro-Canadese
[...]». Il conflitto tra ruolo di studioso e altre identità non è prerogativa della ricerca 'a casa', anche se, per i
motivi espressi, si può incontrare - o si può avvertire - più facilmente in quest'ultima situazione.
23
27
V. Cannada Bartoli, op. cit.
26
riferimento e di provenienza la demologia, sarebbe caratterizzato da istanze documentaristiche,
repertorialistiche e museali, e da alcune continuità, a volte anche biografiche, con le ricerche sul folklore
degli inizi del secolo. L'approccio demartiniano, che costituirebbe il secondo filone di ricerca, e dal quale, a
sua volta, e con le debite differenze, deriverebbero molte ricerche sui "dislivelli interni di cultura", in
particolare nel Meridione, condividerebbe, con la precedente impostazione, un aspetto della pratica di
ricerca, cioè la non-prescrittività di una residenza prolungata in loco; anche se metodi di ricerca - ad
esempio, la ricerca interdisciplinare di équipe - problemi affrontati, e portata teorica si differenziano ed
esulano dall'ambito strettamente folklorico; il terzo filone, invece, tuttora in via di costituzione, mutuerebbe
la pratica di ricerca dai canoni britannici e americani di fieldwork, con tematiche e riferimenti bibliografici
appartenenti e derivanti dal dibattito etnografico e antropologico internazionale.
La formazione dei primi due filoni di ricerca sarebbe quindi indipendente dai canoni anglosassoni di
ricerca empirica: il primo filone infatti sarebbe anteriore cronologicamente; il secondo ne sarebbe
concettualmente distinto, in quanto basato su un'impostazione differente. Il rapporto fra tradizioni di ricerca
- e, in particolare, fra tradizioni (italiane) di studio basate su spedizioni e tradizioni (estere) basate su
soggiorni - e resoconti di scrittura dovrebbe allora essere stato modificato dall'apertura a suggerimenti e
istanze provenienti da altre tradizioni etnografiche28.
Insomma, considerando, anche con uno sguardo di superfice, le situazioni di diversi paesi, incontriamo
una differenza di condizioni in merito ai rapporti fra ricerche etnografiche e ricerche folkloriche. Queste
ultime, infatti, che precedono la nascita dell’etnografia moderna - qui identificata con la centralità accordata
alla ricerca sul campo, in seguito a Boas e a Malinowski - erano imperniate su differenti modalità di ricerca,
che, se e quando prevedevano un soggiorno in loco, lo commisuravano più a esigenze documentarie, spesso
finalizzate a documentazioni e repertorializzazioni areali di alcuni fenomeni - ad esempio, feste, oppure
tradizioni orali, fogge del vestire, forme abitative, tecniche di “cultura materiale”, ecc., che al bisogno di
raggiungere un livello di immedesimazione capace di “cogliere il punto di vista dei nativi”, secondo la
famosa espressione di Malinowski.
C’è quindi una diversità di formazione storica, di metodo, di costruzione dell’oggetto di ricerca,
soprattutto da quando l’etnografia è venuta a coincidere con il fieldwork di lunga durata in luoghi remoti. Nei
periodi precedenti, in cui la centralità era documentaria, gli esempi potevano essere tratti agevolmente dai
due ambiti, dell’esotico e del folklore, anche se quest’ultimo non deve essere ritenuto immune da
atteggiamenti esotizzanti: «Per definizione, i fatti sociali attinenti all’ambito folklorico presentano un aspetto
vetusto, quantomeno in misura relativa e, nella pratica, quelli che vengono evidenziati sono i più pittoreschi,
quelli che attirano immediatamente l’attenzione grazie a una differenza che colpisce, dovuta al loro arcaismo
spesso rafforzato da un esotismo: un esotismo che può giocare il proprio ruolo senza che debba trattarsi di un
altra nazione, ma soltanto di un altro ambito: ad esempio, la campagna rispetto alla città, la provincia rispetto
alla capitale, la classe operaia rispetto alle classi borghesi, portate a considerare come folkloriche,
quantomeno implicitamente, alcuni usi e costumi della classe operaia, usi che sembrano loro naïfs o desueti
(legati a vecchi modelli) rispetto ai loro propri usi e costumi, di modo che esse tendereanno a considerare che
il fatto di bere appartiene al folklore, ma non il rito che consiste nel portare un toast29 ».
Questa diversità di impostazione ha comportato che, in linea generale, curricula di formazione ed
esponenti delle due aree appartenessero spesso ad ambiti differenti, non necessariamente portati a incontrarsi,
nonostante, naturalmente, sia possibile trovare esempi contrari (ad esempio, Dell Hymes, esponente di primo
piano dell’antropologia, della sociolinguistica e del folklore); per cui, quando la tradizione di studi della
ricerca etnografica moderna si è ripiegata su se stessa, assumendo come oggetto di ricerca il terreno di casa
propria, si è trovata a fare i conti con il patrimonio preesistente di ricerca folklorica, anche perché, nella
(ri)costituzione degli oggetti di ricerca, si era rivolta in primo luogo verso le sacche di “diversità” interna,
precedente oggetto di ricerca del folklore. L’incontro ha dato luogo ad esiti differenti, dall’ibridazione, alla
frequente assunzione di tematiche e dati folklorici all’interno di cornici teoriche più generali, elaborate
28
Peraltro in De Martino erano già centrali l'attenzione per le condizioni dell'«incontro etnografico» e
l'esplicitazione della soggettività che questo incontro suscitava nel ricercatore. V., oltre ai testi classici di
De Martino, anche le sue note di ricerca in: Ernesto DE MARTINO, 1995, op. cit.
29
Michel LEIRIS, 1974 «Folklore et culture vivante» in JAULIN, op. cit. ; il passo è citato anche in Nicole
BELMONT, Arnold Van Gennep créateur de l'ethnographie française, Paris, Payot: 24-25.
27
dall’antropologia - un caso classico può essere quello de La Tarasque di Louis Dumont 30- ma anche,
naturalmente, il processo inverso - basti pensare alla categoria dei “riti di passaggio” di Van Gennep: un
processo di incontro che andrebbe riconsiderato nella prospettiva, spesso trascurata, della lotta per i
finanziamenti e per l’accesso alle cariche accademiche, che fa sì che rapporti pacifici siano - e siano stati più rari di quelli concorrenti - anche, comunque, prima della “riconversione”31.
4. «L'etnografo non dovrebbe…»: terreno e ricerca ‘a casa’
«A case in point» di questa differenza nell’intendere la ricerca, sul quale vorrei soffermarmi, mi sembra
rappresentato da alcune posizioni espresse in Europe observed, un'antologia di studi europei curata da John
Campbell e Joao Pina-Cabral32, in cui un aspetto comune ai diversi interventi è il rilievo accordato a
problemi di metodo ed esperienze personali di ricerca.
In particolare, Pina-Cabral dedica il suo scritto33 alla relazione tra ricerca "a casa" e ricerca "altrove",
sostenendo che, fino a non troppo tempo fa, la ricerca condotta in Europa non sembrava avere le credenziali
per stare alla pari con quella condotta presso "altre" culture, o culture più "altre". Accanito sostenitore della
possibilità di evincere e attribuire un "valore di verità" alla ricerca sul campo, e altrettanto tenace oppositore
della "metafora della traduzione" - il titolo del suo intervento è Against translation: the role of researcher in
the production of ethnographic knowledge - Pina-Cabral sostiene la necessità, per le «nuove scuole di
antropologia sociale che si sono venute stabilendo lentamente nell'ultimo decennio in Portogallo, Spagna,
Italia, e, ora anche in Grecia»34, e che si sono andate orientando verso "etnografie nazionali", di non venir
meno alla pratica di un "prolungato e ininterrotto" soggiorno di ricerca, stigmatizzando il fatto che «gli
Europeisti si sono sottratti troppo a lungo a una discussione concreta sulla deontologia della ricerca sul
campo con la scusa che le condizioni del "terreno" sono così variabili che non è possibile o desiderabile
30
Nel suo studio della festa popolare francese della Tarasque (Louis DUMONT, La Tarasque, Paris,
Gallimard, 1987), Louis Dumont analizza le precedenti interpretazioni e il corpus foklorico preesistente,
formulando una sua ipotesi interpretativa di tipo strutturalista. Il caso di Dumont, tra l’altro, il cui percorso di
ricerca inizia appunto con La Tarasque, ovvero su un terreno “nostrano”, prosegue in India, con uno studio
del sistema castale (Homo hierarchicus, Milano, Adelphi, 1991 [ed. orig. 1979]), ma che è già volto a
confrontare la gerarchizzazione indiana e l’egalitarismo occidentale, per poi ritornare a considerazioni
teoriche generali sull’Occidente nell’ultimo periodo (Louis Dumont, Homo aequalis, Milano, Adelphi, 1984
[ed. orig. 1976]), può essere un caso classico di negazione del tragitto dal “loro” al “noi”. Per queste
considerazioni, il rimando è sempre all’intervista a Daniel Fabre.
31
Un esempio di rapporti conflittuali e di diverse impostazioni tra folkloristi ed etnografi può essere costituito
dallo studio di Jeanne Favret Saada (Les mots, la mort, les choses: la sorcellerie au Bocage, Paris,
Gallimard, 1977: 19) sulla “sorcellerie” nel Bocage, nella Francia orientale, dichiaratamente polemica nei
confronti delle precedenti ricerche folkloriche, tacciate di rifarsi a un’impostazione dicotomizzante tra
irrazionalità della credenza locale e spiegazione razionale dello studioso: «Il lavoro del folklorista consiste
nel marcare la differenza fra la propria teoria (che, per definizione, è quella “vera”) e quelle dei contadini,
che sono soltanto credenze», equiparando gli stereotipi dei media alle definizioni dei fokloristi. V. anche ,
nell’appendice del libro (1977: 371-80), il paragrafo dedicato più in dettaglio a Van Gennep e al folklore, “le
métier d’ignorant”. Un punto di vista diverso, sempre in seno all’antropologia francese, è quello di Nicole
Belmont, nel suo libro su Van Gennep, il quale viene posto in opposizione alle precedenti ricostruzioni
passatiste: «Per tutti gli specialisti in effetti il folklore si occupa di sopravvivenze, di vestigia del passato, di
arcaismi. Per Van Gennep, al contrario, l’”etnografia delle popolazioni rurali d’Europa” (alias il folklore) si
occupa dei fatti collettivi viventi; vedremo come, a suo parere, si sarebbe dovuta applicare anche ai fatti
nascenti [...] Ma si trattava di insorgere contro una realtà di fatto che associava, e associa ancora, ai giorni
nostri, il folklore all’arcaismo» (Belmont, op. cit., p. 24); o di Martine Segalen (1989 «Introduzione» a
Martine SEGALEN (a cura di) L'Autre et le semblable. Regards sur l'ethnologie des sociétés
contemporaines. Paris: CNRS, 1989), la quale vede in Van Gennep colui che ha posto per primo la famiglia
al centro delle analisi etnografiche.
32
John CAMPBELL; Joao PINA CABRAL (a cura di) Europe observed, 1992, London, Macmillan.
33
Joao PINA-CABRAL 1992 «Against translation: The Role of the Researcher in the Production of
Ethnographic Knowledge» in John CAMPBELL, Joao PINA CABRAL (a cura di), Europe observed.
34
Pina-Cabral, op. cit., pag. 4.
28
fissare dei punti fermi per quanto riguarda la loro pratica»35 . Pina Cabral ritiene invece che si possano
stabilire alcune "condizioni minime", sulla scia di quanto fatto dagli «antropologi dei primi decenni del
secolo con evidenti profitti»: «l'etnografo non dovrebbe avere altri lavori oltre la ricerca durante il suo
periodo di permanenza sul terreno; dovrebbe evitare un ruolo in cui possa assumere decisioni in qualità di
organizzatore, di notabile, o in cui possa avere responsabilità pubbliche; non dovrebbe svolgere attività di
proselitismo religioso; dovrebbe evitare di svolgere la propria attività in comunità dove abbia interessi sociali
radicati e, in particolare, in comunità dove sia cresciuto; dovrebbe risiedere sul campo per un periodo
prolungato e ininterrotto; dovrebbe evitare di spostarsi da una comunità a un'altra; e così via»36.
Questo ‘decalogo deontologico’ – che sembra presentare qualche affinità con le condizioni prescritte
per il rapporto di distanza, e distanziante, tra psicoanalista e paziente, censurando qualsiasi rapporto che
gli preesista o che esuli da quello ‘professionale’ – comporterebbe, se assunto in senso letterale, che molte
ricerche condotte da italiani in Italia o da francesi in Francia – e, più in generale, in Europa – dovrebbero
essere ‘bandite’. In particolare, il ‘decalogo’ non sembra convincente anche nel merito, e sembra dare per
scontato che l'antropologo debba occuparsi soltanto di "comunità" di piccole dimensioni, senza
considerare che in altri casi, come, ad esempio, in città, molte di queste prescrizioni sembrano
automaticamente venir meno, per la minore rilevanza dell'interazione faccia-a-faccia e per il fatto che il
ricercatore non è accessibile all'intera comunità.
Ma, al di là dei punti specifici trattati, mi sembra di poter cogliere una contraddizione di fondo tra la
tendenza a voler inscrivere la situazione del ricercatore all'interno della ricerca e il desiderio di creare una
sorta di "ideal-tipo" di ricercatore puro cui conformarsi; mi sembra invece più coerente, e più economico,
riportare all'interno della cornice della ricerca la situazione particolare del ricercatore, secondo
un'affermazione di Maybury-Lewis citata dallo stesso Pina-Cabral: «È ora di abbandonare la mistica che
circonda il lavoro sul campo e di rendere parte della procedura la descrizione dettagliata delle circostanze di
raccolta dei dati in modo che esse possano essere soggette a uno scrutinio allo stesso modo dei dati»37.
"Mistica del lavoro sul campo" che invece ritorna appieno nell'intervento di Pitt-Rivers38 - una
riedizione del suo precedente intervento apparso su L'Uomo del 1980 - in cui viene compiuta un'esaltazione
del culture-shock e di tutti i suoi effetti collaterali, visto come una prima fase, necessaria anche se dolorosa,
che porterà alla rinascita e al ritrovamento di un equilibrio psicologico da parte del ricercatore, e con
affermazioni enfatiche quali «il momento della rivelazione è preceduto sempre dal buio della notte». Al di là
dell'enfasi e della retorica, Pitt-Rivers indica comunque altre forme di ricerca che non richiedono
necessariamente una presenza annuale o pluriennale del ricercatore, in particolare quando si prendono in
considerazione singoli aspetti della società e non si mira alla ricostruzione olistica della comunità - obiettivo
che, per inciso, sembra sempre più difficilmente perseguibile anche nelle ricerche "classiche". Ed è proprio a
questo secondo tipo di ricerca che Pitt-Rivers dedica il racconto di una sua passata esperienza, condotta
insieme con un collega messicano, relativa a un'inchiesta di vasto raggio sulla terminologia dello status
etnico nell'area delle Ande e dell'America centrale. Se la ricerca 'classica' è descritta con enfasi,
sottolineando tutte le difficoltà di adattamento e la forza, fisica e psicologica, necessaria per resistere, come
una qualità rara, che non tutti possono avere, questa seconda modalità di ricerca, caratterizzata dalla estreme
brevità dei soggiorni, più vicina a un censimento, viene invece correlata alla necessità di una sorta di
brutalità volta a ottenere il massimo dell'informazione nel minimo del tempo, e priva del debito rispetto
umano verso gli indagati: «Si va in cerca della persona che sa quello che volete sapere e che è preparata a
dirvelo [...] Quando diventa evidente che che non si sta ottenendo quello che si voleva, ci si rivolge altrove,
lasciando in tronco l'amabile persona che si stava preparando a raccontarvi qualcosa sui suoi successi
giovanili o le sue impressioni su altri posti che aveva visitato. Viene richiesto un modo di fare sbrigativo e
insistente. Gli eventuali passi falsi non interessano - da domattina non si sarà mai più lì - e sono considerati
di interesse soltanto quelle persone che sono in grado di aiutarvi»39.
Pitt-Rivers, quindi, pur prendendo in considerazione modalità di ricerca differenti da quelle
'canoniche', le relega in secondo piano, non solo dal punto di vista conoscitivo («Il nostro obiettivo
consisteva nel raccogliere dati economici e demografici, esempi di discorso, osservazioni focalizzate,
fotografie e mappe - quell'insieme di cose che viene definito come "hard data"»), quanto da quello
35
IDEM, pag. 9.
IBIDEM.
37
IDEM, pag. 12.
38
Julian PITT RIVERS, 1992, «The Personal Factors in Fieldwork» in Campbell, Piña Cabral, op. cit.
39
Pitt Rivers, op. cit.: 145
36
29
deontologico («Dato questo scopo, non c'era tempo per entrare in empatia su una base di tempo più
prolungata»).
Negli altri scritti del libro40, il confronto tra l'osservazione partecipante di tipo "classico" e le nuove
esigenze poste dai nuovi contesti di ricerca si orienta verso l'esplorazione di una pluralità di metodi di ricerca
- ad esempio, la necessità e la problematicità insita nella necessità di tener conto dell'aspetto storico, dei
media, il rapporto con gli studi locali, l'utilizzo di metodi quantitativi, e così via - o si focalizza sulle
modalità di adattamento e di rapporto con gli indagati41, ma non vengono ipotizzati aspetti conoscitivi
correlati a modalità di soggiorno differenti da quella del soggiorno a lungo termine o casi caratterizzati da
una prossimità tra luogo di ricerca e luogo di residenza del ricercatore: si tratta infatti di antropologi che, in
prevalenza, si rivolgono al sud dell'Europa, in luoghi e nazioni differenti dalla loro residenza, proseguendo
una precedente linea di studio: le prime monografie su quest’area42 individuarono infatti come aspetti
unificanti alcuni fattori, come il senso dell’onore, o il “familismo amorale”, che avrebbero caratterizzato la
“cultura mediterranea”, al di là delle sue differenti sponde e delle sue differenziazioni locali 43. Questi studi
erano condotti perlopiù in comunità di ridotte dimensioni, assunte come unità sociali fortemente coese sul
piano dei valori, secondo l’impostazione degli “studi di comunità”, ovvero delle monografie incentrate su
paesi di non molti abitanti, in cui l’interazione “faccia-a-faccia”, avrebbe giocato un ruolo di rilievo sia nel
rapporto fra gli abitanti che in quello con l’antropologo44.
È a questo tipo di studi che sembra riferirsi Chapman45, nuovamente in Europe observed, quando fa
riferimento a quella che si potrebbe definire la "ricerca del diverso": «È noto che l'antropologia, quando è
ritornata dal mondo esotico e primitivo alla sua casa europea, si è rifatta alla sua immagine più vecchia e ha
trovato per sé stessa una nicchia il più possibile simile ai suoi vecchi luoghi. La normalità era rappresentata
dal nord e dall'ovest dell'Europa, e, in conseguenza, le aree di interesse antropologico erano individuate nel
sud e nell'est».
Le stesse prescrizioni di Pina-Cabral sull'«estraneamento» riportate in precedenza, del resto, possono
essere assunte come tentativi di recuperare una distanza, un'alterità sostantiva tra ricercatore e ricercati, vista
come condizione ineliminabile del rapporto di ricerca: «In altri termini, l'etnografo, se è disposto ad andare
incontro all'esperienza della "differenza", e anche se non può più essere considerato un "alieno", dovrebbe
essere, e dovrebbe restare, durante il suo soggiorno, uno "straniero"»46, dalla quale prendeva le mosse anche
l'analisi di Pitt-Rivers, già nella sua definizione della ricerca etnografica, intesa come «raccolta di dati da
parte di qualcuno appartenente a un'altra cultura, cioè qualcuno le cui categorie siano strutturate in modo
differente»47; mentre una precedente citazione di Schutz da parte di Pina-Cabral48 - «il mondo sociale che noi
percepiamo come denso di significato lo è anche dal punto di vista dello scienziato sociale. Ma il contesto di
significato nel quale egli interpreta questo mondo è quello di uno scrutinio sistematico piuttosto che quello
40
Michael Herzfeld, «History in the Making: National and International Politics in a Rural Cretan
Community»; Gregory SMITH 1992 «The Anthropologist as Critical Historian: Some Problems in the
Ethnography of Celano (Italy)», William DOUGLASS 1992 «Anthropological Methodology in the European
Context», tutti in CAMPBELL, PINA CABRAL, op. cit.
41
Stanley BRANDES, «Sex Roles and Anthropological Research in Rural Andalusia», Malcolm
CHAPMAN, «Fieldwork, Language and Locality in Europe, from the North» in CAMPBELL, PINA
CABRAL, op. cit.
42
Banfield, op. cit.; J.K. Campbell, Honour, Family and Patronage. A Study of Institutions and Moral
Values in a Greek Mountain Community, London, Oxford University Press, 1964; Julien A. Pitt-Rivers, The
people of the sierra, London, 1954.
43
Un’analisi del dibattito in David GILMORE 1990 «On Mediterraneist Studies» in Current Anthropology,
31, 4: 395-96.
44
Per un’agile critica degli studi di comunità, v. Jean CUISINIER, Martine SEGALEN Ethnologie de
l’Europe Paris: Presses Universitaires de France, 1992, in particolare per le ricerche in Francia, anche se i
motivi addotti sono estensibili ad altre situazioni; Herman BAUSINGER Volkskunde, ou l'ethnologie
allemande Paris: Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1993 [1971]; v. anche la raccolta curata da
Anthony Cohen per la Gran Bretagna Self Consciousness. An Alternative Anthropology of Identity London:
Routledge, 1994.
45
Malcolm CHAPMAN, op. cit., pag. 39, in CAMPBELL, PINA CABRAL, op. cit.
46
Pina Cabral, op. cit., pag. 9
47
Julien Pitt Rivers, op.cit., pag. 133.
48
Pina Cabral, op. cit., pag. 6
30
della esperienza di vita» - ed altre sue considerazioni 49 - insieme con il frequente richiamo a un altro autore
di impostazione fenomenologica, come Merleau-Ponty, sembrano porre l'accento su un'alterità di tipo
relazionale tra studioso e studiati.
In sintesi, nell'esposizione di Pina-Cabral – qui assunta come esponente di una più vasta area di studi
– mi sembra trasparire, inavvertita, una differenza fra due prospettive che possono fungere da discrimine
teorico per lo studio del ‘noi’: nella prima prospettiva – il cui esempio più estremo può essere costituito
dall’anelito al culture-shock – l'etnografia 'rende' quando c'è differenza culturale di partenza fra osservatore
e osservato, e questa condizione deve essere ricreata, per quanto possibile, anche quando si studia la
‘propria’ cultura; nella seconda – rappresentata dalla prospettiva fenomenologica, e dalle citazioni di
Merleau-Ponty e di Schutz – la pratica di ricerca diventa conseguenza della posizione assunta
dall'osservatore; nella prima, quindi, egli dovrebbe raggiungere una condizione di "estraneamento" 50,
capace di schiudere la percezione di aspetti altrimenti celati; mentre nella seconda sarebbe più un
"distanziamento"; la prima concezione sarebbe il portato storico di una concezione della differenza culturale
che trarrebbe origine nell'incontro dell'altro, e si riferirebbe non solo al ruolo di antropologo, ma anche alla
sua 'seconda natura' di attore sociale cresciuto in un'altra cultura - e, quindi, portatore di una differenza
culturale, con i suoi effetti nei termini di percezione del mondo e dell'altro - e al tentativo di trasporre questa
esperienza dello shock culturale allo studio della propria cultura; nella seconda prospettiva la differenza
sarebbe dovuta, più che a una differenza culturale di base tra osservatore e osservati, all'assunzione di una
posizione differente da parte dell'osservatore rispetto alle attività degli osservati e all'inscrizione, da parte
dello studioso, della selezione che opera nei confronti del reale in un insieme di nozioni, modelli,
preesistenti come corpus di pensiero, e che costituiscono lo sfondo di confronto per questa sua selezione51.
Questa seconda impostazione mi sembra comune a correnti di pensiero anche differenti, tra autori
che hanno studiato non solo "altre" società, ma anche la "propria" - penso, con le debite differenze, agli studi
di Goffman, in cui l'oggetto di ricerca sono le pratiche quotidiane dell'interazione, all'accento di Bourdieu
sulla riflessività e sulla necessità di oggettivare lo "sguardo oggettivante", agli scritti di Augé sulla possibilità
di assumere come oggetto di studio alcuni aspetti, apparentemente banali, del proprio modo di vita.
49
«Un approccio dichiaratamente autocritico al resoconto etnografico che riconosca la prospettiva insita in
ogni resoconto etnografico può solo incrementare il valore del lavoro etnografico e diventa particolarmente
doveroso nel caso di etnografi che lavorano nelle loro stesse aree culturali, dove la relazione con il campo è
spesso estremamente complessa» Joao PINA-CABRAL 1992 «Against translation: The Role of the
Researcher in the Production of Ethnographic Knowledge» in John CAMPBELL, Joao PINA CABRAL, op.
cit., p. 14)
50
Del resto, già molto tempo prima che Pitt-Rivers scrivesse queste righe, il culture-shock come momento
centrale della ricerca sul terreno era già stato criticato da Dell Hymes nell’antologia Reinventing
Anthropology (1969 «The Use of Anthropology: Critical, Political, Personal» in IDEM (ed.) Reinventing
Anthropology New York: Vintage Books, 1969: 32), all’interno di una critica più ampia alla tendenza
passatista e all’incapacità degli antropologi di affrontare lo studio delle società occidentali: «La pretesa più
comune è la necessità di uno “shock culturale” e di oggettività nello studio di una cultura molto differente
dalla propria. L’obiettività e lo “shock culturale”, in primo luogo, sono parzialmente in conflitto. Maggiore è
l’obiettività, minore è la plausibilità dello shock. Lo “shock culturale” di per sé può risultare più potente
quando si scopre quanto possano essere diversi e distanti da sé i propri colleghi, vicini o concittadini nella
loro visione del mondo [...] è vero che un osservatore esterno può notare ciò che un “insider” assume per
scontato, ma la ricerca etnografica non si basa su impressioni, ma su uno scrutinio sistematico di una qualità
che dà un gran vantaggio agli appartenenti a una cultura. Si può sostenere che i contributi più penetranti e
significativi teoricamente provengano più verosimilmente dallo studio di quelle situazioni culturali di cui uno
ha una conoscenza di fondo più facilmente disponibile: ovvero delle proprie.
In sintesi, non è una ragione sufficiente studiare un’altra cultura semplicemente perché è “altra”:
anche dal punto di vista etico e politico, ci dovrebbe essere una buona ragione per infliggere un altro
ricercatore americano in un’altra parte del mondo».
Un’altra critica, in tempi più recenti, espressa, tra l’altro, dall’interno dell’antropologia sociale
britannica, cioè la tradizione di studi più conservatrice in tema di fieldwork, è quella di Cohen, op. cit.
51
Alfred SCHUTZ 1971 «Commonsense and scientific interpretation of human action» in Collected papers.
Vol. I The Problem of Social Reality. Edited and introduced by Maurice Natanson Tha Hague, Martinus
Nijhoff, 1971, pag. 37-40.
31
Se, allora, non si deve necessariamente dare o postulare una differenza sostantiva tra ricercatore e
ricercati, in aggiunta a quella della differente prospettiva - generalizzando e banalizzando, di studio e di vita
– quale rilevanza può avere un'eventuale residenza in loco, non più come ricerca o passaggio obbligato di o
tra shocks culturali, e quale (dis)continuità con il concetto "classico" di "campo"?
Mi sembra che si debba prendere atto del fatto che molte ricerche, specialmente in ambito demologico,
vengono condotte senza uno spostamento di residenza52: non necessariamente questo si lega a un'attenzione
esclusiva per quel tipo di hard data cui si riferiva Pitt-Rivers, e non necessariamente questo dovrebbe
corrispondere automaticamente a una divisione tra ricerche di serie A e di serie B, quanto a far riflettere sulla
ridefinizione, concettuale e operativa, in atto, della nozione di "campo"; una ridefinizione cui concorrono
anche fattori come il "rientro a casa" e che può essere messa in dubbio o discussa, ma non sottaciuta, né nella
direzione di un 'complesso di colpa' per non avere adempiuto fino in fondo il precetto del "soggiorno
prolungato e ininterrotto", né in quella della facile condanna delle "altre" modalità di ricerca che non si
conformano a questa prescrizione; sicché, pochi anni dopo Europe observed, alcuni autori come Goddard,
Llobera e Shore53, legati, anche biograficamente, alla ricerca sul terreno, ne ponevano in discussione il suo
essere requisito ineludibile dell'antropologia: ««È stato spesso affermato che il lavoro dell'antropologo si
definisce dalla sua tecnica di ricerca, cioè dall'osservazione partecipante in una situazione d'interazione
faccia a faccia (tradizionalmente, in una comunità di ridotte dimensioni). Se l'antropologia appare essere
soltanto la somma delle sue etnografie, e la conoscenza di unità socio-culturali di livello più alto (si tratti di
distretti, regioni, etnonazioni, stati-nazione, stati multinazionali, federazioni, sistemi mondiali o di
manifestazioni e tratti culturali più ampi) risulta problematica e difficoltosa, questo è in gran parte la
conseguenza delle limitazioni imposte dalla centralità di questa tecnica di ricerca.
Quello che poteva avere senso tra i Trobriandesi e gli abitanti di Tikopia degli anni passati non è
adeguato in relazione ai Piedmontese [sic] o ai Bretoni di oggi (per non parlare dei burocrati dell'Unione
Europea o delle corporazioni transnazionali). Il punto in questione è che gli antropologi non dovrebbero
essere definiti dalla loro aderenza a un modo particolare di raccogliere dati, ma dal carattere scientifico dei
loro progetti. Il problema non consiste nell'alternativa tra intraprendere o meno il fieldwork, ma nel fatto che
quest'ultimo non dovrebbe essere fons et origo della disciplina».
5. Costruzione dell’alterità e rapporto fra ricercatore e ‘ricercati’
Le posizioni esposte possono mostrare come il processo di “ritorno a casa” dia luogo a un’estensione
dell’effetto di ripensamento verso direzioni teoriche diverse e verso considerazioni sulla pratica di ricerca. In
questo senso, un altro punto tralasciato dalla ricostruzione precedente sui fattori che lo avrebbero
determinato è che, tra i suoi costituenti, va incluso il radicamento della critica a quella che è stata denominata
la “costruzione dell’alterità”54, ovvero quel processo per cui gli antropologi sono stati accusati, o per meglio
52
La diminuzione dei fondi di ricerca disponibili, anche per l'aumento di studenti e studiosi, è uno tra i
motivi di questa mancanza di spostamento dei ricercatori; una diminuzione che non riguarda soltanto l'Italia,
ma anche altre nazioni occidentali (Michael AGAR, The professional stranger, New York, Academic Press,
1980: pag. 23). Credo che questa contrazione, al di là della sua apparente contingenza, sia a sua volta degna
di studio, in quanto finisce per attuare una selezione degli obiettivi di ricerca, evidenziando temi ed aree
ritenuti più meritevoli di finanziamento. Del resto, anche senza voler ricorrere a determinismi finanziari,
l'aspetto economico è stato, anche in passato, tra i motivi di apertura di altri campi di ricerca - ad esempio,
come ricorda Hilda Kuper (1984 «Function, History, Biography: Reflections on Fifty Years in the British
Anthropological Tradition» in George W. STOCKING, 1984, Functionalism Historicized, The University of
Wisconsin Press, Madison), e come sottolinea anche la Kuklik, op. cit., il fatto che Malinowski fosse
riuscito ad ottenere finanziamenti dall'International African Institute aveva permesso - e, entro certi limiti,
obbligato, o comunque diretto - i suoi allievi allo studio dei mutamenti in atto in Africa, sicché il metodo
dell'osservazione partecipante si trovò ad essere traslato da un isoletta del Pacifico al continente africano. Su
questi temi, v. ora il libro di GOODY, op. cit.
53
Victoria A. GODDARD; Joseph R. LLOBERA; Chris SHORE 1994 (eds.) «Introduction» in The Anthropology
of Europe: identity and boundaries in conflict, Oxfors, Berg, pag. 32.
GODDARD Victoria A.; Joseph R. LLOBERA; Chris SHORE 1994a «Introduction: The Anthropology of
Europe» in Goddard, Llobera, Shore (1994)
54
Carrier, op. cit.; Cohen, op. cit.; Roger KEESING, 1990 «Exotic readings of cultural texts» in Current
Anthropology, 30: 459-69; Adam KUPER, The Invention of Primitive Society, London, Routledge, 1988;
Sharon MAC DONALD, 1996, «Europe, Western» in Encyclopedia of Cultural Anthropology; ; ma i
32
dire, si sono auto-accusati55, di aver costruito un’immagine dell’”altro” in termini necessariamente
contrastivi con quella - altrettanto supposta 56- dell’”Occidente”, accentuando e “sostantivizzando” le
differenze, e tralasciando invece i caratteri comuni, magari perché ritenuti scarsamente interessanti57, ma
anche attraverso diverse strategie, che vanno dalla scelta di un apparato iconografico atto a fornire una
rappresentazione arcaicizzante58, all’impiego di retoriche tese a restituire un’immagine coesa delle società
studiate - ad esempio, il discorso indiretto per generalizzare le affermazioni riportate59, al tentativo di
restituire vivezza ad usi desueti attraverso il cosiddetto “presente etnografico” - sia attraverso processi
interpretativi delle intenzioni improntati alla psicologia comune, ma, a loro volta, non processati, in sostanza
generalizzando arbitrariamente gli assunti di alcuni individui60, secondo la spinta propulsiva, mai esaurita,
dell’esotismo, e tenendo fuori dal campo dell’analisi la soggettività del ricercatore 61 oppure, ma in un’altra
accezione, escludendo dalla cornice dell’analisi l’atto di oggettivazione compiuta dallo “sguardo
oggettivante”62.
Nel conto di queste prospettive va inclusa anche l’assunzione dell’ “Occidente”, della “nostra
società”, come insiemi omogenei, e dell’ “Occidente” come la parte non problematizzata - e, spesso, non
problematizzabile - della rappresentazione63, per cui si è perseguita una dicotomia tra “noi” e “altri”, anche al
di là di evidenti processi storici di contatto e di intersezione.
Questa negazione ha portato alla critica della distinzione tra un’”antropologia del noi” contrapposta a un’
“antropologia del “loro”, in primo luogo perché, rispetto alle strategie di penetrazione etnografica, vi
sarebbero aspetti comuni, rispetto ai quali questa diverrebbe irrilevante: la scelta di una prospettiva locale,
come ambito di ricerca, ma la costruzione di ipotesi di più ampio respiro; la restituzione delle prospettive
locali; il rapporto, quasi sempre problematico, con gli indagati, al di là della differenza, nel caso
dell’antropologia “a casa”, nel grado di padronanza della lingua, di conoscenza pregressa degli oggetti di
ricerca e dell’eventuale comunanza - o differenza - di condivisione di prospettive, ideologie politiche, fedi
religiose, ecc. Da questo punto di vista, non vi sarebbe una frattura tra due diverse sub-discipline, ma una
concorrenza di intenti, in cui le ipotesi prodotte nella ricerca e le categorie locali “restituite” sarebbero
soggette a un processo continuo di verifica e di confronto con realtà distanti o vicine64. L’analisi si è quindi
spesso incentrata sulla differenza nel condurre ricerche etnografiche in contesti diversi e sugli eventuali pro e
riferimenti bibliografici sono moltissimi, per la centralità della tematica negli ultimi anni, e provengono
anche da impostazioni differenti.
55
Hymes, op. cit.
56
Carrier, op. cit.
57
Pascal BOYER, The Naturalness of Religious Ideas, Stanford, California University Press, 1994.
58
Pascal BLANCHARD et al., L'Autre et Nous. «Scènes et types», Paris, Syros, 1995; James CLIFFORD,
«Sull’autorità etnografica» in I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX Torino,
Bollati Boringhieri, 1993 [1988]; George MARCUS; Michael FISHER 1986 Anthropology as Cultural
Critique: An Experimental Moment in Human Sciences Chicago-London; Edward SAID, Orientalism,
Harmondsworth, Penguin, 1978.
59
V. in particolare Dan SPERBER, Il sapere degli antropologi, Milano, Feltrinelli, 1981 [1974].
60
Cohen, op. cit.; Boyer, op. cit.; Dan SPERBER, La contagion des idées, Paris, Odile Jacob, 1996.
61
V. Clifford Geertz, Interpretazione di culture, Bologna, Il Mulino, 1987 [1973] e tutta la successiva
produzione postmoderna, da cui, solo a titolo di esempio, Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in
Marocco, Berkeley, University of California Press, 1984.
62
Il riferimento è a un concetto di Pierre Bourdieu, ribadito in diversi luoghi della sua numerosa produzione:
Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980; IDEM, Risposte, Torino, Bollati
Boringhieri, 1992 [1992].
63
«Il partner silente dei lavori e dibattiti [antropologici] […]» (James CARRIER, «Introduction» in
CARRIER, op. cit., pag. 1-32) «Ero piuttosto disturbato dal modo in cui alcuni antropologi tipizzavano gli
Stati Uniti in particolare e la società occidentale in generale […] in termini così semplicistici che non
sarebbero stati tollerati se un antropologo avesse parlato in questo modo di una piccola comunità di villaggio
[…] A mano a mano i miei stati d’animo iniziali di scoraggiamento e di veemenza persero il loro impeto per
tramutarsi in un quesito intellettuale: in che misura gli antropologi caratterizzano l’Occidente in termini
essenzialisti e semplicistici?» (CARRIER, «Preface» in CARRIER, op. cit.: pag. vii-x)
64
Si tratta di una prospettiva largamente condivisa in Francia; v. AUGÉ, op. cit.; v. anche il denso, e difficile,
articolo di Marylin STRATHERN, 1987, «The limits of auto-anthropology» in Anthony JACKSON 1987 (ed.)
Anthropology at home London: Tavistock, 1987; in Italia, v. le conclusioni dell’articolo di PALUMBO, op. cit.
33
contro: come scrive la Strathern65, si incontrano spesso due valutazioni divergenti, ovvero che la ricerca
condotta in un contesto familiare comporti, anche per la maggiore facilità di penetrazione linguistica e
culturale, un guadagno maggiore in termini di informazione; e, all'opposto, che non produca altro che
banalità già note; entrambe queste affermazioni deriverebbero da un assunto sotteso, ovvero che la ricerca “a
casa” sarebbe basata su una maggiore riflessività, una nozione che la Strathern propone di estendere, per
includervi non soltanto l’analisi della propria società, ma anche il processo di restituzione delle categorie
indigene, in quanto processate dallo studioso, al di là della differenza di contesto.
La stessa distinzione tra etnografo “nativo” o “straniero” è stata contestata, sia per le motivazioni
precedenti, ovvero per la specificità dell’atteggiamento conoscitivo, che prevarrebbe sulla provenienza, sia in
riferimento a possibili, e sempre più frequenti, appartenenze plurime a “culture” differenti 66, sia per la
difficoltà, avvertita sempre più nettamente, nel tracciare confini netti di separazione fra culture, anche per i
nessi della globalizzazione e lo sviluppo delle comunicazioni, che renderebbero più vicini e frequenti contatti
e interdipendenze fra realtà geografiche anche distanti.
La critica alla costruzione dell’alterità può essere assunta sia come causa, sia come effetto del
“ritorno”: in questo gioca anche l’incidenza dei fattori politici ricordati, che hanno puntato l’indice contro la
“torre d’avorio” degli studi e il fatto che gli antropologi fossero specialisti di zone remote, ma non fossero in
grado di intervenire su temi di attualità67. La ricerca in “Occidente” ha portato anche a rendersi conto di
quanto generalizzazioni formulate in altri contesti fossero difficilmente sostenibili, e tendessero a restituire
un’immagine troppo coesa delle altre società: questo aspetto può essere forse assunto come motivazione
della denominazione “antropologia delle società complesse”, in opposizione, evidentemente, a supposte
società “semplici”, o, perlomeno, “meno complesse”.
La prospettiva del “ritorno” a casa rischia anche di concettualizzare l’inversione del vettore della
ricerca in una dimensione meramente geografica: mentre in precedenza ricercatori europei o statunitensi
andavano nel Terzo Mondo, a partire da una certa data si sarebbero mossi all’interno dei loro paesi; mentre,
nell’ambito degli studi sull’Europa, si può osservare una differenziazione fra i primi studi, focalizzati sui
“valori” delle comunità rurali, e studi più recenti, che assumono e costruiscono altri oggetti di studio, dai
media ai processi relativi alla costituzione della CEE68: da questo punto di vista, non vi sarebbe soltanto un
mutamento di aree - con uno spostamento dalle aree rurali alle città -, quanto una differenza nello sguardo,
rivolto non più soltanto verso aspetti concepiti come ultime vestigia di un passato da testimoniare, ma verso
modi di vita contemporanei.
Questo andamento, però, è riferibile - e si è attuato - non soltanto in relazione ai luoghi di formazione
dell’antropologia, ma anche nelle “altre” situazioni o “altre” culture: delle quali, come per l’”Occidente”,
possono essere messi in rilievo aspetti radicati nel passato e nella “tradizione” o aspetti legati alla
contemporaneità; né è soltanto questione attinente a differenti oggetti di studio, quanto alla loro differente
costruzione, così che, ad esempio, un’”etnia” può essere rappresentato come un “tutto integrato” - secondo la
terminologia funzionalista - un’unità naturalmente isolabile dalle altre che la circondano, oppure come
inestricabilmente immessa in rapporti di vicinato, e in rapporto con entità più vaste e composite, come lo
Stato-Nazione, o reti commerciali internazionali, variazioni del mercato, ecc., e con una consistenza interna
non necessariamente compatta69.
6. L’attuazione del “ritorno” e la ricerca sul terreno
65
STRATHERN, op. cit., pag. 17-18.
Kim NARAYAN, 1993, «How Native is a "Native" Anthropologist?» in American Anthropologist, 95: 67186; Emiko OHNUKI-TIERNEY 1984 "Native" Anthropologists in American Ethnologist, 11: 584-86; A.
SHAMSUL, 1982, «The superiority of Indigenous Scholars? Some Facts and Fallacies with Special Reference
to Malay Anthropologists and Sociologists in Fieldwork» in Man and Society, 3: 24-33.
66
67
v. Dell Hymes, op. cit., già nel 1968.
Per un rapido quadro d’insieme v. Michael HERZFELD, 1996, «Europe, Southern» in Encyclopedia of
Cultural Anthropology, New York, Henry Holt & Co.: 461-66; MAC DONALD, op. cit.
68
69
Jean-Loup Amselle, Logiques métisses: anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs Paris, Payot,
1990; Fredrik Barth Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference, London,
Allen & Unwin, 1969. Un resoconto italiano su queste tematiche in Ugo Fabietti, L’identità etnica, Roma,
NIS, 1998.
34
Quale iter, quindi, per il processo di “ritorno”? È opinione comune70 che, mentre nella teoria
dell’antropologia si potrebbero rintracciare date e opere che fanno da spartiacque - ad esempio, gli Argonauti
o Il saggio sul dono - nel caso dell’interesse etnografico per l’”Occidente” questo processo sarebbe avvenuto
in sordina. Questa caratteristica sarebbe dovuta anche al minore prestigio che avrebbero ricevuto gli studi
condotti in “Occidente” rispetto a quelli condotti secondo il canonico fieldwork.
A questo aspetto ne va affiancato un altro, ovvero il carattere di “antropologia applicata”, spesso in
équipe interdisciplinare, da cui provenivano alcune ricerche, focalizzate sulle aree più “arretrate” - la Grecia,
il sud dell’Italia, alcune aree della Spagna - , anche in connessione con il piano di aiuti finanziari americani
del dopoguerra.
In ogni caso, nonostante alcuni tentativi pioneristici71 - restavano fuori dal campo di studi alcuni
luoghi e temi, come la dimensione metropolitana, cui non erano facilmente applicabili impostazioni maturate
altrove, e che esigevano metodi di indagine diversi, o quantomeno complementari, rispetto all’”osservazione
partecipante”.
A fianco, quindi, o, a seconda dei casi, successivamente, a queste ricerche, si sono sviluppate, anche
in seguito alle critiche degli studi di comunità, ricerche focalizzate su altri temi, o che guardavano agli stessi
problemi da altre prospettive - in particolare, per quanto riguarda i rapporti tra comunità e aree circostanti, in
contrasto con la tesi, difficilmente sostenibile sul piano dei rapporti storici, dell’”isolamento culturale” delle
comunità.
Un aspetto di questi nuovi orientamenti può essere una maggiore attenzione alle istanze della
contemporaneità: da una parte, la volontà di assumere all’interno della ricerca aspetti come la dimensione
politica dei rapporti fra comunità locale e collettività più ampia - mentre, sul piano della ricerca etnografica,
si è mantenenuto il focus sulla dimensione locale. Negli ultimi anni, si è prestata una particolare attenzione
alle tematiche delle rivendicazioni identitarie locali, trasponendo e ridefinendo una tematica centrale
dell’antropologia nel confronto con temi che appaiono anche sui mass-media; dall’altra, si è avuta una
tendenza a costruire l’oggetto di ricerca non necessariamente a partire da tematiche classiche di studio, ma,
appunto, prendendo spunto da argomenti “quotidiani” – la procreazione assistita72, l’AIDS73, il calcio74,
l’aborto75 - e ampiamente presenti sui media, a loro volta entrati nel panorama degli oggetti possibili di
studio, anche in questo caso in modi differenti: con un’attenzione al rapporto fra rappresentazione e pratica
sociale, assumendo come argomento di ricerca le modalità di rappresentazione dei media, o focalizzandosi
sulle esportazioni tecnologiche e i processi di appropriazione e fruizione della tecnologia da parte degli “exindigeni”.
Questo diverso percorso di costruzione dell’oggetto, non più dalle categorie tradizionali di studio, ma
dall’attualità, è particolarmente presente negli Stati Uniti, dove gli antropologi sono più presenti in molti
campi, esterni all’università, attinenti alla gestione di problemi sociali, dall’assistenza sanitaria alla lotta agli
stupefacenti, a problemi di razzismo, ecc., ovvero dove è molto più presente, rispetto all’Europa, la
dimensione “applicata” dell’antropologia “a casa”.
Si assiste quindi a una ridefinizione del “terreno”, in direzioni diverse, che vanno dall’individuazione
di nuovi oggetti di studio e, quindi, dall’apertura di nuovi terreni, a quell’effetto “diffuso” che ha portato a un
ripensamento, attraverso l’ampliamento del campo di applicazione, degli oggetti di studio tradizionali
dell’antropologia, in generale con l’attribuzione di una maggiore estensione alle categorie preesistenti - come
70
v. Segalen, op. cit.; Augé, op. cit.
Michael YOUNG, Peter WILLMOTT, Family and kinship in East London, London, Routledge, 1957.
72
Françoise HERITIER, «Don et utilisation de sperme et d'ovocytes. Mères de substitution. Un point de vue
fondée sur l'anthropologie» in Génétique, procréation et Droit, a cura di Hubert NYSSEN, Paris, Actes Sud,
1985: 237-53
73
Emily MARTIN, Flexible Bodies. Tracing Immunity in American culture from the Days of Polio to the Age
of AIDS, Boston, Beacon, 1994
71
74
Christian Bromberger, avec la collaboration de Alain Hayot et Jean-Marc Mariottini, Le match de football.
Etnologie d’une passion partisane à Marseille, Naples et Turin Paris: Éditions de la Maison des Sciences de
l’Homme, 1995; Alessandro DAL LAGO, Descrizione di una battaglia, Bologna, Il Mulino, 1990; Alessandro
DAL LAGO, Roberto MOSCATI, Regalateci un sogno: miti e realtà del tifo calcistico in Italia, Milano,
Bompiani, 1992; Ossimori, numero n. 1.
75
Faye GINSBURG Contested lives: the abortion Debate in an American Community, Berkeley, University of
California Press, 1989
35
nel caso del “rito” - o con la ridefinizione concettuale di alcune teorie in riferimento a quello che era il metro
implicito (e tacito) di confronto - come nel caso della parentela.
Un riflesso di questo processo di ridefinizione, connesso all’insoddisfazione per le tradizionali unità di
analisi, è sfociato in in quella che si potrebbe definire l’ ”esplosione” della dimensione locale della ricerca,
necessariamente condotta su più ambiti, secondo un processo che prende le mosse da quella corrente di studi,
che, negli anni Settanta e Ottanta, si è interessata ai processi di formazione di un’economia mondiale e
dell’interazione fra capitalismo e società locali76, fino a quella che è si è auto-definita la “multi-sited
ethnography”77, in relazione all’approccio “transnazionale” e al tema della “globalizzazione”, con
un’attenuazione della contrapposizione fra un “centro” e una “periferia”, in favore di una “trasversalità” dei
processi di comunicazione e di diffusione.
Non bisogna quindi pensare il processo di “ritorno” come caratterizzato da fasi ben distinte, in cui
orientamenti teorici e processi di selezione e costruzione dell’oggetto di ricerca - con tutto il correlato delle
pratiche relative alla ricerca, dal finanziamento dei progetti alla scelta del luogo, alla formazione di nuovi
curricula - si sarebbero differenziati e succeduti in modo netto: al contrario, ancora oggi, o perlomeno fino a
tempi recenti78, e, come si è detto, anche a seconda delle diverse tradizioni accademiche, si possono
incontrare resistenze al riconoscimento di una “pari dignità” alle ricerche “a casa”. Anche l’attenzione per
nuovi oggetti non sempre è orientato da prospettive teoricamente aggiornate, ma anzi può rifarsi a tradizioni
interpretative precedenti: a questo concorrono anche esigenze e modalità di formazione della ricerca
etnografica, in cui la difficoltà, anche logistica, della presa di contatto con un nuovo “terreno” può essere uno
dei motivi per il mantenimento, e la trasmissione, attraverso le differenti generazioni accademiche, di
rapporti più o meno stabili con i luoghi di ricerca, mentre l’avvicendamento dei ricercatori, e
l’aggiornamento dei quadri teorici, possono portare facilmente a una tensione tra cornice teorica preesistente
e impostazione individuale; cosicché, ancora oggi, può essere comune assegnare - o vedersi assegnare - per
argomento di tesi di laurea o di dottorato ricerche improntate a concezioni in cui il luogo di ricerca viene
concepito quasi in isolamento.
7. Il ‘ritorno a casa’ come processo
Il “ritorno a casa” dell’antropologia potrebbe allora essere inteso non tanto come evento temporalmente
circoscrivibile, quanto come processo diffuso che: i) si attua non soltanto in alcune aree, ma anche in una
dimensione temporale; ii) mette in crisi il concetto stesso di “casa”, o di centro e di periferia, al di là della
provenienza dell’antropologia da alcuni paesi occidentali, in quanto iii) si costituisce in modo teorico e
tematico, al di là dei differenti contesti etnografici, (retro)agendo sul modus operandi dell’antropologia, cioè
sulla pratica della ricerca etnografica. Il suo esame diventa allora difficilmente separabile dal dibattito più
ampio inerente la ricerca sul terreno, e il rapporto fra ricercatore e “ricercati”.
Nello stesso tempo, l’incremento dell’interesse etnografico per il “nostro” modo di vita può essere
ricondotto anche a fattori contingenti, quali il fermento politico e ideologico del ‘68, con la
“politicizzazione” di alcuni studi, e la focalizzazione su alcune tematiche - come la tematica del potere, in
seguito all’emergere di nuovi orientamenti e nuovi pensatori, come Michel Foucault, Michel de Certeau, o al
rinnovamento di interesse per autori del passato, come Gramsci, accomunati dall’attenzione per il rapporto
tra potere e cultura; ma, soprattutto, in riferimento all’”esplosione” del movimento femminista, che porterà
alla costituzione progressiva di un campo di studi interdisciplinare, focalizzato sul “gender”, e capace di far
avvertire la sua influenza dalla storia, alla critica letteraria, allo studio delle istituzioni, al diritto,
all’antropologia e alla sociologia.
In generale, l’interdisciplinarietà può essere assunta come caratteristica costitutiva del processo di
“ritorno”, in quanto la nascita di una tematica avviene all’interno di spazi in cui sono già presenti altre
discipline. Gli studi sul “gender” possono essere assunti come esempio di inversione nel rapporto fra luogo
di nascita di una tematica e suo successivo ambito di estensione, secondo un vettore generalmente orientato,
in senso temporale e spaziale, dai contesti etnografici verso le nostre società, come, ad esempio, nel caso
76
In modo diverso, Immanuel WALLERSTEIN, Il sistema mondiale dell'economia, Bologna, Il Mulino, 19781991 [1974-1989]; Immanuel WALLERSTEIN, Geopolitics and Geoculture. Essays on the changing
world-system Cambridge: University Press, Paris: Maison des Sciences de l’Homme; 1991; Eric Wolf
L'Europa e i popoli senza storia Bologna: Il Mulino, 1990 [1982].
77
George MARCUS, 1995 «Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited
Ethnography» in Annual Review of Anthropology, 24: 95-117.
78
Carrier, 1992, op. cit.
36
dello studio della parentela o di quello del rito; in questo caso, invece, la tematica “nasce” legata alla
contingenza politica e viene successivamente assunta come chiave di lettura ed esportata in altri ambiti.
Infine, va tenuto presente un altro aspetto, antecedente e indipendente, ma, finalmente, relato:
l’interesse, più avvertibile in particolare nella seconda metà del Novecento, per la dimensione quotidiana,
ordinaria, dell’uso del linguaggio, a seguito dell’influenza di filosofi, pur differenti fra loro, come
Wittgenstein79 e Austin80. Questo interesse, tralignando dall’ambito filosofico, si è esteso ad altre aree di
studio, tra le quali, in primo luogo, la linguistica, la sociologia, l’antropologia, ma anche il diritto; ha
concorso alla nascita di orientamenti, come la pragmatica, l’etnometodologia e la sociolinguistica, che fanno
riferimento, a titolo e in modo diverso, al “contesto” come unità pertinente per l’analisi di un atto di
comunicazione.
In antropologia, questo processo - e queste impostazioni - hanno rafforzato la propensione, già
costitutiva degli inizi dell’etnografia moderna, ad attribuire centralità alla dimensione del linguaggio in
rapporto al contesto81 e hanno dato luogo ad analisi incentrate sui processi comunicativi ordinari, come nell’
“ethnography of speaking”82 o nella focalizzazione sulla dimensione dell’interazione (specialmente ad opera
di Erving Goffman83). Nello stesso tempo, in analogia con quanto avveniva in linguistica, l’accento sulla
dimensione dell’uso ha concorso, in antropologia, a porre in primo piano la dimensione della pratica sociale,
non più epifenomeno di leggi o regolarità celate da svelare, come nelle impostazioni chomskiane o
levistraussiane, ma livello pertinente dell’analisi84.
In particolare, il cosiddetto “secondo” Wittgenstein, spesso citato per quello che è divenuto una sorta di
‘slogan’ improntato alla centralità della dimensione dell’uso: “il significato è l’uso” (Ludwig Wittgenstein,
Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1967 [1953]).
80
Anche l’opera di Austin è all’origine di un termine molto fortunato, sempre relativo alla dimensione
dell’uso linguistico, quello del “performativo” (John Austin, Quando dire è fare, Torino, Marietti, 1974
[1962]).
81
V., ad esempio, Bronislaw MALINOWSKI, «Il problema del significato nei linguaggi primitivi», in Il
significato del significato: studio dell’influsso del linguaggio sul pensiero e della scienza del simbolismo, a
cura di Charles K. Ogden e Ivor Armstrong Richards, Milano, Garzanti, 1966 [1923]; IDEM, 1935, Coral
Gardens and Their Magic, London: Allen & Unwin; e la lettura che ne fa Stanley TAMBIAH, 1968, «The
magical power of words» in Man, 3, 2: 175-208.
82
Richard BAUMAN, Joel SHERZER, Explorations in the ethnography of speaking, Cambridge, Cambridge
University Press, 1974; John Gumperz, Dell Hymes (a cura di), The ethnography of communication,
Washington, numero speciale di “American Anthropologist”, 1964; Dell Hymes, 1962, «The Ethnography of
Speaking», in Anthropology and the Human Behavior, a cura di T. Gladwin, W.C. Sturtevant, Washington,
Anthropological Society of Washington.
83
Erving GOFFMAN, «La situazione trascurata» in Linguaggio e società, a cura di Pier Paolo GIGLIOLI,
Bologna, Il Mulino; IDEM, Frame analysis New York: Harper & Row, 1974; IDEM, Il comportamento in
pubblico. L'interazione sociale nei luoghi di riunione. Torino: Einaudi, 1971 [1963]; IDEM, Modelli di
interazione. Bologna: IL Mulino, 1971 [1967]; IDEM, Relazioni in pubblico. Milano: Bompiani, 1981 [1971];
IDEM, Forme del parlare. Bologna: Il Mulino, 1987 [1981].
84
V. Sherry Ortner, 1984, «Theory in Anthropology since the Sixties» in Comparative Studies in
Society and History 26, n°1: 126-166
79
37
6. Moda senza tempo. Sul jazz
Theodor W. Adorno
(da T.W. Adorno, Prismi, trad. it. E. Filippini, Torino, Einaudi, 1972, pp. 115-28 [ed. orig. 1955])
1.
Per più di quarant'anni, da quando scoppiò in America nel 1914 il contagioso entusiasmo per il jazz,
questo è andato affermandosi come fenomeno di massa. Il procedimento jazzístico, la cui preistoria inizia
con certe canzonette come Turkey in the Straw e Old Zip Coon risalenti alla prima metà del secolo XIX, è
rimasto immutato nonostante tutte le proclamazioni dei suoi storici propagandistici: il jazz è una musica,
che, con una struttura melodica armonica metrica e formale elementarissima combina lo svolgimento
musicale a partite da sincopi in qualche modo irritanti che non scalfiscono però mai l'ottusa uniformità del
ritmo fondamentale, né i tempi sempre identici, i quarti. Ciò non vuol dire che il jazz non abbia avuto una
sua vicenda, per esempio il pianoforte monocromo venne spodestato dall'egemonia di cui godeva al
tempo del rag-time e soppiantato dai piccoli complessi, per lo più di fiati; oppure la prassi ostentatamente
selvaggia in uso presso le prime bande del Sud specie di New Orleans, ma anche di Chicago, si è andata
placando con la progressiva commercializzazione e divulgazione, per essere regolarmente ripresa dai
tentativi di restaurazione degli «specialisti», tentativi, dallo swing al be-bop, però regolarmente riassorbiti
nel business e privati del loro mordente. Soprattutto, il principio fondamentale del jazz, che all'inizio
dovette imporsi con l'esagerazione, è diventato cosi abituale che può perfino fare a meno degli accenti sui
tempi deboli delle battute di cui prima aveva bisogno, tanto che se qualcuno oggi facesse musica con
accenti del genere, sarebbe tacciato di essere corny, superato come un abito da sera del 1927.La rivolta è
diventata una levigatezza di secondo grado: la forma di reazione costituita dal jazz si è talmente
accumulata che tutta una gioventù sente ormai naturalmente, primariamente, a sincopi e non coglie più
l’originario conflitto fra le sincopi ed il metro fondamentale. Ma questo non toglie nulla all’invariabilità
del jazz, che pone di fronte all’enigma: perché mai milioni di uomini non sembrano ancora sazi di
un’eccitazione così monotona?Winthrop Sargeant, oggi universalmente noto come redattore artistico di
“Life”, al quale dobbiamo il libro migliore, più attendibile e meditato sull'argomento, diciassette anni fa
scriveva che il jazz non è affatto un nuovo idioma musicale, bensì «anche nelle sue manifestazioni più
complesse una faccenda
semplicissima, un ritorno incessante di formule».Questo si avverte
in modo cosi spregiudicato soltanto in America: in Europa, dove il jazz non è ancora diventato
un'istituzione quotidiana, soprattutto quei credenti che lo coltivano con animo ideologico tendono a
prenderlo per un trionfo della natura primordiale e sfrenata sui beni culturali museificati. Ma se è certa la
presenza di elementi africani nel jazz, altrettanto lo è, fin da principio, l'irreggimentazione, la riduzione a
rigido schema dell'elemento irregolare, la fusione del gesto di rivolta con la disposizione alla cieca
obbedienza, cosi come la psicologia analitica c'insegna che il sadomasochista reagisce alla figura del
padre pur ammirandolo in segreto, vuole emularlo eppure gode dell'odiata subordinazione. Furono
proprio queste tendenze intrinseche a favorire la standardizzazione, lo sfruttamento commerciale e la
pietrificazione del genere. Non furono dei perfidi uomini d'affari a rovinare la voce della natura, ma è il
jazz stesso che se ne incarica, producendo in grazia dei suoi usi l'abuso contro il quale protestano i cultori
del jazz originario e non annacquato. Già i negro spirituals che precorrono i blues univano, in quanto
musica di schiavi, il lamento sull'oppressione con la ratificazione della medesima. Del resto è assai
difficile isolare nel jazz gli autentici elementi negri. Anche il proletariato di straccioni bianchi del Sud
ebbe la sua parte nella preistoria del jazz, prima che esso fosse inquadrato dai riflettori di una società che
sembrava aspettarlo, ed alla quale i suoi impulsi erano già familiari attraverso il cake-walk e lo stepdance.
Proprio lo smilzo repertorio di procedimenti, la rigorosa esclusione di ogni spunto non regolamentare
rendono cosi difficilmente comprensibile la tenace sopravvivenza di una specialità cosi povera, in cui
furono introdotti mutamenti soltanto al minimo possibile e per lo più con fini pubblicitari. Mentre, in un
periodo storico tutt'altro che statico, il jazz si è sottratto al tempo, né mostra la minima disposizione a
cedere qualcosa del suo monopolio, ma soltanto quella ad adattarsi docilmente agli ascoltatori, a seconda
che siano dei conoscitori o la massa indifferenziata degli arretrati, esso non ha perduto nulla della
caratteristica della moda. Quello che si ammannisce da quarant’anni appare tanto effimero come se
durasse una sola stagione. Il jazz è un manierismo dell’interpretazione. Come sempre nelle mode, si tratta
della presentazione e non della cosa stessa: non si compone veramente del jazz ma ci ai limita a ritoccare
38
la musica leggera, i più vuoti prodotti dell'industria delle canzonette. I fanatici, i fans, lo intuiscono, e
quindi fanno appello ai tratti dell'esecuzione che hanno l'aria di essere improvvisati, ma questo è un
pretesto: qualunque ragazzo un po' sveglio in America sa benissimo che oggi la routine non lascia alcun
margine all'improvvisazione e che ciò che si presenta come spontaneo è stato studiato con precisione
meccanica. Ma anche là dove una volta si improvvisava veramente e nei complessi eterodossi di oggi che
forse si cimentano in questo per il loro piacere, l'unico materiale sonoro sono le canzonette. Quindi le
cosiddette improvvisazioni si riducono a perifrasi delle formule fondamentali e lo schema riappare ad
ogni tratto sotto il loro velo. Anche le improvvisazioni sono in gran parte regolamentate e si ripetono
sempre. Tutto quel che può succedere nel jazz si aggira entro limiti cosi stretti come i tagli particolari dei
vestiti. Di fronte alla ricchezza di possibilità di inventare e variare il materiale sonoro perfino nella sfera
della musica leggera, ammesso che questa ne abbia assolutamente bisogno, il jazz appare di una squallida
povertà. Ciò che il jazz adopera delle tecniche musicali disponibili è del tutto arbitrario. Già il divieto di
modificare o trasformare in modo vivo e vitale la battuta fondamentale man mano che il pezzo procede,
limita talmente il musicista che l'accettarlo con zelo richiede piuttosto una regressione psicologica che
non la coscienza estetica di uno stile. Altrettanto duri sono i ceppi delle varie restrizioni metriche,
armoniche, formali. L'immutevolezza del jazz non dipende da un'organizzazione del materiale sonoro
entro la quale la fantasia abbia libero corso, come entro un linguaggio articolato, bensì dall'elevazione di
certi trucchi o di certe formulette e stereotipi a principe esclusivi. E’ come se ci si aggrappasse
spasmodicamente al fascino di ciò che è in voga e si negasse l'immagine visiva di un anno trascorso
rifiutandosi di strappare il foglio dal calendario. La moda si mette in trono come fenomeno permanente e
cosi facendo perde per l'appunto la dignità che della moda è propria: quella della sua transitorietà.
2.
Se si vuol capire perché mai un paio di ricette circoscrivano tutta una sfera quasi che al di fuori di essa
non ci fosse nulla, è bene eliminare tutte le frasi fatte sulla vitalità e sul ritmo dell'epoca che la pubblicità
recita diuturnamente, insieme al suo seguito giornalistico e infine insieme a tutte le sue vittime. Dal lato
ritmico il jazz ha da offrire ben poco: la musica seria da Brahms in poi aveva già espresso tutto ciò che
può colpirci nel jazz, ma senza insistervi. Ed è assai dubbia la vitalità di un procedimento standardizzato
perfino nelle sue deviazioni. Gli ideologi del jazz soprattutto in Europa, incorrono nell'errore di
scambiare una somma di effetti psicotecnicamente calcolati e collaudati per l'espressione di quella
condizione spirituale la cui immagine illusoria viene impressa dall'industria nell'ascoltatore; è come se si
scambiassero le stelle del cinematografo i cui volti levigati o dolenti sono stilizzati secondo i ritratti di
personaggi famosi per essere veramente identici a Lucrezia Borgia o Lady Hamilton, ammesso che queste
donne non siano già state le mannequins di se stesse. Ciò che un'innocenza caparbiamente fissata
sull'entusiasmo considera una foresta vergine è nient'altro che merce di fabbrica anche nei casi in cui la
spontaneità viene messa in mostra come un ramo dell'attività aziendale. La paradossale immortalità del
jazz ha le sue radici nell'economia. La concorrenza sul mercato culturale ha mostrato come una quantità
di tratti: il sincopato, il timbro metà vocale e metà strumentale. la scorrevole armonia impressionistica, la
lussuosa strumentazione (secondo il motto «Da noi non si bada a spese»),. siano di successo garantito.
Essi sono stati perciò assortiti, caleidoscopicamente ordinati in combinazioni sempre nuove, senza che
abbia mai avuto luogo la minima influenza reciproca fra lo schema generale e i particolari, non meno
schematici. Sono rimasti solo gli effetti della libera concorrenza (che forse non era già essa tanto libera),
e tutta la procedura è stata livellata soprattutto dalla radio. Gli investimenti fatti in name bands, nelle
bande di jazz rese famose da una propaganda scientificamente comandata, e ancor più il denaro speso
dalle aziende che comprano il tempo radiofonico per la loro pubblicità per programmi di best sellers
musicali e di hit parades, rendono troppo rischiosa ogni deviazione. Inoltre la standardizzazione significa
padronanza sempre più salda delle masse degli ascoltatori e dei loro riflessi condizionati. Ci si aspetta
che essi desiderino soltanto ciò a cui sono abituati e che si irritino se qualcosa delude le loro aspettative,
la cui soddisfazione essi ormai considerano come diritto dell'uomo e del cliente. La concentrazione delle
forze economiche rende a priori senza speranza ogni tentativo, se mai lo si osasse, di far penetrare
nell'ambito della musica leggera qualcosa di diversamente congegnato.
Nell'impossibilità di superare qualcosa che è intrinsecamente arbitrario e casuale si riflette l'arbitrio
dell'attuale sistema di controlli sociali. Quanto più integralmente l'industria culturale stronca le
deviazioni e quindi inibisce le possibilità di sviluppo dei suoi mezzi, tanto più l'attività strepitosamente
dinamica si avvicina alla stasi perfetta. Nessun brano di jazz conosce, dal punto di vista musicale, la
storia, tutte le sue parti sono smontabili e rimontabili, nessuna battuta consegue da una logica dello
39
sviluppo: cosi questa moda senza tempo diventa l'immagine d'una società pianificata e congelata non
tanto lontana dal raccapricciante Brave New World di Huxley. Gli economisti potranno meditare se in tal
modo l'ideologia esprima o identifichi una tendenza della società della sovraccumulazione a regredire allo
stadio della riproduzione semplice. Il timore espresso negli ultimi scritti di Veblen, che alla fine era
radicalmente libero da illusioni, che il gioco delle forze sociali e commerciali si sarebbe paralizzato in una
condizione gerarchica, negativa e senza storia, in una specie di sistema feudale potenziato, forse non ha
molta probabilità di avverarsi, ma è certamente presente come desiderio nel jazz. L'imago del mondo
tecnificato contiene un elemento astorico che lo porta a configurarsi come una mitica fantasmagoria
dell'eternità. La produzione pianificata, che elimina dal processo della vita tutto quanto non è controllato,
prevedibile e calcolato, sembra cosi sottoporgli quell'elemento di novità sostanziale senza il quale la
storia è difficilmente concepibile e la forma del prodotto di serie standardizzato comunica anche a quello
che gli succede temporalmente lo stampo del sempre uguale. Riesce infatti paradossale che una
locomotiva del I950 appaia diversa da una del 1850, perciò i rapidi più moderni vengono talvolta decorati
con fotografie di treni antiquati. Da Apollinaire in poi i surrealisti che per parecchi aspetti sono
ricollegabili al jazz, hanno fatto leva su questa sensazione: «ici méme les automobiles ont l'air d'être
anciennes». Inconsciamente la moda senza tempo ha assimilato tracce di ciò; il jazz, che non a caso
solidarizza con la tecnica, nella sua qualità di atto cultuale rigorosamente reiterato ma senza oggetto,
collabora a creare il «velo tecnologico» e finge che il ventesimo secolo sia un Egitto di schiavi e di
dinastie senza fine. Finge, perché laddove la tecnica viene simboleggiata con il modello della ruota che
gira uniformemente, le sue forze si sviluppano smisuratamente, ed essa è legata ad una società le cui
tensioni vanno avanti, la cui irrazionalità permane, e che concede agli uomini più storia di quanta essi non
desiderino. L'atemporalità viene proiettata sulla tecnica da una struttura del mondo che non vorrebbe più
cambiare per scongiurare il proprio crollo. La falsa eternità viene però sbugiardata dalla cattiva
accidentalità e volgarità che si instaurano come principio universale. I capi degl'imperi millenari di oggi
hanno volti di criminali e il gesto perenne della cultura di massa è quello degli asociali. Che proprio il
trucco del sincopato fosse adatto ad una dittatura musicale delle masse ha un aspetto usurpatorio: il
controllo totalitario è irrazionale nonostante la razionalità dei suoi mezzi. Nel jazz meccanismi che
appartengono in realtà alla ideologia contemporanea, a tutta l'industria culturale, galleggiano visibili in
superficie proprio perché senza conoscenze tecniche non sono così facili da inchiodare dentro come per
esempio nel film. Ma anche il jazz adotta le sue misure di sicurezza: parallela alla standardizzazione
procede la pseudoindividualizzazione.
Tanto più gli ascoltatori vengono presi per la cavezza, tanto meno debbono accorgersene. Li si persuade
che hanno a che fare con un'arte per il consumatore, tagliata su misura. Gli effetti specifici con i quali il
jazz riempie il suo schema, particolarmente il sincopato, si presentano come esplosioni ovvero caricature
di una soggettività non controllata (virtualmente quella dello spettatore) o anche come raffinatissime
sfumature in suo onore. Ma il metodo si imprigiona nella propria rete: mentre deve incessantemente
promettere all'ascoltatore qualcosa di straordinario, pungolarne l’attenzione, differenziarsi dalla grigia
monotonia, non può d'altra parte mai valicare il cerchio magico tracciato: deve essere sempre nuovo e
sempre uguale. Perciò le deviazioni sono altrettanto standardizzate degli standards e scompaiono non
appena si siano presentate: il jazz, come tutta l'industria culturale, soddisfa i desideri soltanto per rifiutarli
al. contempo.
Tanto più il soggetto del jazz, il sostituto dell'ascoltatore nella musica, si comporta come uno
stravagante, tanto meno lo è di fatto. I tratti individuali che non corrispondono alla norma ne restano
segnati, sono stimmate della mutilazione. Pieno d'angoscia egli si identifica con la società che lo teme,
perché fu essa a renderlo come è. Di qui il carattere affermativo del rituale jazzistico: grazie ad esso si
entra in una comunità di uguali non liberi. Sotto il segno di questa comunità il jazz può con diabolica
buona fede appellarsi alle stesse masse di ascoltatori. I procedimenti standardizzati che dominano senza
incontrare resistenza e vengono maneggiati per lunghi spazi di tempo, provocano reazioni standardizzate.
Troppo innocente sarebbe l'idea che si potesse istillare agli uomini violentati qualcosa di meglio, o anche
solo un po' di varietà, grazie ad una diversa politica di programmi come quella vagheggiata da educatori
bene intenzionati. Seri mutamenti nella politica dei programmi, a meno che non si estendano molto al di
là del dominio ideologico dell'industria culturale, sarebbero in realtà respinti con indignazione. La
popolazione è talmente assuefatta all'infamia che le viene inflitta da non osare rinunciarvi anche quando
riesca a smascherarla in parte, anzi deve stimolare la propria eccitazione per convincersi che l'oltraggio
ricevuto è una grazia. Il jazz offre schemi di comportamento sociale al quale gli uomini sono comunque
costretti a piegarsi. Su di esso essi esercitano quei comportamenti, per di più amandolo perché rende loro
40
più facile l'inevitabile. Esso riproduce la sua base di massa senza però che per questo siano meno
colpevoli coloro che lo producono. L'eternità della moda è un circolo vizioso.
3.
I sostenitori del jazz si articolano, come ha notato David Riesman, in due gruppi distinti. All'interno si
trovano gli esperti o quelli che si ritengono tali (più spesso sono soltanto dei fanatici che con una
terminologia già «collaudata» calano fendenti e distinguono pretenziosamente diversi stili di jazz senza
essere capaci di rendere conto in concetti precisi e tecnico-musicalí di quanto, a loro dire, li entusiasma).
In grazia d'una confusione che oggi alligna dappertutto, per lo più si credono all'avanguardia. Uno dei
sintomi del crollo della cultura, e non tra gli ultimi, è questo: la distinzione, pur discutibile che sia, fra arte
«alta», autonoma e «leggera», commerciale, non viene bensì esaminata criticamente, ma in compenso non
è neanche più percepita. Dopo che certi intellettuali disfattisti della cultura giocarono a contrapporre la
seconda alla prima, i campioni illetterati dell'industria culturale hanno l’orgogliosa fiducia di marciare
all'avanguardia dello spirito del tempo. La ripartizione dei livelli culturali in tre programmi
rispettivamente per ascoltatori low, middle e bigh brow è in sé disgustosa.
Ma non si può superarla facendo si che delle sette di low brows si autoproclamino high brow. Il legittimo
disagio della cultura offre il pretesto ma non la ragione per esaltare una branca iperrazionalizzata della
produzione di massa (che abbassa e liquida quella cultura senza affatto trascenderla), spacciandola per
l'irruzione d'un nuovo sentimento cosmico e mescolandola con il cubismo, la lirica di Eliot e la prosa di
Joyce. La regressione non è l'originario, il primordiale, ma questo è l'ideologia di quella. Chi si lascia
indurre dalla crescente rispettabilità della cultura di massa a scambiare per musica moderna una
canzonetta perché un clarino geme delle note false e prende per atonale un accordo perfetto inframezzato
di dirty notes, di note «sporche», ha già capitolato davanti alla barbarie. La cultura decaduta a cultura è
colpita dalla punizione poiché viene confusa senza possibilità di difesa, quanto più si diffonde il suo
malcostume, con i suoi prodotti di scarto. L'analfabetismo autocosciente, per il quale l'ottusità
dell'eccesso tollerato coincide con il regno della libertà, gliela fa pagare al privilegio culturale. Nella
debole rivolta c'è già la disposizione a piegare il collo, cosi come suggerisce il jazz, che integra gli
inciampi e i passi prematuri nel passo di marcia collettivo. Notevole è la somiglianza fra il tipo del
fanatico di jazz e certi giovani adepti del neopositivismo logico che buttano all'aria ogni preparazione
filosofica come quelli rigettano l'educazione musicale. L'entusiasmo si è trasferito sulla sobrietà, le
emozioni si legano ad una tecnica ostile ad ogni significato. Ci si sente al riparo entro un sistema che è
tanto ben definito da non ammettere errori al suo interno e la nostalgia repressa di ciò che potrebbe
esserci al di fuori si esprime in un odio intollerante ed in un atteggiamento che unisce la saputaggine
dell'iniziato alla pretesa d'esser liberi da ogni illusione. La trivialità trionfante, l'esser prigionieri della
superficie come certezza senza dubbi, trasfigurano la difesa codarda da ogni riflessione su se medesimi.
Tutte queste vecchie forme di reazione hanno recentemente perduto la loro innocenza: si propongono
come filosofia e cosi divengono interamente maligne.
Attorno alla cerchia interna dei conoscitori di ciò che non offre niente da capire salvo certe regole di
gioco, si cristallizzano gli adepti vaghi e inarticolati, i quali per lo più si inebriano della fama
dell'industria di massa che li manipola: è perfettamente lo stesso se convengono in clubs fondati per
venerare delle stelle del cinema o per raccogliere autografi di altrettali celebrità. Si tratta per loro di
appartenere ad un gruppo, di potersi identificare, senza che facciano molto caso del contenuto singolo. Le
ragazze hanno imparato a cadere in deliquio alla voce di un crooner, d'un cantante di jazz. Il loro
applauso scatta al segnale d'una luce elettrica e viene ritrasmesso dai programmi radiofonici: si chiamano
da sole jitterbugs, insetti agitati da riflessi motorii, spettatrici della propria estasi. La loro esistenza
misera e senza fantasia si sente compensata dal fatto che qualcosa le trascina, che possiedono qualcosa di
putativamente loro. Il gesto dell'adolescenza, il risoluto delirare per questo o quello secondo la giornata,
la prontezza a maledire domani come sciocchezza ciò che oggi si persegue con zelo, è stato socializzato.
Certo, spesso in Europa si trascura il fatto che i fanatici locali del jazz sono. diversi dagli americani. Oggi
in America manca del tutto quel tanto di eccessivo, di insubordinato che si avverte nel jazz in Europa. Il
ricordo delle origini anarchiche, che il jazz ha in comune con tutti i movimenti di massa oggi accettati, è
totalmente represso, anche se forse continua ad aggirarsi spettrale nel sottosuolo. Il jazz come istituzione
è un dato di fatto, taken for granted, ripulito e verniciato. La facilità a cadere nell’esaltazione esagerata e
parodistica è però comune agli entusiasti di jazz in tutti i paesi, e in ciò il loro gioco somiglia alla bestiale
serietà dei seguaci del governo nei paesi totalitari, anche se la distinzione fra gioco e serietà può ridursi a
quella fra vita e morte. La pubblicità d'una canzonetta suonata da una celebre name band diceva: Follow
41
your leader. Mentre nelle dittature europee i dittatori delle due sfumature inveirono contro la
«decadenza» jazzistica, la gioventù degli altri stati si lasciava elettrizzare come da marce militari dalle
danze sincopate le cui orchestre non a caso derivano dalle bande militari. La divisione fra truppe scelte e
massa di manovra ha qualcosa di analogo a quella fra élite del partito e popolazione.
4.
Il monopolio del jazz deriva dall'esclusività dell'offerta e dallo strapotere economico che c'è dietro. Ma
essa sarebbe ormai da tempo infranta se la specialità onnipresente non presentasse dei caratteri generali
che allettano gli uomini. Il jazz deve avere una «base di massa»: la tecnica deve avere un rapporto con un
momento interiore dei singoli, certo a sua volta collegato alla struttura della società ed ai conflitti tipici
fra l'io e la società. A cercare di individuare tale elemento si pensa subito al clown eccentrico od ai
vecchi comici del cinematografo. La manifestazione di debolezza individuale viene ritirata, l'inciampo
viene promosso a abilità particolare e più sottile. Nell 'integrazione dell'elemento asociale il jazz si
accosta allo schema altrettanto standardizzato del romanzo poliziesco e delle sue propaggini, dove
regolarmente il mondo è cosi deformato - o messo a nudo - che l'asocialità, il delitto diventa norma
quotidiana, ma al contempo la seducente e minacciosa tentazione viene esorcizzata con la vittoria
dell'ordine. Solo la dottrina psicanalitica può spiegare adeguatamente questi fenomeni. Scopo del jazz è
la riproduzione meccanica di un momento regressivo, un simbolismo di castrazione che sembra
significare: abbandona la pretesa di virilità, lasciati castrare, senti come il suono eunucoide della banda
del jazz lo decide e lo proclama; per questo verrai ricompensato, sarai adottato da una lega virile che
spartisce con te il mistero dell'impotenza, che si svela solamente nell'attimo del rito di iniziazione.
(Questa tesi è stata svolta nello studio Über Jazz [Il jazz], apparso nel 1936 nella «Zeitschrift für
Sozialforschung» (pp. 252 sgg.), e integrata in una critica dei libri di Sargeant e Hobson apparsa negli
«Studies in Philosophy and Socíal. Science», 1941, p. 175).
. Che tale interpretazione del jazz, delle cui implicazioni sessuali i nemici indignati hanno un'idea assai
più viva degli apologeti, non sia affatto arbitraria e tirata per i capelli, lo si potrebbe dimostrare con
innumerevoli particolari sia della musica che del testo delle canzonette. Nel libro American Jazz Music
Wilder Hobson descrive uno dei primi direttori di banda jazz, di nome Mike Riley, che, in segno di
eccentricità musicale, deve avere operato vere e proprie mutilazioni sugli strumenti: «La banda schizzava
acqua e stracciava vestiti, e Riley offriva forse la massima azione comica del trombone, una folle
interpretazione di Dinah durante la quale egli smembrava ripetutamente il corno e lo rimetteva assieme in
modo assurdo finché l'insieme dei tubi pendeva giù come mobili di ottone in una bottega di rigattiere, con
un gemito vagamente armonico che ancora usciva da una o più estremità libere ».
Assai prima Virgil Thompson aveva paragonato le prestazioni di Armstrong a quelle dei grandi castrati
del Settecento. Per tutta questa sfera testimonia l'uso linguistico di distinguere fra musicisti long haired e
sbort haired; questi sono i suonatori di jazz che guadagnano e quindi possono permettersi un aspetto
curato, mentre gli altri sono all'incirca la caricatura del pianista slavo dalla folta criniera, e cadono sotto
uno stereotipo denigratorio, quello dell'artista affamato che si oppone sfacciatamente alle convenzioni.
Fin qui il contenuto manifesto dell'uso linguistico. Ma ciò che rappresenta la chioma recisa non ha
bisogno di delucidazioni. Nel jazz vengono celebrati i filistei, eternamente trionfanti su Sansone.
I fìlistei, perché mentre la simbologia della castrazione è probabilmente sepolta nell'esecuzione del jazz
e separata dalla coscienza grazie all'istituzionalizzazione del sempre uguale, anche se forse proprio perciò
vieppiù possente, la prassi jazzistica si esaurisce socialmente nel riconoscimento di un mondo senza sogni
e realistico, depurato da ogni ricordo di ciò che non è - totalmente inserito nella società; riconoscimento
penetrato fin nel cuore della psicologia del soggetto. Per individuare la base di massa del jazz bisogna
rendersi conto del tabú che opprime oggi in America qualsiasi espressione artistica, nonostante le attività
artistiche ufficiali, perseguitando perfino i moti espressivi dei fanciulli (la progressive education che li
stimola alla libertà espressiva e produttiva non è che una reazione a tutto ciò).Mentre l'artista è
parzialmente tollerato e parzialmente inserito come entertainer («intrattenitore»), come funzionario, nella
sfera del consumo, ed è sottoposto alle esigenze del servizio come un cameriere ben pagato, al contempo,
lo stereotipo dell'artista è quello dell'introverso, del buffone egocentrico, spesso dell'omosessuale.
Quand'anche queste particolarità sono tollerate nei professionisti dell'arte e anzi ci si aspetta una vita
scandalosa come parte del trattenimento, ogni altra persona si rende già sospetta se presenta emozioni
artistiche spontanee, non socialmente preformate. Un bambino che preferisca ascoltare musica seria o
suoni il pianoforte invece di assistere ad una partita di baseball o di guardarla alla televisione, viene
disprezzato come sissy, debole ed effemminato nella sua classe o negli altri gruppi cui appartiene e che
42
per lui incarnano un’autorità assai maggiore di quella dei parenti o degli insegnanti. La volontà di
esprimersi si attira già la minaccia di castrazione che nel jazz è simboleggiata e padroneggiata in guisa
meccanica e rituale. Ma proprio negli anni dell'adolescenza il bisogno di esprimersi, che può anche non
aver nulla da fare con l'arte nella sua qualità oggettiva, non si può del tutto eliminare. Gli adolescenti non
sono ancora sottoposti al giogo della lotta per il guadagno e del suo corrispettivo psichico: il principio di
realtà. I loro impulsi estetici non vengono semplicemente cassati dalla repressione, ma deviati. Il jazz è lo
strumento preferito per operare questa deviazione. La moda senza tempo offre alle masse giovanili che
accorrono ad essa di anno in anno, probabilmente per scordarsene dopo un paio d'anni, un compromesso
fra la sublimazione artistica e l'adattamento sociale. L’elemento «non realistico», non praticamente
utilizzabile, immaginoso, viene lasciato passare solo se si modifica al punto da assomigliarsi senza tregua
al suo opposto, il meccanismo della realtà, accogliendone le istanze, ripetendole, acconsentendo ad esse e
quindi inserendosi di nuovo nel circuito da cui tentava di evadere. All'arte viene sottratta la qualità
artistica ed essa appare come un frammento di quell'adattamento che contrasta con il suo stesso principio.
Cosi si spiegano certi singolari aspetti del procedimento jazzistico. L'arrangiamento, ad esempio, che non
si spiega adeguatamente con la divisione tecnica del lavoro o con l'analfabetismo musicale dei cosiddetti
compositori. Nulla deve sussistere quale è in se stesso: tutto dev'essere giustificato, recare il marchio di
un'elaborazione che, avvicinandolo a ciò che è già noto, lo rende più facilmente comprensibile e nel
contempo lo mostra destinato al servizio dell'ascoltatore, senza tuttavia idealizzarlo, e infine lo
caratterizza come qualcosa che è approvato dal sistema, che non pretende di creare una distanza, ma anzi
si associa senza riserve: una musica che non crede di essere qualcosa di meglio.
L'abilità particolare richiesta dai musicanti e anche in certa misura dagli ascoltatori, certamente dai
ballerini, obbedisce anch'essa al primato dell'adattamento. La tecnica estetica, come somma dei mezzi
che permettono l'oggettivazione d'una realtà autonoma, viene sostituita dalla capacità di accettare ostacoli,
di non lasciarsi disorientare da fattori di disturbo, come le sincopi, portando tuttavia a termine con astuzia
l'operazione particolare sottoposta all'astratta regola del gioco. L'esecuzione artistica è ridotta a sport in
base a sistema di trucchi. Chi rimane padrone di sé si dimostra «pratico». La prestazione del musicante di
jazz o dell'intenditore si riduce a una serie di tests felicemente superati. L'espressione, l'unico vero
strumento della protesta estetica, soccombe invece al potere contro il quale protesta. Da questo essa trae
il timbro della malignità e della lamentosità, che appena fuggevolmente si paluda di violenza e di
eccitazione. Il soggetto che si esprime, proprio nel far ciò esprime: io non sono niente, sono immondizia,
mi sta bene ciò che mi si fa. E’ già potenzialmente uno degli accusati di stampo russo che, pur essendo
innocenti, fin da principio collaborano col pubblico ministero e non trovano mai nessuna punizione
adeguata ai propri misfatti. L'esteticità come sfera retta da leggi proprie nacque dal magico tabù, che
separava il sacro dal quotidiano e ingiungeva di tener puro il primo; ora il profano si vendica sull'erede
della magia, sull'arte, che viene lasciata in vita solo se rinuncia al diritto di essere diversa e si subordina
all'onnipotenza del profano, in cui trapassò a suo tempo il tabù. Nulla deve essere che non sia come ciò
che è. Il jazz è la falsa liquidazione dell'arte: invece di avverarsi, l'utopia scompare dall'orizzonte.
(1953).
43
44