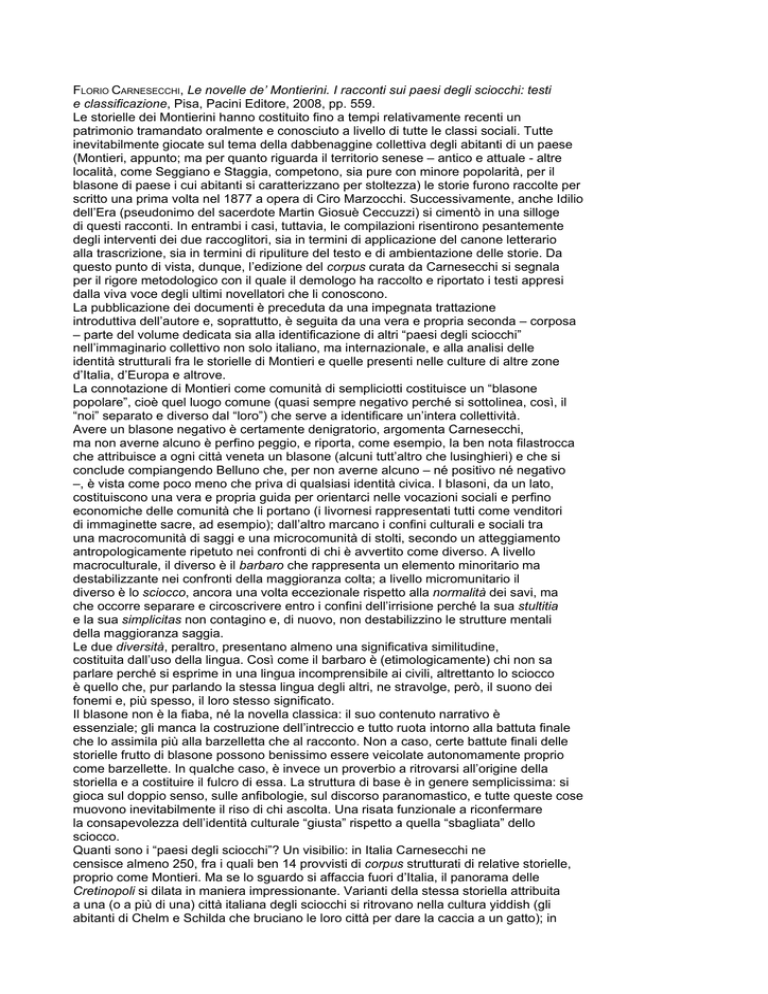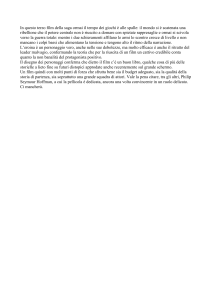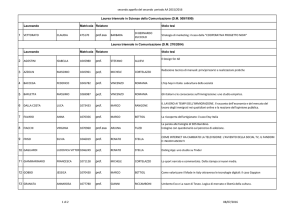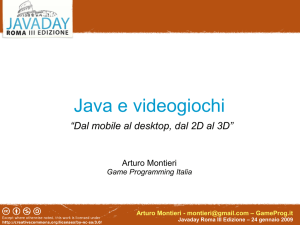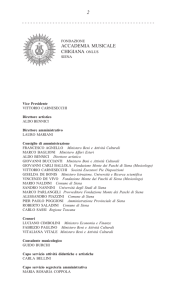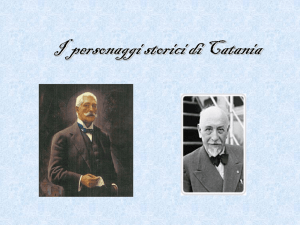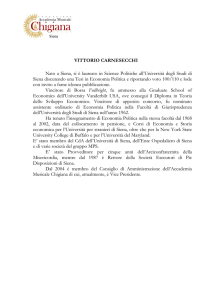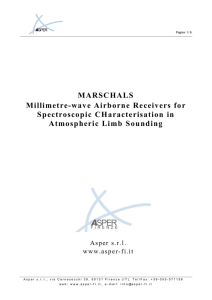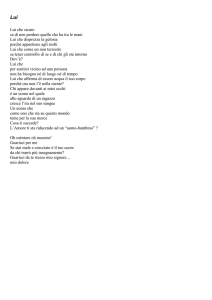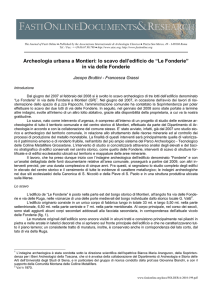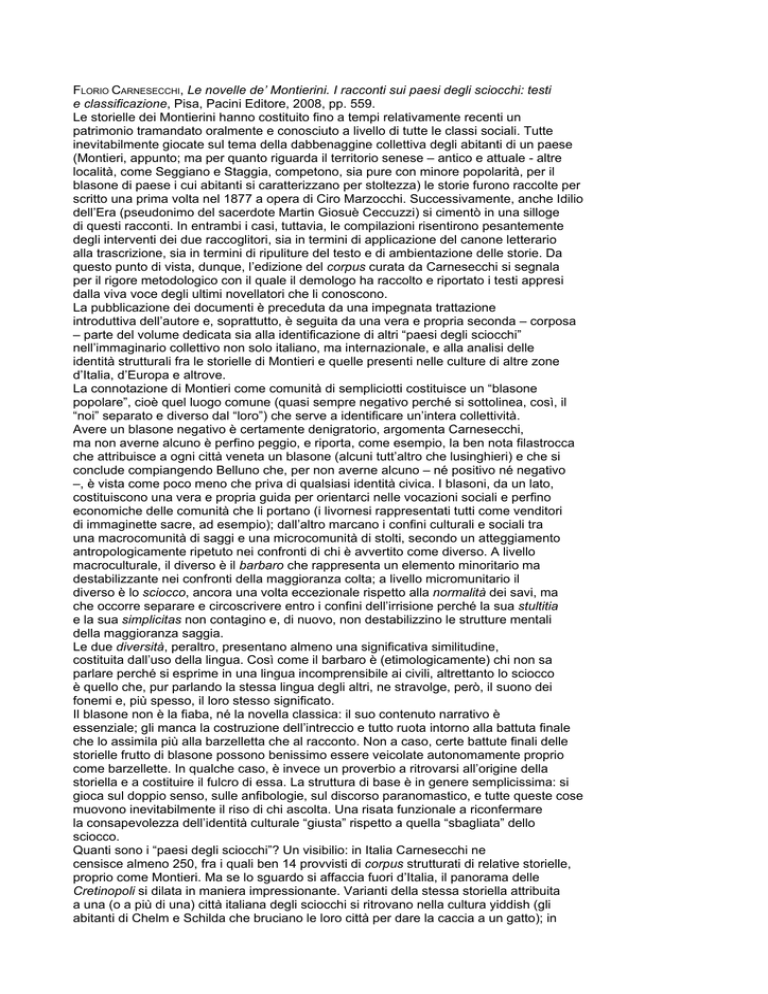
FLORIO CARNESECCHI, Le novelle de’ Montierini. I racconti sui paesi degli sciocchi: testi
e classificazione, Pisa, Pacini Editore, 2008, pp. 559.
Le storielle dei Montierini hanno costituito fino a tempi relativamente recenti un
patrimonio tramandato oralmente e conosciuto a livello di tutte le classi sociali. Tutte
inevitabilmente giocate sul tema della dabbenaggine collettiva degli abitanti di un paese
(Montieri, appunto; ma per quanto riguarda il territorio senese – antico e attuale - altre
località, come Seggiano e Staggia, competono, sia pure con minore popolarità, per il
blasone di paese i cui abitanti si caratterizzano per stoltezza) le storie furono raccolte per
scritto una prima volta nel 1877 a opera di Ciro Marzocchi. Successivamente, anche Idilio
dell’Era (pseudonimo del sacerdote Martin Giosuè Ceccuzzi) si cimentò in una silloge
di questi racconti. In entrambi i casi, tuttavia, le compilazioni risentirono pesantemente
degli interventi dei due raccoglitori, sia in termini di applicazione del canone letterario
alla trascrizione, sia in termini di ripuliture del testo e di ambientazione delle storie. Da
questo punto di vista, dunque, l’edizione del corpus curata da Carnesecchi si segnala
per il rigore metodologico con il quale il demologo ha raccolto e riportato i testi appresi
dalla viva voce degli ultimi novellatori che li conoscono.
La pubblicazione dei documenti è preceduta da una impegnata trattazione
introduttiva dell’autore e, soprattutto, è seguita da una vera e propria seconda – corposa
– parte del volume dedicata sia alla identificazione di altri “paesi degli sciocchi”
nell’immaginario collettivo non solo italiano, ma internazionale, e alla analisi delle
identità strutturali fra le storielle di Montieri e quelle presenti nelle culture di altre zone
d’Italia, d’Europa e altrove.
La connotazione di Montieri come comunità di sempliciotti costituisce un “blasone
popolare”, cioè quel luogo comune (quasi sempre negativo perché si sottolinea, così, il
“noi” separato e diverso dal “loro”) che serve a identificare un’intera collettività.
Avere un blasone negativo è certamente denigratorio, argomenta Carnesecchi,
ma non averne alcuno è perfino peggio, e riporta, come esempio, la ben nota filastrocca
che attribuisce a ogni città veneta un blasone (alcuni tutt’altro che lusinghieri) e che si
conclude compiangendo Belluno che, per non averne alcuno – né positivo né negativo
–, è vista come poco meno che priva di qualsiasi identità civica. I blasoni, da un lato,
costituiscono una vera e propria guida per orientarci nelle vocazioni sociali e perfino
economiche delle comunità che li portano (i livornesi rappresentati tutti come venditori
di immaginette sacre, ad esempio); dall’altro marcano i confini culturali e sociali tra
una macrocomunità di saggi e una microcomunità di stolti, secondo un atteggiamento
antropologicamente ripetuto nei confronti di chi è avvertito come diverso. A livello
macroculturale, il diverso è il barbaro che rappresenta un elemento minoritario ma
destabilizzante nei confronti della maggioranza colta; a livello micromunitario il
diverso è lo sciocco, ancora una volta eccezionale rispetto alla normalità dei savi, ma
che occorre separare e circoscrivere entro i confini dell’irrisione perché la sua stultitia
e la sua simplicitas non contagino e, di nuovo, non destabilizzino le strutture mentali
della maggioranza saggia.
Le due diversità, peraltro, presentano almeno una significativa similitudine,
costituita dall’uso della lingua. Così come il barbaro è (etimologicamente) chi non sa
parlare perché si esprime in una lingua incomprensibile ai civili, altrettanto lo sciocco
è quello che, pur parlando la stessa lingua degli altri, ne stravolge, però, il suono dei
fonemi e, più spesso, il loro stesso significato.
Il blasone non è la fiaba, né la novella classica: il suo contenuto narrativo è
essenziale; gli manca la costruzione dell’intreccio e tutto ruota intorno alla battuta finale
che lo assimila più alla barzelletta che al racconto. Non a caso, certe battute finali delle
storielle frutto di blasone possono benissimo essere veicolate autonomamente proprio
come barzellette. In qualche caso, è invece un proverbio a ritrovarsi all’origine della
storiella e a costituire il fulcro di essa. La struttura di base è in genere semplicissima: si
gioca sul doppio senso, sulle anfibologie, sul discorso paranomastico, e tutte queste cose
muovono inevitabilmente il riso di chi ascolta. Una risata funzionale a riconfermare
la consapevolezza dell’identità culturale “giusta” rispetto a quella “sbagliata” dello
sciocco.
Quanti sono i “paesi degli sciocchi”? Un visibilio: in Italia Carnesecchi ne
censisce almeno 250, fra i quali ben 14 provvisti di corpus strutturati di relative storielle,
proprio come Montieri. Ma se lo sguardo si affaccia fuori d’Italia, il panorama delle
Cretinopoli si dilata in maniera impressionante. Varianti della stessa storiella attribuita
a una (o a più di una) città italiana degli sciocchi si ritrovano nella cultura yiddish (gli
abitanti di Chelm e Schilda che bruciano le loro città per dare la caccia a un gatto); in
quella tedesca, francese, boema, inglese; la saga turca di Nasreddin Hogia sposta in
Asia Minore il trionfo della stupidità.
Ma come nasce il blasone della sciocchezza e, soprattutto, perché viene cucito
addosso agli abitanti di una comunità piuttosto che a quelli di un’altra? E’ vero che,
come Carnesecchi commenta, “non ha molto senso cercare perché certe località. Ha
più senso spiegare perché nasce il topos del paese degli stolti”, ma i criteri in base
ai quali il blasone ricade su alcuni e su altri no non sembra una domanda del tutto
priva di senso, anche se ad essa non è facile dare una risposta coerente. La storiografia
positivista, spericolatamente sfidando il determinismo geografico, individuava le
ragioni nell’isolamento di un paese. E Montieri, certo, può essere vista come una
località rimasta per secoli isolata (ma non più di altre sue vicine: anzi, rispetto ad
alcune, decisamente meno). Però come metterla con “paesi di sciocchi” come Canepina,
Onano, addirittura Cuneo? Non di cause geografiche si tratta, insomma, ma, semmai,
solo antropologiche. La domanda, comunque, anche spostandola su questo secondo
piano, rimane ugualmente senza risposta: è la tipologia delle attività svolte a dare ad
una comunità uno statuto di diversità esorcizzato attribuendole quello collaterale di
stoltezza? Canepina e Onano sono paesi di commercianti in un contesto di economia
agricola; Montieri ha una presenza significativa di attività minerarie in un mondo
altrimenti contadino. Invece, nel caso di Cuneo, è la frequenza dell’ipertiroidismo che
a lungo ha fatto denominare i suoi abitanti come “gozzuti” a stabilirne l’alterità rispetto
alle comunità vicine? Forse. Ma siamo, come si vede, ancora nel campo di ipotesi che
non trovano comuni denominatori in grado di offrire un’accettabile decodificazione del
fenomeno.
Nel caso delle storielle che coinvolgono le comunità di campagna, comunque,
non possiamo che concordare con Carnesecchi quando identifica in esse un fenomeno
culturale fondamentale nella storia antropologica di lungo periodo: in questi casi,
argomenta il curatore, siamo in presenza di un mondo rurale che accetta di autoraccontarsi
e di autoridicolizzarsi “isolando” al suo interno alcune realtà sociali che fungono così da
“capro espiatorio” destinato, per questo, ad attirare su di sé ogni negatività lasciandone
immuni le altre.
Le storielle dei paesi degli sciocchi ruotano, in genere, intorno a un meccanismo
di antinomia: per una comunità di allocchi ce n’è una di furbi che, regolarmente, li
imbrogliano. Nel caso di Montieri, la città antinomica è, di prevalenza, Siena: qui
si svolgono alcune ridicole loro performance; qui allignano i bottegai disonesti o i
lestofanti di strada che turlupinano gli ingenui Montierini. E l’antinomia, in questo
caso, si traduce in un controblasone altrettanto negativo quanto quello che devono, loro
malgrado, esibire i buoni rustici: se Montieri è il paese degli sciocchi, Siena è la città
dei disonesti. E, come sottolinea a questo proposito Carnesecchi, ci si domanda se si
ride solo dei Montierini stolti o anche dei Senesi truffaldini.
Le storie di Montieri (delle tante Montieri nel mondo) presentano peraltro
pochissimi elementi realistici: si svolgono in un tempo immobile; si muovono in uno
spazio schematico fatto di pochi elementi topici: una chiesa, un campanile, un cimitero,
un pozzo. Non di società reali, insomma, si tratta, né di gente in carne e ossa, ma
di una metafora della condizione umana: si ritiene indispensabile la presenza della
sciocchezza (versione domesticata e meno inquietante della pazzia) perché essa serve a
recuperare la razionalità e a rassicurare chi, deridendo la prima, è sicuro di non essersi
allontanato dalla seconda. Del resto, non di rado questo tipo di storielle presentano, al
loro interno, un significativo criptocorrettivo che recupera al mondo “sapiente” anche
lo sciocco. Il Giufà di turno, deriso e isolato, trova il sistema per varcare il confine labile
fra la stoltezza e la furbizia, e diventa, magari, ricco e gabba i gabbatori, dimostrando
che ogni emarginato è, come ab antiquo, un sacer, e come tale in grado di elevarsi al
di sopra della società di chi si autoinganna considerandosi intelligente e, per questo,
superiore a lui.
Il corpus montierino e, soprattutto, il commento e l’apparato con i quali
Carnesecchi lo ha arricchito rappresentano, insomma, una formidabile ripartenza
per ricominciare la ricerca e per mettere sul tavolo nuove e importanti domande che
investono il campo della storia dell’antropologia e, tout court, della società.
DUCCIO BALESTRACCI