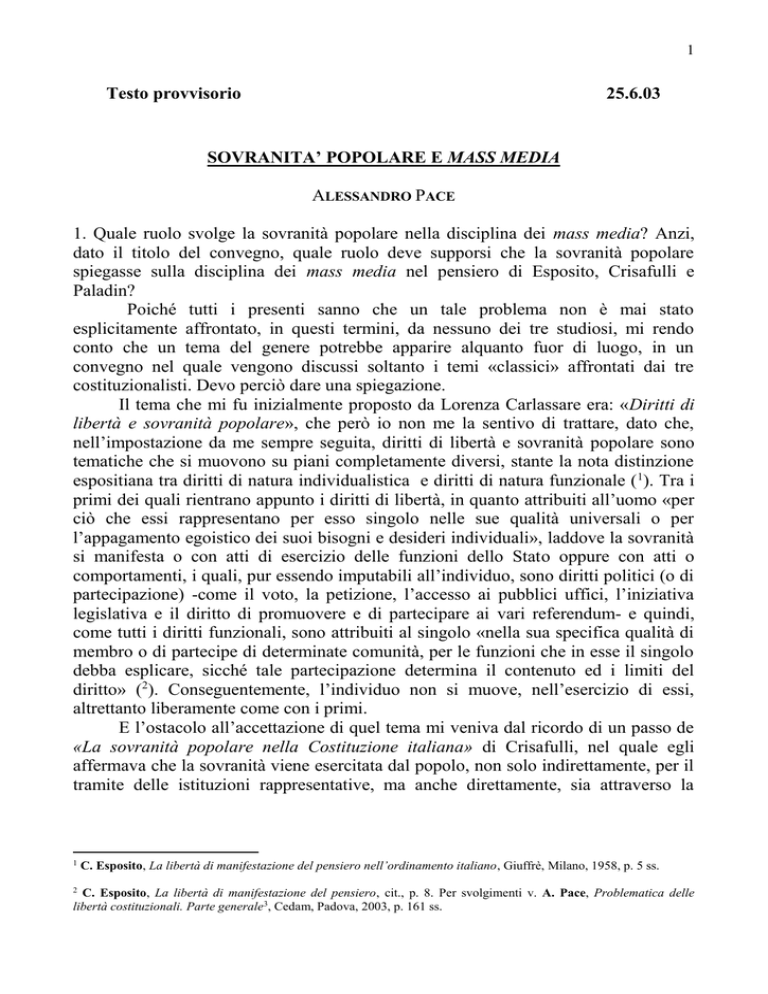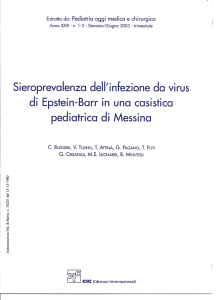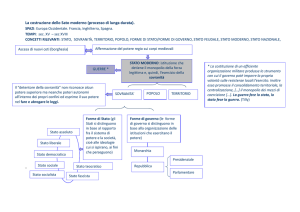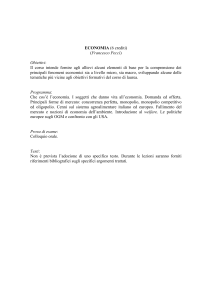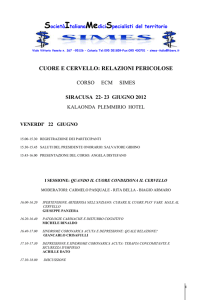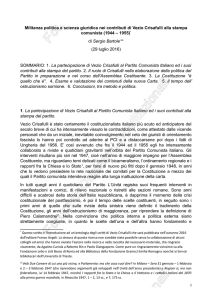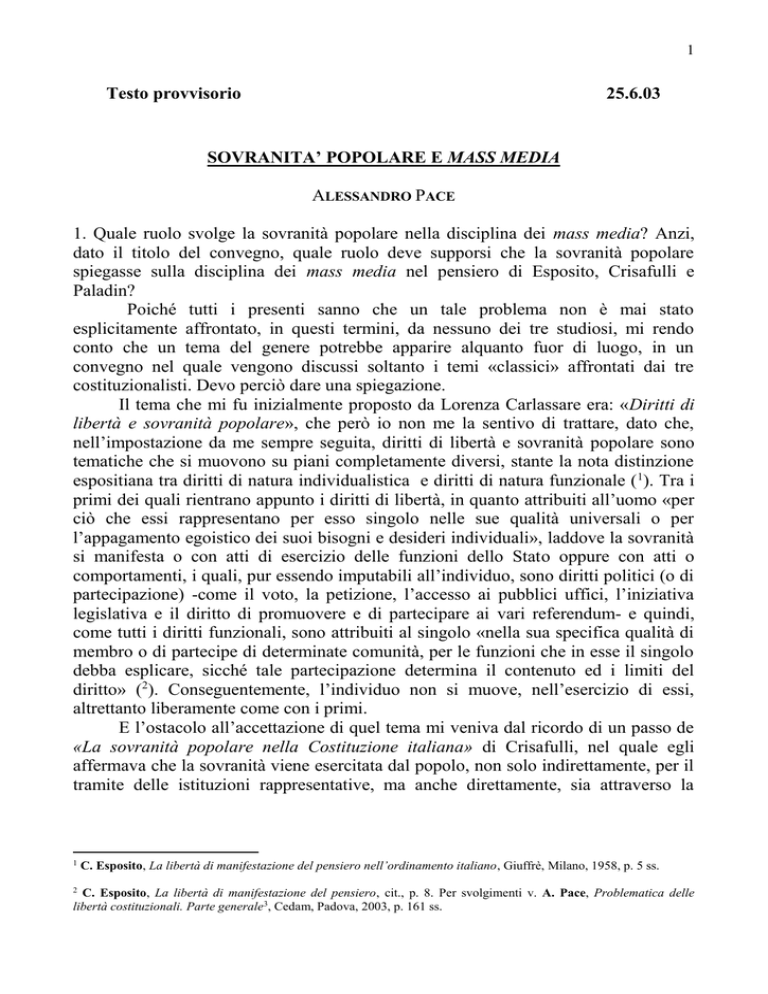
1
Testo provvisorio
25.6.03
SOVRANITA’ POPOLARE E MASS MEDIA
ALESSANDRO PACE
1. Quale ruolo svolge la sovranità popolare nella disciplina dei mass media? Anzi,
dato il titolo del convegno, quale ruolo deve supporsi che la sovranità popolare
spiegasse sulla disciplina dei mass media nel pensiero di Esposito, Crisafulli e
Paladin?
Poiché tutti i presenti sanno che un tale problema non è mai stato
esplicitamente affrontato, in questi termini, da nessuno dei tre studiosi, mi rendo
conto che un tema del genere potrebbe apparire alquanto fuor di luogo, in un
convegno nel quale vengono discussi soltanto i temi «classici» affrontati dai tre
costituzionalisti. Devo perciò dare una spiegazione.
Il tema che mi fu inizialmente proposto da Lorenza Carlassare era: «Diritti di
libertà e sovranità popolare», che però io non me la sentivo di trattare, dato che,
nell’impostazione da me sempre seguita, diritti di libertà e sovranità popolare sono
tematiche che si muovono su piani completamente diversi, stante la nota distinzione
espositiana tra diritti di natura individualistica e diritti di natura funzionale ( 1). Tra i
primi dei quali rientrano appunto i diritti di libertà, in quanto attribuiti all’uomo «per
ciò che essi rappresentano per esso singolo nelle sue qualità universali o per
l’appagamento egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali», laddove la sovranità
si manifesta o con atti di esercizio delle funzioni dello Stato oppure con atti o
comportamenti, i quali, pur essendo imputabili all’individuo, sono diritti politici (o di
partecipazione) -come il voto, la petizione, l’accesso ai pubblici uffici, l’iniziativa
legislativa e il diritto di promuovere e di partecipare ai vari referendum- e quindi,
come tutti i diritti funzionali, sono attribuiti al singolo «nella sua specifica qualità di
membro o di partecipe di determinate comunità, per le funzioni che in esse il singolo
debba esplicare, sicché tale partecipazione determina il contenuto ed i limiti del
diritto» (2). Conseguentemente, l’individuo non si muove, nell’esercizio di essi,
altrettanto liberamente come con i primi.
E l’ostacolo all’accettazione di quel tema mi veniva dal ricordo di un passo de
«La sovranità popolare nella Costituzione italiana» di Crisafulli, nel quale egli
affermava che la sovranità viene esercitata dal popolo, non solo indirettamente, per il
tramite delle istituzioni rappresentative, ma anche direttamente, sia attraverso la
1
2
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 1958, p. 5 ss.
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 8. Per svolgimenti v. A. Pace, Problematica delle
libertà costituzionali. Parte generale3, Cedam, Padova, 2003, p. 161 ss.
2
funzione elettorale e gli istituti di democrazia diretta, sia attraverso «l’esplicazione
delle libertà politiche e di talune libertà civili fondamentali da parte dei cittadini» (3).
In un secondo momento, rileggendo quel saggio, mi sono però convinto che «il
rilievo del nesso funzionale che unisce tali libertà ai diritti politici»(4) non fosse, per
Crisafulli, tale da pregiudicare la natura individualistica dei diritti di libertà. Mi è
parso cioè che si possa ben sostenere che Crisafulli, alludendo a quel nesso,
intendesse sottolineare il ruolo che i diritti di libertà svolgono come precondizioni per
un efficace esercizio dei diritti politici. In altre parole, secondo questa lettura, le
libertà civili sarebbero, per Crisafulli, le «ancelle» dei diritti politici, come un tempo
si disse che la proprietà e/o i diritti politici sarebbero le «ancelle» della libertà.
Anzi, in un’impostazione più complessa ma anche più realistica dei reciproci
rapporti tra diritti, ci si potrebbe spingere anche più in là, e si potrebbe addirittura
sostenere che i diritti di libertà e i diritti politici si pongono di fatto come
reciprocamente serventi, in una rete di situazioni giuridiche soggettive anche
strutturalmente diverse tra loro, ma tutte di fatto convergenti alla più piena
realizzazione, nel nostro Paese, di una democrazia liberale.
E che a questo approdo si possa giungere pur partendo dal pensiero di
Crisafulli, mi sembra confermato, da quel suo rilievo, presente anch’esso nel saggio
sulla sovranità popolare, secondo il quale nella libertà di stampa, di riunione e di
associazione (le tre libertà civili evocate da Crisafulli come strumenti per l’esercizio
della sovranità), l’interesse tutelato è bensì «essenzialmente individuale, ma in
moltissimi casi, al tempo stesso collettivo, e collettivo-politico, proprio cioè del
singolo in quanto membro della collettività popolare (…), similmente (…) a quanto si
riscontra per i diritti politici propriamente detti…». «Certo -sottolineava ancora, nello
stesso saggio, Crisafulli-, una differenza permane tuttavia tra questi ultimi e quei
diritti di libertà che occupano una posizione intermedia tra le libertà civili e le
politiche: giacché, nei primi, l’interesse protetto dalla norma è sempre,
originariamente e necessariamente, un interesse collettivo, proprio di ciascun
cittadino in quanto tale (un interesse politico), mentre, nei secondi, l’interesse può
essere (e di fatto, specie modernamente, è il più delle volte) della medesima natura,
ma può anche essere meramente individuale, e più spesso collettivo-privato o di
categoria o comunque non politico, perché non inerente alla posizione di membro
della collettività popolare del cittadino, titolare del rispettivo diritto di libertà
costituzionalmente garantito». E ciò, anche più decisamente, verrà ribadito dieci anni
più tardi, nel saggio sulla «Problematica della “libertà d’informazione”», là dove si
sottolinea come la libertà di espressione, ancorché sia essenzialmente un diritto di
libertà, realizzi «un modo indiretto di partecipazione dei cittadini alla formazione
degli indirizzi politici e quindi (…) un modo ancor più indiretto (e approssimativo) di
partecipazione all’esercizio del potere» (5).
3
V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (1954), ora in Id., Stato, popolo, governo. Illusioni e
delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, p. 119. Corsivo mio.
4
V. Crisafulli, La sovranità popolare, cit., p.129.
5
V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», ne Il politico, 1964. p. 292.
3
Per ciò che riguarda Esposito, è addirittura scontato -dopo quanto si è premesso
a proposito della sua distinzione tra diritti individuali e diritti funzionali- che il
collegamento tra sovranità popolare e diritti di libertà non è tale (né mai poteva esser
tale) da funzionalizzare i diritti di libertà. Ed infatti, se, da un lato, in un notissimo
passo del «Commento all’art. 1 della Costituzione», egli rilevava che occorre, perché
la democrazia possa concretamente realizzarsi, che il popolo «possa riunirsi e
formare associazioni per discutere liberamente ogni atto dei governanti, possa
iscriversi a partiti che influiscono sulle direttive di vita dello Stato, e che esistano
libertà di stampa e libere elezioni degli organi del governo e libere decisioni popolari,
e che siano esclusi dal voto solo gli incapaci, e che le decisioni degli organi supremi
siano pubbliche e possibilmente prese innanzi al popolo in sedute pubbliche» (6) (e
analogamente si esprimeva nel saggio sui partiti politici)(7), d’altro lato, nel saggio
sulla «Libertà di manifestazione del pensiero», Esposito era addirittura lapidario nel
sottolineare che «non la democraticità dello Stato ha per conseguenza il
riconoscimento di quella libertà (di manifestazione del pensiero: n.d.r.), sicché possa
determinarne la funzione e i limiti, ma che le ragioni ideali del riconoscimento di
quella libertà (e cioè del valore della persona umana) portano tra le tante conseguenze
anche alla affermazione dello Stato democratico»(8).
Semmai, ciò che non convince, nel pensiero di Esposito, è la collocazione, tra i
diritti funzionali, della libertà di associarsi in partiti politici (9). Egli infatti
considerava «il concorso alla determinazione “della politica nazionale”» come se
fosse un limite intrinseco e finalistico del diritto riconosciuto dall’art. 49 Cost.,
laddove, a ben vedere, esso costituisce solo una specificazione del contenuto di tale
diritto, che vale a differenziarlo dal diritto riconosciuto dall’art. 18 Cost.(10). Questa,
però, è una notazione marginale che non incide sul problema del rapporto
intercorrente, nel pensiero di Esposito, tra diritti di libertà ed esercizio della sovranità
popolare.
Quanto a Paladin, dubbi relativi ad una sua eventuale impostazione in termini
funzionali dei diritti di libertà in ragione della sovranità popolare, non hanno (né
avevano) alcuna ragion d’essere, essendo nota la nettissima preferenza di Livio per la
concezione individualistica (11).
C. Esposito, Commento all’art. 1 della Costituzione, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, p.
10 s.
6
7
C. Esposito, I partiti nella Costituzione italiana, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova, 1954, p. 227.
8
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 12.
9
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 8.
10
In questo senso v. già A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, cit., p. 85.
L. Paladin, Libertà di pensiero e libertà d’informazione. Le problematiche attuali, in in Quad. cost., 1987, p. 13,
successivamente pubblicato anche in Associazione italiana dei costituzionalisti, Libertà di pensiero e mezzi di
diffusione, Atti del convegno di Padova (16-18 ottobre 1986), Cedam, Padova, 1992.
11
4
Ma, una volta acquisita la certezza che, pur parlando dei diritti di libertà come
precondizioni dell’esercizio della sovranità popolare, non avrei tradito il pensiero dei
tre studiosi, mi venne anche l’idea -subito accolta da Lorenza- di specificare
ulteriormente il tema del rapporto tra sovranità popolare e diritti di libertà,
restringendolo ai mass media, per verificare se, dal pensiero dei tre costituzionalisti,
fosse desumibile una qualche risposta al problema delle conseguenze sul concreto
esercizio della sovranità popolare, derivanti dalla concentrazione, nelle mani di pochi
soggetti, dei mezzi di comunicazione di massa.
2. Il primo rilievo da fare a proposito dei mass media, è che sia Esposito sia
Crisafulli, pur muovendosi in un’ottica liberale (ma con notevoli diversità di
sfumature), ritenevano entrambi legittimo l’allora vigente monopolio radiotelevisivo,
poiché entrambi partivano dall’idea che il regime monopolistico radiotelevisivo non
potesse spiegare conseguenze pregiudizievoli sulla libertà di espressione, e che
comunque fosse preferibile un monopolio pubblico ad un monopolio privato.
Esposito, nel saggio su «La libertà di manifestazione del pensiero», sosteneva,
infatti, con specifico riferimento al mezzo radiotelevisivo, che il legislatore, nella
disciplina dei mezzi, incontra un solo limite assoluto (e cioè che l’«uso di un mezzo
in generale» non sia riservato «solo a manifestazioni di un determinato contenuto») e
per il resto solo prescrizioni indicative, nel senso cioè, che -dovendo la disciplina del
mezzo essere adeguata al fine- il legislatore debba evitare misure preventive, censure
e condanne là dove non strettamente necessarie (12). Né, a tal riguardo, può essere
dimenticata quella significativa affermazione, contenuta in una nota a pie’ di pagina,
secondo la quale «l’essenza di questa libertà non è che il singolo abbia possibilità di
uso dei mezzi di diffusione del pensiero, ma che egli possa liberamente manifestare
ciò che pensa, con i mezzi a propria disposizione»(13). Una frase, questa, che
Crisafulli, nella sua veste di estensore, avrebbe richiamato e significativamente
sviluppato nella sent. n. 105/1972: «Naturalmente, che “tutti” abbiano diritto di
manifestare il proprio pensiero “con ogni mezzo”, non può significare che tutti
debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di
diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la
giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi
eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla
esigenza di assicurare l’armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela
di altri interessi costituzionalmente apprezzabili, giusta i criteri di cui questa Corte ha
fatto applicazione in varie occasioni (sentt. n. 59 /1960, n. 48/1964, n. 11/1968)» (ma
v. nello stesso senso anche le sentt. nn. 225/1974 e 94/1977).
Invece, per ciò che riguarda la stampa in genere, Esposito riteneva che in quel
settore «vi sia e debba permanere l’iniziativa economica privata», ciò discendendo
dal divieto di autorizzazioni e censure e dall’obbligo di rendere note le fonti di
12
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 24.
13
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 27 nota 58.
5
finanziamento(14). Il che però, a ben vedere, implicava una qualche eccessiva -e non
condivisibile- conseguenza per la stampa scientifica, la cui ammissibilità in mano
pubblica (ancor oggi riconosciuta) dovrebbe allora -ma irragionevolmente- ritenersi
incostituzionale.
Dal canto suo, nel saggio sulla libertà d’informazione (del 1964), Crisafulli
offriva agli studiosi una notevolissima varietà di spunti di riflessione. In primo luogo,
sosteneva l’immutabilità della natura individualistica della libertà di espressione,
posto che «un’attività non cambia natura né qualificazione giuridica a seconda dei
modi in cui si esercita (…) attraverso certi mezzi, invece che attraverso altri»(15).
In secondo luogo, quanto alla natura (pubblica o privata) del mezzo di
diffusione (quale che esso sia), Crisafulli negava, «almeno in termini assoluti e senza
le necessarie distinzioni, che della nozione liberale faccia parte integrante necessaria
il riconoscimento, con la libertà della manifestazione, anche della libertà (economica)
di impresa». «Quel che veramente e soltanto importa -egli sottolineava- è che la
manifestazione sia libera nel contenuto, giuridicamente possibile a chiunque, e come
tale garantita dal diritto positivo»(16).
«In linea di massima -rilevava conseguentemente Crisafulli-, è lecito affermare
che, anche nel silenzio dei testi costituzionali, la garanzia della libertà di espressione
deve comprendere quella del libero uso dei mezzi, non già di escluderne una
disciplina differenziata, e meno che mai di imporne l’appartenenza e la gestione
privata, quanto nel senso che debba esserne assicurata la libera utilizzazione in
condizioni di eguaglianza»(17). «Non è detto, infatti, che il sistema privatistico sia
quello che meglio permette di raggiungere un tale risultato, essendo circostanza
risaputa che proprietà dei beni strumentali destinati alla diffusione e libertà di
impresa per il loro esercizio sono, in realtà, privilegio di pochi (e di pochi e potenti
gruppi economici, non certo di singoli individui o di libere associazioni, ove si
prescinda dal caso dei grandi partiti e di talune organizzazioni sindacali). D’altro
canto, nulla si oppone alla configurabilità dei mezzi di diffusione come pubblici
servizi né alla sottoposizione di taluni tra essi al regime dei pubblici servizi in mano
pubblica, purché, beninteso, il mezzo sia legalmente (e potenzialmente) a
disposizione di tutti»(18).
Infine, con riferimento ai relativi doveri dello Stato, Crisafulli distingueva il
dovere negativo (comune ai privati) -consistente nel «non frapporre ostacoli alla
libera diffusione, e alla libera ricerca e recezione, delle idee e delle notizie»- dagli
eventuali doveri positivi (specifici dello Stato). Premessa la distinzione tra diffusione
di opinioni e diffusione di notizie, egli faceva rientrare, tra i doveri positivi, la
14
C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, cit., p. 29.
15
V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», cit., p. 294.
16
V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», cit., p. 296.
17
V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», cit., p. 297.
18
V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», cit., p. 297 s..
6
possibilità per il legislatore di imporre alle imprese giornalistiche e radiotelevisive,
ancorché in mano privata, l’obbligo di diffondere integralmente notiziari di Stato, e
cioè «comunicati del governo e degli organi di vertice della pubblica
amministrazione, compresi quelli preposti alla pianificazione e programmazione
economica; resoconti “autorizzati” dei dibattiti parlamentari, smentite ufficiali a
notizie precedentemente pubblicate ecc.»(19).
Era ovviamente impensabile, in quell’epoca, che la proprietà del gruppo
dominante nel settore televisivo privato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
potessero, trent’anni dopo, identificarsi nella stessa persona fisica.
3. Nettamente diversa è l’impostazione degli stessi problemi seguita da Paladin. Il
primo ampio contributo di Livio in materia radiotelevisiva è il saggio introduttivo del
volume collettaneo «La libertà d’informazione» del 1977, apparso nella bella collana
di studi comparatistici curata dal compianto Giuseppino Treves.
Diversamente da Esposito e Crisafulli, Paladin fa perciò il suo esordio in
materia quando già vi erano state svariate sentenze della Corte costituzionale in
materia di libertà di stampa e in materia radiotelevisiva: tra quest’ultime, quelle
dichiarative dell’incostituzionalità sia delle cd. «modalità d’esercizio» del monopolio
radiotelevisivo statale e della riserva statale delle trasmissioni provenienti dall’estero
(sent. n. 225/1974), sia del monopolio radiotelevisivo statale via cavo in ambito
locale (sent. n. 226/1974), sia infine del monopolio radiotelevisivo statale via etere in
ambito locale (sent. n. 202/1976).
Al di là delle sue preferenze personali, era pertanto lo stesso contesto politicogiurisprudenziale a determinare un approccio ai problemi, diverso da quello dei suoi
(e miei) due maestri.
Infatti, tanto in quel suo primo saggio, quanto nei successivi, Livio è sempre
stato favorevole alla disciplina esclusivamente privatistica dell’impresa
giornalistica(20); è stato favorevole, in un primo tempo, al monopolio radiotelevisivo
statale, ma solo in un primo tempo e solo «nella misura in cui lo impongano ragioni
di carattere tecnico»(21); è stato contrario ad una mitizzazione sia del ruolo
dell’ordine dei giornalisti (22), sia della cd. struttura democratica dei quotidiani come
garante della «completezza ed obiettività del panorama delle informazioni fornite»,
quale «auspicata» negli anni ’70 dalla FNSI(23); era contrario all’applicazione della
19
V. Crisafulli, Problematica della «libertà d’informazione», cit., p. 301 s..
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione nell’ordinamento giuridico italiano, in AA.VV., La
libertà d’informazione, a cura di L. Paladin, Utet, Torino, 1977, p. 52.
20
21
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., pp. 37 e 53.
22
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., p. 30.
23
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., p. 58.
7
nozione di «servizio pubblico essenziale» ai mass media, quali che essi fossero (24);
credeva profondamente nel cd. pluralismo esterno e nella pluralità delle fonti
informative (25). Per contro, era profondamente critico del cd. pluralismo interno,
considerandolo anzi come addirittura antitetico ad un’informazione obiettiva e
imparziale(26).
La scelta di campo di Paladin, diversamente da Esposito e da Crisafulli, era
perciò essenzialmente contraria al monopolio statale in materia radiotelevisiva, e
nettamente favorevole alla presenza in tale settore delle imprese radiotelevisive
private, al punto di lamentare, ancora nel 1999, che la sent. n. 148/1981 fosse stata di
rigetto e non di accoglimento parziale della q.l.c. del monopolio a livello
nazionale(27). Non era però a tal punto favorevole alle imprese televisive private da
sostenere che «i mass media rimangano del tutto disponibili, sul piano costituzionale,
da parte dell’iniziativa economica privata».
Questo punto risulta ben chiaro già nella relazione al convegno dell’AIC del
28
1986( ), ma lo è, se può dirsi, ancor di più, nella relazione al convegno fiorentino del
1993, nel quale Paladin ipotizzava bensì la cessione di una delle tre reti televisive
Rai, ma sosteneva anche la necessità, per la società concessionaria del servizio
pubblico, non solo di conservare, ma addirittura di aumentare il canone e, soprattutto,
di «riacquistare una sua legittimazione attraverso una riforma, la quale quanto meno
incida sul consiglio d’amministrazione, sostituendolo con forme più neutrali di
governo del servizio pubblico» (29).
Ancorché Paladin, nell’affrontare questi temi abbia sempre mantenuto quel suo
distacco scientifico che poteva esser scambiato per freddezza, non è però
assolutamente sostenibile che egli approvasse la situazione venutasi a creare, sul
versante privato, dopo i cd. decreti Berlusconi del 1984-1985 e soprattutto dopo la cd.
legge Mammì del 1990. E ciò è tanto vero, che nella relazione all’incontro di studio
patavino del 1999, egli condannava giustamente tale legge non solo per l’abnorme
numero di reti nazionali di cui essa aveva consentito il controllo da parte di uno
stesso soggetto (il 25 % delle reti e comunque non più di tre), ma anche per il fatto
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., p. 50; Id., Stato e problemi delle diffusioni
radiotelevisive private, in Dir.radiodiff. telecom., 1981, p. 13 s.; Id., Libertà di pensiero e libertà d’informazione, cit.,
p. 14.
24
25
L. Paladin, Libertà di pensiero e libertà d’informazione, cit., p. 21.
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., p. 60; Id., Libertà di pensiero e libertà
d’informazione, cit., p. 21.
.
27
L. Paladin, Quale pluralismo televisivo dopo le sentenze della Corte costituzionale? In AA.VV., La comunicazione
del futuro e i diritti delle persone, Atti dell’incontro di studio del 16 marzo 1999, a cura di L. Carlassare, Cedam,
Padova, 2000, p. 18.
26
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., p. 60; Id., Libertà di pensiero e libertà
d’informazione, cit., p. 21.
28
L. Paladin, Perché i costituzionalisti si occupano di televisione, AA.VV., Rapporto ’93 sui problemi giuridici della
radiotelevisione in Italia, Giappichelli, Torino, 1994, p. 391.
29
8
che, per arrivare a questo risultato, la legge Mammì avesse falsamente ipotizzato
l’esistenza di dodici reti televisive, laddove «(a) tutto concedere -rilevava esattamente
Livio- le reti erano nove»(30). D’altra parte, i limiti proprietari previsti da tale legge,
con riferimento a quanto deciso nella sent. n. n. 826/1988, erano, per Livio,
«intrinsecamente inadeguati nella prospettiva della Corte, sia perché valevano a
stabilizzare la posizione dominante già esistente negli anni ’80 anziché contenerla e
ridimensionarla, sia perché, di riflesso, assegnavano alla Fininvest un esorbitante
vantaggio nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità».
Per sfatare ogni dubbio a proposito di quello che per Paladin avrebbe dovuto
essere il ruolo dei privati, è comunque opportuno tracciare un profilo sintetico del suo
pensiero in proposito.
In primo luogo, è bensì vero che, nel manuale di «Diritto costituzionale», egli
affermava esplicitamente che l’art. 21 comma 1 Cost. tutelerebbe omisso medio «se
non altro, il libero uso dei mezzi primari» (31) -e quindi finiva per affermare che tale
norma riconoscerebbe anche il diritto all’uso dei mezzi ( 32) (contro quanto
esplicitamente statuito, e mai disatteso, dalla Corte costituzionale nella citata sent. n.
105/1972, relatore Crisafulli)-; tuttavia, è altrettanto vero che nello stesso manuale,
di lì a qualche pagina, Paladin lamenta il mancato rispetto, da parte del legislatore,
della sentenza n. 202/1976, là dove questa «postulava “la necessità dell’intervento
del legislatore”»(33). In altre parole, anche Paladin lamentava la gravissima e
colpevole mancanza, da parte del legislatore, di quel previo intervento normativo che
aveva invece reso indolore l’abbandono del monopolio statale in Germania, in
Francia e in Spagna…
In secondo luogo, mi sembra davvero impensabile che Livio, in contrasto con
quanto aveva scritto a proposito dell’art. 3 Cost., abbia potuto sostenere che il libero
uso dei mezzi primari possa avvenire senza rispettare il principio di eguaglianza. Ma
se questo è vero, ciò significa altresì che, anche per Paladin, era comunque necessaria
una disciplina legislativa che previamente assicuri a tutti i possibili richiedenti (le
radiofrequenze) un doveroso pari trattamento ex art. 97 Cost. Il che è tanto più vero
se si rifletta che il settore radiotelevisivo che utilizza le radiofrequenze via etere
terrestre (quello cioè di cui Paladin si occupava) è tecnicamente un settore chiuso,
tuttora sottoposto a regime di concessione.
30
L. Paladin, Quale pluralismo televisivo dopo le sentenze della Corte costituzionale? , cit., p. 20.
31
L. Paladin, Diritto costituzionale3, Cedam, Padova, 1998, p. 629.
L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., p. 629, e , già prima, Id., Libertà di pensiero e libertà d’informazione, cit., p.
17. Per la verità Paladin argomenta sulla base della identità della manifestazione con la divulgazione, che però allude ad
un problema diverso e più ristretto.
32
33
L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., p. 635. Nel precedente saggio del 1977 (Libertà di pensiero e libertà
d’informazione, cit., p. 24 s.), Paladin riteneva bensì (giustamente) inapplicabile alla specie il rilievo di Esposito
secondo il quale «le libertà giuridiche non richiedono una specifica regolamentazione, ma astensione dalla
regolamentazione»; ciò non di meno, con specifico riferimento ai mezzi di diffusione, egli affermava che l’intervento
del legislatore «appare utile, se non addirittura indispensabile».
9
In terzo luogo, pur affrontando il problema dell’assetto complessivo del
sistema da un’angolatura inconsueta -e cioè affermando che la logica della
radiotelevisione, anche pubblica, non è tanto «la logica dell’informazione, anche se il
momento informativo ha la sua essenziale importanza», ma è piuttosto «la logica del
“divertissement”»(34)-, Paladin riteneva che «il pluralismo senza aggettivi giova ad
escludere che vi siano strumenti o centri dotati di troppo potere nel campo delle
trasmissioni radiotelevisive, i quali condizionino comunque l’opinione pubblica,
anche al di fuori del campo elettorale, della politica partitica e via discorrendo». E
così concludeva: «E’ questo che rende il pluralismo un valore da difendere, al di là di
ciò che diceva, in una logica forse un po’ troppo stretta, la sentenza del 1981. Ed è un
valore comunque costituzionale, perché fondato ad un tempo sia sull’art. 41 sia
sull’art. 21, guardando non tanto al secondo comma, bensì al primo comma
dell’articolo stesso. Là dove l’art. 21 afferma che tutti hanno il diritto di manifestare
il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, la sua stessa logica impone che non
vi siano mezzi preclusi in partenza, o per ragioni giuridiche o per ragioni
economiche, a questo concorso -non dirò generale perché sarebbe un’illusione- ma il
più ampio possibile»(35).
Ovviamente, non è però soltanto del divertissement quotidiano che Paladin si
preoccupava. Anzi, a mio avviso, l’importanza data da Livio al divertissement era
volutamente provocatoria e nascondeva, in realtà, ben più gravi preoccupazioni
istituzionali. Altrimenti, nell’incontro di studio del 1999 non avrebbe detto,
riferendosi alla sent. n. 148/1981 -alla decisione della quale egli aveva concorso
come giudice e il suo maestro Crisafulli come difensore della Rai(36)-, che di essa
«ciò che rimane sono alcuni passi centrali della motivazione, nei quali si insiste sul
contesto socio-economico in cui l’emittenza televisiva privata era ed è destinata a
svilupparsi; e dunque si avverte il pericolo di lasciare ad un soggetto privato,
operante in regime di monopolio o oligopolio, una potenziale capacità di influenza
incompatibile con le regole del sistema democratico»(37). Una frase, questa, che, nella
sostanza, sottende la stessa preoccupazione che ventidue anni prima gli aveva fatto
affermare che «senza una libera informazione non potrebbe neppure fondarsi ed
esistere una democrazia del tipo in cui si colloca l’Italia, perché il voto non sarebbe
sostanzialmente libero, il controllo sugli organi di governo diverrebbe impraticabile,
la vita politica stessa risulterebbe svuotata dei suoi contenuti essenziali» (38).
34
L. Paladin, Perché i costituzionalisti si occupano di televisione, cit., p.392.
35
L. Paladin, Perché i costituzionalisti si occupano di televisione, cit., p.392.
36
Con riferimento al ruolo svolto da Crisafulli nel giudizio conclusosi con la sent. n. 148/1981, ho ritenuto interessante
pubblicare (anche per i profili dottrinali affrontati), in calce a questa mia relazione, la lettera che, nell’accettare
l’incarico defensionale conferitogli dalla Rai, Crisafulli indirizzò all’allora direttore degli Affari legali della Rai, per
illustrare il suo punto di vista sulle questioni sollevate nell’ordinanza del Pretore di Roma.
37
L. Paladin, Quale pluralismo televisivo dopo le sentenze della Corte costituzionale? , cit., p. 18.
38
L. Paladin, Problemi e vicende della libertà d’informazione, cit., p.3 s.
10
E così, nelle parole del più giovane dei tre costituzionalisti che oggi onoriamo,
ritornavano, forse inavvertitamente, le parole che Esposito aveva pronunciato per
primo nel 1948 (39), che Crisafulli aveva richiamate nel 1954(40) e che lui avrebbe
fatte proprie riportandole nel manuale. E cioè che la sovranità popolare «va
concepita, a questa stregua, come la risultante dell’esercizio di tutti i diritti propri dei
cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni alle quali appartengono in base all’art.
2 Cost. (o come soggetti agenti per il tramite delle formazioni medesime). Sicché i
poteri in questione concernono, ad un tempo, l’ “investitura”, la “critica”, il
“controllo”, la “direttiva”, che i cittadini sono posti in grado di effettuare, valendosi
di tutti i mezzi prefigurati a tali scopi dalla Costituzione»(41).
4. Mi avvio alla conclusione. Nelle battute finali del suo intervento al convegno
fiorentino del 1993 -significativamente intitolato «Perché i costituzionalisti si
occupano di televisione»- Paladin avvertiva, con riferimento alla tutela del pluralismo
e agli artt. 21 e 41 Cost.: «Naturalmente quando si pongono alla base del discorso
valori costituzionali di questo genere, così larghi e così generici come quello della
iniziativa economica privata e quindi della libera concorrenza, o come quello di
libertà di manifestazione del pensiero, si rendono necessarie delicatissime opere di
bilanciamento, che spetteranno come sempre in prima battuta al legislatore, in ultima
battuta -se sarà il caso- alla Corte costituzionale. Ma proprio questo mi rende
ottimista, perché vale a dimostrare che la legge Mammì, il regolamento di attuazione,
il sepolto decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni non sono la fine della
storia, sono soltanto una tappa a cui moltissime altre si aggiungeranno nel futuro: così
legittimando anche, per quel poco che può loro competere, l’ingresso in questo
campo dei costituzionalisti e della scienza del diritto costituzionale».
Io mi permetterei di aggiungere, proprio con riferimento alle ulteriori
preoccupazioni sollevate da Paladin sia nel saggio introduttivo del volume collettaneo
del 1977, sia nell’intervento al convegno di studio tenuto qui a Padova nel 1999, che i
valori che vengono in gioco nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa
sono anche quelli sottesi all’art. 1 comma 2 Cost., e quindi anche i valori ai quali si
richiamano le norme costituzionali in tema di diritti politici (artt. 48, 49, 50, 51, 71,
75 e 138 Cost.).
I mass media, come risulta chiaro dal pensiero di tutti i tre gli studiosi che qui
affettuosamente ricordiamo e onoriamo, precondizionano indiscutibilmente
l’esercizio dei diritti politici. Quindi la loro disciplina -o la loro «non» disciplina- può
avere un effetto determinante sulla politica nazionale e sugli esiti delle consultazioni
elettorali e referendarie. Si chiedeva Paladin, nell’intervento del 1999: «Fino a che
punto contano i media televisivi nel condizionare il voto? Reggono ancora i calcoli di
Livolsi e Volli, che nel 1995 valutavano tale incidenza in una misura oscillante tra il
39
C. Esposito, Commento all’art. 1 della Costituzione, cit., p. 11.
40
V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana , cit., p. 122.
41
L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., p. 272.
11
5 e il 10 %?»(42). Ebbene, quand’anche l’incidenza fosse solo del 5 %, è evidente che,
con l’introduzione del sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, la capacità di
condizionamento del 5 % dei votanti rappresenta un fattore decisivo per il successo o
meno nelle elezioni(43).
Ed è perciò che, contrariamente a Livio, io non sono affatto ottimista, anche se
sono d’accordo con lui sul rilievo che ineluttabilmente i costituzionalisti dovranno
continuare ad occuparsi di televisione. Non sono affatto ottimista perché è bensì vero
quel che diceva Paladin, e cioè che la legge Mammi, la legge Maccanico e così via
non sono - grazie a Dio!- «la fine della storia», ma è anche vero che ogni legge
approvata dal Parlamento in materia televisiva è peggiore della precedente, come
dimostra il d.d.l. Gasparri.
Del resto, se, alla fine degli anni ’70, le forze politiche avevano già contratto
tali «compromissioni» con gli interessi economico-imprenditoriali, da non riuscire a
varare una legge sull’emittenza radiotelevisiva privata, a fortiori è lecito essere
pessimisti oggi. E’ infatti irrealistico, oggi come oggi, ipotizzare l’approvazione di
una legge che, in aggiunta alla (o in sostituzione della) normativa sulla cd. par
condicio -la cui scarsa efficacia è sotto gli occhi di tutti-, riduca effettivamente la
possibilità, attraverso i mass media, di condizionare subdolamente la volontà
dell’elettore; è del pari irrealistico, oggi come oggi, ipotizzare l’approvazione di una
legge che disciplini seriamente il conflitto d’interessi dei titolari degli organi di
governo e dei parlamentari; ed è infine ancor più irrealistico ipotizzare
l’approvazione di una legge che preveda l’ineleggibilità di chi - essendo il legale
rappresentante di un’emittente privata o pubblica, ovvero detenendo il pacchetto di
maggioranza di una società privata titolare di una concessione radiotelevisiva a
livello nazionale o locale- sia in grado di esercitare, rispettivamente, sulle elezioni
nazionali e locali, «una capacità di influenza incompatibile con le regole del sistema
democratico» (sent. n. 148/1981) (44). Eppure, dovrebbe essere intuitiva la necessità
42
L. Paladin, Quale pluralismo televisivo dopo le sentenze della Corte costituzionale? , cit., p. 17.
Il vero è che l’attuale capacità di condizionamento delle trasmissioni televisive sugli elettori è di gran lunga più
rilevante di quanto Paladin potesse allora immaginare, dando per buoni i dati del 1995. Si legge infatti nel capitolo
dedicato a «Comunicazione e cultura» del recentissimo 36° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, relativo
all’anno 2002, elaborato dal Censis (pp. 587-642 del volume): «La tribù principale che troviamo tra i Poveri di media,
invece, è rappresentata da quanti usano abitualmente la Tv, la radio e il cellulare, che arriva a coprire il 22,1% del
gruppo. Poco sotto si trova, però, la Tribù di “Tv più cellulare”, che si fa fatica a distinguere dai Marginali, e che, col
suo 17,9%, è composta da oltre tre milioni di persone. Visto che la tribù di quanti si accostano solamente alla Tv si
avvicina ai cinque milioni di componenti, possiamo dunque affermare che in Italia ci sono otto milioni di persone che
sono completamente dipendenti dalla televisione dal punto di vista comunicativo».
43
44
A mio avviso, la previsione di tale ineleggibilità (per ciò che riguarda la proprietà della maggioranza del pacchetto
azionario di una società titolare di concessione televisiva di rilevante interesse economico) già esiste nel nostro sistema
e va rinvenuta nell’art. 10, comma 1 n. 3, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (a proposito del quale v. A. Pace, Ineleggibilità,
incompatibilità e conflitto di interessi dei parlamentari e dei titolari di organi di governo, in S. Cassese e B.G.
Mattarella [cur.], Democrazia e cariche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 53 ss.). Tale disposizione sancisce
infatti l’ineleggibilità parlamentare di «coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese
private risultino vincolati con lo Stato (…) per concessioni (…) di notevole entità economica ecc. ecc.». Orbene, la
locuzione «in proprio», sistematicamente interpretata nel combinato disposto del n. 1 con il successivo n. 3, non può
non alludere anche a chi sia proprietario della maggioranza del pacchetto azionario della società concessionaria. Se non
fosse così (e cioè se non si equiparasse il proprietario della maggioranza delle azioni al proprietario dell’impresa
individuale), non si spiegherebbe come mai, mentre sono ineleggibili i soggetti indicati nel n. 3, e cioè «i consulenti
12
di tali leggi, se la sovranità popolare ha un senso e se titolari di tale conclamata
sovranità sono tutti gli elettori, anche quelli -che ammontano a ben oltre il 20 %!- la
cui unica fonte d’informazione e di conoscenza è data dalla televisione(45).
Questi problemi -già di per sé gravissimi e la cui mancata risoluzione è esiziale
per il concreto, «consapevole» esercizio della sovranità da parte di tutto il popolo
italiano- rischiano comunque di essere non già superati, ma ulteriormente complicati
dai nuovi problemi che verranno alla luce seguito dell’ acquisizione di Telepiù e di
Stream da parte del gruppo Murdoch, e della conseguente loro fusione in Sky Italia.
Problemi che sono rilevanti sotto il profilo del rapporto tra sovranità popolare e mass
media già per un solo e semplice fatto: e cioè che, mentre finora i gruppi in posizione
dominante nel settore televisivo sono stati italiani (Rai e Mediaset) -e quindi
direttamente o indirettamente hanno servito «interessi politici» italiani, buoni o meno
buoni che essi fossero-, a partire dal prossimo 31 luglio il panorama potrebbe
cambiare sensibilmente con l’irradiazione dei programmi satellitari del gruppo
Murdoch. Il quale già «fa politica» nel Regno Unito e negli S.U., e che potrebbe, in
Italia, fare altrettanto.
Postilla
Avutane l’autorizzazione dall’attuale direttore della Direzione Affari legali della RAIRadiotelevisione Italiana S.p.a., avv. Rubens Esposito -che sentitamente ringrazio-, pubblico, qui di
seguito, per la sua importanza dottrinale oltre che storica, la lettera inviata dal prof. Vezio
Crisafulli all’avv. Attilio Zoccali, allora direttore degli Affari legali RAI, in data 29 dicembre 1980,
e cioè subito dopo il conferimento al prof. Crisafulli dell’incarico di difendere la RAI, dinanzi alla
Corte costituzionale -insieme con Giuseppe Guarino, Paolo Barile, Natalino Irti e al sottoscritto-,
nel giudizio di legittimità costituzionale introdotto dal Pretore di Roma con ordinanza del 18
novembre 1980, definito con la sentenza della Corte costituzionale del 21 luglio 1981, n. 148, alla
quale ripetutamente faccio riferimento nel testo della relazione.
Egregio Avvocato,
legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2»,
sarebbero invece eleggibili le persone indicate al n. 1 della stessa disposizione, che sono poi le persone… con i soldi dei
quali vengono pagate le parcelle dei consulenti, e che pertanto hanno titolo ad interferire, sugli amministratori, a
proposito delle scelte dei consulenti.
A tale tesi non può obiettarsi, coma fa G.E. Vigevani, Stato democratico ed eleggibilità, Giuffrè, Milano,
2001, p. 228 ss., che «la natura eccezionale delle ineleggibilità comporta che tali norme debbano essere tassativamente
fissate dal legislatore e non possano essere estese oltre quanto espressamente previsto dalla legge», perché questo
rilievo vale con riferimento al divieto di analogia, ma non certo a proposito dell’interpretazione sistematica, come
appunto quella da me sopra prospettata. Quanto poi all’altra obiezione, pure formulata da Vigevani, secondo la quale
l’interpretazione da me suggerita solleverebbe perplessità perché essa non fornirebbe «criteri certi che possano fungere
da guida per l’interprete nell’individuazione dei casi di ineleggibilità implicitamente ricavabili dall’art. 10», è facile
replicare che, proprio in applicazione dei criteri restrittivi dettati dalla Corte costituzionale, l’ineleggibilità
sistematicamente desumibile dal combinato disposto dei nn. 1 e 3 va logicamente limitata alla sola ipotesi della
proprietà della maggioranza del pacchetto azionario della società titolare di concessione (che è poi la maggioranza
necessaria e sufficiente per la nomina dei titolari delle cariche sociali).
Per contro, l’ineleggibilità non può logicamente essere estesa all’azionista in posizione di controllo (art. 2359
c.c.) -alla quale allude criticamente Vigevani-, posto che gli effetti derivanti da una siffatta situazione, essendo
derogatori del principio di maggioranza, sono di stretta interpretazione (art. 7 l. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2 commi 6
e 18 l. 31 luglio 1997, n. 249).
45
V. supra la nota 43.
13
come d’accordo, a seguito dei nostri scambi di idee, metto qui di seguito sulla carta, senza
eccessive preoccupazioni di forma e di ordine sistematico, alcune considerazioni suggeritemi da un
attento esame dell’ordinanza del Pretore di Roma che rimette alla Corte costituzionale la questione
di legittimità costituzionale del monopolio radiotelevisivo e degli atti relativi.
* * *
Mi pare sia da rilevare, anzitutto, che -nei suoi termini essenziali, ed a prescindere da aspetti
marginali e residuali e da argomenti sussidiari che non incidono sulla sostanza dei problemi- la
questione sollevata dal Pretore di Roma è la stessa che, nel corso di un ventennio, a partire
dall’anno 1960, è stata periodicamente proposta e riproposta alla Corte costituzionale, ma da questa
-in linea di principio- sempre respinta. Fa eccezione, soltanto in apparenza, la sent. n. 225 del
1974, che (a parte ora la “liberalizzazione” dei c.d. ripetitori di emittenti straniere) si concludeva
formalmente con un dispositivo di illegittimità del monopolio statale, ma non in sé e per sé, bensì
per il modo in cui ne era disciplinato l’esercizio, senza idonee garanzie (come la Corte ritenne) di
apertura al pluralismo politico-sociale della società nazionale; ed è significativo come in quella
occasione la Corte si fosse astenuta dall’estendere ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria
di illegittimità alla legge di proroga della convenzione con la RAI-TV frattanto intercorsa (la cui
illegittimità era chiaramente “conseguenziale”), proprio allo scopo (così almeno è lecito presumere)
di evitare la caducazione immediata del monopolio all’atto della pubblicazione della sentenza,
dando invece un margine di tempo al legislatore per intervenire nei sensi indicati dalla sentenza
stessa.
E vale la pena di registrare fin d’ora che, nelle ordinanze su cui tale sentenza ebbe a
decidere, emesse a partire dal 1971, già affiorava la prospettazione (che l’attuale ordinanza del
Pretore di Roma assume come “nuova” ai fini della riproposizione di una questione, che altrimenti
avrebbe dovuto esser dichiarata manifestamente infondata) dei progressi della tecnica delle
radiocomunicazioni, che avrebbero fatto venir meno la limitatezza delle frequenze e quindi i
presupposti di fatto delle precedenti decisioni, richiamandosi ai quali la Corte aveva, in un primo
tempo, giustificato il monopolio statale.
Vero è, infatti, che tale monopolio era stato giudicato dalla notissima sent. n. 59 del 1960,
conforme alle previsioni dell’art. 43 Cost. (anche ed in particolare quanto all’“utilità generale” di
istituire la riserva) e non contrastante con la libertà di manifestazione del pensiero di cui al primo
comma dell’art. 21, argomentando esclusivamente della limitatezza “di fatto” dei canali disponibili:
essendo perciò questo particolare mezzo di diffusione del pensiero, per sua natura, limitato -rilevava
la Corte- esso, in regime di libertà, finirebbe per diventare “privilegio di pochi”, dando luogo a
situazioni di monopolio o quanto meno di oligopolio, rientranti nell’area dell’art. 43. Seguiva, in
analogo ordine di idee, la sent. n. 46 del 1961, affermando però in primo luogo (ben più
esplicitamente) che “il diritto di cui all’art. 21 non implica sempre e necessariamente la pretesa alla
disponibilità del mezzo di diffusione (...) e che, anzi, allorché (....) la naturale limitatezza del mezzo
stesso consente solo a pochi tale disponibilità, l’accordare allo Stato l’esclusività del medesimo,
lungi dal contrastare alle esigenze che l’art. 21 ha voluto tutelare, ne rende più agevole la
soddisfazione, dato che lo Stato (...) può meglio che ogni altro soggetto assicurare l’accesso di tutti
gli interessati, in condizioni di obiettività e di imparzialità, al detto mezzo di comunicazione”.
Ed è altresì vero che il motivo della limitatezza (o non limitatezza: tv via cavo, tv via etere a
raggio locale ...), cui strettamente si collega, di solito, la considerazione dei costi di impianto e di
esercizio, continua ad essere evocato nella successiva giurisprudenza costituzionale; ma è anche
vero (e l’ordinanza del Pretore di Roma è seriamente censurabile per non averne fatto il minimo
conto) che accanto ad esso, a partire dalla già cit. n. 225 del 1974, viene enucleandosi sempre più
recisamente l’ulteriore e diverso argomento tratto dal carattere di “servizio pubblico essenziale”, e
per giunta “di preminente interesse nazionale”, che inerisce al mezzo radiotelevisivo, facendolo
rientrare anche sotto questo profilo (distinto ed autonomo) nell’ambito dell’art. 43 Cost.
14
Il rapporto tra i due ordini di argomenti resta però incerto, ambiguo, anche nella più recente
decisione n. 202 del 1976. A momenti, parrebbe che quello del servizio pubblico essenziale divenga
prevalente, addirittura autosufficiente, come ad es. allorché quest’ultima sentenza, procedendo a
“liberalizzare” le trasmissioni radiofoniche e televisive via etere su scala locale (non sussistendo in
tal caso la limitatezza delle frequenze), si affretta ad aggiungere che ciò “non richiede né tanto
meno comporta” che debba escludersi la legittimità costituzionale della riserva allo Stato su scala
nazionale, giacché -“e ciò giova ribadirlo in modo espresso- la radiodiffusione sonora e televisiva
su scala nazionale rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale”.
Ma poche righe prima o dopo, s’incontrano, nella medesima decisione, affermazioni di segno
diverso od opposto, pur dovendosi avvertire che la limitatezza o meno delle frequenze vi è sempre
assunta in senso relativo (ed in rapporto con il costo), escludendosi, anche per le trasmissioni via
etere su scala locale, quella illimitatezza che caratterizzerebbe invece le tv via cavo.
Tanto che non è irriverente supporre che la Corte, dopo essersi in un primo tempo avvalsa
(nella sent. n. 59 del 1960) del solo argomento della limitatezza delle frequenze (e conseguente
rischio di situazioni di monopolio od oligopolio privato, contrastanti con l’art. 43), che era, per dir
così, a portata di mano, abbia in seguito trovato comodo adagiarvisi, un po’ per forza di inerzia, un
po’ anche perché, in quanto argomento tecnico e quindi “neutrale”, serviva ad alleggerirne il
compito, consentendole per di più una certa elasticità di manovra nel decidere sulle singole
questioni di volta in volta propostele, senza intaccare la continuità degli orientamenti di massima fin
dall’inizio affermati.
Comunque, poiché, per una ragione o per l’altra, il motivo della limitatezza delle frequenze,
anche se non più esclusivo ed anzi, forse, nella più recente giurisprudenza costituzionale,
tendenzialmente recessivo, non è stato mai abbandonato, sarebbe non solo scorretto, ma anche
errore di condotta defensionale, trascurarlo o sottovalutarlo: non foss’altro perché é su questo che si
radica la “novità” (d’altronde relativa, come accennato poc’anzi) della questione così come
prospettata dal Pretore di Roma.
E’ perciò consigliabile che sul punto venga formalmente richiesto alla Corte, sin dalle
deduzioni di costituzione, di disporre un accertamento peritale, valendosi dei poteri istruttori
sicuramente ad essa attribuiti dal combinato disposto degli artt. 13 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e
12 delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, con specifico riguardo
(poiché questo è ormai il problema concretamente rilevante) alla ammissibilità di reti televisive
private su scala nazionale (o quasi), in relazione sia ai prevedibili oneri finanziari che
comporterebbero, sia alle conseguenze che ne deriverebbero sul c.d. “diritto di antenna” delle
piccole trasmittenti a raggio locale oltre che sul regolare e indisturbato esercizio del pubblico
monopolio: non essendo dubbio, a prima vista, che il sorgere di reti nazionali toglierebbe alle
emittenti locali spazio economico (sottraendo loro pubblicità) e (probabilmente, ma qui dovrebbe
intervenire un chiarimento tecnico rigorosamente obiettivo) inciderebbe anche riduttivamente sulla
disponibilità di frequenze da esse utilizzabili.
A proposito di che, non dobbiamo dimenticare che la richiamata sent. n. 202 del 1976, al
punto 8° della motivazione, si preoccupava di precisare le condizioni alle quali la emananda legge
avrebbe dovuto subordinare l'autorizzazione alla installazione di trasmittenti via etere a raggio
locale, "data la connessione con il servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale
(...) affidato al monopolio statale", in particolare specificando, tra l'altro, alla lett. c) "l'esatta
indicazione dell'ambito di esercizio, il cui carattere "locale" deve essere ancorato a ragionevoli
parametri di ordine geografico, civico, socio-economico, che consentano di circoscrivere una
limitata ed omogenea zona di utenza"; nonché, alla lett. f), "ogni altra condizione necessaria perché
l'esercizio del diritto, previa autorizzazione, si svolga effettivamente nell'ambito locale e non dia
luogo a forme di concentrazione o situazioni di monopolio o oligopolio". Che è proprio il contrario
di quel che oggi si vorrebbe fare o che comunque deriverebbe fatalmente da una decisione che
dichiarasse in toto la illegittimità della riserva allo Stato.
15
Il vero è che bisogna affrontare senza reticenze e falsi pudori il nodo centrale della
questione, che, come traspare anche (e talora, abbiamo constatato, nel modo più netto) dalla
giurisprudenza costituzionale a partire dal 1974, è quello del servizio di radiodiffusione nazionale
come "servizio pubblico" (secondo nozione oggettiva, e perciò da definire storicamente), con tutte
le sue implicazioni di ordine costituzionale. Servizio pubblico da considerarsi, certamente,
nell'epoca attuale, "essenziale" e "di preminente interesse generale", così come richiesto dall'art. 43
Cost., per poter essere legittimamente riservato allo Stato. Chi potrebbe negare, infatti, gli anzidetti
caratteri ad un mezzo, come la radiotelevisione, che all'enorme diffusione soggettiva unisce una
penetrazione capillare così articolata e profonda? Come potrebbe contestarsi l'esigenza che
l'esercizio ne sia assicurato comunque, con regolare continuità, toccando tempestivamente ogni più
remota località del territorio nazionale?
"La radiotelevisione -si legge nella sent. n. 225 del 1974, sopra cit. -adempie a fondamentali
compiti di informazione, concorre alla formazione culturale del Paese, diffonde programmi che in
vario modo incidono sulla pubblica opinione e perciò è necessario che essa non divenga strumento
di parte: solo l'avocazione allo Stato può e deve impedirlo". Ricorrono perciò -conclude la
decisione- i "fini di utilità generale" richiesti a loro volta dall'art. 43: e ciò, mi sembra possa
aggiungersi senza forzarne lo spirito, indipendentemente dalla maggiore o minore limitatezza del
mezzo. E sempre avendo ben presente che di illimitatezza nel senso di effettiva disponibilità da
parte di "tutti" non è nemmeno il caso di parlare: in questo senso, esattamente si è espressa la sent.
n. 225, rilevando che, se non ci fosse la riserva statale, "non perciò riuscirebbe ad avere attuazione il
diritto di 'tutti' di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione" (ma si
veda anche, sebbene con particolare riferimento al diritto di accesso, la decisione della Corte
Suprema USA, cit. dal Pace a p. 192-193 dello scritto "La problematica del controllo sulle
radiotelevisioni private", nel vol. Radiotelevisione pubblica e privata in Italia, a cura di P. Barile,
E. Cheli, R. Zaccaria, 1980: "Diversamente da altri mezzi di espressione del pensiero, la
radiodiffusione per sua natura non può essere nella disponibilità di tutti. Questa è la sua unica
caratteristica ed è questa la ragione per la quale diversamente dagli altri mezzi di espressione essa è
soggetta a regolamentazione governativa").
Ed a quanti si affrettano ad opporre il principio della libertà di manifestazione del pensiero,
garantito dall'art. 21, primo comma, Cost., è da replicare preliminarmente che non è solamente per i
motivi tecnici qui più volte ricordati (limitatezza nel mezzo), ma anche per altre svariate e
consistenti ragioni (quali l'esigenza di garantire i diritti individuali verso i privati oltre che nei
confronti delle pubbliche autorità e la consapevolezza che la libertà di manifestazione del pensiero
può essere limitata "non solo dall'alto, ma anche dal basso", come nell'esempio classico del
monopolio, che, per restare in argomento, non deriva unicamente dall'eventuale limitatezza del
mezzo di diffusione), che un Autore come Carlo Esposito poteva affermare, sulla scia d'altronde di
una vasta ed autorevole dottrina straniera, non potersi "escludere che il rispetto della libera
iniziativa possa restringere ancor più della nazionalizzazione il numero e la varietà delle idee in
grado di giovarsi del mezzo di diffusione" (La libertà di manifestazione del pensiero
nell'ordinamento italiano, Milano, 1958, p. 30).
La libertà e segretezza della corrispondenza sono garantite come diritto "inviolabile" dall'art.
15 Cost., e tuttavia la legge, senza con ciò violare la norma costituzionale, stabilisce il monopolio
pubblico delle comunicazioni epistolari telegrafiche e telefoniche, le quali sono altresì potenzialmente, il segreto essendo disponibile dai privati- mezzi di diffusione del pensiero, da
collocarsi, in questo senso, accanto alla stampa e alle radiodiffusioni circolari.
Ma il vero è che l'art. 21, come sicuramente non prescrive la proprietà privata e il regime di
libera impresa dei mezzi di diffusione del pensiero, così nemmeno garantisce (secondo
l'interpretazione letteralmente e sistematicamente più attendibile, accolta anche dalla Corte nelle
rammentate sent. n. 46 del 1961 e n. 225 del 1974, nonché, ad altro proposito, nella n. 105 del 1972)
il diritto di disporre di tutti quelli possibili. Il primo comma (a parte la confusione tra la parola,
16
parlata o scritta, ed i mezzi di diffusione, che stanno sopra un piano diverso) non dice "con tutti i
mezzi di diffusione", ma "con ogni altro mezzo di diffusione". Linguisticamente, è una sfumatura;
ma giuridicamente, il concetto risulta diverso: quel che l'art. 21 garantisce, cioè, è la libertà della
manifestazione nel suo contenuto, quali che siano il mezzo e i modi traverso cui avviene. Come
rilevava l'Esposito (loc. cit., p. 20-21, richiamando nel medesimo senso l'opinione del Bobbio,
Politica e cultura, 1955, p. 278), il principio è che il singolo possa manifestare liberamente "ciò che
pensa con i mezzi a propria disposizione", con il solo limite -soggiungeva l'Esposito- che "non sia
riservato l'uso di un mezzo in generale solo a manifestazioni di un determinato contenuto".
A rigore, anzi, l'art. 21, nel suo primo comma, non si occupa dei mezzi di diffusione, mentre,
nei commi successivi prevede bensì e disciplina uno solo di essi, e precisamente la stampa (in
particolare, periodica), stabilendo al riguardo un regime non estensibile automaticamente ad altri
mezzi quali la radiodiffusione. Significativa la differenza con il corrispondente art. 5 della
Costituzione della Repubblica federale tedesca, che, dopo aver riconosciuto la libertà di espressione
mediante parole, scritti e immagini, garantisce altresì specificamente (ecco il riferimento ai "mezzi"
veri e propri) la libertà "di stampa e di informazione mediante la radio ed il cinematografo": il che
non impedisce, sia detto di passaggio, che l'attività di radiotelediffusione sia, in Germania, oggetto
di pubblico monopolio (a livello di Stato federale e di Länder) e che tale sistema sia stato giudicato
costituzionalmente legittimo dal Bundesverfassungsgericht, che ha ammesso bensì la possibilità di
trasmittenti private, a condizione però che siano organizzate in modo da assicurare nel loro interno
l'intervento di tutte le forze socialmente rilevanti, sotto rigoroso controllo statale.
Per quanto fin qui detto, può concludersi che l'art. 21 non si oppone a che, secondo
valutazioni discrezionali del legislatore (sottoposte, beninteso, a sindacato di ragionevolezza della
Corte costituzionale) determinati mezzi di diffusione del pensiero vengano configurati come
pubblici servizi e riservati alla mano pubblica (come scrivevo io stesso ne Il Politico del 1964, pp.
297-298): purché ne sia assicurata la libera utilizzabilità "legale", in regime di eguaglianza, "nella
misura massima consentita dai mezzi tecnici" (come ebbe a dire benissimo la sent. n. 225 del 1974,
più volte cit., al punto 8° della motivazione).
Conclusione, la quale -è bene avvertirlo subito, per prevenire un argomento ad effetto spesso
ripetuto- se calza perfettamente per la radiotelediffusione, non sarebbe invece applicabile alla
stampa, anche a considerarla un pubblico servizio anch'essa. Ciò, non soltanto per le notevoli
differenze che distinguono l'uno dall'altro mezzo, ma anche perché (come osservava acutamente
Esposito nello scritto tante volte qui ricordato) l'art. 21 Cost., nel disciplinare la stampa prevedendo
tra l'altro il divieto di "autorizzazioni", oltre che di "censure", e prevedendo altresì che possa la
legge prescrivere che ne siano resi noti i mezzi di finanziamento, mostra di disporre o quanto meno
di presupporre che in tale settore via sia e debba esserci libertà di iniziativa economica.
Ad un ultimo punto vorrei brevemente accennare, prima di chiudere, che è tra quelli
residuali che all'inizio avevo accantonato, ma pare a me meriti qualche attenzione. Mi riferisco
all'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della vigente normativa sul monopolio pubblico
per violazione dell'art. 3 Cost., stante il diverso trattamento (privilegiato) che, a seguito della sent.
n. 225 del 1974 e della legge n. 103 del 1975 (titolo III), risulterebbe fatto alle reti televisive estere,
che, attraverso i c.d. ripetitori, possono diffondere sull'intero territorio nazionale.
Senonché -a parte che la Corte ritenne, tra l'altro, di suffragare tale sua decisione sul punto
con il solito richiamo alla disponibilità delle frequenze, incorrendo però in una svista tecnica, e che
non sarebbe evidentemente consentito assumere a termine di raffronto una situazione determinata
da una errore nei presupposti di fatto- deve riconoscersi che non mancavano valide ragioni
suscettibili di giustificare questa sorta di "apertura di finestre" verso l'esterno, alla quale la Corte fu
indotta anche da motivi di opportunità politica immediata.
***
17
Spero che le considerazioni che precedono, pur nella loro stringatezza, possano riuscirLe di
qualche utilità. E, mentre La saluto cordialmente, mi dichiaro a Sua disposizione per ogni eventuale
chiarimento ulteriore
Vezio Crisafulli