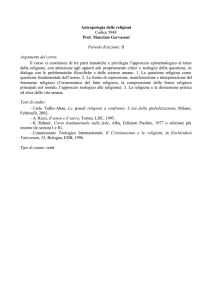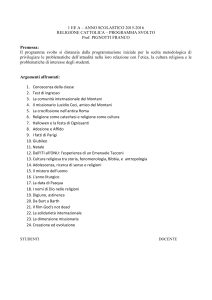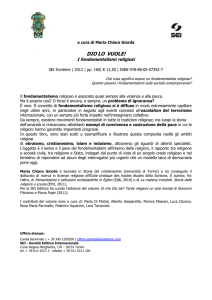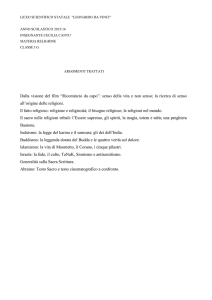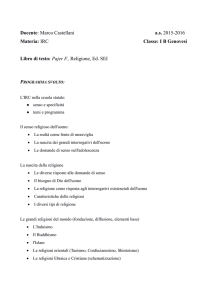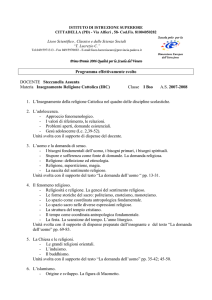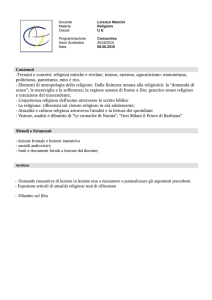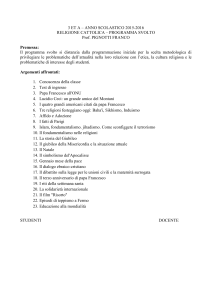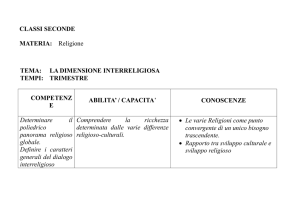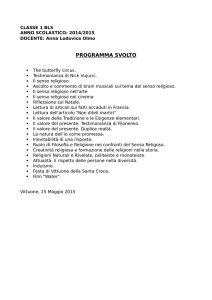Fondamentalismi e religione
Per una definizione di fondamentalismo
Generalmente il termine “indica quella posizione intellettuale che pretende di
derivare i principi politici da un testo ritenuto sacro”, come ricorda Youssef M.
Choueiri in un suo illuminante saggio relativo al fondamentalismo islamico 1 . Ma
anche questa definizione appare viziata da un certo uso limitato che solitamente si fa
dei termini impiegati. Per “principi politici”, infatti, si deve intendere, in senso
allargato, quei valori che fondano la società e il vivere insieme degli uomini. In altri
termini, i fondamentalismo è profondamente convinto che esista un unico modello di
vita sociale e che tale modello sia contenuto in un testo sacro, chiaro nelle sue
determinazioni e nelle sue argomentazioni. Nelle visioni fondamentaliste, dunque,
esiste chiaro e identificabile un FONDAMENTO, ossia un evento rivelatore di Dio al
quale è necessario riferirsi. Il FONDAMENTO non può venire messo in discussione,
pena la perdita di pregnanza e di peso specifico di ogni argomentare religioso. Ogni
movimento che vuole riformare, interpretando e disconstandosi dalla lettera del testo,
è visto con estremo sospetto all’interno dell’orizzonte fondamentalista, fino a
sfociare, come in certe frange del radicalismo islamico – ma non solo – in una sorta
di rifiuto radicale del secolarismo in tutte le sue manifestazioni. Per rimanere
nell’ambito dell’islamismo, il radicalismo islamico di stampo fondamentalista, quello
che va dalla teologia iraniana degli ayatollah alla visione dei mullah afgani, crede che
la sovranità assoluta di Dio e il ruolo del jihad siano gli aspetti più rilevanti
dell’Islam. Ma, come afferma sempre Choueiri, “Fintanto che un testo rivelato è
ritenuto il riferimento ultimo e assoluto delle questioni umane, o di ciò che è vero o è
falso, il fondamentalismo è destinato ad apparire sotto varie etichette e in diversi
sistemi di credenza”.
Il fondamentalismo, infatti, è una realtà – per certi versi “un pericolo”, presente in
molti – e vorrei dire tutti – i percorsi religiosi. Emblematico, a questo proposito, è la
cronaca dell’incontro tra Francisco Pizzarro e Diego de Almagro con l’imperatore
Inca Atahualpa, raccolta nel libro di Poma de Ayala. Fray Vincente, il frate al seguito
degli spagnoli, esorta in maniera piuttosto sbrigativa l’imperatore a convertirsi, vista
la superiorità del cristianesimo alla religione incaica. Ma l’imperatore è titubante. Il
frate, allora, presenta il Libro della Verità all’imperatore, affermando solennemente
che la Verità è racchiusa nel libro dell’Evangelo. L’imperatore guarda il libro, non
capisce il linguaggio e i segni, e, dopo averlo esaminato attentamente, dice: “a me
non dice nulla, non mi parla”, e getta il libro lontano. Fray Vincente grida al
sacrilegio e, all’istante, l’imperatore viene imprigionato e gli spagnoli avviano il
massacro. Al di là delle considerazione storiche che possiamo fare, risalta in modo
netto l’incapacità degli spagnoli di uscire fuori dalla propria Weltanschauung. Esiste
una sola verità e contenuta in un Libro. Agli occhi degli spagnoli, sacrilego e
fondamentalista era lo stesso imperatore, accecato dalla sua ignoranza. Il
fondamentalismo, infatti, è sempre visto all’esterno del proprio mondo culturale e
1
Cfr. Y. M. CHOUEIRI, Il fondamentalismo islamico, Il Mulino, Bologna 1993, p. 29
mai all’interno. I fondamentalisti sono sempre gli altri, mentre la verità appartiene
sempre al proprio contesto culturale e religioso di riferimento. Il fondamentalismo è,
dunque, un problema di prospettiva e l’astigmatismo che caratterizza ogni cultura e
ogni religione rende incapaci di poter addivenire a giudizi oggettivi. Parlare di
intransigenza e di fondamento, apre numerosi problemi di autopercezione: esistono
valori assoluti? Che cosa significa non essere fondamentalisti? E’ un solo
atteggiamento di rispetto passivo, come la tolleranza? O presuppone un
coinvolgimento più attivo nel destino degli altri? E poi, è lecito o no considerare ogni
sistema come chiuso? Oppure, è del tutto sbagliato prevedere dei processi di
protezione e immunizzazione culturali che passano attraverso un’identità culturale
che è anche religiosa?
Rispondere agli interrogativi è compito titanico e forse anche sterile. Ma cerchiamo
di sgomberare almeno un po’ il campo da alcuni equivoci: l’essere religiosi, significa
aprirsi ad una realtà che non accetta nessun “penultimo”, nessuna contrazione. E’ un
adesione che fa riferimento alla decisione, alla riflessione, ma ancor di più al
sentimento. E questo perché ogni percorso religioso possiede una sua inner logic
come afferma Smart e che “non si può prescindere da quella logica per capire la
religione, altrimenti si rischia di non comprendere affatto i significati del percorso
religioso. Gli uomini di fede dovrebbero prendere coscienza che esiste sempre, anche
in forme lievi, una forma di fondamentalismo connaturata all’essere religiosi.
Per una fenomenologia del fondamentalismo: Autopercezione ed
attribuzione di significato
Parlare di religione in rapporto alla violenza sembra una contraddizione in
termini, sia perché le religioni continuamente proclamano intenti di pace, sia
perché le condotte religiose, ossia i comportamenti messi in atto dai credenti,
nell’immaginario collettivo dei credenti stessi vengono avvertite come
nonviolente.
Sono convinto, infatti, che se si chiedesse ad una persona religiosa di
associare liberamente il termine “religione” ad altre parole, quelle più ricorrenti
sarebbero: “amore”, “pace”, “giustizia”, “servizio”, “preghiera”;
ricorrerebbero, cioè, termini dalla chiara valenza positiva. E questo perché le
religioni sono vissute dai credenti come una realtà opposta ad ogni negatività,
come una grande costruzione di pensiero fondata su un evento rivelatore
storicamente accaduto o resosi evidente nei recessi della coscienza capace di
aprire alla speranza e di garantire lo sviluppo di valori autentici, e fonte di
un’etica volta a realizzare una “salute” terrena e una “salvezza” spirituale. Non
credo, infatti, che le persone di fede abbiano la consapevolezza del potenziale
di violenza che le religioni contengono, della dinamite concettuale sempre
pronta ad esplodere presente in ogni realtà storico-religiosa. All’interno di ogni
prospettiva di fede fondamentalista non si riesce adeguatamente a distinguere
tra la dimensione trascendente a cui le religioni tentano di adeguarsi, in virtù di
una rivelazione che hanno ricevuto storicamente – come le fedi abramiche
(ebraismo, cristianesimo, islamismo) – o interiormente – come le illuminazioni
orientali (induismo e buddhismo) – , e la dimensione dinamico-storica delle
religioni stesse.
Perché nasce il fondamentalismo
Se, da un lato, proprio grazie alla loro anima trascendente, le religioni si
percepiscono simbolicamente in armonia col divino e, in quanto tali,
catalizzatrici di ogni valore assoluto e positivo, dall’altro, sul piano storico,
dimenticano spesso di essere zavorrate dalla pochezza dell’uomo e come strette
nell’abbraccio stritolante del limite. Per un verso, c’è il divino che si rivela
sotto le più disparate forme e, per l’altro, c’è l’uomo che fruisce di tale
rivelazione e che, necessariamente, tende a contrarla in categorie proprie,
difese con tenacia e, spesso, con aggressività. In altre parole, se, in un primo
tempo, le religioni nascono come “eresie” rispetto ad un sistema socioculturale, come “scosse elettriche” che attraversano e bruciano gran parte degli
schemi culturali precedenti, ancorando tale azione iconoclasta ad una
dimensione trascendente, poi, lentamente si trasformano nella nuova base
culturale del gruppo sociale in cui si diffondono, diventando motore di idee e
progettualità non più eretiche, ma funzionali al sistema.
In questo secondo momento le religioni si amalgamano con la cultura della
società in cui nascono, divenendone fertilizzante e rafforzandone l’identità,
ma, simultaneamente, derogano in parte alla loro natura spirituale originaria
per costituirsi come istituzioni e come realtà di potere. Ed è proprio
dall’abbraccio tra cultura e religione che scaturisce la dimensione guerriera e
integralista delle religioni, perché quelle stesse provocazioni spirituali nate
per scardinare un precedente sistema e per essere la nuova “coscienza critica”
dell’individuo e del gruppo in cui si impiantano, diventano progressivamente
funzione della cultura.
E’, quindi, necessario affermare in maniera chiara che la violenza rientra nel
sono storicamente
dna storico delle religioni, dal momento che le fedi
incapaci di rinunciare a loro stesse e sono disposte a difendere anche con forza
il loro tesoro teologico frutto di un compromesso tra sintesi religiose e sintesi
culturali. Agganciandosi in modo più o meno definitivo alle culture di
riferimento, i “credo” religiosi ne assumono gran parte dei “vizi”, divenendo
rigidi nelle enunciazioni, muscolosi nelle argomentazioni, collosi nel rapporto
con le altre sensibilità religiose, ossia fondamentalmente chiusi in se stessi e
prigionieri del proprio patrimonio sapienziale. Ogni realtà religiosa tende a
vedere il mondo solo attraverso la curvatura della propria cornea e a ridurre
ogni alterità fino a trasformarla in identità, soffocando, consapevolmente o, più
spesso inconsapevolmente, ogni dimensione che parta da paradigmi differenti.
In definitiva, si potrebbe affermare che le religioni diventano violente perché
rinunciano alla loro carica dirompente originaria, che è sempre eversiva nei
confronti di ogni rigida classificazione, fino a marginalizzare il cuore pulsante
dell’esperienza religiosa per piegarsi a parlare il linguaggio delle culture e delle
società in cui sono presenti.
L’uomo religioso contemporaneo deve necessariamente muoversi da qui se
desidera rifondare un discorso di fede che voglia interrogarsi seriamente sul
ruolo delle religioni nella costruzione di un mondo pacifico. Deve, insomma,
riconoscere che le religioni sono, come realtà storica, decisamente suscettibili,
prive di autoironia e solidamente ancorate alla loro elaborazione, ossia al loro
linguaggio, alle loro modalità rituali, alla verità che dichiarano di accogliere.
Ma – aggiungerei - le religioni sono quasi costrette ad essere intransigenti
verso ogni differenza per salvaguardare l’identità più autentica del loro
messaggio, pena la messa in discussione integrale del loro “sapere”. Le
religioni proiettano sul mondo un’ombra lunga e compatta che non soffre
riduzionismi né eccessive frammentazioni e che, probabilmente, non potrà mai
essere dissipata.
Gli “errori” delle visioni fondamentaliste
PRIMO ERRORE: La mia religione è l’unica verità possibile
Alla base di questa convinzione propria del fondamentalismo c’è l’errata
convinzione che la propria religione sia depositaria di una verità del tutto
nuova. Ai fondamentalismi, infatti, manca la consapevolezza che, sotto
alcuni aspetti, ogni religione è anche un sincretismo, come afferma Van der
Leeuw. Per il grande fenomenologo, infatti, una religione nasce come
sincretismo per poi trasformarsi in una sintesi autonoma. Il
fondamentalismo, dunque, manca di una qualsiasi sensibilità nei confronti di
quelle tradizioni “altre” da cui il proprio credo ha attinto a piene mani.
Ma, dietro ad ogni visione fondamentalista, si nasconde anche
un’essenza concettuale più graniticamente monoteista. Si può affermare,
infatti, che ogni fondamentalismo è monoteista, prendendo ad esempio il
primo grande vero monoteismo-fondamentalista egizio dell’imperatore
Akhenaton. Per essere forte e arroccato in idee chiare e comprensibili, il
fondamentalismo religioso spesso si rinchiude negli angusti confini di un
monoteismo culturale. E questo perché, come afferma Marc Augé, il
monoteismo ha una struttura monolitica ed è fondato su un paradigma che
non afferma alternative. Il monoteismo è funzionale al fondamentalismo
perché tende a sconfinare facilmente in una sorta di tirannia. Per superare lo
scoglio del monoteismo fondamentalista, ricorda Marc Augé (Il senso degli
altri. Anabasi, Piacenza 94), ma anche U Volli (Per il politeismo), le
religioni dovrebbero riscoprire la loro anima pagana. E’ chiaro che, sotto
questo profilo, il monoteismo di cui si parla non ha niente a che vedere con il
monoteismo religioso tout court, ma si trasforma in una metafora per
indicare una sorta di MONOTEISMO DELLA VERITA’. Tale forma è un
modo di pensare la propria religione come un insieme di senso che offre
l’unico senso possibile al discorso su Dio. E’ un monoteismo che al suo
interno può anche essere o non essere pluralista, ma che pluralista non lo è
mai quando si confronta con le alterità religiose e culturali. Il
fondamentalismo, in altre parole, è convinto di poter disporre di Dio a
proprio piacimento proprio perché riduce Dio in schemi e contrazione
concettuali che soffocano il potenziale di Dio stesso. E’ un monoteismo che
si ostina a leggere Dio solo all’interno della propria curvatura concettuale.
Connesso a questo discorso c’è, poi, quello della demistificazione del sacro.
Un vero fondamentalismo di stampo monoteistico tende a diminuire gli
spazi della mistica e ad aumentare gli spazi della liturgia e della catechesi.
Cerca di soffocare sotto un gas etico il potenziale ossigenante
dell’esperienza religiosa, intesa come ascolto, ricerca inesausta. Il
fondamentalismo è etico perché l’etica è più attenta alle differenze e non
mistico, perché la mistica è più attenta alle consonanze. Uccidere il
potenziale poetico delle religioni significa ucciderne il potenziale mistico
correndo il rischio di cadere nella trappola del monoteismo-fondamentalismo
della verità. Per superare quest’ostacolo bisogna riscoprire il sacro nelle
religioni, che è l’irrazionale, il passionale, il ludico, l’emotivo.
SECONDO ERRORE: il “linguaggio” senza limite
Una secondo errore, connesso al primo, va ricercato nel linguaggio con
cui il credente o, meglio, la comunità dei credenti, cerca di veicolare
l’essenza profonda del messaggio religioso. All’interno dell’orizzonte
fondamentalista, infatti, si è persa la consapevolezza che esiste un confine
invalicabile tra l’uomo e il divino, capace di marcare la loro irriducibile
differenza. Da un lato si pone, infatti, la totalità inimmaginabile di Dio, il
Totalmente altro dell’Occidente, l’anyad eva 2 delle Upanishad e, dall’altro,
l’esiguità del potenziale simbolico e verbale dell’uomo, che cerca
disperatamente di riprodurre l’infinitezza di Dio, incespicando sulla propria
incapacità. La tensione verso il Regno propria del Cristianesimo è attratta,
per mezzo della rivelazione di Cristo, verso la perfezione e, nel contempo,
viene come soffocata dalla pochezza delle possibilità umane.
Il linguaggio delle religioni tenta di veicolare la pienezza della
rivelazione propria di ogni percorso, ma è come contratto dal potenziale
culturale, ideologico, filosofico e anche religioso di cui ogni dimensione
spirituale è in qualche modo vittima. Paul Tillich ricordava sempre che
quando pronunciamo il nome “Dio” noi, in realtà, creiamo una metafora per
Dio, ossia veicoliamo in un concetto una realtà che non può essere
facilmente concettualizzata. Lo stesso termine “religione” è estremamente
vago e, di per sé, misero, con la sua radice latina “religo”, ossia “vincolo”,
2
Anyad eva è un’espressione sanscrita che significa “totalmente altro” e nelle Upanishad induiste è impiegato per
spiegare il Brahman, il principio macrocosmico universale. Per un confronto tra la visione occidentale e quella orientale
si legga: R. Otto, Mistica orientale, mistica occidentale, Marietti, casale Monferrato (AL), 1985.
che sottoilinea solo un aspetto, quello più propriamente rituale, del momento
religioso. L’oriente induista non parla di religione, bensì di “sanatana
dharma, ossia di “verità eterna”, di “destino eterno” entro cui si dà l’uomo e
la sua storia e mostra i suoi sentieri per raggiungere la comprensione del
Tutto, dell’assoluto, le vie yoghiche della compassione, dello studio o
dell’azione. Il buddhismo, poi, rinuncia del tutto all’idea di Dio e di
religione, affermando che ogni concetto è caduco e vuoto, un riempiticcio
che l’uomo fa per darsi dei significati e chiede al credente di spogliarsi di
ogni preconcetto, persiono dell’ego, per lasciarsi ospitare dal senso: fare
vuoto (sunyam) perché solo allora il senso, se esiste, può ospitare l’uomo.
L’Islam, accanto al concetto di sottomissione, usa quello di “al dyn” per
veicolare qualcosa di simile alla nostra parola “religione”, che ha una
sfumatura vincolante, evocando un debito che l’uomo ha contratto con Dio e
che deve essere risarcito con la fede. In tutte le religioni, poi, vi è come una
sorta di disgusto per il termine stesso religione e tutte si affannano a dire che
no, non sono religioni, bensì fedi, ossia si basano su un credere che deriva da
un dato di fatto, da un incontro, unico e irripetibile. E non si creda che queste
differenze siano soltanto “erotismo” da filologi, perché, osservando il mondo
oggi, non si può che convenire con Wittegenstein quando affermava che
“immaginare un linguaggio significa immaginare una forma di vita”.
Parlando di Dio noi diamo vita a un Dio. Questa è la grande consapevolezza
che manca ai fondamentalisti.
La frontiera del linguaggio è scabrosa, intimorisce il ricercatore ed è
spesso sconosciuta al credente che riduce ogni esperienza al suo modo di
chiamare Dio e parlare di lui.
Ogni interpretazione fondamentalista dà delle risposte che hanno una
mediazione linguistica, un sottofondo simbolico, aprono a nuovi immaginari
che hanno un senso preciso solo per quella tradizione, ma che, per essere
validi ed efficaci, devono essere avvertiti come assoluti e universali. E
soprattutto rivelati, ossia non prodotti dall’uomo da ricevuti direttamente da
Dio e, in quanto tali, inappellabili.
I fondamentalismi parlano spesso, quindi, il linguaggio dell’urgenza,
dell’ansia creaturale, e ospitano la tensione dell’uomo verso quella totalità di
significati che è Dio. E pensano il Dio che riescono a pensare come il Dio
assoluto: Dio, gli dei, o, più genericamente, il sacro, rispondono all’esigenza di
staticità dell’uomo contro un dinamismo esistenziale minaccioso e sempre
precario; incarnano la staticità della perfezione, dell’armonia, e del bene
assoluto contro l’instabile e ondivaga esperienza umana, spesso
indissolubilmente schiacciata dal senso dell’imperfezione, dalla realtà del
dolore e dalle costrizioni del male.
Affermare che questo “Dio” è anche ( ripeto è “anche” e non “solo”) frutto
di un’invenzione culturale, nel senso etimologico di “ricerca volta a trovare una
risposta”, è intollerabile per i fondamentalisti, che non sopportano ogni seppur
minima contrazione di significato. Non sopportano le sfumature metaforiche
che ogni parola contiene.
TERZO ERRORE: L’ESPERIENZA DEL CREDENTE E’
ASSOLUTA
La frontiera che l’uomo non può attraversare è costituita dall’esperienza
stessa che il credente fa di Dio. Questa consapevolezza manca al
fondamentalismo, mentre, quando si parla di “religione”, si dovrebbe essere
sempre consapevoli che si analizza questo ritaglio del discorso, senza avere
la pretesa di parlare con l’assolutezza di Dio. Nei fondamentalismi, invece,
questa consapevolezza è quasi sempre assente. L’uomo religioso si sente
spinto, in forza della sua esperienza radicale di Dio, a guardare il mondo
attraverso il suo punto di vista e a credere che la salvezza del cosmo coincida
con tale sguardo. Questa certezza si trasforma, spesso, in intemperanza, in
una forma di sottile violenza che spinge le comunità dei credenti a
improntare il mondo a partire dalla propria mediazione di Dio. Il più delle
volte si tratta di una contrazione in buona fede, ma che rischia, comunque, di
essere violenta, impositiva e coercitiva.
E’, tuttavia, necessario chiarire che il mio discorso non compromette
l’assolutezza di Dio, né l’integrità del messaggio rivelato, ma vuole porre
l’accento sull’uomo e sulle sue scarse capacità ricettive. Per tutte le religioni,
infatti, la Verità si rivela storicamente, come evento – si pensi
all’incarnazione, o al Corano 3 – oppure interiormente, come illuminazione e
risveglio della coscienza – si pensi al moksa induista, al samadhi dello yoga,
al nirvana buddhista 4 – ma in tutte le religioni c’è un soggetto che fa
esperienza di tale verità e che, necessariamente, la contrae nelle sue
categorie. L’esperienza diviene, dunque, un passo invalicabile, una strada
senza uscita, un labirinto, perché parlare di religioni e di fede significa
sempre parlare del proprio modo di esperire quello che R. Otto chiamava “il
numinoso” 5 .
Ma l’esperienza appartiene sempre al campo del soggettivo, anche se
spesso questa soggettività non emerge in modo consapevole. Il grande
antropologo Cliffor Geertz diceva che noi occidentali, abituati a vivere in
stanze quadrate non possiamo che formulare che pensieri quadrati. Di per sé
non c’è nulla di male nell’elaborare pensieri quadrati, ma, se volessimo
comprendere altre culture, non dovremmo cercare di applicare i nostri
schematismi. Se volessimo metterci alla prova, dice Geertz, dovremmo
provare ad indossare un sombrero e a pensare il mondo a partire dalla grande
e pesante rotondità che ci sovrasterebbe. Il mondo, allora, ci sembrerebbe
3
Il Corano, nell’Islam, è l’evento della rivelazione di Dio, raffrontabile, in sede di comparazione tra le religioni,
all’evento di Cristo e non alla Bibbia. Cfr. G. Rizzardi, Introduzione all’Islam, Queriniana, Brescia, 1992, pp. 49-63
4
Cfr. A. N. Terrin, Il respiro religioso dell’Oriente, EDB, Bologna, 1997.
5
Il numinoso è, per R. Otto, “una manifestazione dell’essere di fronte alla quale vi è tutto uno srotolamento di
sentimenti non traducibili in linguaggio”. Cfr. A. N. Terrin, Scienza delle religioni e teologia nel pensiero di Rudolf
Otto, Morcelliana, Brescia 1978, p. 51.
davvero diverso. Questo è per dire che l’esperienza spesso è intemperante e
riduttiva, anche se non esistono altre vie per entrare in contatto con il
mondo. L’importante è, allora, tentare di dare corpo al dubbio, come valore.
QUALI VIE D’USCITA?
La dinamica culturale del fondamentalismo costituisce certamente una
nuova frontiera per le religioni, per superare la quale sono convinto vi siano
strade migliori che non quella di gridare metaforicamente “al lupo, al lupo”.
E se da un lato ritengo indispensabile che ogni percorso religioso inviti
all’adesione integrale (e non integralista) al messaggio e al senso profondo
della propria fede, invitando il credente ad addentrasi nelle viscere
dell’esperienza religiosa senza rimanere in superficie, dall’altro credo che la
situazione contemporanea possa essere anche una grande opportunità, se
diviene capace di farci riscoprire due grandi valori perduti:
1. Il valore del nomadismo
2. Il valore dell’eresia
1. La natura “nomade” del bisogno religioso contemporaneo
L’esperienza religiosa contemporanea, sulla scia delle profonde modificazioni
culturali, nasce in relazione al movimento e alla trasformazione. Per effetto delle
varie rivoluzioni scientifiche, l’Occidente è oggi culturalmente come “tarantolato”, in
balia di un movimento compulsivo che allontana sempre di più gli individui da quel
centro di gravità ideologico che era patrimonio dei nostri “padri”. Le culture
occidentali, infatti, seppur dal punto di vista economico risultino sempre più violente
e normative 6 , sotto il profilo sapienziale già da tempo sono entrate in una zona di
turbolenza che apre falle sempre più gigantesche nel tessuto compatto della nostra
autopercezione. Gli individui, oggi, si sentono orfani delle antiche certezze,
avvertendo sia la precarietà della propria visione del mondo, della propria valutazione
dei fatti, sia la necessità di spostarsi altrove culturalmente, per recuperare qualche
parvenza di certezza. Questo nomadismo è, innanzi tutto, attrazione verso la
mutevolezza con cui, volente o nolente, l’individuo impara a confrontarsi ed è una
presa di coscienza, esplicita o implicita, che esiste un valore anche al di là di se stessi
e del proprio orizzonte culturale. “L’uomo nomade – afferma P. Prini – ha appreso
dalla scienza la sua più alta lezione etica, cioè l’abolizione degli assoluti”7 . Abituati a
una cultura pronta a definire e a definirci, oggi ci sorprendiamo ad essere sospinti
senza meta nel flusso di una ricerca religiosa che non vuole concludere né approdare
apparentemente in nessun dove, ma che tenta solo di ritrovare un barlume di
armonia. Il bisogno religioso contemporaneo, infatti, è sempre più intimamente
spaventato dalle grandi narrazioni epico-religiose in grado di dare senso ad una
6
Cfr. A. GIDDENS, Le conseguenze della modernità. Fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Il Mulino, Bologna 1990,
pp. 63-70.
7
P. PRINI, L’uomo nomade nella natura in movimento, in: E. BACCARINI, a cura di, Il pensiero nomade. Per una
antropologia planetaria, Cittadella, Assisi 1994, p. 13
cultura 8 , ma capaci di inchiodare ad una visione univoca e monocroma del mondo, ed
è sempre più attratto verso il buco nero del non-sense e del pastiche. Ma perché
avviene questo? Rispondere non è facile, ma credo che il filo di Arianna capace di
condurci al centro della problematica, vada ricercato proprio nella messa in stato
d’accusa delle grandi visioni religiose. Il credente contemporaneo, in qualche modo
reso edotto dai traguardi della linguistica, dello strutturalismo e della filosofia del
linguaggio, è sempre più consapevole della precarietà semantica del discorso, e
diventa cosciente che ogni religione, raccontando un’esperienza di rivelazione, la
storicizza e la culturalizza, riducendola e comprimendola nelle proprie categorie. Alla
fine, ogni cultura religiosa diviene schiava di ciò che racconta e finisce coll’essere
più fedele a quella narrazione che all’esperienza religiosa. Il credente postmoderno,
invece, sente il bisogno di ossigeno, avverte la necessità di respirare al di là delle
molte narrazioni che gli vengono trasmesse e, per liberarsi dagli stretti lacci di tale
costrizione culturale, si sposta continuamente da un luogo all’altro delle narrazioni
religiose, accettandole tutte e, simultaneamente, sospettando di tutte. La metafora del
nomade, dunque, è appropriata per designare la mappa genetica di un cercatore
spirituale che non vuole cadere prigioniero del déjà vu, che non vuole finire nella
“trappola” dell’istituzione religiosa, ma desidera ardentemente un orizzonte
esperienziale libero da ogni ingombro teologico e razionalizzante, credendo
fermamente in quello che Gauchet chiama, con un paradosso, “la religione dell’uscita
dalla religione” 9 . Il credente contemporaneo avverte un’esigenza di libertà che si
concretizza nel rifiuto di ogni “stanzialità” culturale e ideologica. Libertà significa
movimento da ogni “stop” concettuale e rifiuto di ogni forma cristallizzata per vivere
la condizione del nomade che si fa straniero ad ogni costringente appartenenza.
Essere nomadi significa, quindi, rifiutare la religione, o meglio, le religioni, per
ricercare un’autentica religiosità che si coniughi con un’ardente vita spirituale. Il
nomade non si fida di una prospettiva e migra alla ricerca di nuove soluzioni
culturali, anch’esse avvertite precarie e insoddisfacenti, ma, nel contempo, garanzia
dell’inafferrabilità dell’Assoluto. Nello spostamento, il cercatore afferma che esiste
uno scarto tra sé e il divino di cui diviene consapevole con serena tranquillità: tale
scarto gli permette di “salvare” Dio dalle aporie del mondo e dalle contraddizioni
della storia .
Più specificamente, potremmo affermare che essere nomadi significa, innanzi tutto,
diventare liberi dalle parole che imprigionano ogni nostra intuizione. Il credente
contemporaneo, da un lato, sente l’esigenza di comunicare ciò che esperisce,
dall’altro, prende irrimediabilmente coscienza dell’esiguità semantica del proprio
dire, ossia del fatto che ogni parola pronunciata è un compromesso stipulato con la
verità. Emanciparsi dal linguaggio significa anche emanciparsi dalla costruzione
culturale che si eleva col linguaggio e quindi dalle religioni, che sono essenzialmente
costruzioni linguistiche.
8
J. F. LYOTARD, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, Milano 1985, in particolare il cap. IX,
Narrazione e legittimazione del sapere, pp. 58-69.
9
M. GAUCHET, Il disincanto del mondo. Una storia politica della religione, Einaudi, Torino 1992, p. 133 e ss.
Infine, credo che la dimensione nomade implichi anche una certa emancipazione
dall’idolo dell’identità personale e distinta, proprio di molto occidente. Possedere
un’identità significa riconoscersi in una forma definita, conosciuta, domestica e
quotidiana alla quale affidarsi senza scossoni né turbamenti. Il credente
contemporaneo, invece, percepisce quanto di mitizzato ci sia nella “favola
dell’identità” e lotta contro le certezze del “chi sono”, ossia contro ogni tentativo di
mettere delle didascalie a se stessi. La molteplicità dei linguaggi e delle culture che ci
avvolge ci spinge sempre di più a prendere coscienza di quella molteplicità insanabile
presente in noi stessi, di quella zona d’ombra e d’ambiguità che nessun proclama di
identità acquisita può cancellare. Di conseguenza, il nomade cerca non un dio che
non diffonda certezze, che possieda un volto conosciuto o conoscibile nel dettaglio,
ma un’emozione religiosa che lasci sfumati tutti i confini classificatori. E, se c’è un
desiderio sommerso nel mondo religioso postmoderno, è semmai quello della fusione
e non quello dell’identità separata e definita 10 , ossia è ricerca di quel “varco” di
montaliana memoria che conduca al di là del conosciuto e sia occasione di incontro
con qualcosa che superi e inglobi l’ego. E’ una lotta all’io, quindi, che ha, dal punto
di vista religioso, la conseguenza di far nascere un senso mistico di sconfinamento,
capace di condurre al di là di ogni scissione esistenziale.
Religiosità dell’eresia
In primo luogo, mi pare che il più significativo tratto della religiosità
contemporanea sia quello che si coniuga con l’eresia, come affermava già negli anni
Ottanta l’illuminata intuizione di P. L. Berger 11 . Il credente odierno è sempre spinto
un passo più in là rispetto ad ogni verità confezionata e narrata. Non credendo più
nelle grandi costruzioni di senso, non fidandosi più delle narrazioni fondanti, l’uomo
religioso di oggi è sempre in fuga dalle certezze, che avverte come una minaccia alla
sua integrità e alla sua libertà.
Al contrario, invece, l’uomo del nostro tempo sente la necessità di liberarsi dalla
perentorietà delle regole e dei dettami e vive la “religione” come forza capace di dare
ossigeno ad ogni dogmatismo, come scelta di autenticità grazie alla quale riuscire a
far emergere quella zona d’ombra che si agita in ognuno. La necessità di religione
odierna ci parla del bisogno di dissentire, di rovesciare, di dissacrare e di
risacralizzare dell’uomo contemporaneo, ossia viene ad essere una carica positiva ed
eversiva di trasformazione indispensabile per non essere omologati.
L’eresia permette di non considerare ermeticamente chiuso un sistema di
pensiero, permette allo stesso di essere dinamico e sempre aperto alla trasformazione,
di non soffocarsi con un dogmatismo perentorio e fondamentalistico. Il coraggio
dell’eresia non coincide con un’estetica del contrario e del differente, ma diviene
tensione profonda verso la molteplicità del reale, nella consapevolezza che nessuna
10
E. BACCARINI, Essere in sé – uscire da sé: la nuova provocazione antropologica, in: Id., op. cit., pp. 15-48.
Cfr. P. L. BERGER, L’imperativo eretico. Possibilità contemporanee di affermazione religiosa, Elle di ci, Leumann
(TO) 1987.
11
definizione e, quindi, nessun sistema, sono in grado, di per sé, di contenere la
complessità.
In questo tentativo della religiosità contemporanea di oltrepassare continuamente
i confini sta anche la grande responsabilità del nostro tempo: riuscire a parlare
linguaggi distanti, componendo agglomerati di pensiero che non necessariamente
seguano le regole dell’armonia occidentale. E’ un modo per liberarsi da quello che U.
Volli descrive come il “monoteismo culturale” che ci ha dominati e continua a
dominarci 12 , per aprirci ad un neopoliteismo del pensiero in cui le diversità possono
convivere e respirare insieme, senza ridursi né sincretizzarsi. La nuova sensibilità
religiosa vuole compiere il passo dalla visione negativistica e soffocante della
frammentazione elaborata dal pensiero novecentesco ad una concezione pacificata di
pluralismo, in cui le differenze siano veicolo di conoscenza intraculturale. Conoscersi
attraverso il diverso, in un’accezione propriamente psicologica, diventa l’imperativo
categorico delle nuove spiritualità, che affermano con la forza di cui sono capaci la
necessità di uscire da quel soffocante narcisismo culturale dell’occidente, per cui il
mondo incomincia e finisce attraverso i miei soli strumenti di comprensione.
Ma non si tratta di un ritorno alla tolleranza, che è un principio aristocratico e
poco produttivo. Si tratta di allenare la nostra coscienza al capovolgimento,
all’osservazione dei fenomeni da punti di vista differenti, alla comprensione
dell’alterità dall’interno del suo modo di coniugare se stessa e l’intero universo. Il che
non reprime il contrasto che si può creare fra le culture, non sminuzza né
omogeneizza l’irriducibilità delle differenze, ma allena alla comprensione che le
differenze possono convivere anche senza uniformarsi e che nessuna cultura detiene
una organizzazione lineare e chiara del senso del mondo.
Certo, si può giustamente obiettare che spesso il bisogno religioso contemporaneo
è, al di là di quanto detto, stritolato dai meccanismi del mercato, assoggettato alle
logiche occidentali, globalizzante e poco rispettoso. Ma quello che dobbiamo
cogliere, prima ancora del negativo, sono le grandi intuizioni della nuova sensibilità
religiosa. La religiosità, in questo senso, desidera tornare ad essere anche una grande
utopia storico-sociale, che sogna un mondo pacificato ed integrato, ma si fa
soprattutto nuova speranza, affermando implicitamente che il mondo ha un “qualche”
senso, magari non “dato” e fisso, ma da costruire; un senso profondo e autentico di
cui ognuno deve responsabilmente farsi garante e interprete, partendo da una radicale
– eretica, appunto – messa in discussione di sé.
CONCLUSIONE
Forse oggi come non mai abbiamo l’occasione per comprendere che lo
straniero, l’altro religioso, è necessario per calarsi con sempre maggiore
autenticità nel profondo del proprio discorso religioso, rendendosi conto,
simultaneamente, che ognuno è “altro” per l’altro. La sfida consiste nel
12
Cfr. U. VOLLI, Per il politeismo. Esercizi di pluralità dei linguaggi, Feltrinelli, Milano 1992
trovare una convergenza che non inquini l’adesione alla propria fede né
aggredisca quella altrui, ma tenti di fondare una profonda interazione, in
virtù della quale ognuno possa convertirsi alla Verità anche grazie alle verità
dell’altro. Un mondo religioso, insomma, che creda veramente in ciò che
professa, senza eludere i problemi, ma anche senza nascondersi sempre
dietro le difficoltà dell’incontro; che non sia schiavo dei numeri e non si
preoccupi solo di distinguere, ma sappia anche vivere la comunione e voglia,
semmai, convincere prima ancora di voler convertire.