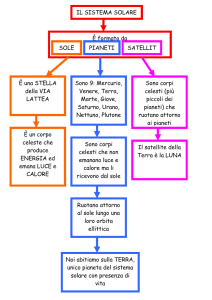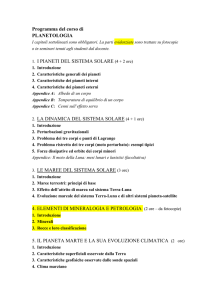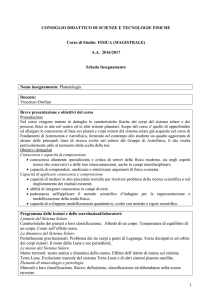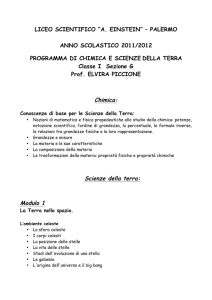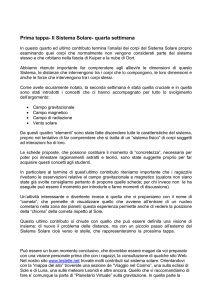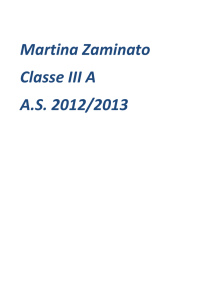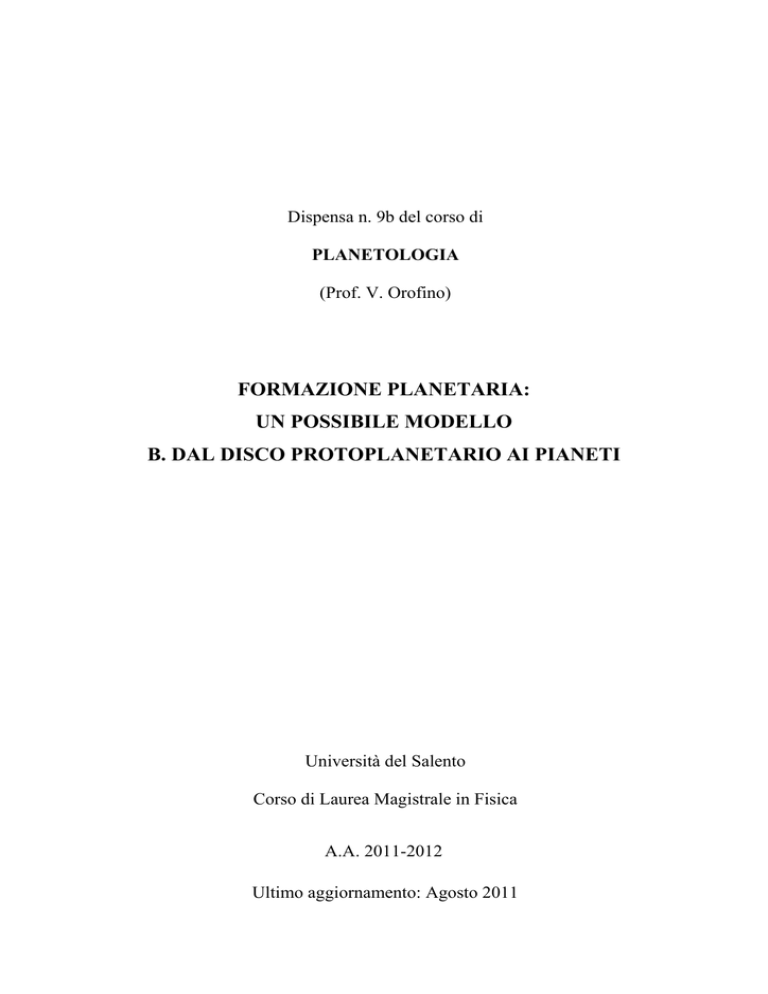
Dispensa n. 9b del corso di
PLANETOLOGIA
(Prof. V. Orofino)
FORMAZIONE PLANETARIA:
UN POSSIBILE MODELLO
B. DAL DISCO PROTOPLANETARIO AI PIANETI
Università del Salento
Corso di Laurea Magistrale in Fisica
A.A. 2011-2012
Ultimo aggiornamento: Agosto 2011
1. Caratteristiche generali del disco protoplanetario solare
Il Sistema Solare è un oggetto alquanto complesso composto da una stella
centrale, il Sole, attorno a cui orbitano i pianeti con i rispettivi satelliti, nonché
asteroidi e comete. Tali corpi si sono formati nell’arco di qualche centinaio di milioni
di anni a partire da un disco circumstellare (la cui formazione è stata descritta nella
dispensa precedente).
Evidentemente la massa del disco protoplanetario doveva essere almeno pari
alla massa attuale del Sistema Solare. Di questa si può dare però solo una stima
poiché non è facile calcolare quanta massa sia sotto forma di materia interplanetaria,
asteroidi e soprattutto comete. Il contributo della materia interplanetaria può essere
considerato trascurabile mentre quello degli asteroidi è di circa 3 1024 g e quello
delle comete, secondo le ultime stime, dovrebbe essere compreso tra 7 1029 e
1 1030 g (Duncan et al., 1995; Stern, 1995; Weissman, 1998). A circa 1027 g
ammonta il contributo dei satelliti, mentre i pianeti, le cui masse sono note con
precisione, forniscono una massa di circa 3 1030 g. Escludendo il Sole, la massa del
Sistema Solare attuale risulta globalmente di 2 10-3 M ed è per lo più concentrata
nel pianeta Giove. Tuttavia questo valore costituisce un limite inferiore poiché, se si
considerano le abbondanze chimiche degli elementi delle nebulosa protosolare (v.
tab.1) e si tiene conto del fatto che gli elementi più volatili (prevalentemente idrogeno
ed elio) sono scomparsi dalla zona dei pianeti interni, bisogna arrivare ad un valore
della massa della nebulosa di almeno 0.02 M, cioè dieci volte più grande del
precedente (Coradini et al., 1978; Ruden, 1999).
Tab. 1 Abbondanze relative (sia in massa rispetto a quella totale, che in numero di atomi per atomo
di silicio) di alcuni elementi presenti nel disco protoplanetario (da Coradini et al., 1980).
Elemento Percentuale in massa
N(X) /N(Si)
Caratteristiche
H
He
0.762
0.224
25000
2000
gassosi in tutte le regioni del disco
C
N
O
0.0032
0.0009
0.0072
10
3
20
volatili, condensano nelle regioni
esterne (T 150 K)
Mg
Si
Fe
0.0003
0.0006
0.0012
1
1
0.8
solidi, sono i maggiori costituenti
dei pianeti di tipo terrestre
2
Secondo alcuni ricercatori, come per esempio Cameron (1976), questo valore
è però ancora troppo piccolo perché bisogna tener conto anche di un altro
meccanismo che può aver contribuito in modo notevole a far perdere massa alla
nebulosa: il forte vento stellare emesso dal Sole nelle sue fasi iniziali (fase T Tauri).
Secondo Cameron (1976) l’intensa emissione di gas ionizzato solare non solo avrebbe
spazzato via gli elementi volatili nella zona dei pianeti interni, ma avrebbe fatto
perdere alla nebulosa anche una cospicua quantità di materiale solido. Pertanto
Cameron assume per la massa del disco protoplanetario un valore dell’ordine dei 0.1
M. Tuttavia secondo calcoli eseguiti da Safronov (1977), il meccanismo del vento T
Tauri difficilmente può essere responsabile di una grande fuoriuscita di materia dal
sistema planetario. In effetti il nostro Sole attraversò la fase T Tauri quando i pianeti
avevano già completato il loro accrescimento ed a quel punto, cioè a pianeti già
formati è difficile eliminare una grande quantità di materiale solido. Questa
osservazione, unita ad un grave problema di instabilità che compare quando la massa
del disco supera 0.3 M (Shu et al., 1990), ha ormai fatto abbandonare i modelli alla
Cameron che prevedono un disco massiccio.
In conclusione, quindi, all’inizio del processo di formazione planetaria il
Sistema Solare è costituito da un ammasso di gas e polvere concentrati in un disco di
massa pari a pochi centesimi della massa del Sole.
2. Formazione dei planetesimi di prima generazione secondo i primi modelli
Come già accennato in precedenza, i grani di polvere, dalle dimensioni via via
crescenti al passare del tempo, tendono a scendere verso il piano centrale sotto
l’azione della forza di gravità non efficacemente contrastata dalla forza associata alla
pressione del gas. Si forma allora una struttura stratificata in cui la polvere,
sedimentando sul piano centrale, tende ad addensarsi e a prevalere sul gas nelle
regioni poste immediatamente intorno a tale piano, mentre il gas predomina negli
strati al di sopra ed al di sotto di quello centrale. Inizialmente, il rapporto tra la
densità dei grani e quella del gas è circa pari a 1/60 nelle regioni più esterne dello
strato centrale, dove T 170 K; nelle regioni più interne, dove la temperatura
raggiunge i 1500 K e molta polvere sublima lasciando solo i solidi più refrattari, il
valore di scende a 1/240 (Hayashi, 1981). In ogni caso, al passare del tempo, il
rapporto di densità va aumentando sempre di più, raggiungendo alla fine un valore
dell’ordine dell’unità.
In assenza di turbolenze una configurazione a due strati del tipo ora descritto è
però instabile poiché basta una piccola perturbazione per far si che il disco
protoplanetario si frammenti in una serie di anelli concentrici che tendono
3
rapidamente a separarsi gli uni dagli altri contraendosi sotto l’azione
dell’autogravitazione. Gli anelli a loro volta sono instabili e tendono a frammentarsi
formando condensazioni di polvere che si contraggono fino a raggiungere la densità di
almeno 3 g/cm3, nella zona dei pianeti terrestri e di 0.01 g/cm3 in quella dei pianeti
esterni (Coradini, 1983). Tali aggregati di particelle non sono ancora corpi solidi, ma
possono essere pensati come delle enormi “nuvole di polvere” dalle dimensioni di
circa 400 km che alla fine condensano in corpi solidi denominati “planetesimi”
(Coradini et al., 1978). Questi ultimi sono corpi dalle dimensioni che vanno da uno ad
una decina di chilometri in prossimità del Sole e di qualche centinaia di chilometri
nelle regioni esterne (Coradini, 1983). Le masse di questi corpi sono tali da
disaccoppiarli totalmente dal gas e farli muovere con moto kepleriano attorno alla
stella (Coradini et al., 1978).
Il meccanismo della formazione dei planetesimi, è stato studiato per la prima
volta da Safronov (1969) e indipendentemente da Goldreich e Ward (1973). Questi
autori hanno trovato che il disco diventa instabile se la sua densità superficiale supera
un certo valore critico dato da:
c
,
G
(1)
dove = (G/r3)1/2 è la cosiddetta “frequenza di Keplero”, mentre c rappresenta la
velocità del suono nel gas, molto vicina a quella termica media delle particelle che lo
costituiscono. Se la densità del disco supera *, allora quest’ultimo, secondo i
processi descritti in precedenza, si frantuma in agglomerati in cui le particelle,
attraendosi per la mutua forza gravitazionale, condensano in planetesimi. Ed è questo
secondo Safronov (1969) e Goldreich e Ward (1973) l’unico modo possibile per
spiegare la formazione di tali corpi. Qualsiasi processo di adesione tra grani viene
trascurato dal momento che secondo questi autori la crescita dei grani per le collisioni
binarie e la conseguente coagulazione è un meccanismo che richiederebbe tempi
molto lunghi.
Le dimensioni e la massa dei frammenti che si creano nel disco sono
rispettivamente c = 5 108 cm ed m 1018 g, dai quali si formano corpi solidi di
massa inferiore a 2 1014 g e dimensioni inferiori a 0.5 km (Goldreich e Ward, 1973).
Questi costituiscono i così detti “planetesimi di prima generazione”.
4
3. Formazione dei planetesimi di prima generazione secondo i modelli più
recenti: ruolo delle turbolenze
Nell’ultimo decennio sono state mosse numerose critiche al modello sopra
descritto perché troppo semplicistico, in quanto considera la formazione dei
planetesimi direttamente dalle particelle micrometriche attraverso l’autogravitazione,
trascurando ogni altro processo di adesione (Wetherill, 1980; Weidenschilling, 1988).
In effetti la forza di gravità che interessa particelle delle dimensioni del micrometro è
trascurabile rispetto a quella associata alla pressione del gas; pertanto, quello che
porta alla formazione di aggregati di grani non può essere solo la gravità, ma questa
tutt’al più potrebbe subentrare in un secondo momento, quando si sono già formati
corpi di dimensioni superiori al metro (Weidenschilling, 1994). Di fatto, fino a
quando gli agglomerati in via di formazione sono di dimensioni inferiori al metro, essi
risentono della presenza del gas che li trascina nel suo moto. Ed è proprio per questo
effetto di trascinamento e per la discordanza tra la velocità del gas e quella kepleriana
posseduta dalle particelle, che si dovrebbero creare delle turbolenze all’interno del
disco. In altre parole l’attrito tra il gas e i grani di polvere è una delle principali cause
delle turbolenze nel disco che si manifestano come dei vortici sia sul piano del disco
che lungo la direzione ad esso perpendicolare. Le dimensioni di questi vortici possono
variare enormemente. Infatti, come da una nube molecolare si formano nubi
protostellari più piccole, anche nel disco protoplanetario si ha una ridistribuzione dei
grandi vortici in uno spettro di vortici di dimensioni minori. Si noti che l’attrito tra gas
e polvere genera moti turbolenti anche in assenza di altre cause. L’effetto delle
turbolenze è quello di inibire il raggiungimento della densità critica richiesta *
(Weidenschilling, 1997).
In ogni caso, anche ammesso che la densità critica si raggiunga e si instauri
l’instabilità gravitazionale, affinché questa continui si deve considerare un’altra
importante condizione; e cioè che la dispersione delle velocità deve essere minore di
un valore critico, condizione che viene raggiunta solo quando le particelle hanno
dimensioni di qualche metro (Weidenschilling, 1994).
Si deve comunque osservare che nelle regioni più esterne della nube è più
facile raggiungere l’instabilità, perché tutta una serie di condizioni favorevoli la
facilitano. Prima di tutto il valore * è più basso a causa della lontananza dal Sole (in
quanto sono più bassi sia che c); inoltre si trova una più bassa densità del gas, e
quindi una minore trazione che questo esercita sulle particelle (Weidenshilling, 1994).
Secondo questo scenario, quindi, i planetesimi non si sarebbero formati
esclusivamente per instabilità gravitazionale, ma anche per l’accrescimento dei grani
in seguito alla loro collisioni binarie, quanto meno fino alla formazione di corpi
dell’ordine del metro, quando finalmente potrebbe essere intervenuta l’instabilità
5
gravitazionale prima citata. La mancanza di studi approfonditi sull’argomento,
successivi ai pionieristici lavori di Safronov (1969) e Goldreich e Ward (1973) lascia
però ancora aperta la possibilità che l’instabilità gravitazionale possa essersi instaurata
già nelle prime fasi, quando i grani erano ancora delle dimensioni di qualche
micrometro. In particolare, proprio l’attrito del gas potrebbe fornire una causa di
instabilità non ostacolata dalle turbolenze (Ward, 1999).
4. Collisioni binarie ed accrescimento dei grani
Nella prima fase della nascita di un sistema planetario, la componente solida è
costituita da grani interstellari sopravvissuti al collasso della nube e/o da particelle
direttamente condensate all’interno del disco (laddove le condizioni di densità e
temperatura lo consentano). Tutti questi grani sono composti principalmente da ferro,
olivina ((MgFe)2 SiO4), quarzo (SiO2), troilite (FeS), sostanze organiche varie e
ghiaccio d’acqua (Pollack et al., 1994).
Nei correnti modelli standard la formazione dei pianeti terrestri e degli
eventuali nuclei solidi dei pianeti giganti avverrebbe dall’accumulazione dei piccoli
grani micrometrici che, aggregandosi durante le collisioni binarie, aumentano le loro
dimensioni di un fattore 1013 e la loro massa di un fattore 1040 (Beckwith et al., 2000).
La crescita dei grani dipende da meccanismi di aggregazione non
gravitazionali e comincia già nel mezzo interstellare, sebbene qui sia molto lenta a
causa delle grandi distanze tra i grani nel mezzo estremamente rarefatto. Inoltre,
raggiunge probabilmente un valore limite per la presenza di un fattore equilibrante
costituito dagli urti ad alta velocità che tendono a distruggere e frammentare i grani
stessi (Coradini e Magni, 1978).
I più importanti processi di aggregazione dei grani di polvere sono legati alla
presenza di forze attrattive che si esercitano quando i grani si avvicinano e si urtano a
causa dell’agitazione termica e dei moti browniani (ovvero moti disordinati e casuali
delle particelle microscopiche legati al movimento delle molecole del gas).
Un primo tipo di forza è legata alla carica elettrica posseduta dai grani e dagli
aggregati. In effetti durante le collisioni le particelle possono acquistare una carica
elettrica a causa di processi di triboelettricità (vedi Appendice B). Inoltre nel mezzo
interstellare e quindi anche nella nube protoplanetaria, c’è un continuo passaggio di
elettroni dai grani al gas, causato sia dalle collisioni tra atomi e ioni, sia dall’effetto
fotoelettrico dovuto alla radiazione ultravioletta che causa la fuoriuscita di elettroni
dal materiale di cui sono composti i grani. Questi avranno alla fine una carica che
6
dipende dalle condizioni fisiche del gas circostante, dalla loro composizione chimica e
dimensione (Coradini e Magni, 1978) e saranno soggetti a forze elettrostatiche che
secondo recenti esperimenti sono di norma attrattive (Poppe et al., 2000b).
Un’altra forza attrattiva è data dalla forza di Van der Waals. Tale forza è una
versione più debole delle forze di dipolo-dipolo, ovvero le forze che si esercitano tra le
molecole che possiedono dei dipoli permanenti. Le forze di Van der Waals sono anche
dette “forze di dipolo indotto”, poiché l’attrazione avviene quando molecole non polari
diventano polari per un breve periodo di tempo. Anche le molecole che non
possiedono un dipolo permanente, infatti, possono acquisirne uno temporaneo.
All’inizio i loro elettroni sono costantemente in moto in modo tale da costituire una
struttura che globalmente ha carica totale neutra. Se il moto degli elettroni è, però,
disturbato, può succedere che in alcune parti della molecola si crei un accumulo di
carica negativa; si ha quindi una separazione tra i baricentri delle cariche positive e
negative, cosicché la molecola acquista temporaneamente un momento di dipolo,
finché non si ristabilisce l’equilibrio delle cariche elettriche. Durante questo periodo in
cui la molecola si comporta da dipolo, disturba la distribuzione di carica nelle
molecole vicine generando altri dipoli temporanei con i quali si stabilisce un legame
(Brandvold, 2000). Tuttavia, sia le forze di Van der Waals che le forze elettrostatiche
hanno un raggio d’azione molto corto e sono rilevanti solo fino a quando si parla di
particelle delle dimensioni del micrometro che si muovono accoppiate con il gas
moderatamente turbolento (Weidenschilling, 1980). Quando le dimensioni crescono
cominciano a diventare rilevanti altri aspetti legati alle collisioni binarie tra le
particelle come ad esempio i processi anelastici, che portano i corpi collidenti ad
accrescersi quando si incastrano e si conficcano gli uni dentro gli altri.
Dopo una prima fase in cui, ai fini delle collisioni è fondamentale il moto
legato all’agitazione termica, acquista un’importanza sempre maggiore il moto delle
particelle verso il piano centrale legato alla sedimentazione o il moto radiale dovuto
principalmente al decadimento dell’orbita per effetto del frenamento del gas o per i
moti turbolenti legati ai fattori descritti in precedenza. Diventa quindi importante
quella che è la forma delle particelle ed alcune loro caratteristiche come ad esempio la
compattezza e la composizione, perché tutto ciò influisce direttamente sulle
caratteristiche aerodinamiche delle particelle. Nell’Appendice A si discuterà anche
l’importanza ad esempio di uno strato di ghiaccio che ricopre gli aggregati e ne facilita
la crescita per le sue caratteristiche di adesività. Solo dopo che le particelle hanno
raggiunto le dimensioni del metro subentra la gravità come forza legante, che porta i
corpi di quelle dimensioni a raccogliere la polvere rimasta mescolata al mezzo
circostante raggiungendo le dimensioni dei planetesimi.
La crescita dei grani di polvere è fortemente influenzata dalla temperatura che
gioca un ruolo diverso a seconda della zona del disco che si considera. T varia in
7
funzione della distanza dalla stella centrale: quanto più ci si allontana dalla stella,
tanto più diminuisce la temperatura. In prossimità della stella infatti dove la
temperatura è elevata al punto da fondere il materiale solido, la capacità di
aggregazione aumenta per la tendenza che hanno le gocce di un liquido, urtandosi di
formare gocce più grosse (Coradini e Magni, 1978). Per questo si ipotizza che in
questa regione si possano formare più facilmente particelle di massa di qualche
grammo (Coradini e Magni, 1978). Le zone più esterne invece sono più fredde, ma
ciò non vuol dire che lì non ci sia accrescimento; tutt’altro. In queste zone compare
un’altra forma di aggregazione delle particelle dovuta alla condensazione di strati di
ghiaccio sui grani e gli agglomerati. Un tale rivestimento è fondamentale perché
influisce sul comportamento dinamico delle particelle in due modi: prima di tutto
favorisce la perdita di energia nella collisione ammortizzando l’urto e poi favorisce
l’accrescimento con le sue caratteristiche strutturali e l’elevata capacità di unificare
più corpi (Bridges et al., 1996). Tuttavia, un tale processo è importante per la crescita
delle particelle submicrometriche, ma irrilevante per la crescita delle particelle dal
micrometro al metro o al chilometro (Preibisch et al., 1993).
In realtà la temperatura può dipendere anche dall’altezza sul piano,
presentando spesso forti discontinuità avvicinandosi ad esso. Così le particelle che
sedimentano, possono attraversare fasi di sublimazione e di condensazione che
influiscono sulla loro forma e struttura interna originale (Nelson et al., 2000).
La temperatura gioca un ruolo importante nella fase in cui il disco è opaco alla
radiazione stellare che non riesce a raggiungere la periferia e riscaldarla. Quindi questa
rimane molto fredda e tale condizione le permette di trattenere con molta facilità il gas
che rimane mescolato alla polvere per molto più tempo rispetto alle zone più interne e
più calde. In queste zone, infatti, l’alta temperatura favorisce il deflusso del gas verso
l’esterno del disco protoplanetario. Ciò spiega anche come mai i pianeti che si trovano
al di qua della fascia degli asteroidi sono di natura rocciosa, mentre i pianeti giganti
sono di natura gassosa. Si intuisce così che a seconda del luogo considerato, le
particelle, i planetesimi e i pianeti, possono avere caratteristiche molto diverse, così
come a seconda della fase evolutiva considerata risultano diversi i meccanismi di
aggregazione delle particelle solide.
Nel disco esiste una discrepanza tra la velocità del gas ad una data distanza
dalla stella centrale e quella che le particelle dovrebbero avere se si muovessero in
orbita kepleriana a quella stessa distanza. Detta Vg la velocità del gas e Vk quella
kepleriana delle particelle, la quantità V = (Vk – Vg) rappresenta lo scarto della
velocità del gas da quella kepleriana, che è stimato dalla teoria di Hayashi et al.
(1985) in un valore molto minore della velocità del suono (c), ossia: V = 5400 cm/s.
E’ per questo motivo che nelle prime fasi evolutive del disco le particelle (che sono
trasportate dal gas) hanno una velocità inferiore rispetto a quella che dovrebbero avere
8
se non ci fosse il gas e ciò almeno fino a quando non si formano corpi di dimensioni
sufficienti (i planetesimi) per disaccoppiarsi dal gas. In realtà, comunque, i corpi
cominciano a disaccoppiarsi dal gas già quando raggiungono le dimensioni del metro,
per muoversi poi con moto perfettamente kepleriano una volta assunte le dimensioni
dei planetesimi (Weidenschilling, 1997).
Per studiare la dinamica dei grani e dei loro agglomerati è comodo rifarsi alla
dinamica dei fluidi ed introdurre quindi un parametro che permetta di valutare se e
quanto tali particelle sono accoppiate al gas. Si introduce così il “tempo di risposta”
che si indica con te ed è dato da (Weidenscilling e Cuzzi, 1993):
te
mV
Fd
dove m e V sono la massa e la velocità delle particelle, mentre Fd è la forza legata al
trascinamento che esercita il gas, che dipende sempre dalle dimensioni e dalla velocità
delle particelle nonché dalle proprietà locali del gas. Queste altre si esprimono
attraverso due parametri fondamentali: i numeri di Reynolds e di Knudsen
(rispettivamente: Re =Vd/, con d che è il diametro della particella, la viscosità
molecolare; Kn = /d, con libero cammino medio).
In classiche condizioni nebulari, essendo di norma le dimensioni delle
particelle inferiori al loro libero cammino medio, si ricorre alle leggi dei fluidi di
Epstein, in cui Fd = - (1/3) d 2 c V, dove si ricorda che è la densità volumetrica
del gas. Per una particella sferica, con opportune sostituzioni si trova (Weidenscilling
e Cuzzi, 1993):
te
d p
(2)
2 c
con p che rappresenta la densità del materiale costituente le particelle. Questo
parametro può essere interpretato come il tempo di cui ha bisogno un agglomerato per
adeguarsi al moto del gas e comuoversi con esso.
Un parametro importante da cui dipende te, è la forma degli agglomerati che,
data la casualità con cui si uniscono i grani, risulta altamente irregolare (si ricordi che
la (2) si riferisce invece ad una struttura a simmetria sferica di diametro d). Un
esempio della complessità degli aggregati di polvere è riportato in fig. 1. Per le loro
caratteristiche strutturali tali oggetti si possono trattare come “frattali”
(Weidenschilling e Cuzzi, 1993), cioè sistemi che possiedono strutture molto
9
irregolari a tutte le scale, con le strutture di piccola scala che sono simili a quelle a
scala più grande (Pietronero et al., 1998). A questi oggetti si attribuisce una
“dimensione frattale” D, legata implicitamente alla loro irregolarità.
Fig. 1 – Modello di grano frattale di dimensione D = 2.1 riprodotto al computer. La sua struttura
irregolare è fondamentale nello studio della coagulazione, perché una tale proprietà è tipica dei grani
presenti nella nube protoplanetaria (da Weidenschilling e Cuzzi, 1993).
Per capire però se le particelle sono o no accoppiate al gas, bisogna effettuare
un confronto di te con l’inverso della frequenza di Keplero (). Si trova che, se
te 1/, ossia te 1, le particelle sono fortemente accoppiate al gas e le forze di
attrito viscoso costringono le particelle a comuoversi con il gas. Quando te 1 la
gravità del Sole domina e le particelle si muovono con moto kepleriano. Poiché te
dipende dal rapporto massa/area e questo aumenta con le dimensioni, si ha che i
piccoli aggregati sono fortemente accoppiati al gas mentre quelli più grandi e più
compatti risentono sempre più debolmente del gas e maggiormente della gravità
solare (Weidenscilling e Cuzzi, 1993).
Si definiscono piccole particelle quelle per cui te 1, e grandi quelle che
hanno te 1. Per modelli nebulari di bassa concentrazione di massa (M 0.1 M),
la transizione tra il diametro dei piccoli e dei grandi oggetti si ha quando te 1, che
corrisponde ad un diametro di circa 1 metro ed é indipendente dalla distanza dal Sole
(Weidenschilling, 1977).
10
5. Planetesimi della seconda generazione ed instabilità del gas
Indipendentemente da come possano essersi formati i planetesimi di prima
generazione (se per instabilità gravitazionale o per le continue collisioni binarie), la
fase successiva che porta alla formazione dei planetesimi di seconda generazione,
ovvero di corpi più massicci e più grandi dei precedenti, è sicuramente controllata
dalle forze attrattive legate alla gravità.
Secondo Cameron (1976) i planetesimi di prima generazione dopo la loro
formazione si raggruppano in piccoli ammassi composti da 104 membri che ruotano
attorno ad un asse comune e sono abbastanza stabili contro il collasso gravitazionale
(il valore di cambia, se pur di poco dalla teoria di Safronov in cui vale 0.1 ed in
quella di Goldreich e Ward in cui vale 0.25 ). Tali ammassi non si fondono in un
solo grande aggregato solido a causa del momento angolare dei corpi che li
costituiscono, che li fa ruotare velocemente intorno al centro di gravità dell’ammasso.
Tuttavia, quando due ammassi si avvicinano, si fondono in uno solo; in tal caso la
fluttuazione del campo gravitazionale dovuta alla formazione del grande ammasso,
provoca un violento rilassamento dinamico dei moti dei corpi, di modo che molti di
essi si fondono per formare dei nuclei intorno a cui altri entrano in orbita.
Incontri ravvicinati tra ammassi non sono rari in questo periodo poiché essi
interagiscono gravitazionalmente tra loro su distanze abbastanza grandi. Molto
lentamente, così, si formano quei corpi che sono normalmente denominati
“planetesimi di seconda generazione” di massa e raggio dati rispettivamente da
(Goldreich e Ward, 1973):
m 2 1018 2 g ,
2
r 5 3 km
che, considerato l’ordine di grandezza di , devono avere massa dell’ordine di 1017 g e
diametro al più di pochi chilometri.
Per concludere il discorso sull’instabilità gravitazionale occorre notare che tale
processo potrebbe interessare anche il gas che fa parte della nube protoplanetaria.
Infatti dalla (1) si può ottenere un valore critico anche per la densità superficiale del
gas; esso vale (Goldreich e Ward, 1973):
g * = 7.6 103 T 1/2 g/cm2 .
(3)
Se si assume una massa del disco pari a 0.01 , dalla sua estensione si ricava un
valore della densità superficiale media data da g = 1.5 103 g/cm2 (Goldreich e
11
Ward, 1973). Ciò implica per la (3) che il disco è instabile per T 0.04 K. Ma
essendo questa temperatura inaccettabilmente bassa si deve concludere che, in tale
caso, nel gas non si instaura mai un’instabilità gravitazionale. Tuttavia se il disco
avesse una massa M = 1 , rifacendo i conti il disco risulterebbe instabile per T
400 K. Siccome in gran parte del disco questa condizione risulta soddisfatta, si può
quindi concludere che soprattutto nelle parti più esterne del disco si potrebbe
innescare l’instabilità gravitazionale del gas che porterebbe alla formazione di grandi
protopianeti gassosi.
6. Accrescimento dei planetesimi e formazione degli embrioni planetari
Una volta che i planetesimi si sono formati ed hanno cominciato ad orbitare
attorno al Sole non influenzati dal gas, questi corpi continuano ad interagire
gravitazionalmente, urtandosi gli uni contro gli altri, tendendo nuovamente a
frammentarsi e diffondere nello spazio uno sciame di detriti di dimensioni ridotte.
A questo punto è determinante la massa del più grande frammento prodottosi.
Se infatti questo è sufficientemente massiccio, è improbabile che una successiva
collisione lo frantumi o gli sottragga una grande quantità di massa, così la sua
attrazione gravitazionale è sufficientemente grande da permettergli di catturare le
particelle che gli passano vicino e le sue dimensioni possono così aumentare. Questo
processo di crescita (comunemente denominato “runaway”), porta alla formazione dei
cosiddetti “embrioni” dei futuri pianeti, di dimensioni comprese tra 200 e 500 km e
massa compresa tra 1025 e 1027 g (Wetherill e Stewart, 1989).
Il problema della formazione degli embrioni è stato approfonditamente
affrontato da diversi lavori. Questi studi si dividono in due categorie: quelli basati su
un approccio analitico di tipo statistico legato allo sviluppo delle equazioni della
coagulazione delle particelle (Safronov, 1969; Nakagawa et al., 1983; Wetherill e
Stewart, 1988; Weidenshilling et al., 1997); e quelli basati su simulazioni al
calcolatore che hanno come oggetto l’evoluzione dinamica di sistemi ad N-corpi
(Wetherill e Stewart, 1998, Wetherill, 2000; Kokubo e Ida, 1996, 2000; Richardson et
al., 2000).
Per quanto riguarda i modelli che sfruttano il primo approccio, vi è da dire che
i primi lavori sono stati realizzati da Safronov (1969) e Nakagawa et al. (1983).
Secondo questi autori la formazione degli embrioni avviene attraverso una crescita
ordinata, in cui da un gran numero iniziale di planetesimi della stessa massa (circa
1010 corpi di massa m = 1018 g) si giunge alla formazione di circa mille corpi di massa
pari a 1025 g. Wetherill e Stewart (1989) hanno dimostrato, invece, che diversi
12
processi non considerati in questi primi lavori possono condurre ad una crescita
oligarchica (runaway) di pochi corpi di dimensioni maggiori che si accrescono più
rapidamente di quelli vicini andando a formare gli embrioni planetari. Tra i due più
importanti processi di questo tipo, si devono ricordare la frantumazione dei
planetesimi durante le collisioni e la ridistribuzione dell’energia dai corpi più grandi a
quelli più piccoli durante gli incontri ravvicinati. In particolare Stewart e Kaula
(1980) hanno trovato che la mutua interazione tra i planetesimi che si incontrano
percorrendo orbite eliocentriche si può anche esprimere in termini di viscosità, simile
a quella che si esercita tra le particelle di un fluido. Questa viscosità conduce ad una
trasformazione dell’orbita da circolare in eccentrica. Inoltre negli incontri ravvicinati
l’attrito dinamico dovuto alla viscosità, decelera i planetesimi più massivi ed accelera
quelli di piccole dimensioni tendendo verso una equipartizione dell’energia, contro
quanto affermato da Safronov (1969). Secondo Wetherill e Stewart (1989) tale
equipartizione conduce ad una crescita preferenziale dei planetesimi più grandi e dà
quindi luogo al runaway.
Un altro importante risultato è stato raggiunto poi da Wetherill e Stewart
(1993), riguardo alla ricostruzione delle fasi della frammentazione dei corpi. Questi
autori hanno trovato che tale processo contribuisce a riempire in continuazione lo
spazio di piccoli corpi con una bassa velocità relativa, in modo tale da agevolare la
cattura e quindi la crescita dei corpi maggiori. I frammenti residui che non sono
catturati, invece, hanno dimensioni abbastanza piccole da essere trascinati per l’attrito
del gas e spiraleggiare sulla stella ripulendo così lo spazio circostante (Wetherill e
Stewart, 1993).
Per quanto riguarda i modelli basati sulle simulazioni al calcolatore, bisogna
notare che vi è un’ottima concordanza tra i risultati che portano a concludere che il
tempo necessario perché si formino gli embrioni planetari è di circa 105 anni ad 1 UA
dal Sole e che il tempo aumenta con l’aumentare della distanza. Da queste simulazioni
emerge anche un altro risultato importante riguardante l’orbita degli embrioni che
appare quasi circolare, con un’eccentricità pari a 10-410-5 (Wetherill e Stewart,
1989).
Un altro importante risultato è costituito dalla verifica che la presenza di un
pianeta di grandi dimensioni (tipo Giove), posto in un’orbita esterna alla zona dei
pianeti terrestri, non ostacola la loro formazione, ma tutt’al più quella degli oggetti
che si trovano a ridosso della sua orbita (giustificando anche l’attuale distribuzione
dei corpi nella fascia degli asteroidi).
Nei lavori più recenti, Wetherill e Stewart (1998) partono da corpi delle
dimensioni di 15 m, che nel giro sempre di 105 anni, si accrescono in embrioni di
massa pari a 10261027 g. La crescita per runaway, comunque comincia solo dopo che
13
si sono formati corpi di dimensioni di 110 km, in quanto fino a quelle dimensioni i
planetesimi si accrescono in maniera ordinata per un periodo che dura circa 50000
anni. Inoltre la maggior parte della massa iniziale rimane concentrata in corpi di
diametro medio pari a 1 km (contro i 10 km dei lavori precedenti), mentre il 10 si
raggruppa in embrioni dal diametro di 2000 km circa.
Le varie tappe del processo ora descritto, che porta dalla nube protoplanetaria
alla formazione degli embrioni planetari, sono mostrate in fig. 2.
Fig. 2 – Evoluzione della nube protoplanetaria. (a): L’inviluppo protoplanetario, costituito da gas e
particelle micrometriche, si stacca dalla protostella; (b): Si crea un disco appiattito in cui le particelle si
accrescono per le loro collisioni binarie, fino a raggiungere le dimensioni del metro; (c): I corpi
continuano ad accrescersi per le collisioni binarie (e probabilmente a causa dell’insorgenza di
instabilità gravitazionale), formando i planetesimi di prima generazione che si riuniscono in ammassi
(non in scala); (d) Si formano successivamente gli embrioni planetari (da Coradini et al., 1980).
14
7. Formazione dei pianeti e comparsa in essi di un moto di rotazione assiale
diretto
La crescita degli embrioni planetari continua fino a quando questi non hanno
raccolto, in un’epoca dominata da violentissime collisioni, tutti i planetesimi minori
rimasti ad orbitare attorno al Sole che ricadono nel loro raggio di azione.
All’aumentare delle dimensioni dell’embrione maggiore, segue un
ampliamento della sua sfera d’azione, tanto da perturbare l’orbita dell’embrione
minore più vicino che viene così catturato. Il processo si esaurisce quando i corpi
formati, che ormai possono essere chiamati pianeti, sono a distanze tali da non potersi
influenzare gravitazionalmente in maniera tale da distruggere la stabilità dinamica del
sistema.
Secondo il modello di Safronov (1969) la massa m di un embrione di raggio r
cresce in maniera proporzionale alla sezione d’urto di collisione, alla densità
superficiale p del materiale solido che si trova nella sua zona di accrescimento ed in
maniera inversamente proporzionale al periodo P di rivoluzione dell’embrione intorno
al Sole, cioè:
p
dm
4 r 2 1 2
4 r 2
dt
P
2Gm p
1
r v 2 P
(4)
dove è un parametro adimensionale compreso tra 2 e 7, mentre v è la velocità
relativa media dei corpi collidenti; quest’ultima è dell’ordine della velocità di fuga
dall’embrione e quindi vale:
v2
Gm
.
r
Nella (4) la grandezza r2 ( 1 + 2 ) è la sezione d’urto efficace dell’embrione
planetario. Tale sezione d’urto non è evidentemente quella geometrica perché tiene
conto dell’effetto focalizzante della forza gravitazionale.
Secondo questo modello gli embrioni riescono a perturbare gravitazionalmente
prima e catturare per urti poi tutti i corpi all’interno di una zona la cui ampiezza è
migliaia di volte maggiore del loro diametro (v. fig. 3) dando alla fine origine ai
pianeti.
15
Fig. 3 – Geometria del processo di accumulazione protoplanetaria (da Paolicchi, 1979).
Si dovrebbe in tal modo spiegare la legge di Titius-Bode che nella sua forma
più conosciuta si esprime come:
dn = 0.4 + 0.3 2n
( n = - , 0, 1, ......., 7 )
(dove dn è la distanza media orbitale dell’n-esimo pianeta in UA) e al di là della
numerologia, dovrebbe in qualche modo riflettere un meccanismo fisico (ancora quasi
completamente sconosciuto) che, nel processo di accrescimento degli embrioni, ha
privilegiato certe posizioni piuttosto che altre, dando luogo ai vari pianeti.
Dalla (4) si ricava che il tempo di formazione di un pianeta vale in prima
approssimazione (Safronov, 1969):
1 P
rp
2 p
(5)
(con e rp che rappresentano rispettivamente la densità e il raggio del pianeta
definitivamente formato). Si può così vedere che il processo di formazione del
Sistema Solare richiede un tempo compreso tra qualche decina ed alcune centinaia di
milioni di anni alla fine dei quali il Sistema Solare raggiunge una configurazione
simile a quella attuale. Questo valore teorico è consistente con i risultati delle
simulazioni eseguite da Wetherill (1988) e da Weidenschilling (2000).
16
Scendendo più in dettaglio è importante, però, precisare che dopo 100 milioni
di anni solo i pianeti terrestri hanno più o meno raggiunto le loro dimensioni attuali.
Nella zona dei pianeti giganti i processi di accumulazione sono infatti complicati dalla
presenza del gas e dai processi di eiezione di materiale verso l’esterno. Tale processo
di accrescimento può essere grossolanamente distinto in due fasi: dapprima
l’accumulazione di embrioni allo stato solido con meccanismi del tipo di quelli che
interessano pianeti terrestri e successivamente la cattura del gas presente nella
nebulosa.
Nella descrizione data da Cameron (1976) la formazione dei pianeti esterni si
attuerebbe nel seguente modo: al crescere della massa del nucleo solido dell’embrione
planetario, il gas del disco viene concentrato gravitazionalmente nei pressi
dell’embrione stesso; con la crescita continua di quest’ultimo la quantità di gas
concentrato vicino al nucleo aumenta più rapidamente della massa del nucleo stesso e
così, ad un certo punto, l’embrione raggiunge una massa critica (che dipende dalle
condizioni di temperatura del gas circostante e che ad esempio nel caso di Giove e
Saturno è di 10 20 masse terrestri) tale che il gas diventa idrodinamicamente
instabile e collassa sul nucleo planetario.
Il processo di accrescimento del protopianeta solido, fino a raggiungere una
massa tale da consentire la cattura del gas, dovrebbe richiedere, come per i pianeti
terrestri, un tempo dell’ordine dei 100 milioni di anni. Secondo Coradini et al. (1978)
la seconda fase dovrebbe avere invece una durata decisamente più breve; circa 10
mila anni nel caso di Giove e Saturno, ma in generale è fortemente legata alle
condizioni presenti negli specifici dischi protoplanetari considerati.
Occorre però ricordare che nelle ultime simulazioni sulla formazione del
Sistema Solare (Kokubo e Ida, 2000), la massa finale che dovrebbe raggiungere
l’embrione di Giove prima di iniziare la cattura del gas circostante risulta pari a 5
masse terrestri (Mt) e si attuerebbe in un periodo di circa 107 anni. Secondo altre
simulazioni eseguite, invece, da Inaba e Wetherill (2001) il pianeta Giove potrebbe
completare la sua formazione addirittura in 2 106 anni.
I principali componenti delle atmosfere di Giove e Saturno sono idrogeno ed
elio e si ritiene che questi pianeti abbiano acquisito la maggior parte della massa
proprio attraverso processi di concentrazione e di collasso del gas. Idrogeno ed elio
sono invece responsabili di una piccola frazione della massa di Urano e Nettuno, fatto
che dimostra che probabilmente i loro nuclei non raggiunsero mai le dimensioni
critiche per il collasso idrodinamico; questi pianeti crebbero però abbastanza per
conservare gran parte dell’idrogeno e dell’elio che si erano concentrati per gravità in
prossimità del loro nucleo.
17
Per quanto riguarda Urano, Nettuno ed in parte anche Saturno, bisogna notare
che esistono notevoli difficoltà per spiegare la loro formazione dato che essa
richiederebbe tempi che, per la (5), risultano essere più lunghi dell’età del Sistema
Solare. La situazione non è però senza speranza perché, in base alla (5), per
abbreviare si possono invocare grandi valori del prodotto p; in particolare per
ottenere tempi di formazione accettabili per Urano e Nettuno è necessario che il
prodotto suddetto risulti pari almeno a 100 g cm-2 e questo valore non è irragionevole
se si tiene conto che la densità attuale è sicuramente sottostimata a causa
dell’espulsione di materia da quella zona e che è certamente maggiore di 5 a causa
della presenza del gas.
Tempi brevi sono richiesti anche per la formazione di Giove, in modo che le
sue perturbazioni gravitazionali sulle zone vicine ed interne possano essere usate per
giustificare la presenza della fascia asteroidale e la massa anomala di Marte.
Un problema a parte è rappresentato poi da Plutone, la cui piccola massa,
l’esistenza di un satellite paragonabile al primario, l’orbita molto eccentrica e
inclinata indicano l’intervento di meccanismi ad hoc rispetto al modello di formazione
qui descritto.
L’intero processo di formazione del Sistema Solare, dalla polvere fino ai
pianeti, è rappresentato nella fig. 4.
La rotazione diretta dei pianeti deve essere un prodotto secondario del
processo di formazione. Giuli (1968) ha mostrato che nel calcolo del momento
angolare assiale il contributo dominante (pari a circa il 90%) è dato dai planetesimi
che urtano l’embrione su orbite quasi tangenti in afelio o in perielio. Infatti mentre
l’embrione si muove su un’orbita quasi circolare i planetesimi percorrono orbite
ellittiche. Ciò fa sì che, per i corpi su orbite tangenti “dall’esterno” la velocità al
perielio è maggiore di quella dell’embrione e pertanto i planetesimi raggiungono
l’embrione e l’impattano dall’esterno, trasferendo momento angolare in senso diretto
(ossia in senso antiorario guardando l’embrione dal suo polo Nord). Un
ragionamento analogo vale per i planetesimi tangenti “dall’interno”, per i quali la
velocità all’afelio è minore di quella dell’embrione e questa volta sono i planetesimi
stessi ad essere raggiunti e trasferire il momento angolare in senso diretto (v. fig. 5).
Infine le diverse inclinazioni degli assi di rotazione dei vari pianeti possono
essere state determinate da impatti sporadici di corpi massivi che hanno potuto essere
equilibrati solo da una modificazione dell’assetto dinamico del sistema. Il rapporto tra
la massa del corpo responsabile di tali variazioni e quella del pianeta risulta, in questa
ipotesi, sempre dell’ordine di qualche millesimo, con l’importante eccezione di Urano
18
(che ha un asse inclinato di circa 90 ed inoltre ha, insieme con Venere, una rotazione
assiale retrograda) per cui si ha un valore di tale rapporto pari circa ad un decimo.
Fig. 4 – Fasi del processo di formazione dei pianeti. I pianeti cominciano a formarsi quando granuli di
polvere interstellare collidono e si aggregano tra loro formando grani più grandi (a). Questi cadono sul
piano mediano dell’inviluppo (b) e vi formano un disco diffuso dove continuano a collidere
aggregandosi fino a raggiungere le dimensioni di qualche metro. Ulteriori collisioni binarie ed
instabilità gravitazionali danno, poi, luogo a migliaia di corpi di dimensioni intorno ad 1 km (c), che
danno origine ad ammassi gravitazionali (d). Quando gli amassi collidono e si fondono (e), i loro campi
gravitazionali diminuiscono ed essi coagulano in nuclei solidi di una decina di chilometri attorno ai
quali probabilmente orbitano dei corpi (f). Accrescimento e consolidamento continuati possono creare
un corpo di dimensioni planetarie (g). Se il nucleo diventa sufficientemente grande può concentrare per
effetto gravitazionale parte del gas della nube (h). Un nucleo ancora più grande può provocare il
collasso del gas fino a formare un guscio compatto (i) (adattata dalla figura a pag. 27 di Cameron,
1976).
19
Fig. 5 – Processo di cattura di planetesimi da parte di un embrione planetario. I planetesimi con orbite
eliocentriche sempre esterne rispetto a quella dell’embrione (schema a sinistra) lo urtano sempre
nell’emisfero non illuminato dando luogo ad una rotazione assiale diretta dell’embrione. I planetesimi
con orbite sempre interne rispetto a quelle dell’embrione (schema a destra), lo urtano sempre
nell’emisfero illuminato, trasferendo momento angolare ancora nel verso diretto.
8. Influenza della massa della nebulosa originaria sull’evoluzione di sistemi
planetari
Alla luce di quanto visto finora, è interessante esaminare l’evoluzione di un
sistema stellare a seconda della massa della polvere presente nella nube di partenza.
Per questo verranno presi in considerazione tre diversi sistemi stellari con diverse
configurazioni iniziali di massa, chiamando con A, B, e C tali sistemi. Nel sistema A
la massa iniziale dei grani della nebulosa originaria è relativamente piccola; nel
sistema C questa massa è relativamente grande; infine nel sistema B si ha un valore
intermedio, rappresentativo del Sistema Solare. Inizialmente i grani hanno dimensioni
dell’ordine del micrometro (v. fig. 6a).
Secondo un modello elaborato da Hartman (1976) sulla base dalla teoria
dell’instabilità gravitazionale di Goldreich e Ward (1973), nel sistema A le particelle
si uniscono finché il loro diametro medio cresce fino a circa un chilometro. Nel
sistema B il processo di mutua attrazione porta alla produzione di quasi lo stesso
numero di corpi, ma con un diametro medio molto superiore ad un chilometro. Nel
sistema C i corpi finali non solo sono più numerosi, ma anche più grandi di quelli dei
casi precedenti (v. fig. 6b).
L’evoluzione successiva dei tre ipotetici sistemi dipende dalla frequenza (e
dalla violenza) delle collisioni che avvengono tra questi planetesimi. In effetti questi
corpi simili ad asteroidi collidono tra di loro e stretti avvicinamenti ne alterano le
20
21
orbite. Nelle collisioni ad alta velocità che seguono, la frammentazione comincia a
competere con il processo di crescita continua.
La curva a forma di campana delle figg. 6b, che rappresenta le distribuzione di
dimensioni, è alterata perché una successione di collisioni polverizzatrici dà origine
ad una grande quantità di detriti di piccola scala (v. figg. 6c,d). La maggior parte di
questa polvere fine è probabilmente spazzata via da ciascuno dei tre sistemi, espulsa
nello spazio interstellare dalla pressione di radiazione o dal vento stellare. Frammenti
più grandi di dimensioni centimetriche possono muoversi a spirale verso la stella
centrale spinti dall’effetto Poynting-Robertson.
Se la velocità di collisione è alta, i planetesimi possono frammentarsi fino a
scomparire del tutto. Per lo stesso motivo, se alcuni planetesimi crescono fino a
dimensioni notevoli durante il periodo iniziale di collisioni a basse velocità, possono
continuare a crescere ancora, poiché diminuisce la probabilità che successive
collisioni li frantumino o sottraggano loro massa. Inoltre tanto più grande è il corpo,
tanto maggiore è il suo campo gravitazionale e la sua capacità di catturare particelle
che gli passano vicino. Perciò una volta superate certe dimensioni di soglia, i corpi si
accrescono fino a dimensioni planetarie. E’ questa la ragione per cui un diagramma
della distribuzione di massa del nostro Sistema Solare mostra una sovrabbondanza di
massa distribuita tra pochi corpi grandi.
Nel sistema A povero di polvere, nessun corpo diventa grande abbastanza da
avvicinarsi alla soglia planetaria. Il processo di frammentazione supera quello di
accumulazione, finché alla fine le dimensioni dei soli planetesimi in orbita intorno
alla stella sono comprese in un intervallo che va da meno di un centimetro a meno di
un chilometro. Questi sistemi planetari contengono solo asteroidi di piccole
dimensioni (v. figg. 6e,f).
Nel sistema C il rifornimento di planetesimi è abbastanza grande perché corpi
in accrescimento in ogni parte del sistema possano superare la soglia planetaria. Alla
fine il processo di accumulazione raccoglie quasi tutti i planetesimi con dimensioni da
subcentimetriche a subchilometriche. Sistemi come questi possono non contenere
neanche un asteroide e possono avere anche due o più soli.
Nel nostro Sistema Solare invece alcuni planetesimi sono rimasti sotto forma
di asteroidi e comete per l’effetto perturbatore di Giove e, forse, Nettuno che hanno
impedito un’ulteriore crescita di questi corpi. Per la stessa ragione anche i sistemi B e
C potrebbero contenere comete ed asteroidi (v. figg. 6e,f).
Occorre ricordare che il modello ora descritto (Hartman, 1976) si basa
sull’accrescimento dei grani ad opera dell’instabilità gravitazionale di Goldreich e
Ward (1973) e pertanto non si può considerare una fedele simulazione di quello che
22
realmente potrebbe accadere. L’analisi di tale modello (le cui varie fasi sono
schematizzate in fig. 6) è importante, però, quanto meno per mettere in evidenza le
diverse strutture finali che si possono ottenere in funzione di diversi valori iniziali che
si adottano per la massa.
9. Formazione dei corpi minori del Sistema Solare : satelliti, comete ed asteroidi
Finora non si è ancora discusso un altro importante aspetto della genesi del
Sistema Solare e cioè la formazione dei satelliti.
Si possono distinguere due classi di oggetti di questo tipo, i satelliti regolari e
quelli irregolari. I sistemi di satelliti regolari mostrano delle proprietà assai simili a
quelle del sistema planetario (orbite quasi circolari, bassa inclinazione sul piano
equatoriale, percorrenza dell’orbita in senso diretto). Si può ipotizzare pertanto che il
processo di formazione dei satelliti sia in qualche modo analogo e contemporaneo a
quello di formazione dei pianeti. Infatti intorno al pianeta può restare addensato uno
sciame di particelle solide collidenti anelasticamente. All’interno di questo sciame
possono verificarsi quindi fenomeni di coalescenza e accrezione delle particelle del
tutto analoghi a quelli descritti nel disco protoplanetario. Tali processi possono
portare alla formazione di corpi con mutue interazioni gravitazionali ridotte e quindi
relativamente stabili dal punto di vista dinamico. In effetti Black (1971) ha mostrato
che, anche nei sistemi di satelliti regolari di Giove, Saturno ed Urano è possibile
stabilire una legge del tipo di quella di Titius-Bode.
Accanto ai satelliti regolari ci sono poi quelli irregolari per orbita (che può
essere sia diretta che retrograda), forma e composizione, che sono presenti attorno a
tutti i pianeti giganti. E’ ormai certo che questo tipo di satelliti non si sono formati in
situ, ma si presume che siano asteroidi o corpi della fascia di Edgeworth-Kuiper
(fascia E-K) catturati dal pianeta in epoche successive alla loro formazione. In
particolare molti satelliti irregolari dei pianeti maggiori potrebbero provenire proprio
dalla fascia E-K.
Un’altra grossa anomalia è data anche dal nostro satellite, poiché questo è
troppo massiccio rispetto al nostro pianeta. Gli ultimi dibattimenti si concentrano
sull’ipotesi che la Luna si sia formata da un impatto della Terra con un grosso
planetesimo dalle dimensioni simili a quelle attuali di Marte. Il punto debole di questa
teoria è dato dal basso momento angolare posseduto attualmente dal sistema TerraLuna rispetto a quello che avrebbe dovuto avere se ci fosse stato realmente un
impatto; e se questo è stato dissipato, non si riesce a capire attraverso quale
meccanismo. Ma è ancora tutto da vedere.
23
Quanto alle comete, occorre dire subito che l’ipotesi di Cameron (1976) che i
nuclei cometari si siano formati nella stessa nube di Oort è molto improbabile perché
a simili distanze dal Sole la materia è troppo rarefatta per dar luogo, per collisioni
binarie, a corpi delle dimensioni cometarie. Öpik (1973) suggerì in un primo
momento che questi corpi si fossero formati vicino Giove e fossero stati perturbati dal
campo gravitazionale di tale pianeta su orbite molto grandi, arrotondate poi da
perturbazioni stellari. Tuttavia, tenendo conto delle temperature che dovevano
prevalere in prossimità di Giove, sembra improbabile che molecole come CO2, NH3,
CH4, molto abbondanti nei nuclei cometari, potessero conservarsi allo stato solido in
queste regioni. Queste sostanze si possono trovare invece allo stato solido nelle zone
più esterne del disco protoplanetario e perciò secondo Safronov (1969), i nuclei
cometari si sarebbero formati intorno Urano e Nettuno e sarebbero entrati a far parte
della nube di Oort per azione del campo gravitazionale di questi pianeti (v. tab. 2):
questo trasferimento fino agli estremi confini del Sistema Solare sarebbe stato
ultimato in circa 5 08 anni.
Tab. 2 – Masse cometarie espulse dalla zona dei pianeti esterni verso lo spazio interstellare e verso la
nube di Oort (da Bailey et al., 1986).
Pianeta
Massa espulsa
(Mt)
Massa posta nella Nube di Oort
(Mt)
Giove
Saturno
Urano
Nettuno
100
80
50
60
0.2
0.4
0.6
1.3
Totale
290
2.5
Recenti studi avvalorano l’idea che la formazione delle comete possa aver
avuto luogo in tutta la regione dei pianeti giganti; ciò spiegherebbe in parte anche la
diversa composizione chimica di diversi gruppi di comete (Weissman, 1998). Inoltre
una parte dei grani che compongono le comete sicuramente è stata prodotta nella parte
interna del Sistema Solare e successivamente trasportata nelle regioni esterne
attraverso moti di convezione. In effetti osservazioni spettroscopiche hanno
individuato la presenza nella chioma della cometa di Halley di particelle di olivina
cristallina (Campins e Ryan, 1989), che in laboratorio si ottengono da grani amorfi
che vengono riscaldati ad una temperatura non inferiore a 850 K (Nuth III et al.,
24
2000). Queste temperature non si possono certo ottenere nella zona dei pianeti giganti.
Si può quindi concludere che la regione di provenienza di quel particolare tipo di
particelle deve necessariamente essere quella dei pianeti interni.
Rimane inoltre da fare un cenno alla formazione della fascia asteroidale e della
fascia E-K. E’ ormai completamente superata l’ipotesi secondo la quale gli asteroidi
sarebbero stati originati dalla distruzione di un preesistente pianeta (anche a causa
dell’assoluta mancanza di una fonte plausibile per l’energia necessaria per spezzare
un pianeta di grandi dimensioni e disperdere i suoi frammenti in direzione contraria al
suo stesso campo gravitazionale). Si può invece pensare che il processo di
accumulazione protoplanetaria sia stato interrotto nel momento in cui Giove raggiunse
una massa sufficiente per perturbare la distribuzione delle velocità relative dei corpi,
in particolare aumentandole. Tale aumento di velocità relativa favorì le collisioni
distruttive nella fascia degli asteroidi ed in parte pure nella zona di formazione di
Marte. E’ per questo motivo che la massa di Marte risulta inferiore a quella che si
sarebbe potuta ottenere se non fossero intervenute queste perturbazioni.
Quello che sorprende nel caso degli asteroidi è che nella zona corrispondente
alla fascia principale il processo di accrescimento si è in qualche modo arrestato, e
gran parte della massa ivi presente è andata irrimediabilmente perduta (la massa totale
di tutti gli asteroidi messi insieme è infatti molto inferiore a quella da attendersi per
un pianeta formatosi in quella zona). Il motivo di questo insuccesso nella formazione
di un pianeta in questa regione è probabilmente imputabile alla rapida crescita di
Giove nella zona adiacente. In particolare, si pensa che durante le ultime fasi della sua
formazione, Giove possa aver perturbato ed espulso dalla sua zona numerosi
planetesimi massicci, che passando nella zona dell'attuale cintura asteroidale
potrebbero aver perturbato i planetesimi ivi presenti, facendo aumentare le velocità
medie di incontro, fino al punto di far diventare distruttivi, anziché costruttivi, gli
impatti reciproci tra questi corpi. In questo modo, un pianeta non si sarebbe mai
formato, e gran parte della massa sarebbe stata alla fine espulsa dalla zona, o
finemente polverizzata a seguito di impatti reciproci violenti. Secondo una teoria
alternativa, invece, almeno due grandi planetesimi di massa equivalente a quella di
Marte potrebbero essersi formati nella fascia asteroidale durante gli ultimi stadi di
formazione planetaria. Questi due grandi oggetti potrebbero essersi perturbati
reciprocamente fino al punto da provocare la mutua espulsione dalla regione e da
espellere allo stesso tempo la maggior parte della massa presente. Anche questa teoria
appare plausibile, e sappiamo in particolare che planetesimi di massa marziana
devono aver vagato per il Sistema Solare durante le ultime fasi di formazione dei
pianeti, provocando anche impatti violentissimi con questi ultimi, come l'esistenza
della nostra Luna (v. sopra) e l'obliquità di Urano starebbero a dimostrare. In ogni
25
caso, si può concludere che gli asteroidi dovrebbero essere dei "fossili viventi" della
popolazione di planetesimi da cui i pianeti maggiori hanno avuto origine. Per questo
motivo il loro studio può fornire informazioni insostituibili sulla formazione del
nostro Sistema Solare.
Per quanto riguarda la fascia E-K, nel processo di formazione di quest’ultima,
il pianeta Nettuno potrebbe aver avuto lo stesso ruolo giocato da Giove per la fascia
degli asteroidi. In effetti secondo alcuni autori ci sarebbero evidenze di una
inizialmente intensa accrezione planetaria nella fascia E-K bloccatasi alquanto
prematuramente a causa delle perturbazioni gravitazionali di Nettuno (Stern e
Campins, 1996). E’ tuttavia probabile che la mancanza di corpi di dimensioni
planetarie in questa regione del Sistema Solare sia semplicemente dovuta alla bassa
densità di quelle zone, che comporta, in base alla (5), tempi di scala per la formazione
planetaria molto più lunghi dell’età del Sistema Solare (Jewitt, 1999).
Comunque siano andate le cose, resta il fatto che l’azione gravitazionale di
Nettuno ha sicuramente influito sull’evoluzione dinamica della fascia E-K. Infatti
deboli instabilità dinamiche (dovute a risonanze tra il periodo orbitale dei corpi della
fascia e quello di Nettuno) dovrebbero aver rimosso dalla fascia E-K oggetti con
caratteristiche orbitali di questo tipo, spingendoli verso l’interno del Sistema Solare.
Tali oggetti hanno così dato luogo alle comete di corto periodo. Lo svuotamento di
queste regioni è ancora in atto, così come pure il processo di allontanamento dei corpi
dalle zone più interne della fascia, quelle cioè più prossime a Nettuno (Duncan et al.,
1995).
Dopo 107108 anni, quindi il Sistema Solare si può ormai considerare formato:
Sole, pianeti terrestri ed esterni (ed i loro satelliti), asteroidi e comete sono presenti in
uno stadio definitivo. Nell’ultima fase del processo di accrescimento ciascun
neopianeta sarebbe stato in grado di catturare per la sua maggiore gravità i frammenti
ancora presenti in prossimità della sua orbita. Ciò sarebbe all’origine dei mari lunari e
di tutti i bacini più grandi, scoperti sulle superfici dei pianeti fino ad oggi osservati,
che sarebbero appunto il prodotto dell’impatto catastrofico degli ultimi planetesimi,
vaganti nel Sistema Solare, sulla superficie planetaria appena formata. L’epoca di
questo bombardamento più intenso sembra collocarsi fra 4.5 e 3.8 miliardi di anni fa.
Da allora il flusso di impatti sembra essersi mantenuto costante su valori piuttosto
bassi e la storia di ciascun pianeta si è svolta indipendentemente da quella di tutti gli
altri, determinata dalle condizioni fisiche, chimiche e dinamiche in cui ogni oggetto è
venuto a trovarsi.
Un’ultima osservazione merita la lenta rotazione retrograda di Venere che non
può essere attribuita (come probabilmente nel caso di Urano) all’impatto di un corpo
di grande massa, ma che potrebbe essere messa in relazione con l’attuale mancanza di
26
satelliti. Infatti, se si suppone che Venere fosse originariamente dotata di un
movimento di rotazione assiale diretto e che avesse un satellite di tipo lunare in un
orbita leggermente più eccentrica di quella lunare, allora l’attrito di marea tra Venere
e il satellite avrebbe provocato un continuo rallentamento della rotazione planetaria
fino all’inversione ed un conseguente aumento della distanza del satellite che avrebbe
così potuto sfuggire all’attrazione del suo pianeta.
27
APPENDICI
Teorie ed esperimenti riguardanti la crescita dei grani di polvere
Appendice A
Primi studi e recenti simulazioni al calcolatore
I primi studi volti a descrivere i meccanismi di adesione tra particelle solide
risalgono alla fine del XIX secolo e furono condotti da Hertz (1882). Essi assimilano i
grani a delle sfere elastiche e trattano l’urto in una maniera molto semplificata. Circa
un secolo più tardi Johnson et al. (1971), utilizzando il modello di Hertz, hanno
simulato delle collisioni tra le particelle utilizzando sfere con caratteristiche tali da
imitare le forze attrattive che si esercitano tra di esse ottenendo di conseguenza un
aumento del raggio della superficie di contatto. Successivamente Meaking e Donn
(1988) hanno considerato per la prima volta i grani e i loro agglomerati dotati di un
moto di rotazione attorno ad un loro asse. Questo fornisce una maggiore possibilità di
disperdere l’energia dei corpi collidenti (ad esempio attraverso la trasformazione
dell’energia di impatto in energia rotazionale), che costituisce una condizione
fondamentale perché si abbia l’adesione tra i due corpi.
Decisamente più accurate e realistiche sono le simulazioni condotte da
Domink e Tielens (1997); esse tengono infatti conto dei nuovi processi attraverso i
quali l’energia di impatto tra due particelle può essere trasformata, in modo tale che,
dissipando l’energia cinetica di collisione, la crescita di un aggregato sia agevolata. I
risultati ottenuti da Dominik e Tielens (1997) suggeriscono di distinguere diversi casi
che possono realizzarsi nelle collisioni tra singoli grani (monomeri) o tra monomeri
ed aggregati o tra aggregati ed aggregati; si può avere, infatti, un’adesione senza una
ristrutturazione visibile degli oggetti in gioco o una ristrutturazione visibile o una
forte compressione degli aggregati o la perdita di un monomero o, infine, la
distruzione catastrofica dello stesso.
L’importanza di questo lavoro risiede anche nella varietà dei materiali di
interesse astrofisico utilizzati, quali ad esempio il quarzo (scelto come rappresentante
dei silicati), la grafite, il polistirene (come rappresentante della materia organica), il
ghiaccio ed il ferro. Anche le superfici dei grani sono trattate in maniera da tale da
riprodurre le “rugosità” di cui dovrebbe essere dotato un grano di origine interstellare.
L’unico inconveniente è dato, invece, dalla forma di questi monomeri, che vengono
assimilati a delle sfere elastiche.
28
Nelle simulazioni delle collisioni dei due autori viene utilizzato un modello
bidimensionale in cui i grani si muovono su un piano e possono ruotare ciascuno
attorno al proprio asse ortogonale a questo piano.
I risultati delle collisioni mostrano, come ci si aspetta, che in uno scontro
frontale tra due monomeri che impattano con una velocità minore di un certo limite
vstick, questi si uniscano, altrimenti per velocità superiori (e di conseguenza energie più
elevate di un’energia di soglia Ebreak) rimbalzino sempre senza unirsi. Se invece si
considerano collisioni tra un monomero ed un aggregato le cose cambiano perché
anche per energie di poco superiori ad Ebreak, ci può essere l’unione dei due oggetti.
Ciò avviene perché la struttura dell’aggregato non è rigida, e può ridistribuire
l’energia in eccesso su tutto il corpo mettendo in movimento i grani in prossimità del
punto di impatto. Ciò è illustrato nella fig. A1 dove è riportata la sequenza temporale
della collisione tra un aggregato composto da 40 grani, ed un monomero. Questi sono
tutti grani di ghiaccio di raggio pari a 10-5 cm, mentre la velocità di collisione è di
2000 cm/s che dà luogo ad un’energia di collisione pari Eimp 1.810-8 erg (che per
questo tipo di particelle risulta di poco superiore ad Ebreak). Per tempi-scala dell’urto
molto brevi, si può pensare all’urto come se avvenisse tra i primi due grani che
entrano in contatto anche se successivamente l’energia di impatto è trasferita ai grani
adiacenti, e così via.
Se si incrementa la velocità di collisione di un fattore 10 (v. fig. A2), si trova
che vimp = 20000 cm/s ed Eimp 1.710-6 erg, ottenendo la distruzione
dell’aggregato. La fig. A3 illustra invece la configurazione iniziale e finale dei grani
per diverse velocità di impatto, diversi tipi di materiali, e diverse dimensioni dei grani.
Accanto a questi modelli di collisione, si possono considerare anche urti più
complessi tra particelle di diversa dimensione (v. fig. A4). In questi casi non tutta
l’energia che trasporta con se la particella proiettile potrebbe essere utilizzata
dall’aggregato, proprio a causa della diversità della massa del grano incidente e quello
colpito. In particolare, se il grano incidente è più piccolo del primo grano
dell’aggregato con il quale entra in contatto, e la sua velocità è elevata, si verifica che
dopo l’urto il proiettile rimbalza via portando con sé una parte dell’energia cinetica
totale e lasciando all’aggregato la rimanente porzione. Tuttavia per velocità basse,
l’aggregato può avere la capacità di trattenere il proiettile e quindi tutta l’energia
incidente. Nella fig. A4 ad esempio si vede che in quel caso per velocità uguali o
inferiori a 1000 cm/s tutta l’energia incidente viene assorbita, mentre per velocità
superiori la particella incidente può rimbalzare via o distruggere l’aggregato. Nella
fig. A5 sono riportati, inoltre, i risultati di collisioni a diverse velocità tra aggregati
di grani di ghiaccio dal raggio di 1000 Å.
29
Fig. A1 Sequenza temporale della collisione tra un aggregato di 40 grani e un monomero.
Quest’ultimo è il primo da destra e proviene da questa direzione. Il materiale usato è ghiaccio. Il raggio
delle particelle, è di 1000 Å, e la velocità della collisione è di 2000 cm/s. I sei riquadri ricoprono un
tempo complessivo di 11.8 10-8 s, ed il tempo tra ogni riquadro è di circa 2.4 10-8 s (da Dominik e
Tielens, 1997).
Fig. A2 Idem come nella figura precedente, con la sola differenza che la velocità di collisione è di
20000 cm/s, ed il tempo totale è 11.510-9 s in intervalli di 2.310-8 s (da Dominik e Tielens, 1997).
30
(a)
(b)
Fig. A3 Risultati delle collisioni tra un monomero ed un aggregato per diverse velocità di impatto:
nel primo riquadro è presentata la configurazione iniziale (il monomero incidente è il primo da destra e
proviene da questa direzione), mentre negli altri la configurazione finale alle varie velocità nei due casi:
a ) particelle di ghiaccio di 1000 Å, b) grani di 1000 Å di silicati (da Dominik e Tielens, 1997).
31
Fig. A4 Risultati finali delle collisioni di un singolo grano di ghiaccio di 500 Å che impatta a diverse
velocità contro un aggregato di 40 grani dello stesso materiale, ma con dimensioni che vanno da 500 Å
a 2000 Å (da Dominik e Tielens, 1997).
Fig. A5 Risultati finali delle collisioni a diverse velocità tra due aggregati di grani di ghiaccio di
1000 Å di diametro (da Dominik e Tielens, 1997).
32
Occorre sottolineare la fondamentale importanza dei risultati di questo lavoro.
Per la prima volta, infatti, nelle simulazioni è possibile considerare i corpi presenti
all’interno della nube protoplanetaria come degli oggetti comprimibili. Dominik e
Tielens (1997) attribuiscono le cause che permettono di dissipare l’energia di impatto
di due corpi collidenti alla ristrutturazione dei corpi stessi che avviene attraverso un
riordino interno dei singoli grani di quei corpi. Le precedenti simulazioni, ignorando
tale possibilità, mostravano collisioni che davano luogo a frequenti rimbalzi a causa
del basso valore, che risultava dai conti, della velocità critica necessaria per
l’adesione; ad esempio per corpi considerati come delle sfere compatte di 1 metro di
diametro, la risultante velocità critica di adesione è dell’ordine di 10-3 cm/s (Dominik
e Tielens, 1997), molto più bassa della reali velocità di collisione tra grani previste
dalla teoria di Weidenschilling e Cuzzi (1993). Se gli stessi corpi si considerano
invece come sfere comprimibili (in modo tale da ridistribuire l’energia di impatto su
tutto l’aggregato), il valore delle velocità critica può salire fino a 1000 cm/s (Dominik
e Tielens, 1997). Siccome le velocità di collisione tra le particelle del disco devono
essere state minori di questo valore (Weidenschilling e Cuzzi, 1993), ciò implica che
collisioni con adesione dovevano essere molto frequenti nel disco, dando luogo a
corpi solidi di dimensioni sufficientemente grandi da innescare il processo di
instabilità gravitazionale.
33
Appendice B
Recenti studi sperimentali sulla collisione di grani sferici e non sferici e di grani
carichi
Non tutti i lavori sulla polvere sono realizzati attraverso simulazioni al
computer. Ci sono infatti esperimenti altrettanto importanti che ricavano i risultati
direttamente da collisioni realizzate in laboratorio. Come esempio in questa appendice
sono discussi gli ultimi lavori innovativi realizzati all’Università di Jena da Poppe et
al. (2000a). Anche in questo tipo di simulazioni vengono utilizzati grani ricavati da
materiali di interesse astrofisico come i silicati, i metalli ed il ghiaccio d’acqua, ma
l’impostazione è completamente diversa. Mentre Dominik e Tielens (1997) risolvono
le equazioni per ognuno dei grani, in questo caso si ha un approccio sperimentale vero
e proprio. Tramite un’apparecchiatura meccanica, infatti, un fascio di grani è
accelerato verso un bersaglio ben diaframmato in modo da ottenere collisioni con
diversi angoli d’impatto Le immagini dell’impatto vengono raccolte poi da un
microscopio a scansione elettronica a lunga distanza focale dotato di una sofisticata
camera CCD per risalire alla velocità e all’angolo d’impatto come pure alla velocità
di rimbalzo semplicemente conoscendo le caratteristiche tecniche della fotocamera
(tempo intercorrente tra i diversi fotogrammi, spazio fotografato, dimensione dei
pixel, etc.).
I risultati di questi lavori si possono commentare osservando i grafici
riguardanti i diversi parametri delle collisioni come ad esempio la probabilità di
adesione. Inizialmente Poppe e colleghi considerano il caso in cui i proiettili sono
delle particelle sferiche (v. fig. B1). Sulle superfici delle sfere sono presenti delle
scanalature e delle spaccature delle dimensioni di qualche decimo di nanometro per
richiamare le caratteristiche originali dei grani interstellari, il cui ruolo è quello di
facilitare la dispersione dell’energia che avviene prevalentemente attraverso canali
elastici.
L’importanza di queste prove sperimentali effettivamente risiede nei materiali
che rappresentano i grani. Questi materiali sono molto più vicini alla realtà rispetto a
quelli del passato perché le sfere non sono estratte da blocchi di quarzo, ma sono
prodotte in un liquido supersaturato, dove con una reazione chimica vengono poi
depositate le molecole di SiO sulla superficie. Tale metodo consente di produrre
particelle più rassomiglianti a quelle della nube protoplanetaria, perché rende più
realistica la distribuzione delle asperità superficiali.
In questi esperimenti vengono usati due tipi di bersaglio; uno di quarzo
levigato ed uno costituito da un wafer di silicio con le caratteristiche superficiali dei
grani-proiettile descritte in precedenza.
34
Fig. B1 Probabilità di adesione in vari casi: a) sfere di 1.2 m su quarzo levigato; b) sfere di 1.2 m
su wafer di silicio; c) sfere di 0.5 m su quarzo levigato; d) sfere di 0.5 m su wafer di silicio. Le due
linee continue indicano la misura nell’intervallo della deviazione standard (da Poppe et al., 2000a).
Nelle collisioni considerate possono verificarsi tre casi: o le particelle
aderiscono direttamente al bersaglio in seguito all’urto, o rimbalzano più volte sul
bersaglio per poi aderirvi, una volta smaltita l’energia di collisione (come una pallina
lasciata cadere per terra), oppure dopo il rimbalzo proseguono nel cammino ignorando
il bersaglio senza aderirvi. Le tre possibilità si presentano a seconda della velocità e
quindi dell’energia che le particelle possiedono dopo il rimbalzo. Quest’ultima, che è
pari alla differenza dell’energia di collisione meno quella persa nell’urto, deve essere
sufficientemente bassa altrimenti la particella non aderisce.
Sono stati realizzati 858 impatti osservando il comportamento dei proiettili
dopo la collisione col bersaglio. La velocità di cattura è definita come la velocità alla
quale la probabilità di adesione assume il valore 0.5. Per sfere di 1.2 m, Poppe et al.
(2000a) trovano che tale velocità varia nell’intervallo 1.1 1.3 m/s su entrambi i
bersagli, mentre per le sfere di 0.5 m varia nell’intervallo 1.5 2.3 m/s sul wafer di
silicio e si può trascurare per l’altro bersaglio, perché in questo caso si presenta
sempre una probabilità di adesione molto bassa (0.13 in media) e non ha senso parlare
di velocità di cattura.
Accanto agli esperimenti con grani sferici, Poppe et al. (2000a) hanno
realizzato anche delle collisioni con particelle non sferiche, dotate quindi di una
35
caratteristica che rende la collisione più realistica, utilizzando una vasta gamma di
materiali e forme (ad esempio piccoli grani irregolari di diamante prodotti
artificialmente come descritto da Dorschner et al., 1995). In particolare sono stati
utilizzati campioni con grani di diamante, di estatite (MgSiO3) e carburo di silicio
(SiC).
Le conclusioni sono state ottenute con le stesse procedure adottate per i grani
sferici e cambiando solo il tipo di particelle usate. I grafici si riferiscono ancora una
volta alla probabilità di adesione (v. fig. B2), in modo tale da offrire un facile e rapido
confronto con il caso precedente. Proprio da questo confronto emerge la maggior
predisposizione all’accrescimento dei grani non sferici, risultando maggiore la
probabilità di adesione anche a velocità molto elevate (per i grani sferici la velocità
doveva essere inferiore a 10 m/s, mentre per quelli non sferici si trovano velocità che
arrivano anche fino a 30 m/s). Una giustificazione può essere data dall’aumento dei
punti di contatto che un grano irregolare può offrire rispetto ad uno sferico.
Un altro problema affrontato dal gruppo di Jena (Poppe et al., 2000b) riguarda
le collisioni tra le particelle cariche, già studiate da molti altri autori per i molteplici
ruoli che queste hanno avuto nella formazione della nube protoplanetaria. Nel par. 4
della Dispensa n. 9a, infatti, è stato spiegato come le particelle cariche contribuiscano
a smaltire il momento angolare della nube in contrazione. C’è inoltre il sospetto che
le particelle cariche contribuiscano a creare le condizioni ottimali per la formazione
delle condrule di cui si è parlato al par. 3 della Dispensa n. 6. La separazione delle
cariche, infatti, provoca delle scariche elettriche nel gas diluito che probabilmente
costituiscono la principale causa della formazione delle condriti (Horanyi e Robertson
1996; Gibbard et al., 1997).
Ma l’aspetto più importante degli urti tra particelle cariche è sicuramente dato
dall’accrescimento dei grani per effetto delle forze elettrostatiche. Come già è stato
accennato, nella nube protoplanetaria sono presenti particelle che possiedono una
carica elettrica acquisita o per effetto fotoelettrico o per effetti legati alla
“triboelettricità” (carica elettrica generata da una frizione, come ad esempio lo
strofinio di due superfici a contatto). Quando due particelle si sfregano o
semplicemente entrano in contatto (analogamente a quello che succede al mercurio
liquido quando tocca un isolante) ci può essere un passaggio di carica da un corpo
all’altro, che si può manifestare anche se inizialmente la carica delle singole
particelle è nulla ed i materiali sono isolanti. Una volta acquisita una certa carica,
quindi, le singole particelle saranno soggette ad una forza elettrostatica (forza di
Coulomb) che sarà attrattiva o repulsiva a seconda dei segni della carica posseduta.
Trarre dei risultati quantitativi, però, è abbastanza difficile per la difficoltà di
tenere sotto controllo i numerosi parametri che influiscono sul numero di cariche che
36
si possono depositare su un corpo, che sono: la temperatura delle particelle, la
pressione esercitata dalle superfici delle particelle al momento del contatto o dello
strofinio (Harper, 1967), l’orientazione delle strutture cristalline al momento del
contatto, etc..
Fig. B2 Probabilità di adesione in funzione della velocità di impatto, per vari tipi di particelle non
sferiche: a) grani di diamante con diametro medio di 0.14 m; b) grani di diamante con diametro
medio di 1.5 m; c) grani di estatite con diametro medio di 0.54 m; d) grani di carburo di silicio di
dimensioni medie 0.37 m; e) grani di carburo di silicio di dimensioni medie 0.64m (da Poppe et al.,
2000a).
37
La novità del lavoro di Poppe et al. (2000b) consiste nell’uso di materiali non
conduttori e di dimensioni minori rispetto a quelli di esperimenti antecedenti (che
sono in ogni caso molto approssimativi perché si riferiscono spesso agli studi sui
temporali terrestri). L’effetto della presenza della carica elettrica in questo contesto è
quello di generare una forza che attrae le particelle-proiettile verso il bersaglio
facendo in modo che ci sia un’adesione. A questo scopo è necessario che le particelleproiettile acquisiscano una quantità di carica elettrica sufficientemente grande. Perché
ciò avvenga Poppe et al. (2000b) hanno valutato che la velocità con la quale le
particelle devono impattare il bersaglio deve essere superiore a 10 m/s. E’ importante
notare che Blum e Wurm (2000) hanno studiato le collisioni seguendo un criterio
simile a quello precedente, con l’aggiunta che il tutto viene eseguito riproducendo una
condizione di microgravità. I risultati di tale esperimento mostrano che l’adesione tra
un grano-proiettile ed il bersaglio può avvenire per velocità dell’ordine di 1.2 1.9
m/s.
38
Bibliografia
Bailey, M.E., Clube, S. V. M., Napier, W. M.: 1986, Vistas in Astronomy, 29, 53.
Beckwith, S. V. W., Henning, T., Nakagawa, Y.: 2000, in “Protostars and Planets IV”, V., Mannings,
A. P., Boss, S. S. Russell ed., University of Arizona Press (Tucson), pag. 533.
Black, D. C.: 1971, Icarus, 15, 115.
Blum, J., Wurm, G.: 2000, Icarus, 143, 138.
Brandvold, B. S.: 2000, dal sito Web Encyclopedia Encarta
Bridges, F. G., Supulver, K. D., Lin, D. N. C., Knight, R., Zafra, M.: 1996, Icarus, 123, 422.
Cameron, A. G. W.: 1976, Le Scienze, 91, 20.
Campins, H., Ryan, E.V.: 1989, Astrophys. Jou., 341, 398.
Coradini, A.: 1983, Giorn. di Astr., 9, 155.
Coradini, A., Federico, C., Fulchignoni, M., Magni, G.: 1978, in “La Planetologia”, Newton Compton
(Roma), pag. 268.
Coradini, A., Federico, C., Magni, G.:1980, Giorn. di Astr., 6, 175.
Coradini, A., Magni, G.: 1978, in “La Planetologia ”, Newton Compton (Roma), pag. 36.
Dominik, C., Tielens, A. G. G. M.: 1997, Astrophys. Jou., 480, 647.
Dorshchner, J., Begemann, B., Henning, Th., Jäger, C., Mutschke, H.: 1995, Astron. Astrophys., 300,
503.
Duncan, M. J., Levison, H. F., Budd, S. M.: 1995, Astron. Jou., 110, 3073.
Gibbard, S. G., Levy, E. H., Lumine, J. I., de Pater, I.: 1997, Icarus, 130, 517.
Giuli, R. T.: 1968, Icarus, 9, 186.
Goldreich, P., Ward, W. R.: 1973, Astrophys. Jou., 183, 1051.
Hartman, W. K.: 1976, Le Scienze, 91, 115.
Hayashi, C.: 1981, Prog. Theor. Phis. (Suppl.), 70, 35.
Hayashi, C., Nakazawa, K., Nakagawa, Y.: 1985, in “Protostars and Planets II”, D. C. Black, M. S.
Matthews ed., The University of Arizona Press (Tucson), pag. 1100.
Harper, W. R.: 1967, Contact and Frictional Electrification, Clarendon press (Oxford).
Hertz, H.: 1882, Jou. Für Reine und Angewandte Mathematik, 92,155.
Horányi, M., Robertson, S.: 1996, in “Chondrules and the Protoplanetary Disk”, R. H. Hewins, R. H.
Jones, E. R. D. Scott ed., Cambridge University Press (Cambridge), pag. 303.
Inaba, S., Wetherill, G. W.: 2001, in “Origin of Planetary Sistems”, Lunar and Planetary Science
XXXII, contrib.#1384.
Jewitt, D.: 1999, Physics World, 12, 37.
Johnson, K. L., Kendall, K., Roberts, A. D.: 1971, Proc. R. Soc. Lond. A, 72, 783.
Kokubo, E., Ida, S.: 1996, Icarus, 128, 429.
Kokubo, E., Ida, S.: 2000, Icarus, 143, 15.
Meakin, P., Donn, B.: 1988, Astrophys. Jou., 329, 39.
39
Nakagawa, Y., Hayashi, C., Nakazawa, K.: 1983, Icarus, 54, 361.
Nelson, A. F., Benz, W., Ruzmaikina, T. V.: 2000, Astrophys. Jou., 529, 357.
Nuth III, J. A., Hill, H. G. M., Kletetschka, G.: 2000, Nature, 406, 275.
Öpik, E. J.: 1973, Astrophys. Space Sci., 21, 307.
Paolicchi, P.: 1979, Giorn. di Astr., 5,177.
Pietronero, L., Montuori, M., Labini, F. S.: 1998, Le Scienze, 354, 42.
Pollack, J. B., Hollenbach, D., Beckwith, S., Simonelli, D. P., Roush, T., Fong, W.: 1994, Astrophys.
Jou., 421, 615.
Poppe, T., Blum, J., Henning, T.: 2000a, Astrophys. Jou., 533, 454.
Poppe, T., Blum, J., Henning, T.: 2000b, Astrophys. Jou., 533, 472.
Preibisch, T., Ossenkopf, V., Yorke, H. W., Henning, T.: 1993, Astron. Astrophys., 279, 577.
Richardson, C. D., Quinn, T., Stadel, J., Lake, G.: 2000, Icarus, 143, 45.
Ruden, S. P.: 1999, in “The Origin of Stars and Planetary Systems”, C. J. Lada, N. D. Kylafis, ed.,
Kluver Academic Publishers (Amsterdam), pag. 643.
Safronov, V. S.: 1969, in “Evolution of the Protoplanetary Cloud and Formation of Earth and
Planets”, Nouks (Moskov), traduz. Inglese NASA TT F-667, 1972.
Safronov, V. S.: 1977, NASA SP-370, pag. 797.
Shu, F.H., et al.: 1990, Ap. J. 358, 495
Stern, S.A.: 1995, Astron. Jou., 110, 856.
Stern, A., Campins, H.: 1996, Nature, 382, 507.
Stewart, G. R., Kaula, W. M.: 1980, Icarus, 44, 154.
Ward, W. R.: 1999, American Astron. Society, 31 th DPS meeting, contrib. #36.02.
Weidenschilling, S. J.: 1977, Astrophys Space Sci., 51, 153.
Weidenschilling, S. J.: 1980, Icarus, 44, 172.
Weidenschilling, S. J.:1988, in “Workshop on the Origin of Solar Systems”, Lunar and Planetary Inst.,
pag. 31.
Weidenschilling, S. J.:1994, Nature, 368, 721.
Weidenschilling, S. J.: 1997, Icarus, 127, 290.
Weidenschilling, S. J.: 2000, Space Science Reviews, 92, 259.
Weidenschilling, S. J., Cuzzi, J. N.: 1993, in “Protostars and planets III”, E. H. Levy, J. I. Lunine ed.,
The Univesity of Arizona Press (Tucson), pag. 1031.
Weidenschilling, S. J., Spaute, D., Davis, D. R., Marzari, F., Ohtsuki, K.: 1997, Icarus, 128, 429.
Weissmann, P. R.: 1998, Le Scienze, 364, 44.
Wetherill, G. W.: 1988, in “Accumulation of Mercury from Planetesimals”, C. Chapman, F. Vilas ed.,
The University of Arizona Press, (Tucson).
Wetherill, G. W.: 2000, Lunar and Planetary Science conf. XXXI, Lun. Plan. Inst., CD-ROM contrib.
#1048.
Wetherill, G. W., Stewart, G. R.:1989, Icarus, 77, 330.
Wetherill, G. W., Stewart, G. R.: 1993, Icarus, 106, 190.
Wetherill, G. W., Stewart, G. R.: 1998, Lunar and Planetary Science Conf. XXIX, Lun. Plan. Inst.,
CD-ROM, contrib. #1250.
40
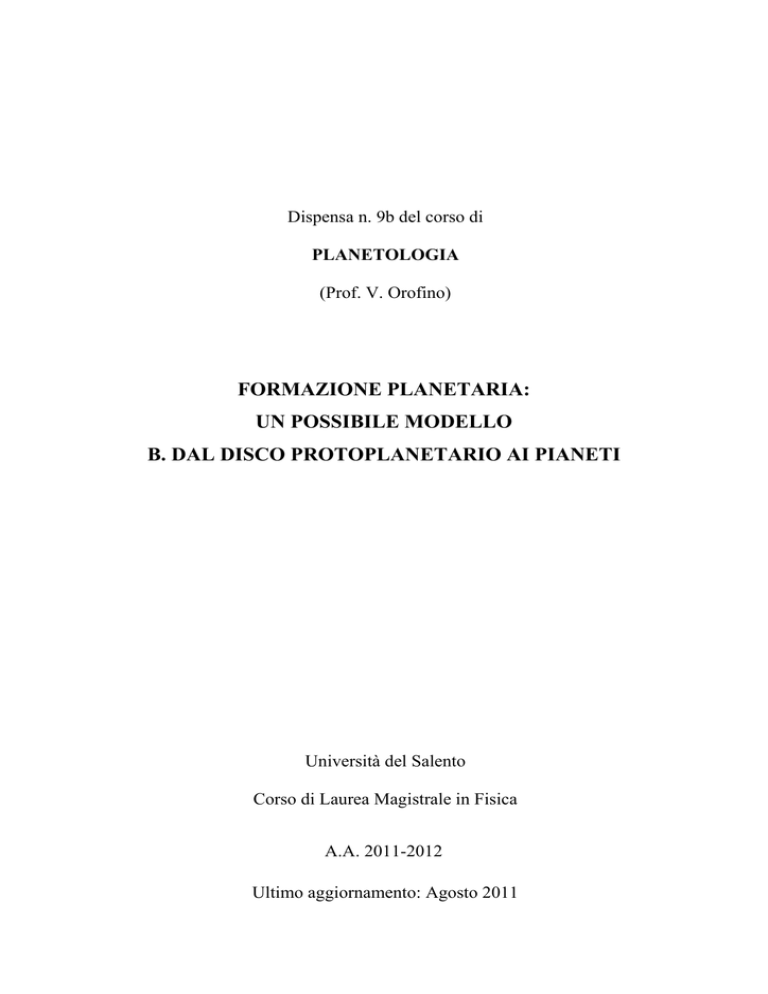
![4) SISTEMA SOLARE [Compatibility Mode]](http://s1.studylibit.com/store/data/000965475_1-ba368397aa6013aaf27bf06ced442315-300x300.png)