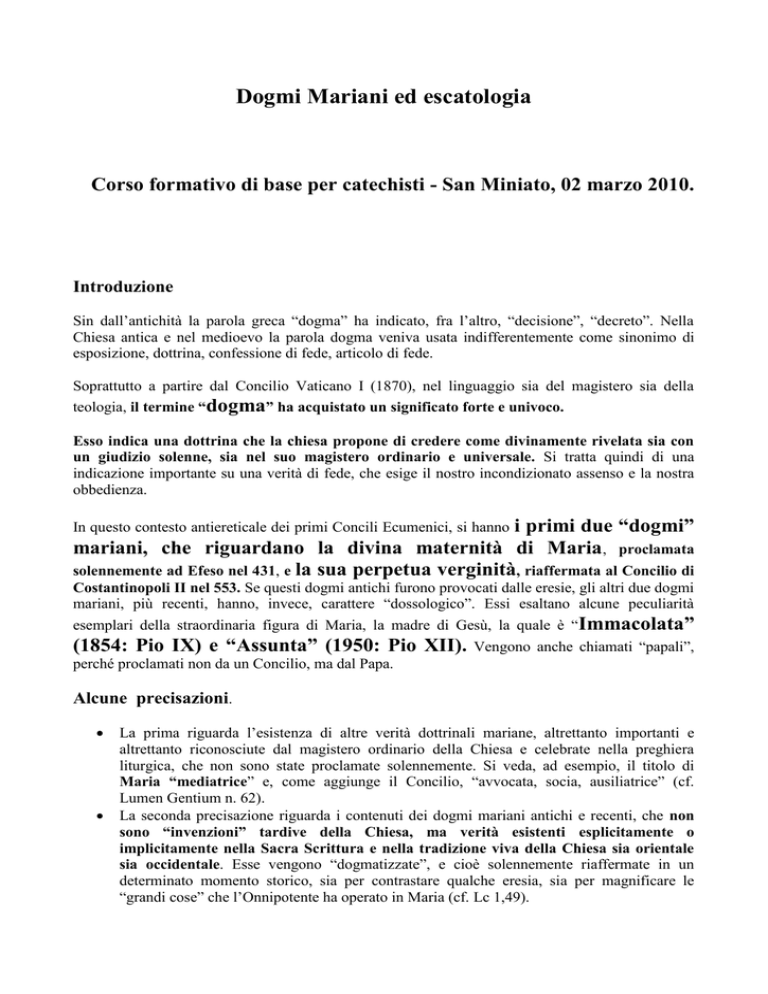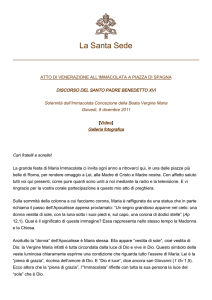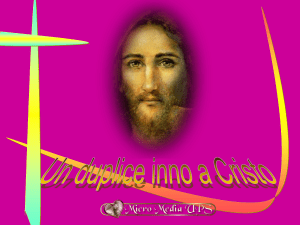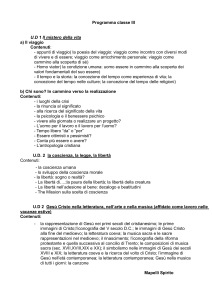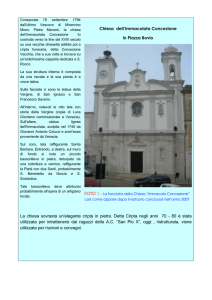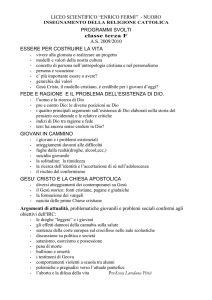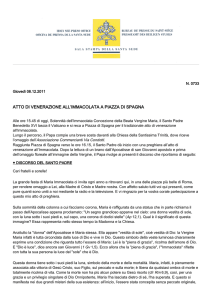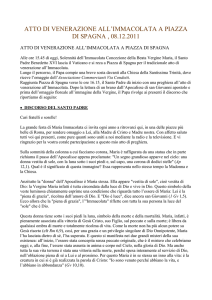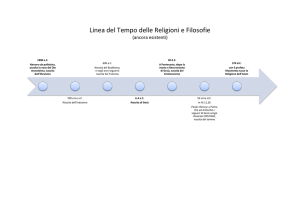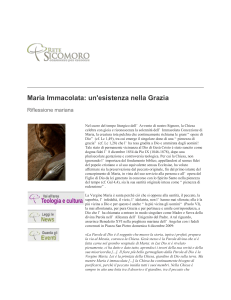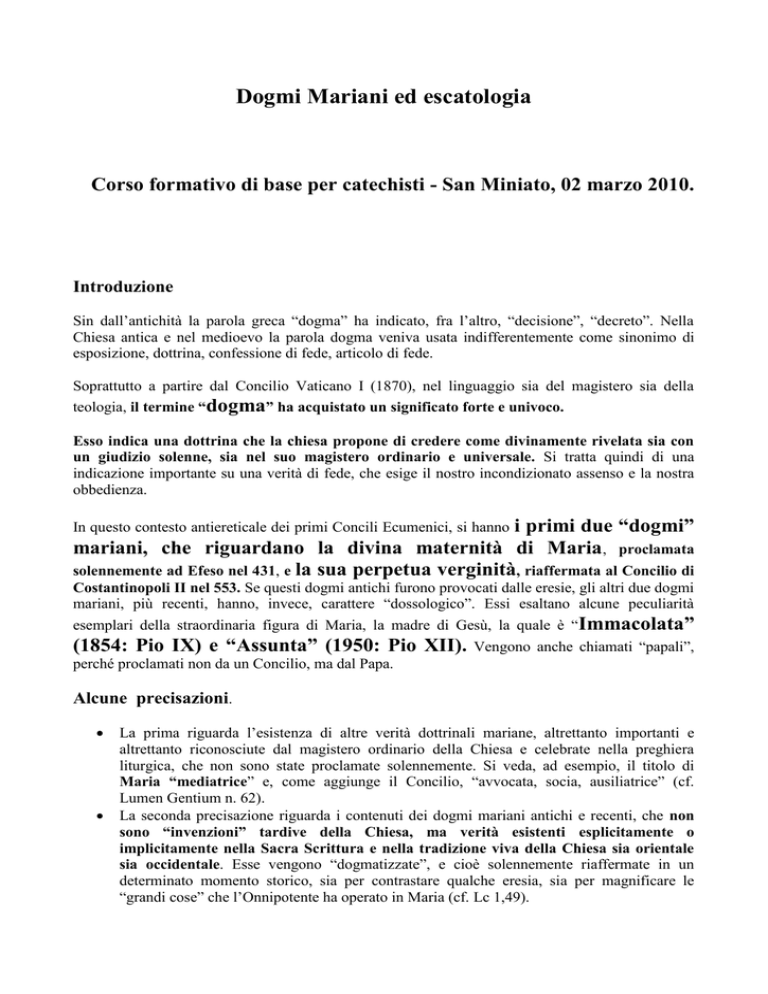
Dogmi Mariani ed escatologia
Corso formativo di base per catechisti - San Miniato, 02 marzo 2010.
Introduzione
Sin dall’antichità la parola greca “dogma” ha indicato, fra l’altro, “decisione”, “decreto”. Nella
Chiesa antica e nel medioevo la parola dogma veniva usata indifferentemente come sinonimo di
esposizione, dottrina, confessione di fede, articolo di fede.
Soprattutto a partire dal Concilio Vaticano I (1870), nel linguaggio sia del magistero sia della
teologia, il termine “dogma” ha acquistato un significato forte e univoco.
Esso indica una dottrina che la chiesa propone di credere come divinamente rivelata sia con
un giudizio solenne, sia nel suo magistero ordinario e universale. Si tratta quindi di una
indicazione importante su una verità di fede, che esige il nostro incondizionato assenso e la nostra
obbedienza.
i primi due “dogmi”
mariani, che riguardano la divina maternità di Maria , proclamata
solennemente ad Efeso nel 431, e la sua perpetua verginità, riaffermata al Concilio di
In questo contesto antiereticale dei primi Concili Ecumenici, si hanno
Costantinopoli II nel 553. Se questi dogmi antichi furono provocati dalle eresie, gli altri due dogmi
mariani, più recenti, hanno, invece, carattere “dossologico”. Essi esaltano alcune peculiarità
esemplari della straordinaria figura di Maria, la madre di Gesù, la quale è “ Immacolata”
(1854: Pio IX) e “Assunta” (1950: Pio XII).
Vengono anche chiamati “papali”,
perché proclamati non da un Concilio, ma dal Papa.
Alcune precisazioni.
La prima riguarda l’esistenza di altre verità dottrinali mariane, altrettanto importanti e
altrettanto riconosciute dal magistero ordinario della Chiesa e celebrate nella preghiera
liturgica, che non sono state proclamate solennemente. Si veda, ad esempio, il titolo di
Maria “mediatrice” e, come aggiunge il Concilio, “avvocata, socia, ausiliatrice” (cf.
Lumen Gentium n. 62).
La seconda precisazione riguarda i contenuti dei dogmi mariani antichi e recenti, che non
sono “invenzioni” tardive della Chiesa, ma verità esistenti esplicitamente o
implicitamente nella Sacra Scrittura e nella tradizione viva della Chiesa sia orientale
sia occidentale. Esse vengono “dogmatizzate”, e cioè solennemente riaffermate in un
determinato momento storico, sia per contrastare qualche eresia, sia per magnificare le
“grandi cose” che l’Onnipotente ha operato in Maria (cf. Lc 1,49).
Maria Madre di Dio
La divina maternità di Maria, fondata sulla Sacra Scrittura e proclamata solennemente nel Concilio
di Efeso nel 431, non solo è una dottrina, ma anche una preghiera. La solennità annuale di Maria,
Madre di Dio, che si celebra all’inizio dell’anno solare (1° gennaio), indica nelle preghiere iniziali il
significato perenne per noi di questa sua straordinaria vocazione.In concreto, la pedagogia liturgica
ci insegna che, anche noi, come Maria e accompagnati dalla sua materna ed efficace intercessione,
possiamo essere dimora di Gesù, Parola divina e Pane di vita eterna. Il “sì” dell’annunciazione,
mediante il quale Maria accolse la Parola di Dio nel suo seno diventando Madre di Gesù,
diventa anche il “sì” del battezzato, il quale, accogliendo Gesù, diventa come Maria dimora di
Gesù, ostensorio della sua grazia, tabernacolo della sua carità. È la realizzazione della parola stessa
di Gesù, che dice: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi stendendo la mano verso i suoi
discepoli disse: Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà del Padre mio
che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre» (Mt 12,48-50; cf. Mc 3,35).Gesù, come ha
trasformato l’acqua in vino e il pane nel suo corpo benedetto, così per l’intercessione materna di
Maria, madre sua e della Chiesa, trasforma le nostre esistenze terrene in esistenze “trinitarie”, in
dimora di Dio Trinità. Accogliendo infatti Gesù nel nostro cuore, noi accogliamo Dio Trinità: “Chi
accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10,40 e paralleli).
Il dogma della maternità divina di Maria ha quindi un carattere di fondazione della
spiritualità cristiana. La spiritualità cristiana è vita di grazia in comunione con Gesù nella carità
dello Spirito Santo in obbedienza al Padre, e Maria è stata la prima a vivere questa esperienza
diventando per noi maestra di spiritualità. Conseguentemente, vivere integralmente la vita di
grazia implica anche essere guidati e sostenuti dall’intercessione materna di Maria.
Maria sempre vergine
Nell’iconografia mariana il dogma della perpetua verginità di Maria – la “aeipárthenos”, la
“semprevergine” (concilio di Costantinopoli II, 553 d.C.) – viene rappresentato simbolicamente
da tre stelle che ornano il mantello della Beata Vergine. Le tre stelle indicano la virginitas ante
partum, la virginitas in partu e la virginitas post partum. Georg Söll, un grande storico dei dogmi
mariani, afferma al riguardo: “Il fatto che la Madre di Dio non cessò mai di essere vergine fu una
realtà non soltanto per i fedeli del tempo di Basilio, ma anche per quelli dei secoli successivi. La
maternità verginale assicura che Gesù è un dono esclusivo di Dio Trinità all’umanità in Maria. La
vita divina nata nel seno di Maria si diffonde nell’umanità intera attraverso l’azione sacramentale
della Chiesa. La Chiesa, come Maria, è la madre che continuamente, mediante il battesimo e gli altri
sacramenti, fa rinascere l’umanità alla comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Immacolata Concezione
Il dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato dal beato Pio IX l’8 dicembre del 1854,
propone come verità di fede divina rivelata “la dottrina che sostiene che la beatissima Vergine
Maria nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio
onnipotente, in vista dei meriti di Gesù Cristo, salvatore del genere umano, è stata preservata
immune da ogni macchia di peccato originale”.Il peccato, retaggio di ogni nato da donna, si
arresta davanti a Maria. Se Gesù Cristo è il tutto santo perché la sua umanità viene interamente
santificata dalla sua persona divina, Maria è la tutta santa in virtù della grazia proveniente dal Padre,
dalla carità dello Spirito e dai meriti del suo divin Figlio. Se Gesù è il redentore, Maria è la sua
prima redenta. La redenzione di Maria non fu per liberazione dal peccato, ma per preservazione.
Essa cioè non fu per nulla segnata dal peccato, ma ne fu preservata, per singolare privilegio divino.
In Maria non ci fu liberazione, ma preservazione. Secondo la geniale intuizione del dottore
dell’Immacolata, il beato Duns Scoto, Gesù Cristo ha esercitato in lei l’atto di mediazione più
eccelso, preservandola dal peccato originale. Diceva il Santo Padre Giovanni Paolo II in una sua
catechesi mariana: “A Maria, prima redenta da Cristo, che ha avuto il privilegio di non essere
sottoposta neppure per un istante al potere del male e del peccato, guardano i cristiani, come al
perfetto modello ed all’icona di quella santità, che sono chiamati a raggiungere, con l’aiuto
della grazia del Signore, nella loro vita”.
Maria Immacolata ricorda a tutti i battezzati la perfezione della santità. La tutta santa è stata e
continua a essere nella Chiesa la guida sicura che conduce alle alte vette della perfezione evangelica.
Premessa storico-liturgica
La riflessione teologica sull’Immacolata concezione di Maria è stata molto lenta. Una festa della
Natività di Maria era celebrata in Oriente verso la fine del VI secolo. Nel secolo seguente, poi, sorse
una festa della Concezione di Maria.In Occidente, invece, questa festa della Concezione di Maria
appare solo in Italia Meridionale, a Napoli, nel IX secolo e intorno al 1060 veniva celebrata anche
in Inghilterra, introdotta molto probabilmente da un monaco orientale. Dopo la conquista dell’isola
da parte dei Normanni, la festa riacquistò vigore e passò in Europa come festa dell’Immacolata
Concezione.
Non tutti i teologi del tempo erano favorevoli. Perfino il grande San bernardo di Chiaravalle (10911153), il cantore di Maria, colui che si sentì rispondere ad un suo saluto rivolto alla statua della
Vergine: “Ave, Bernarde” (Ciao, Bernardo), protestò in una lettera contro i Canonici di Lione per
aver introdotto questa festa.in questo stesso periodo, però, un discepolo di Sant’Anselmo di Aosta
(1033-1109), Eadmero, sostenne la possibilità dell’Immacolata Concezione. L’argomento era molto
semplice: Dio lo poteva fare. Se perciò lo voleva fare, lo fece. Di qui ebbe origine il famoso
assioma: “Potuit, decuit, ergo fecit” (Dio poteva; era conveniente, perciò lo fece). L’intuizione era
buona, ma poteva portare a delle esagerazioni. Una volta che i teologi avevano deciso che una cosa
era conveniente, concludevano che Dio l’aveva fatta. Ed esagerazioni del genere non
mancarono.Seguirono alcuni secoli di dibattito teologico al riguardo. Poi, nel 1477, Sisto IV dà il
suo beneplacido ad una Messa della Concezione; nel 1695, Innocenzo XII approva una Messa con
ufficio e ottava per la Chiesa intera, ed infine, nel 1708, con Clemente IX la festa divenne di
precetto.
Un altro appoggio alla celebrazione dell’Immacolata Concezione venne nel 1830 con le apparizioni
della Vergine a Caterina Labouré, che promosse la diffusione della Medaglia Miracolosa con
l’invocazione: “O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi”.Finalmente
nel 1854, Pio IX definì come dogma di fede la Concezione Immacolata di Maria e quattro anni dopo
la Madonna stessa, a suggello di quanto la Chiesa aveva proclamato, si autodefinì a Lourdes: “Io
sono l’Immacolata Concezione”. Con la riforma liturgica del Vaticano II questa celebrazione ha
assunto il grado di solennità.
L’Immacolata Concezione è spesso fraintesa da chi è privo di una sufficiente istruzione
catechetica: viene confusa con il concepimento verginale di Gesù. Diciamo subito che il Nuovo
Testamento non dice nulla sulla concezione di Maria. La riflessione teologica dei primi secoli toccò
sì Maria, ma in modo indiretto. I primi due dogmi mariani, infatti, cioè la Verginità di Maria e la
Maternità divina, erano prettamente cristologici, nel senso che erano affermazioni fatte su Maria,
ma con il fine di salvaguardare verità riguardanti Gesù. I due dogmi mariani più recenti, cioè quello
dell’Immacolata Concezione e quello dell’Assunzione, riguardano in maniera più diretta Maria. Da
un certo punto di vista essi rappresentano dei privilegi concessi alla Madonna, perché doveva essere
Madre di Gesù, vero Dio e vero uomo. Però il loro significato più profondo è soteriologico, in
quanto riguardano la nostra salvezza. Ci ammaestrano sul nostro fine ultimo, sulla grazia vittoriosa
di Cristo che vince il peccato e ci porta alla gloria finale.la cosa fondamentale che possiamo dire
sull’Immacolata Concezione è che Maria è stata redenta in previsione dei meriti del Figlio suo.
Gesù ha guadagnato sulla croce la grazia dell’Immacolata concezione di sua Madre. Tutto ciò
significa che la salvezza dell’umanità era operativa ancora prima che Cristo nascesse. La salvezza è
sempre un dono gratuito di Dio.
Il bambino è santificato gratuitamente nell’acqua del battesimo e l’adulto accetta come dono di Dio
la grazia della giustificazione mediante la fede. Quando diciamo che Maria è stata concepita senza
macchia di peccato, diciamo che è stata redenta nel modo più perfetto possibile: il peccato non l’ha
potuta nemmeno sfiorare. Questa sua Concezione Immacolata, però, è un dono totalmente gratuito
di Dio. Mediante questo privilegio, dunque, Maria è la perfetta salvata. Ella non ha mai avuto gli
ostacoli spirituali che distolgono noi, creature nate con il peccato originale, dal totale amore di Dio.
Questo dono le ha permesso di pronunciare al momento dell’Annunciazione, pur con un profondo
atto di fede di fronte al disegno imperscrutabile di Dio, un sì senza limiti, senza alcuna restrizione
inconscia. In molti passi la liturgia ci presenta la Vergine Santa come inizio della Chiesa. Sì, perché
Maria è la persona dove la grazia della redenzione raggiunse la sua espressione massima. In Maria,
infatti, la Chiesa incomincia ad esistere “senza macchia né ruga... ma santa e immacolata” (Ef 5,27).
Ciò che la Chiesa intera sarà un giorno, è già perfetto in Maria mediante la sua Immacolata
Concezione e la sua Assunzione.
Assunzione della Madre di Dio
Quasi sintesi del meraviglioso mistero di Maria, il 1° novembre del 1950, Pio XII proclama
solennemente il dogma dell’Assunzione di Maria, con queste parole:
“L’augusta Madre di Dio, arcanamente unita a Gesù Cristo fin da tutta l’eternità con uno stesso
decreto di predestinazione, immacolata nella sua concezione, vergine illibata nella sua divina
maternità, generosa socia del divino Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle
sue conseguenze, alla fine, come supremo coronamento dei suoi privilegi, ottenne di essere
preservata dalla corruzione del sepolcro, e, vinta la morte, come già il suo Figlio, di essere innalzata
in anima e corpo alla gloria del cielo, dove risplende Regina alla destra del Figlio suo, Re immortale
dei secoli”.
Mentre per tutta l’umanità la risurrezione dei corpi avverrà alla fine dei tempi, per Maria, invece,
tale evento si è realizzato già alla fine della sua vita terrena. Per cui il suo corpo è ora gloriosamente
vivente in cielo accanto all’umanità gloriosa del suo Figlio Gesù Cristo. Precisa al riguardo il Santo
Padre Giovanni Paolo II: “La condizione escatologica di Cristo e quella di Maria non vanno certo
poste sullo stesso piano. Maria, nuova Eva, ha ricevuto da Cristo, nuovo Adamo, la pienezza di
grazia e di gloria celeste, essendo stata risuscitata mediante lo Spirito Santo dal potere sovrano del
Figlio”.
Affermava nel 1979 l’allora cardinale Joseph RATZINGER:
Il grado più elevato di canonizzazione (Lc 1,48)
Il dogma dell'Assunta è semplicemente il grado supremo della canonizzazione nella quale il titolo
« santo » viene attribuito nel senso più stretto, volendo significare cioè : interamente e totalmente
nel compimento escatologico. Con ciò si dischiude ormai il contesto biblico fondamentale, che
garantisce tutta l'affermazione. Noi possiamo cioè asserire che il dogma dell'Assunta non fa che
descrivere nel suo contenuto ciò che è stato interiormente presupposto ed affermato nel grado
supremo del culto; nel medesimo istante ci si può e ci si deve allora ricordare che il vangelo stesso
profetizza ed esige il culto di Maria: « D'ora in poi tutte le generazioni mi cm ameranno beata » (Lc
1,48) - è un compito assegnato alla chiesa e la registrazione di Luca presuppone che la
glorificazione di Maria già esiste nella chiesa del suo tempo e che egli la ritiene un dovere della
chiesa per tutte le generazioni. Egli vede incominciare questa lode di Maria col saluto di Elisabetta:
« Beata colei che ha creduto... » (Lc 1,45).
Un elogio legato alla Risurrezione (Mc 12,18-27)
In questa primissima forma di culto di Maria si riflette nuovamente l'unità dei Testamenti,
quell'unità che è caratteristica di tutto il tema mariano : il Dio d'Israele viene chiamato tramite
uomini ai quali egli si è dimostrato grande, nella vita dei quali egli si rende visibile e presente. Essi
sono, per così dire, il suo nome nella storia, grazie a loro egli stesso ha un nome, per loro ed in loro
egli diventa accessibile. Si chiama il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe; chiamarlo significa
chiamare i padri, così come, viceversa, chiamare i padri significa ricordarsi di lui e riconoscerlo.
Non invocare gli uomini, nei quali egli stesso si rende visibile, è ingratitudine, smemoratezza -per la
fede d'Israele però è anche caratteristico che essa abbia memoria e sia memoria.
La glorificazione di Maria si congiunge quindi all'idea di Dio che collega i padri col nome di Dio e
sa che nella glorificazione dei padri c'è l'esaltazione di Dio. Se si tiene bene presente questo fatto,
non si può non prendere in considerazione nel nostro contesto l'interpretazione di Dio Padre che
Gesù ha dato in Mc 12,18-27.
Salita al cielo col suo corpo e la sua anima. (Ef 2,6)
« Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio ». Ciò significa: esiste
come una sorta di « ascensione » del battezzato, della quale parla in termini del tutto espliciti Ef 2,6:
« Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù ».
Stando a questo testo, il battesimo è partecipazione non soltanto alla risurrezione, ma anche
all'ascensione di Cristo. Il battezzato, in quanto battezzato e nella misura in cui là, nel Signore
glorificato, la sua vita nascosta (la sua vera vita! ).
La formula dell' « assunzione » di Maria in corpo ed anima perde, sulla base di questo testo, ogni
carattere speculativo ed arbitrario: essa, infatti, è solamente la forma suprema di canonizzazione: si
dice che in colei che ha generato il Signore « prima col cuore che secondo il corpo » (Agostino ),
della quale la fede, cioè il contenuto interiore del battesimo, può essere asserita illimitatamente,
conformemente a Lc 1,45, nella quale si è quindi realizzata tutta l'essenza del battesimo, in lei la
morte è stata inghiottita nella vittoria di Cristo.
Il culto di Maria è l'oscillare beato nella gioia del Magnificat e, perciò, nella lode di colui verso il
quale è debitrice la figlia di Sion e di colui che lei porta come la vera, non deperibile, indistruttibile
arca dell'alleanza.
Per quanto riguarda l’escatologia abbiamo seguito il Catechismo della Chiesa Cattolica dal n. 988 al
n.1050.
Per approfondire:
Joseph RATZINGER, La figlia di Sion, Jaca Book, Milano 1979, p.69-79
Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 484-507(Maria); 988-1050(escatologia)
Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica “Lumen gentium”, cap. VIII.
“Lettera ai cercatori di Dio” Documento della Commissione Episcopale per la dottrina della fede,
l'annuncio e la catechesi della CEI (scaricabile dal sito ufficiale della Chiesa Cattolica/Ufficio
Catechistico Nazionale/Animazione catechistica/Documentazione).