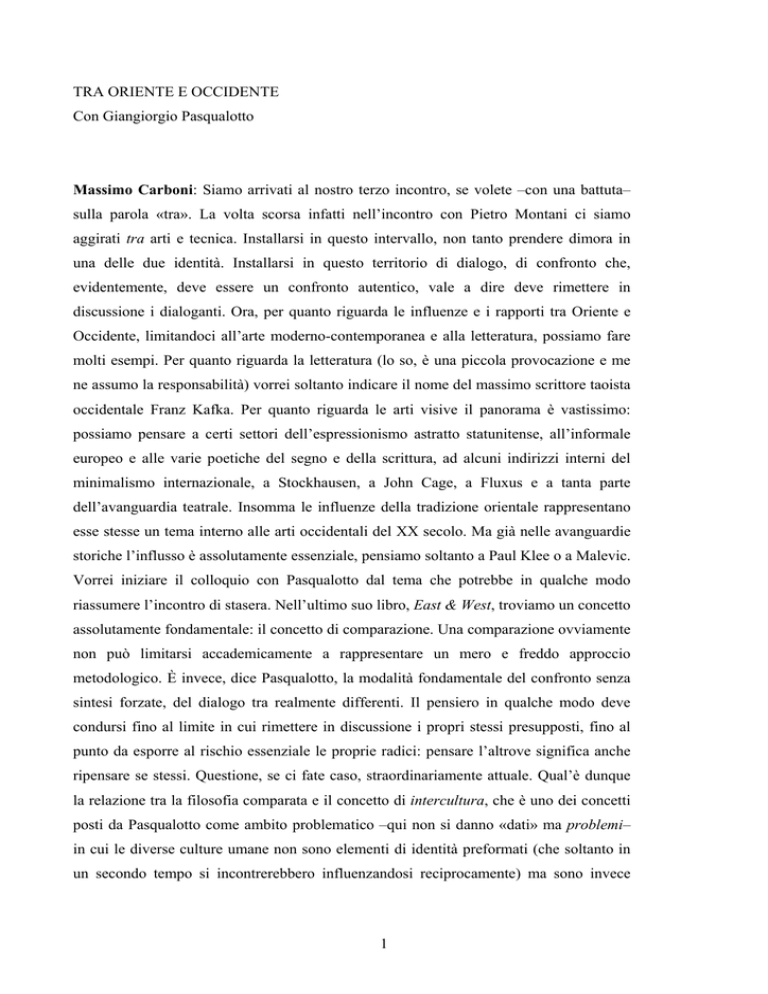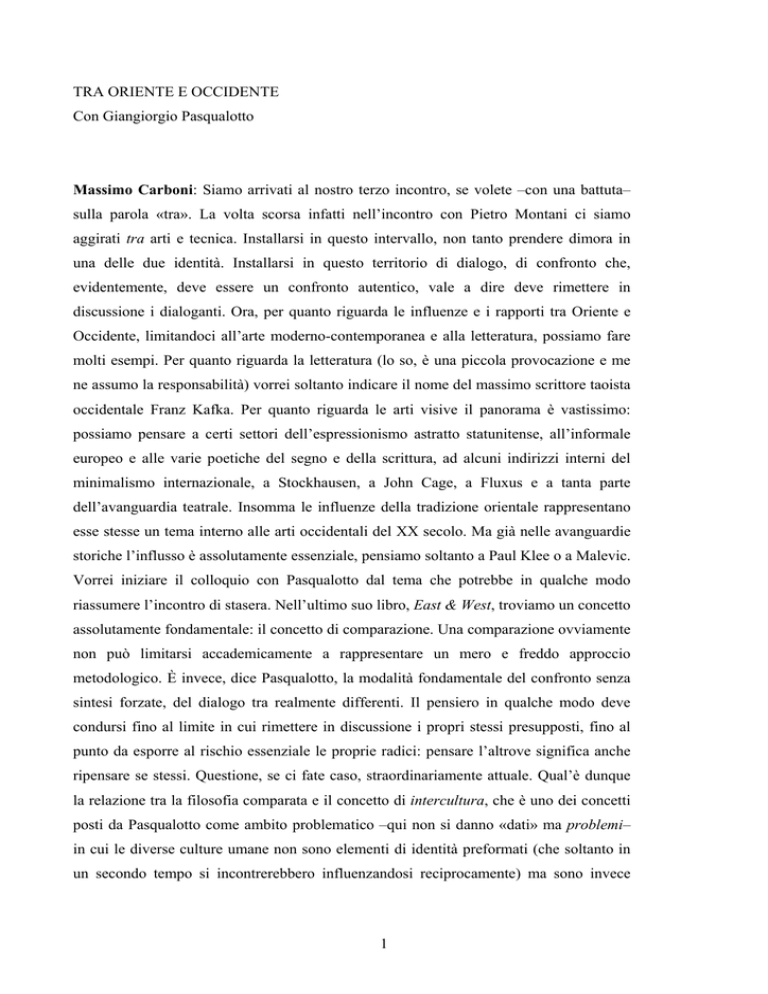
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Con Giangiorgio Pasqualotto
Massimo Carboni: Siamo arrivati al nostro terzo incontro, se volete –con una battuta–
sulla parola «tra». La volta scorsa infatti nell’incontro con Pietro Montani ci siamo
aggirati tra arti e tecnica. Installarsi in questo intervallo, non tanto prendere dimora in
una delle due identità. Installarsi in questo territorio di dialogo, di confronto che,
evidentemente, deve essere un confronto autentico, vale a dire deve rimettere in
discussione i dialoganti. Ora, per quanto riguarda le influenze e i rapporti tra Oriente e
Occidente, limitandoci all’arte moderno-contemporanea e alla letteratura, possiamo fare
molti esempi. Per quanto riguarda la letteratura (lo so, è una piccola provocazione e me
ne assumo la responsabilità) vorrei soltanto indicare il nome del massimo scrittore taoista
occidentale Franz Kafka. Per quanto riguarda le arti visive il panorama è vastissimo:
possiamo pensare a certi settori dell’espressionismo astratto statunitense, all’informale
europeo e alle varie poetiche del segno e della scrittura, ad alcuni indirizzi interni del
minimalismo internazionale, a Stockhausen, a John Cage, a Fluxus e a tanta parte
dell’avanguardia teatrale. Insomma le influenze della tradizione orientale rappresentano
esse stesse un tema interno alle arti occidentali del XX secolo. Ma già nelle avanguardie
storiche l’influsso è assolutamente essenziale, pensiamo soltanto a Paul Klee o a Malevic.
Vorrei iniziare il colloquio con Pasqualotto dal tema che potrebbe in qualche modo
riassumere l’incontro di stasera. Nell’ultimo suo libro, East & West, troviamo un concetto
assolutamente fondamentale: il concetto di comparazione. Una comparazione ovviamente
non può limitarsi accademicamente a rappresentare un mero e freddo approccio
metodologico. È invece, dice Pasqualotto, la modalità fondamentale del confronto senza
sintesi forzate, del dialogo tra realmente differenti. Il pensiero in qualche modo deve
condursi fino al limite in cui rimettere in discussione i propri stessi presupposti, fino al
punto da esporre al rischio essenziale le proprie radici: pensare l’altrove significa anche
ripensare se stessi. Questione, se ci fate caso, straordinariamente attuale. Qual’è dunque
la relazione tra la filosofia comparata e il concetto di intercultura, che è uno dei concetti
posti da Pasqualotto come ambito problematico –qui non si danno «dati» ma problemi–
in cui le diverse culture umane non sono elementi di identità preformati (che soltanto in
un secondo tempo si incontrerebbero influenzandosi reciprocamente) ma sono invece
1
costruzioni, complessi di identità che, in qualche modo, alimentano se stessi per mezzo
del confronto costruttivo con l’altro?
Giangiorgio Pasqualotto: Carboni ha messo in luce i due elementi fondamentali del
problema. Da un lato il concetto di comparazione e dall’altro il concetto di identità. Dico
due cose molto semplici, perché sulla comparazione –in particolare sulla filosofia
comparativa– sono sorti molti equivoci, se non addirittura travisamenti.
Perché ci sono dei problemi quando si parla di filosofia comparata o comparativa?
Innanzitutto, mi riferisco alla storia della filosofia comparata. Una storia che, da un punto
di vista formale, ossia della denominazione «filosofia comparata», nasce nel 1939 negli
Stati Uniti, precisamente ad Honolulu, con un grande progetto finalizzato a produrre una
filosofia mondiale. Non mi soffermo analiticamente a vedere tutte le fasi della storia della
filosofia comparata. Sottolineo soltanto il fatto che tale progetto, da un lato, aveva un’
intenzione positiva, cioè quella di tentare di evitare che le ovvie diversità tra pensieri sorti
in contesti geografici tra loro lontani si trasformassero in opposizioni, dando adito e
giustificazioni a conflitti fra culture; dall’altra, però, il progetto era attraversato da forti
striature di ingenuità, perché, almeno nelle sue versioni principali, pretendeva di prendere
il «meglio» delle varie filosofie prodotte, in epoche diverse, nei diversi luoghi del mondo:
un po’ di filosofia cinese, un po’ di filosofia indiana, un po’ di filosofia occidentale (un
po’ tedesca, un po’ francese ecc.). Per la costruzione di un’ etica mondiale facevano la
parte del leone Kant e Confucio, per la logica Nagarjuna e Wittgenstein, etc. Per fortuna
queste ingenuità, durate circa 30 anni, sono andate progressivamente sfumando, tanto che
nella rivista che è stata storicamente l’’organo’ ufficiale di questo progetto, “Philosophy
East and West”, oggi –grazie soprattutto alla direzione di Roger Ames–, non vengono più
ospitati articoli che coltivano l’utopia di una ‘filosofia mondiale’. È sempre più risultato
evidente, infatti, che la filosofia comparata non può avere un solido fondamento
soprattutto perché è assai problematico stabilire chi può avere l’autorità e il diritto di
decidere che cosa sia il «meglio» da raccogliere e da mettere insieme: ciò
presupporrebbe, l’idea –tanto debole quanto fantasiosa– che ci possa essere un ‘occhio’,
un supervisore, assolutamente neutrale, super partes, che non appartiene a nessun luogo,
a nessun paese, a nessuna cultura particolare nazione. È ovvio che questa idea avrebbe i
caratteri di una pretesa completamente astratta, assolutamente formale, benché i motivi
che la ispirano possano esser considerati ‘buoni e utili’. Questo è il motivo per cui,
quando l’accademia filosofica europea, in particolare quella italiana, sente nominare la
2
filosofia comparata mostra segni di insofferenza o, addirittura, si lascia andare a ‘gesti’ di
irritazione.
Ora, il discorso che personalmente propongo sulla filosofia comparata ha ben poco a che
fare con le varie declinazioni del progetto di ‘filosofia mondiale’, né con molti dei
risultati prodotti dal lavoro comparativo finora svolto; questo perché intendo affrontare il
problema da tutt’altro punto di vista, se volete molto più semplice, andando alla radice
dell’attività comparativa, tornando cioè a ragionare sul concetto di comparazione. In
primissimo luogo è da ricordare che ogni ragionamento è fatto attraverso la
comparazione. Per esempio, ogni giudizio, anche quello più elementare, del tipo «questa
è una penna» o «questo è un tavolo», è costituito da una proposizione prodotta mediante
una comparazione tra un aggettivo e un sostantivo: tale proposizione, infatti, presuppone
una sintesi concettuale che, a sua volta, presuppone un confronto tra i concetti ‘questa’ e
‘penna’ . Quindi, qualsiasi ragionamento, indipendentemente dalla diverse latitudini e dai
diversi tempi in cui nasce, è necessariamente comparativo.
In secondo luogo, volendo entrare nell’ambito della storia della filosofia, si può dire che
non ci sia stato autore o pensatore che non abbia proceduto per comparazioni: sia
all’interno di ogni suo ragionamento, sia all’interno dei confronti istituiti tra il proprio
pensiero e quello dei suoi predecessori e/o dei suoi contemporanei. Faccio un esempio tra
i più noti, quello di Platone che ingaggiò una vera e propria battaglia con Parmenide, la
quale produsse alla fine un testo fondamentale per tutti coloro che hanno studiato e
ancora studiano filosofia, il Parmenide, considerato il dialogo che testimonia il
‘parricidio’ di Platone e, quindi, la sua emancipazione dalla dottrina del maestro. Ma
basta sfogliare la Metafisica di Aristotele per trovare intere pagine dedicate a ‘smontare’
il pensiero dei suoi predecessori. Questa operazione critica fondata sulla comparazione
non vale solo per la storia della filosofia antica: se si prende in considerazione il più
celebrato tra i filosofi contemporanei, Heidegger, si può notare che gran parte del suo
pensiero è costituito da un confronto critico con i suoi predecessori, da Platone a
Nietzsche.
Quindi, alla luce di queste considerazioni, volendo sostituire la formula «filosofia
comparata» –perché inficiata dai limiti prima evidenziati–, credo che si possa sostituirla
con «filosofia come comparazione». Questo è il primo chiarimento da fare quando si
parla di comparazione. Il secondo chiarimento è forse ancora più importante, perché
riguarda il fatto incontrovertibile che, all’interno di ogni ragionamento comparativo, si dà
come presupposta l’identità. Quando prima si faceva l’esempio della proposizione
3
«questa è una penna», si dava come presupposto che «questa» e «penna», siano due realtà
logiche autonome. Questo perché, altrimenti, non sarebbe nemmeno possibile parlare:
sarebbe infatti difficile comunicare se ci fossero degli ‘sfrangiamenti’ che portano a
confondere ‘questa’ con ‘penna’, ‘questo’ con ‘tavolo’, etc. Tuttavia, se da un lato la
distinzione logica che distingue le diverse identità delle parti che costituiscono una
proposizione è affatto necessaria per la comunicazione, dall’altro, essa non dice ‘tutta la
verità’. In effetti, questo tavolo, da un punto di vista fisico-materiale, è il risultato di una
serie di processi (quello naturale che ha prodotto il legno, quello artificiale di chi lo ha
lavorato, etc.) e, dal punto di vista funzionale, risulta da una serie di condizionamenti (dai
diversi usi che ne posso fare, dalle diverse situazioni ambientali in cui può essere
collocato, etc.). In definitiva, questo tavolo che apparentemente è una semplice identità,
si rivela essere anche il ‘luogo’ di una molteplicità di processi e di funzioni. Ora, questo
discorso che porta a svelare molteplicità e processualità al fondo di ogni singola identità,
non è applicabile solo agli oggetti più semplici, ma anche alle realtà più complesse quali
le civiltà. Come è ormai acquisito da parte dell’antropologia contemporanea, le identità
culturali non sono dei dati fissi e immutabili: le identità culturali sono costruite e
continuano a costruirsi, cioè continuano a modificarsi attraverso una serie di
contaminazioni. Perfino quello che ci è stato tramandato come esempio di identità
culturale forte, cioè la cultura greco-romana, è il risultato di un complesso processo, di un
insieme di intrecci e sovrapposizioni: innanzitutto è da precisare che l’unità ‘grecoromana’ va scomposta in due insiemi distinti, ma poi va ricordato che ciascuno di questi
due insiemi è a sua volta scomponibile in numerosi sotto-insiemi. La cultura greca fu il
prodotto di una serie di culture mediterranee, da quella micenea a quella egiziana, da
quella fenicia a quella, addirittura, babilonese. La cultura greca non solo nacque grazie a
delle contaminazioni, ma anche si sviluppò nella contaminazione: per fare un esempio
assai noto a chi studia filosofia e storia della filosofia, una notevole parte della filosofia
greca non fu prodotta in madrepatria, ma nelle colonie greche in terre straniere, dove la
contaminazione con gli ‘indigeni’ costituiva la normale condizione di vita. Inoltre, la
cultura romana –che parte della mia generazione ha percepito come cultura monolitica
prevalentemente autoctona– ha addirittura teorizzato giuridicamente la possibilità di
questa continua contaminazione. Ad esempio: il diritto romano riconobbe la cittadinanza
a tutti i popoli sottomessi, i quali non vennero intesi solo come schiavi in quanto vinti, ma
potevano diventare cittadini romani e addirittura «liberi». Ma, anche a prescindere dai
riconoscimenti giuridici, la civiltà romana, di fatto, si formò attraverso gli apporti
4
provenienti dall’Africa, dalla Gallia, dal Nord e dall’Est. Uno degli esempi più
significativi di questo apporto ‘straniero’ alla cultura romana è costituito dalla figura del
più grande filosofo latino, Seneca, che era spagnolo. Si può dunque parlare di una
“produzione di culture per mezzo di decostruzioni di identità”, o, meglio, di “costruzione
di culture per mezzo di contaminazioni”. (Si tratta, ovviamente, di contaminazioni
‘governate’, che producono anche forme di controllo e di coercizione, non solo scambi
‘idilliaci’!). Per giungere a tempi più vicini a noi, l’esempio degli Stati Uniti prova in
modo chiarissimo e macroscopico il fatto che l’identità è stata e continua ad essere
prodotta grazie all’apporto di contaminazioni. È da ricordare a questo proposito che oggi
all’interno dei laboratori scientifici delle più grandi università americane (Yale, Boston,
etc.) la percentuale dei ricercatori di origine orientale oscilla tra il 40% e il 50% e che il
70% di loro non è di origine anglosassone. (Ma si dovrebbe anche ricordare che quel 30%
di ‘origine anglosassone’ è in realtà formato da discendenti di emigrati dall’Europa,
impossibilitati, quindi, a vantare qualsiasi titolo di ‘purezza etnica’!).
MC: Il panorama che hai delineato risulta particolarmente chiaro. Ma allora a questo
punto mi viene da chiederti quali sono le ragioni del tuo disaccordo rispetto alle teorie
multiculturaliste…
GP: L’ipotesi multiculturalista è un’ipotesi di statistica sociologica o di statistica
antropologica. Multiculturalismo vuol dire semplice registrazione del fatto che ci sono
tante etnìe, tante civiltà, tante culture diverse. Questa ‘registrazione’ può significare
troppo poco o troppo, a seconda di come la si usa: troppo poco, se ci si limita a constatare
la molteplicità delle culture. Rimane infatti aperto il problema di quale atteggiamento da
assumere di fronte a questa molteplicità. Troppo, se, sulla base di questa molteplicità, si
intende stabilire una ‘graduatoria’ delle diverse civiltà: sulla base di quale criterio
possiamo pretendere di stabilire quale civiltà va presa a modello?. Venature, negative, di
multiculturalismo erano presenti anche nelle prime versioni di filosofia comparata che ho
ricordato in precedenza, quando, per esempio si sceglieva l’etica confuciana come
rappresentativa della filosofia cinese (o addirittura orientale), e quella kantiana della
filosofia europea. Questo in base a quale criterio? Si sa, infatti, che contemporanee a
quella kantiana vi erano molte altre idee di che cosa fosse il bene; così come, in ambito
cinese, si sa che vi erano, tra gli altri, i taoisti e i sofisti che sostenevano tesi etiche
radicalmente diverse da quelle confuciane. Quando si vuole ridurre la molteplicità
5
multiculturalista si incorre in un doppio abbaglio: se, per esempio, nel caso del pensiero
cinese, prendiamo il confucianesimo come rappresentativo non solo di tale pensiero, ma
anche di tutta la cultura orientale. Questo secondo abbaglio consiste nel dimenticare che
in realtà la cultura orientale è costituita da un’enorme quantità di culture per nulla
riducibile a varianti di quella cinese: basti pensare –senza considerare quella thai, quella
khmer, quella laotiana, etc.– alla cultura indiana e alle sue numerose articolazioni interne.
Quindi ‘multiculturalismo’, nella migliore delle ipotesi è una parola vuota; nella
peggiore, una parola che può giustificare procedure riduzionistiche. Per questo ritengo
intercultura un termine più appropriato ad indicare una prospettiva in cui ciascuna cultura
è vista come una realtà che ha bisogno delle altre per costituirsi e svilupparsi, come in
natura un albero ha bisogno delle radici per nascere e vivere.
MC: Vorrei fare una domanda molto diretta anche se in qualche modo scontata. Esiste
davvero una filosofia orientale o possiamo parlare solo di saggezza?
GP: La questione è delicata, perché spesso, dando peso eccessivo alle parole, si osserva
che non c’è filosofia orientale in quanto ‘filosofia’ è un termine greco. È questa
un’osservazione, oltre che banale, di sapore sofistico e puramente formale: se si ‘svolge’
il termine ‘filosofia’ in ciò che esso vuol significare, si constata che con esso si intende –
stando almeno a quanto ci ha insegnato Platone– “ricerca della sapienza”. Ma, allora, si
può concludere, con abbondanza di prove, che sia in Cina che in India si sono avuti fior
fiore di pensatori e di dottrine che hanno fatto proprio questo: sono andati in cerca della
sapienza. Per non perpetuare simili equivoci formali propongo quindi di parlare di
pensiero orientale e occidentale, in modo che nessuno possa ancora giocare con le parole
per vantare il monopolio del filosofare. Del resto basta ricordare che ogni cultura ha, in
generale, ‘fatto filosofia’ dal momento in cui si è messa a riflettere su alcuni problemi
cruciali: sul rapporto tra bene e male, tra brutto e bello, tra vero e falso, tanto per citare i
problemi tradizionali della filosofia. Detto questo, però, è necessario fare un'altra
precisazione. In Oriente, ancor oggi –per quel poco di Oriente tradizionale che è rimasto
e che rimarrà– il pensiero (se non si vuol usare il termine ‘filosofia’) non rinvia soltanto a
modalità logico-astratte, ma a concrete forme di vita. Questo è un punto di fondamentale
importanza su cui si è soffermato a più riprese Raimon Panikkar, in particolare in uno dei
suoi ultimi libri tradotti in italiano, L’esperienza filosofica dell’India. Non a caso egli usa
il termine ‘esperienza’: avrebbe potuto intitolarlo La filosofia dell’India, ma ‘esperienza
6
filosofica’ indica esplicitamente il fatto che nella cultura indiana, dalle origini ad oggi,
ogni visione filosofica non comporta soltanto un sistema razionale più o meno completo,
ma anche azioni coerenti rispetto a tale sistema. In parole povere, possiamo dire che
ancor oggi in Oriente, in particolare in India, la filosofia è simile a quello che essa era
nella nostra tradizione più antica, ossia –secondo quanto ci ha insegnato Hadot– stile di
vita. In effetti in Occidente la filosofia comincia ad essere filosofia accademica (legata
soprattutto alla scrittura ed alla lettura) solo nel Medioevo; ma fino alla chiusura
dell’Accademia platonica ovvero, se si preferisce, fino alla morte di Plotino, le scuole
della filosofia greca –da quella pitagorica a quelle epicuree– furono «scuole di vita».
Cosa vuol dire «scuola di vita»? Vuol dire che il maestro istituiva una scuola in cui egli
dava agli allievi i propri insegnamenti ma, contemporaneamente, gli allievi cercavano di
applicare tali insegnamenti nei comportamenti, anche minimi e banali, della vita
quotidiana: dal mangiare al bere, dal coricarsi al passeggiare, essi cercavano di seguire le
indicazioni verbali ma anche gli esempi ‘corporei’ forniti dal maestro.
MC: È esattamente questo il secondo punto che volevo porre alla tua attenzione, lo hai
introdotto perfettamente. È centrale nelle tradizioni orientali la pratica, l’esercizio e la
disciplina del corpo. Un ambito questo dimenticato nella filosofia occidentale in quanto
sapere accademico-istituzionale. Ora, la domanda che volevo porti è questa: proprio da
questo punto di vista non si potrebbe affermare che più attenti all’esperienza orientale
sono proprio gli artisti, con le loro pratiche simboliche e con la loro poiesis? L’artista è
chiamato a fare, non tanto a meditare o pensare, e comunque le sue meditazioni e i suoi
pensieri devono poi, in qualche modo, tradursi in veste fenomenico-concreta con la
costruttività dei loro linguaggi e anche con la disciplina di vita integrale che il loro lavoro
richiede. Non pensi allora che proprio gli artisti siano, o possano essere, i destinatari più
appropriati, per così dire, dell’esperienza orientale?
GP: Sì, questa tua ultima precisazione del «possano» è molto importante perché non tutti
gli artisti lo sono: anzi, in base alle mie esperienze e conoscenze dirette di diversi tipi di
artisti, lo sono solo una ristretta minoranza. Ancor oggi, in molti artisti occidentali (ma
anche orientali, quelli fortemente succubi dei modelli occidentali) si registrano i caratteri
del genio –o aspirante tale– delineati da Burckhardt per l’artista del Rinascimento,
segnato dall’indomabile volontà di rifare, letteralmente, il mondo, in quanto si ritiene
‘centro del mondo’…
7
MC: …e poi la teoria romantica del genio…
GP: …sarebbe interessante fare un ricerca su tutti gli antidoti che comproverebbero
questo tipo di interpretazione del rapporto io-opera, io-pubblico, io-realtà, nell’artista
occidentale. Sarebbe da fare un esperimento per vedere –partendo proprio dagli artisti del
Rinascimento, magari proprio da quelli portati ad esempio da Burckhardt, come Leon
Battista Alberti e Michelangelo, o a partire dai grandi geni romantici– se è vero che essi
avevano una percezione assolutamente autocentrata, quasi maniacale, del proprio ego.
Credo proprio di no. Dai pochi sondaggi che ho fatto, per esempio se leggete il De
familia di Leon Battista Alberti, le cose stanno in maniera completamente diversa. Allora,
o l’Alberti era schizofrenico perché, quando produceva opere d’arte, pensava di essere il
padreterno, ma poi si smentiva nei suoi scritti pedagogici; oppure bisogna rivedere alcuni
giudizi. Un altro tentativo da fare sarebbe quello di prendere in esame la figura e l’opera
di Novalis, sempre considerato come uno degli autori più ‘scatenati’ nell’affermare la
centralità del genio: invece molti suoi ‘frammenti’ significativi stanno ad indicare una
direzione di senso affatto diversa, e cioè che fosse l’opera a dettar legge all’artista, al
genio, e non il contrario.
MC: …l’artista qui è visitato, qualcosa dimora in lui a cui egli è chiamato a dare
espressione.
GP: Esattamente. Quindi, anche qui c’è una grande differenza tra ciò che ritiene il senso
comune (anche quello accademicamente paludato) e la realtà. In effetti, si hanno prove
concrete che Oriente e Occidente siano per molti aspetti più vicini di quanto ci siamo
immaginati, o di quanto abbiamo voluto immaginare. In Oriente, grazie all’influsso del
buddhismo e del taoismo, gran parte degli artisti ha assorbito questa legge che prevede la
drastica riduzione della presenza dell’ego all’interno del proprio lavoro, per cui l’opera
risulta tanto più riuscita quanto meno sono presenti i segni della soggettività dell’artista.
Uno degli esempi più noti a questo riguardo è quello della poesia di Basho, ritenuto il più
grande scrittore di haiku. In ogni poesia di Basho voi trovate molte suggestioni che
possono implicitamente alludere alla soggettività dell’artista (e del lettore), ma mai una
sola parola che si riferisca esplicitamente a tale soggettività (in particolare, è da segnalare
l’assenza di pronomi e di aggettivi possessivi). Alla fine il componimento risulta essere
8
assai simile ad una registrazione fotografica della realtà, ad un’istantanea di un evento o
di una situazione. Nell’arte orientale questa eclissi della soggettività è molto più
frequente e radicata che in quella occidentale. Però non renderei assoluta questa
contrapposizione tra artista occidentale –tutto legato all’espressionismo soggettivo– e
artista orientale tutto votato alla pura oggettività. Anche perché, per controprova, si
potrebbe fare l’esempio di un altro grandissimo compositore di haiku, Hikkiu, del ‘700, il
quale, invece, fa ampio uso di riferimenti personali. Questo per dire che le cose sono
sempre più complesse, intrecciate e sfumate di quello che ci hanno fatto credere molti
compilatori di storie dell’arte orientale e occidentale.
MC: Bene, procediamo su un altro punto. Il carattere anti-tecnologico, in qualche modo
a-scientifico se non proprio anti-scientifico dell’Oriente, della Cina in particolare, è un
cliché, un luogo comune ormai sfatato da tempo, anche se tuttora resiste. C’è l’apologo
del Zhuang-zi sul macellaio che macella gli animali senza mai affilare il suo coltello.
Dice che non ne ha bisogno perché egli si limita a seguire le pieghe, le curve dei muscoli
della carne trovando il punto di frattura e lì inserisce la lama, per cui non ha bisogno di
star sempre ad affilarla. C’è dunque questa tecnica di assecondare la natura, non di
imporle il suo ordine ma, in qualche modo, di accettarne l’immanente articolazione.
Proprio perciò questa tecnica è potente: può proprio in quanto si lascia guidare dalla
physis, dalla natura. Da un certo punto di vista, non conosco elogio della tecnica più
potente e più forte di questo, di cui l’Occidente non ha assolutamente parlato. Di qui il
rapporto con la scienza e con le scienze moderno-contemporanee. In un libro molto
famoso, Il tao della fisica, di Fritjof Capra, l’autore ha sottolineato tutte le analogie che si
possono riscontrare tra i motivi di fondo del pensiero orientale antico e le posizioni più
avanzate dell’epistemologia e della fisica moderno-contemporanee. Ecco il carattere di
evento e non di «cosa», non di dato in sé ma di evento-processo della realtà subatomica
(Pasqualotto diceva prima che questo tavolo in fondo non è altro che un sistema dinamico
e ordinato di elettroni), come un flusso e non come un ente-oggetto stabile che stia
dinanzi a noi, di fronte a noi, separato da noi. Il carattere dunque insostanziale (anatta) e
impermanente (anicca) di elementi che, letteralmente, non sono nulla una volta isolati,
ma che acquistano senso soltanto all’interno di una rete di relazioni e di relazioni di
relazioni. Allora da Eraclito e Chuang-tzu (questa coppia su cui tu stesso ti soffermavi nel
Tao della Filosofia) fino alla meccanica quantistica, il Tutto lo si pensa come un
percorso, innervato da queste sinapsi, intrecci, giunture che interagiscono le une con le
9
altre. Che cosa pensi di questo aspetto specifico del confronto Oriente-Occidente,
orientato appunto sul riferimento alle scienze moderne? C’è un’enfasi eccessiva su
questo oppure…
GP: Non credo che ci sia una esagerazione in questo, anzi. Per esempio Capra, data la
sua formazione di fisico, si interessa di mostrare quali sono le analogie tra le concezioni
della fisica subatomica e le intuizioni che ha avuto soprattutto il buddhismo per quanto
riguarda la struttura ontologica della realtà. Però non si sofferma su un altro punto –
sviluppato molto soprattutto in ambito anglosassone– cioè quello delle enormi
potenzialità presenti nel serbatoio costituito dalle analisi psicologiche prodotte dal
Buddhismo. Questa è una delle prove più straordinarie delle possibilità di confronto tra
forme di sapere orientali ed occidentali, sia per quanto riguarda le procedure dell’analisi,
che per quanto riguarda i risultati delle analisi, e, talvolta, perfino, le terapie. C’è al
proposito un libro uscito di recente, curato da Anthony Molino, Psicoanalisi e buddismo,
il quale raccoglie contributi di psicanalisti americani e inglesi che si sono occupati
proprio di verificare i possibili apporti alla psicologia e alla psicoanalisi da parte delle
riflessioni sviluppate –grazie alle pratiche meditative– dal Buddhismo antico. Questo è un
aspetto che potrebbe ulteriormente provare l’interesse e i motivi di fondo dell’Occidente
contemporaneo per questi orizzonti di senso assai lontani nel tempo e nello spazio. Qual
è, secondo me, il vero problema? Il problema è costituito da quell’ipertrofia della
presunzione tecnologica che si è prodotta in Occidente, almeno a partire da due secoli a
questa parte. Il problema, cioè, sta nel fatto che questa ‘tecnomania’ ormai consolidatasi e
sempre più dilagante tende ad utilizzare ogni apporto culturale –anche quelli più ‘alieni’–
con l’intenzione e la pretesa di poter manipolare e utilizzare la realtà a nostro piacimento.
Questo rimanda, in ultima istanza, ad un antropocentrismo esasperato, dove, però, è
chiaro che non si tratta dell’esasperazione maniacale dell’Uomo in sé, dell’Umanità tutta,
ma di una parte, per ora vincente, dell’umanità che sta conducendo alla rovina tutta
l’umanità.
MC: …quando nel tuo libro parli ad esempio della polvere da sparo. In Oriente con la
polvere da sparo hanno inventato i fuochi d’artificio e noi invece abbiamo fatto bombe.
GP: Questa è una cosa nota da tempo, evidenziata dalle ricerche sulla civiltà cinese fatte
da Needham. Il diverso atteggiamento dell’Oriente e dell’Occidente di fronte alle
10
innovazioni tecnologiche dovrebbe costituire l’oggetto privilegiato di una riflessione
profonda che investe il problema delle possibilità di un approccio interculturale: il fatto –
anch’esso messo in evidenza da Needham– per cui i Cinesi hanno inventato la bussola e
l’hanno usata per navigare, ma non l’hanno, come noi, applicata per scoprire (e
conquistare) nuove terre, mette bene in luce che di fronte ad un medesimo oggetto,
diverse culture ne danno un’interpretazione diversa. Questo non deve indurre ad una
semplice constatazione, ma produrre una riflessione sui motivi delle diversità e quindi, in
definitiva, un giudizio sulla qualità di questi motivi: siamo ancora sicuri che i nostri
motivi siano migliori di quegli degli altri?
MC: Aspetta, vuoi dire che ciò significa che in Oriente non esiste una «volontà di
potenza»?
GP: Comincio a pensare di sì. O almeno essa non è esistita –fino alla metà
dell’ottocento– nelle forme così forti ed estese come in Occidente. In particolare, quella
forma di ‘volontà di potenza’ incarnata nella ‘tecnomania’ è una nostra malattia che
abbiamo diffuso su scala planetaria; e personalmente credo –in modo affatto
pessimistico– che tale epidemia non sia reversibile: il futuro sarà tutto occidentale. La
Cina è uno degli esempi più incredibili –drammatici o esaltanti a seconda dei punti di
vista– di quanto l’Oriente stia facendo per acquisire molte caratteristiche che pensavamo
soprattutto nostre. Personalmente non sono in grado di delineare che cosa succederà in
futuro. Noto solo che, storicamente, l’Oriente ha avuto per millenni un atteggiamento
profondamente diverso dal nostro nei confronti del mondo –sia di quello naturale, che di
quello umano. L’idea che la realtà va studiata per conquistarla, per sottometterla, per
governarla a nostro piacimento è una nostra invenzione occidentale, in particolare
moderna. La Cina, per esempio, per secoli si considerò un paese talmente perfetto da non
aver bisogno di avventurarsi in alcuna forma di espansione. Da un punto di vista
prospettico molto ampio si deve constatare un’inequivocabile asimmetrìa: mentre noi
Occidentali abbiamo conquistato il mondo, gli altri si sono lasciati conquistare. Gli unici
che si sono opposti a questa situazione e ci hanno fatto ‘concorrenza’ sono stati alcuni
popoli islamici: può essere che questo sia dovuto a profonde ragioni religiose, ma
potrebbe anche essere dovuto alla volontà di sanare questa asimmetria. Ma, comunque,
credo che anche questa reazione islamica sia parte integrante della storia e della civiltà
dell’Occidente.
11
MC: Questo ben si lega alla successiva domanda. Volevo partire dall’Islam, o comunque
da come è visto l’Islam oggi. Non esiste un unico Islam, così come non esiste un unico
Occidente. E il primo passo, l’anticamera dello sciovinismo razzista, è proprio quello di
vedere l’altro come un blocco unico, un monolite non attraversato da nessuna differenza.
Sappiamo benissimo invece che l’Occidente non ha assolutamente l’esclusiva della
dialettica interna, né della raffinata ricerca della diversità, che sono patrimonio
ovviamente anche di altre culture. L’Oriente del nostro immaginario (nutrito di letteratura
di evasione, di cinema di serie B, degli equilibri psichici riconquistati a suon di assegni
dopo l’orario d’ufficio, ecc.) è sempre qualcosa di «misterioso». Rispetto a questo
Oriente, a una visione monoblocco dell’Oriente, quanti «Orienti» ci sono? Quanti diversi
linguaggi lo attraversano?
GP: Ecco questo è davvero un grande problema. Limitandoci solamente all’India noi
troviamo una grande quantità di linguaggi –non solo verbali o scritti ma anche linguaggi
artistici, linguaggi antropologicamente significativi, cioè usi e costumi– tale da non poter
essere classificabile in modo semplice ed univoco. Ricordo soltanto che ancora nel 1926
un’équipe di antropologi inglesi stava cercando ci completare un elenco completo degli
dèi dell’India. A un certo momento, quando arrivarono alla cifra di 84000, consapevoli
dell’inutilità dell’impresa, si fermarono. Potevano fermarsi anche prima se solo avessero
studiato un po’ di ‘teologia’ hindu che li avrebbe avvertiti che il politeismo indiano (ma
sarebbe più corretto parlare di ‘monoteismo politeista’) permette una quantità di dèi
equivalente al numero delle visioni del mondo, delle cose, degli eventi etc., virtualmente
infinita e, quindi, impossibile da contabilizzare. Analogamente, quando si dice «Oriente»
non si è detto assolutamente nulla: sarebbe meglio sostituire il singolare col plurale, e
parlare di ’Orienti’ così come di ‘Occidenti’ In ogni caso, un problema –tanto arduo
quanto interessante– che ci sollecita è quello di capire quale atteggiamento assumere di
fronte all’Oriente ( o agli Orienti). In modo assai schematico, sostengo che ci sono due
principali pericoli da evitare: uno è quello in cui è incorso Hegel, l’altro quello in cui è
incorso Guénon. Il primo, pur prendendo in considerazione le civiltà orientali, vede al
loro interno solo i germi di uno sviluppo ulteriore che vedrà la propria pienezza e
maturazione solo nella civiltà europea: così i pensieri dei cinesi e degli indiani vengono
riconosciuti importanti, certo, ma solo in quanto ‘premesse’ necessarie, solo in quanto
hanno preparato il terreno affinché poi i greci, gli ebrei, i cristiani e, infine, soprattutto, i
12
tedeschi portassero al culmine umanamente possibile il processo evolutivo dell’umanità.
L’operazione hegeliana è chiarissima: incorporare tutto l’Oriente come piedistallo su cui
porre il meraviglioso monumento della civiltà europea. Un atteggiamento ed un
procedimento, quindi, sostanzialmente viziati di etnocentrismo. Anche se è bene
precisare che tale etnocentrismo non comporta alcuna presa di posizione di carattere
razzista, per il semplice motivo che, per Hegel, le civiltà orientali risultano tanto
necessarie alla maturità di quella europea così come in nostro esser stati fanciulli risulta
necessario al nostro essere adulti.
Il secondo pericolo da evitare è quello rappresentato –nel modo più evidente e più
‘nobile’– da René Guénon. Guénon ha fatto un itinerario molto coerente, e anche una
scelta, alla fine di questo suo itinerario, altrettanto coerente. L’idea di Guénon è che
l’Occidente sia ormai perduto, almeno a partire dal Rinascimento in poi. Tale decadenza
gli appare irreversibile: l’unica possibilità che l’Occidente ha di tentare una via di
salvezza è quella di guardare ad Oriente, in particolare in direzione di due grandi serbatoi
culturali: l’India e l’Islam. Coerentemente con questa sua idea, Guénon finì per affiliarsi
ad una scuola spirituale islamica. Se per Hegel si può parlare di etnocentrismo, per
Guénon si può parlare di esotismo: mentre Hegel trovava che il luogo della Verità ultima
fosse l’Occidente, e in particolare l’Europa, Guénon trova che il luogo dove la Verità è
custodita –ed è custodita in modo da divenire strumento di salvezza– sta fuori
dall’Occidente.
MC: Siamo all’interno di un modello parabolico discendente. Man mano che ci si
allontana da un’origine considerata come pura, c’è un periodo di decadenza, dunque ecco
giustificata l’alternativa totale e definitiva. In fondo si tratta di un modello totalitario.
GP: Naturalmente. Una domanda cruciale molto forte che dovremmo rivolgere a Guénon
se fosse ancora qui con noi sarebbe: come possono costituire luoghi di verità e di
salvezza questi Orienti di oggi che vediamo sempre più occidentalizzarsi?
C’è tuttavia una terza posizione che mi sembra possa costituire una via per evitare sia
l’etnocentrismo che l’esotismo, ed è quella battuta da François Jullien. Jullien, che
insegna a Parigi, è nel contempo sinologo e grecista. Rifacendosi alle indicazioni
sull’eterotopia date da Foucault, ribadisce che, per conoscere meglio sempre più a fondo
e in maniera sempre più allargata noi stessi, bisogna conoscere gli altri, in particolare
coloro che sono, rispetto a noi, radicalmente altri. Jullien ribadisce che questo
13
approfondimento della conoscenza di noi stessi (‘noi stessi’ non solo come singoli
soggetti, ma come civiltà occidentale) quanto più ‘altri’ sono gli altri che studiamo, tanto
meglio è. Per questo la scelta, da parte sua, della civiltà cinese: perché, a cominciare dalla
lingua scritta, i cinesi presentano rispetto a noi differenze radicali, tanto da essere
‘estranianti’. Questo estraneamento è quasi un capovolgimento, un andare agli antipodi
per conoscere meglio se stessi: un osservarsi da lontano come garanzia per vedersi
meglio, come capita all'artista quando fa qualche passo indietro rispetto alla sua opera per
valutarla più a fondo. Una domanda che mi piacerebbe fare a Jullien sarebbe: anche i
cinesi fanno così? Cioè: anche i cinesi hanno elaborato una modalità di questo tipo –
foucaultiana– per cui il luogo dell’altro è talmente importante per conoscere se stessi?
MC: Veniamo alla terza ed ultima parte del nostro dialogo. Vorrei porti due temi.
L’estetica legata alla tradizione zen non ha assolutamente nulla a che fare con una teoria
della bellezza, né con una teoria del genio, della creazione soggettiva. Si tratta piuttosto
di un mettere in forma l’esperienza. Un esempio: la disposizione asimmetrica e irregolare
delle pietre mi costringe a rallentare mentre ci passo sopra. Sono così più disponibile a
guardare il paesaggio attorno, e dunque la mia locomozione, il mio respiro, tutta la
dimensione antropofisica e antropometrica è coinvolta nell’esperienza estetica. L’estetica,
in qualche modo, è una forma di ascesi, di esercizio formativo, come se introducesse ad
un’arte del vivere, per cui non vi è più produzione di segni, di opere, di oggetti, ma
l’assunzione più equilibrata possibile di comportamenti, modi di vita. In qualche modo
una produzione più di energia che non di oggetti identificabili in quanto tali. In Occidente
invece, come sappiamo, estetica ed etica, pur avendo avuto per farlo le loro ottime
ragioni, già da un bel pezzo hanno divorziato.
GP: Sicuramente quello che noi vediamo diffuso e divulgato è così come dici tu. Può
darsi che in modo sotterraneo alcuni artisti procedano su un binario molto vicino a quello
su cui etica ed estetica sono congiunte come in Oriente. Anche se devo dire che spesso
noi usiamo ‘estetica’ ed ‘etica’ per farci capire nei nostri discorsi, ma se dovessimo usare
questi termini con gli artisti orientali, non capirebbero; nella migliore delle ipotesi
penserebbero che l’opera d’arte serve a migliorare i rapporti umani, come se avesse un
compito didascalico. In realtà, si può dire che, per ampie porzioni dell’arte orientale, in
particolare sino-giapponese, vale l’osservazione che gli intenti didascalici vengono in
secondo piano o non ci sono del tutto. Tuttavia è da ricordare che anche in tal caso
14
l’attività artistica comporta una profonda opera di trasformazione interiore: per esempio,
l’esercizio preparatorio nella calligrafia trasforma la mente dell’artista in modo tale che
quello che produce trasmette forza di depurazione e di trasformazione anche a chi
osserva. L’opera, cioè, trasforma sia l’artista che il fruitore in maniera sostanziale.
Ovviamente questo può succedere se e quando riusciamo ad entrare a fondo, fino quasi a
farci compenetrare, in questo universo di senso. Se invece, per esempio, visitiamo
giardini zen uno dietro l’altro, o passiamo in rassegna decine di bonsai in pochi minuti,
ovvero cataloghiamo gli uni e gli altri per interessi puramente storico-culturali, non c’è
niente da fare: non riusciamo ad entrare in una dinamica in cui estetica ed etica finiscono
per coincidere. Di fronte al giardino di Ryoangi bisognerebbe poter stare ancora –come in
passato– in silenzio assoluto, senza venir disturbati dagli scatti fotografici dei turisti. Se
noi si potesse di nuovo entrare in questo sistema di trasformazione in cui il silenzio è
silenzio sonoro, silenzio visivo (riduzione al massimo degli elementi che entrano nella
visione) e silenzio psicologico (riduzione della attività immaginativa o memorativa, verso
il futuro, il passato ma anche il presente della nostra mente), in modo da raggiungere la
situazione di una calma piatta della mente, a questo punto quale sarebbe il risultato?
Sarebbe che noi disporremmo di una mente e di un corpo attenti ai minimi particolari.
Questo è il risultato, se voglio misurarlo concretamente: l’attenzione. Questo è un
vecchissimo precetto-consiglio buddhista: gli attenti sono vivi, i disattenti sono già preda
della morte. Questo vuol dire stare attenti non soltanto ai minimi particolari, all’ombra di
questo filo, ma stare attenti a tutto ciò che accade, quindi anche alle azioni che si fanno.
Alle azioni che facciamo noi stessi, alle azioni che gli altri fanno nei confronti di altri…
stare insomma attenti a tutto. Ma stare attenti a tutto implica paradossalmente una
predisposizione vuota, una –diciamo noi nella nostra tradizione mistica– «purezza di
spirito». Solo i puri di spirito possono poi agire per il meglio. Qui, secondo me, il testo
più geniale di tutti gli Orienti è il Tao-te-king, cioè là dove si teorizza che per fare bene
bisogna non fare niente. Ma questo non fare niente non è non agire, ma mettersi in una
condizione tale per cui ciò che si fa è spontaneo, naturale, senza nessuna forzatura. Anche
qui faccio pubblicità (anche se non ne ha bisogno) a Jullien, che su questo tema ha scritto
un libro notevolissimo tradotto in italiano da Einaudi che è il Trattato dell’efficacia, dove
spiega in termini occidentali che per essere efficaci bisogna che le cose si facciano da sé.
«Perché si facciano da sé» non è semplicemente un modo per dire: «lascio che facciano
come vogliono», ma è riuscire ad agire nel massimo della spontaneità. Io non posso
adesso trarre tutte le conclusioni che derivano da questo, ma credo che se ognuno per
15
conto proprio cerca di verificare l’efficacia di questo principio lo vede immediatamente,
riesce a riscontrarlo anche nelle azioni quotidiane.
MC: ..anche se questo appunto non significa semplicemente pura assenza di ogni azione.
Un antico pittore cinese diceva pressappoco: troppo facile evocare il vuoto
semplicemente non disegnando nulla, devi evocarlo disegnando pur qualcosa, che però
sia nulla…
16