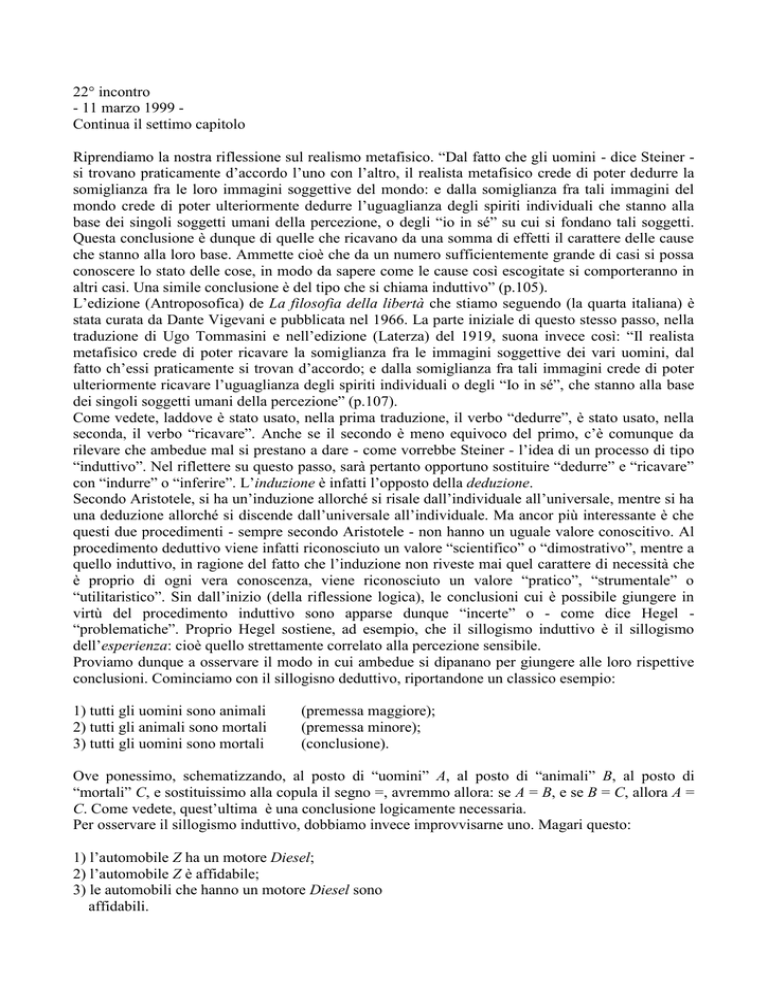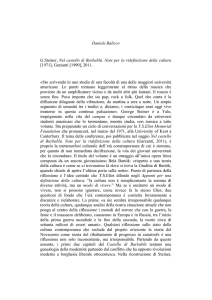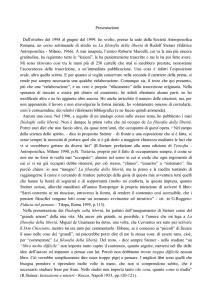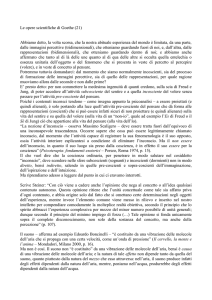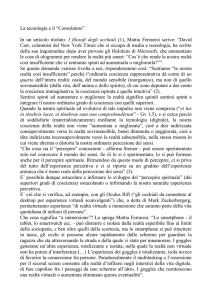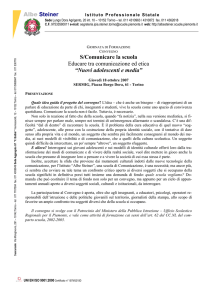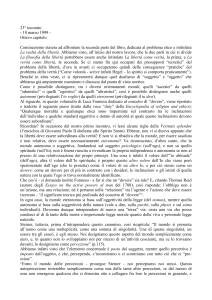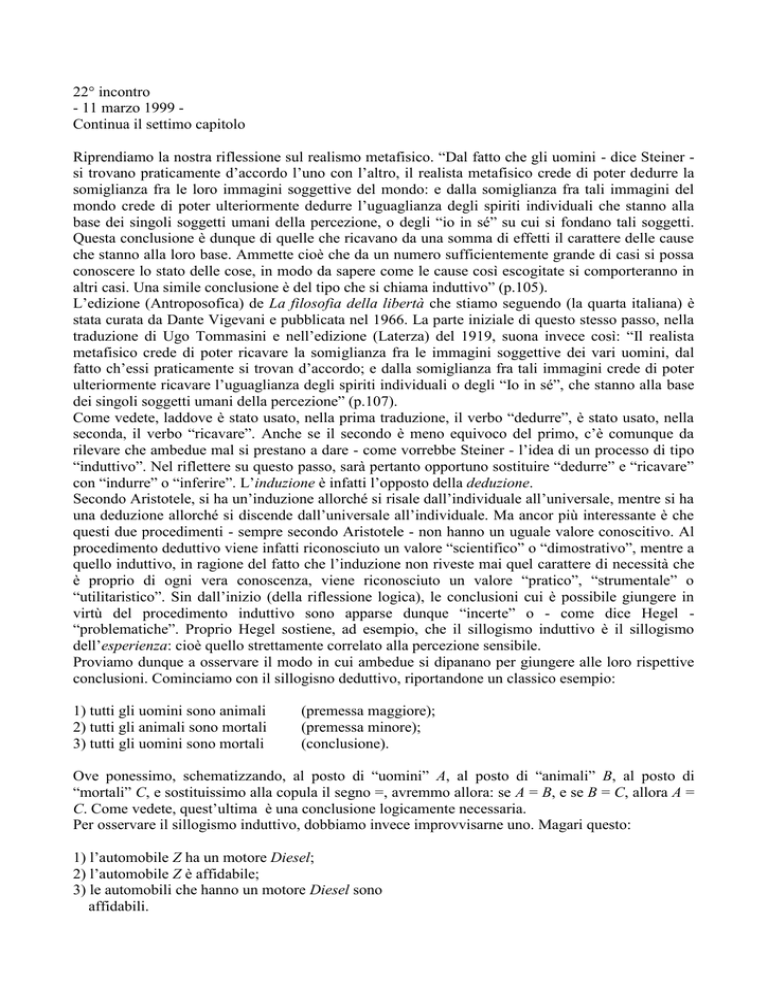
22° incontro
- 11 marzo 1999 Continua il settimo capitolo
Riprendiamo la nostra riflessione sul realismo metafisico. “Dal fatto che gli uomini - dice Steiner si trovano praticamente d’accordo l’uno con l’altro, il realista metafisico crede di poter dedurre la
somiglianza fra le loro immagini soggettive del mondo: e dalla somiglianza fra tali immagini del
mondo crede di poter ulteriormente dedurre l’uguaglianza degli spiriti individuali che stanno alla
base dei singoli soggetti umani della percezione, o degli “io in sé” su cui si fondano tali soggetti.
Questa conclusione è dunque di quelle che ricavano da una somma di effetti il carattere delle cause
che stanno alla loro base. Ammette cioè che da un numero sufficientemente grande di casi si possa
conoscere lo stato delle cose, in modo da sapere come le cause così escogitate si comporteranno in
altri casi. Una simile conclusione è del tipo che si chiama induttivo” (p.105).
L’edizione (Antroposofica) de La filosofia della libertà che stiamo seguendo (la quarta italiana) è
stata curata da Dante Vigevani e pubblicata nel 1966. La parte iniziale di questo stesso passo, nella
traduzione di Ugo Tommasini e nell’edizione (Laterza) del 1919, suona invece così: “Il realista
metafisico crede di poter ricavare la somiglianza fra le immagini soggettive dei vari uomini, dal
fatto ch’essi praticamente si trovan d’accordo; e dalla somiglianza fra tali immagini crede di poter
ulteriormente ricavare l’uguaglianza degli spiriti individuali o degli “Io in sé”, che stanno alla base
dei singoli soggetti umani della percezione” (p.107).
Come vedete, laddove è stato usato, nella prima traduzione, il verbo “dedurre”, è stato usato, nella
seconda, il verbo “ricavare”. Anche se il secondo è meno equivoco del primo, c’è comunque da
rilevare che ambedue mal si prestano a dare - come vorrebbe Steiner - l’idea di un processo di tipo
“induttivo”. Nel riflettere su questo passo, sarà pertanto opportuno sostituire “dedurre” e “ricavare”
con “indurre” o “inferire”. L’induzione è infatti l’opposto della deduzione.
Secondo Aristotele, si ha un’induzione allorché si risale dall’individuale all’universale, mentre si ha
una deduzione allorché si discende dall’universale all’individuale. Ma ancor più interessante è che
questi due procedimenti - sempre secondo Aristotele - non hanno un uguale valore conoscitivo. Al
procedimento deduttivo viene infatti riconosciuto un valore “scientifico” o “dimostrativo”, mentre a
quello induttivo, in ragione del fatto che l’induzione non riveste mai quel carattere di necessità che
è proprio di ogni vera conoscenza, viene riconosciuto un valore “pratico”, “strumentale” o
“utilitaristico”. Sin dall’inizio (della riflessione logica), le conclusioni cui è possibile giungere in
virtù del procedimento induttivo sono apparse dunque “incerte” o - come dice Hegel “problematiche”. Proprio Hegel sostiene, ad esempio, che il sillogismo induttivo è il sillogismo
dell’esperienza: cioè quello strettamente correlato alla percezione sensibile.
Proviamo dunque a osservare il modo in cui ambedue si dipanano per giungere alle loro rispettive
conclusioni. Cominciamo con il sillogisno deduttivo, riportandone un classico esempio:
1) tutti gli uomini sono animali
2) tutti gli animali sono mortali
3) tutti gli uomini sono mortali
(premessa maggiore);
(premessa minore);
(conclusione).
Ove ponessimo, schematizzando, al posto di “uomini” A, al posto di “animali” B, al posto di
“mortali” C, e sostituissimo alla copula il segno =, avremmo allora: se A = B, e se B = C, allora A =
C. Come vedete, quest’ultima è una conclusione logicamente necessaria.
Per osservare il sillogismo induttivo, dobbiamo invece improvvisarne uno. Magari questo:
1) l’automobile Z ha un motore Diesel;
2) l’automobile Z è affidabile;
3) le automobili che hanno un motore Diesel sono
affidabili.
Come si vede, abbiamo qui a che fare non più con tre, ma con quattro elementi: ossia,
schematizzando, con A (l’automobile Z), con B (il motore Diesel), con C (l’affidabilità) e con D (le
automobili). Per questo, avremo allora: se A = B, e se A = C, allora D = C.
In questo caso, dunque, non solo il cosiddetto “termine medio” (la premessa minore) non è affatto
tale, ma nella conclusione appare D invece di A. E che differenza c’è tra D e A? Che D è il plurale
di A: null’altro, ossia, che il risultato di una generalizzazione (le automobili) del singolo dato
d’esperienza (l’automobile Z). Ma quale garanzia abbiamo che, risultando l’automobile Z affidabile,
risultino affidabili tutte quelle con lo stesso tipo di motore? Colui che segue il procedimento
“induttivo” non va dunque dall’individuale all’universale, bensì va dall’individuale (o dal
molteplice) al generale: ovvero, è convinto - come dice Steiner - “che da un numero
sufficientemente grande di casi si possa conoscere lo stato delle cose, in modo da sapere come le
cause escogitate si comporteranno in altri casi”. Le conclusioni cui approda il sillogismo induttivo
risultano perciò provvisorie, incerte, o – come direbbe Popper - “fallibili”.
Quando abbiamo parlato, a suo tempo, del moto “pendolare” con il quale l’Io oscilla liberamente tra
il polo della percezione e quello del concetto, o tra quello del corpo e quello dello spirito, abbiamo
in realtà già parlato di induzione e deduzione. Nella fase in cui l’Io risale dalla percezione al
concetto, o dal corpo allo spirito, si ha infatti un movimento induttivo; nella fase in cui l’Io discende
dal concetto alla percezione, o dallo spirito al corpo, si ha invece un movimento deduttivo. La
natura di questi due opposti movimenti, più che “logica”, è dunque “logodinamica”, e frutto diretto
dell’organizzazione conoscitiva dell’essere umano.
Aggiunta alla seconda edizione del 1918
Dice Steiner: “Sperimentare l’essere del pensare, ossia l’elaborazione attiva del mondo concettuale,
è qualcosa di completamente differente dallo sperimentare quello che si può percepire coi sensi. Di
qualunque senso l’uomo possa mai essere dotato, non potrebbe avere da esso la realtà se egli,
pensando, non compenetrasse di concetti quanto ha percepito, trasmessogli da quel senso; e
qualsiasi senso, così compenetrato, dà all’uomo la realtà” (p.108).
“Sperimentare l’essere del pensare” significa anzitutto sperimentare l’essere dell’attività giudicante.
E’ appunto in virtù di una “elaborazione attiva del mondo concettuale” che prendono infatti forma i
giudizi: giudizi che poi si mutano in quelle immaginazioni che sfociano, per vie diverse, nelle
rappresentazioni e nelle immagini percettive. “Sperimentare” non vuol dire però “speculare”,
“elucubrare” o “spremersi il cervello”, bensì impegnare il pensiero (e per suo mezzo la volontà)
nella pratica interiore. Abbiamo già parlato dell’esercizio della concentrazione. Ebbene, a cos’altro
miriamo, con questo esercizio, se non a metterci nella condizione di poter osservare e percepire il
pensiero? Praticandolo, possiamo infatti osservare e percepire tanto il pensare attivo in noi quanto
noi attivi nel pensare. Ma perché ho detto che, mediante la concentrazione, miriamo “a metterci
nella condizione” di poter osservare il pensiero? Perché, passando questo - come dice Steiner “comunemente inosservato”, vi è bisogno, per poterlo osservare, di adottare o assumere una
posizione “non comune”. Vedete, è un po’ come se io, vedendo una cosa che un altro, dal punto in
cui si trova, non riesce a vedere, dicessi: “Se ti sposti e vieni qui vedrai quello che da lì non ti riesce
di vedere”. Un simile “spostamento” è decisivo perché, in definitiva, o si vede o non si vede. E
finché non si vede si può anche pensare che tutto quello che andiamo dicendo non sia che una
costruzione teorica e astratta, magari solo un po’ più logica, conseguente o convincente di tante
altre.
“Sperimentare l’essere del pensare, ossia l’elaborazione attiva del mondo concettuale - ha detto
inoltre Steiner - è qualcosa di completamente differente dallo sperimentare quello che si può
percepire coi sensi”. Tra queste due esperienze, vi è infatti una differenza immediata, netta e
facilmente afferrabile: “quello che si può percepire coi sensi” non è posto da noi, bensì è imposto a
noi.
Vorrei precisare, a questo proposito, che tutte le volte in cui ho tentato qui di descrivere, in modo
schematico e sommario, i diversi momenti che caratterizzano il processo percettivo, mi sono dovuto
necessariamente mantenere su un piano generale. In realtà, gli organi di senso non sono tutti uguali
e lo schema generale del processo percettivo dovrebbe essere quindi messo a punto in funzione
dello specifico senso che si sta considerando. Steiner ci parla infatti di dodici sensi divisi in tre
gruppi: i quattro del primo, ossia quelli del tatto, della vita, del movimento e dell’equilibrio (ma in
specie gli ultimi tre), c’informano, in quanto “enterocettivi” o “propriocettivi”, dello stato del nostro
organismo; i quattro del secondo, ossia quelli dell’olfatto, del gusto, della vista e del calore, ci
danno invece notizia del mondo esterno; i quattro del terzo, ossia quelli dell’udito, del linguaggio,
del pensiero e dell’Io, ci mettono infine in rapporto con l’“interno dell’esterno”: ovvero, con
l’anima e con lo spirito del mondo e delle cose. Il senso del tatto (detto anche “senso cutaneo”),
trovandosi “diffuso” alla periferia del nostro organismo, è dunque quello che ci permette di
sperimentare, in prima istanza, il limite che ci separa dal mondo esterno. Quando tocchiamo le cose,
facciamo infatti esperienza di una realtà che ci “resiste” o ci si “oppone” (tanto che, a nostra
insaputa, entra in gioco anche il senso dell’equilibrio). Ciò che si verifica con la massima evidenza
nel tatto, si verifica però in tutti gli altri sensi e, in particolare, in quelli dell’olfatto, del gusto, della
vista e del calore.
Ascoltate, in proposito, quanto Steiner afferma in Antropologia: “Quando noi guardiamo gli oggetti,
si compie, solo in maniera più sottile, un processo simile a quello che avviene quando afferriamo
qualche cosa. Quando prendiamo in mano un pezzo di gesso, si tratta di un fatto fisico del tutto
analogo a quello spirituale che si svolge quando scocchiamo dagli occhi delle forze eteriche per
afferrare un oggetto per mezzo della vista”.
Quando ci “sentiamo osservati”, è come se ci sentissimo quindi “toccati”, “tastati” o “palpati” dallo
sguardo altrui. Si tratta del sottile “toccare”, “tastare” o “palpare” di una forza di natura volitiva che
- come dice Steiner - “scocca” dagli occhi e che si perderebbe all’orizzonte se non incontrasse
qualcosa che ne arresta il movimento.
Ciò vuol dire dunque che le cose, nell’esperienza percettiva, c’impongono la loro presenza. L’esatto
contrario, perciò, di quel che accade nell’esperienza pensante, dove i concetti, per essere presenti,
devono essere posti da noi. La differenza tra la prima esperienza e la seconda è dunque la stessa che
c’è tra l’imporre (del pensare nel volere) e il porre (del volere nel pensare).
In questo stesso contesto, Steiner parla anche di coloro che sono convinti che “i limiti del mondo
delle percezioni umane sono determinati dai limiti dei sensi dell’uomo, e che questo avrebbe
davanti a sé un mondo completamente diverso, se ai sensi di cui dispone potesse aggiungerne altri,
o se addirittura possedesse dei sensi diversi” (p.107).
Come si vede, pur di affermare la limitatezza del conoscere umano, quando non ci si appella ai
limiti del pensiero, ci si appella allora a quelli della percezione. Si dovrebbe tener conto, tuttavia,
che se l’uomo avesse più sensi di quanti ne ha (e ne ha - come abbiamo visto - più di quanti
immaginino coloro che si danno a fantasie di questo genere), o avesse dei sensi diversi da quelli che
ha, il suo conoscere potrebbe guadagnare in estensione, ma non di certo in intensione o in
profondità, in quanto il processo conoscitivo si svolgerebbe sempre allo stesso modo. Il maggior
numero (o la diversa qualità) dei dati provenienti da un campo percettivo più ampio, esigerebbe
infatti di essere comunque integrato, mediante il pensare, dai concetti.
Al riguardo, vorrei ricordare che Steiner afferma, ne L’iniziazione, che non vi è persona meno
adatta a seguire la via indicata dalla scienza dello spirito di quella sognatrice, visionaria o
superstiziosa: di quella, insomma, che si compiace, in una forma o nell’altra, delle proprie
fantasticherie. Un compiacimento del genere è infatti frutto dell’amore di sé (“Innammorarsi di sé
stessi - dice Oscar Wilde - è l’inizio di un idillio che dura tutta la vita”), e non dell’amore per la
realtà e per il mondo (e quindi per il nostro vero Io). Ho già ricordato, al riguardo, quel che dice la
sapienza occulta: “Le verità sono tante, la realtà è una”. Guai, dunque, a innamorarsi di una sola
verità e non della realtà, perché la verità di cui ci si innamora, o con cui ci s’identifica, si
assolutizzerà e tenderà per ciò stesso a collidere, più o meno violentemente, con le altre.
Immaginate un vaso che, cadendo, vada - come si dice - “in mille pezzi”. Orbene, se il vaso fosse la
realtà, i suoi “mille pezzi” sarebbero le sue “mille verità”. Considerando che l’unitaria realtà del
mondo viene mandata in “pezzi” dalla percezione, e ch’è appunto da questi pezzi che prendiamo le
mosse per la conoscenza, dovrebbe esserci chiaro allora che il nostro compito non è quello di
raccogliere una o più verità (uno o più pezzi) spacciandole per l’intera realtà (per l’intero vaso),
quanto piuttosto quello di raccogliere pazientemente quante più verità è possibile (quanti più pezzi è
possibile) nella speranza di poter così ricostruire pian piano la realtà originaria (il vaso originario).
Ciò vuol dire quindi che si deve avere cura, non solo di raccogliere quante più verità è possibile, ma
anche di rispettare, nel ricomporle, le loro oggettive e reciproche relazioni (sarebbe bene, in
proposito, andarsi a rileggere quanto dice Goethe in L’esperimento come mediatore fra oggetto e
soggetto). Chiunque, infatti, approfittando della circostanza che il vaso è finito in pezzi, si servisse
in parte o in tutto di questi per dar forma a un qualche intelligente o brillante parto della propria
mente (ovvero, a una “invenzione” non meno “prelibata” di quella del Figaro rossiniano),
dimostrerebbe, con ciò, di avere più a cuore la propria intelligenza o brillantezza che non la realtà:
dimostrerebbe cioè - per dirla in termini freudiani - di essere in preda alla libido “narcisistica”, e di
non aver perciò maturato la libido “oggettuale”.
Proprio qui, tuttavia, s’incontrano le maggiori difficoltà. La nostra natura personale (che potremmo
definire anche “idiota” in quanto idios, in greco, sta appunto per “proprio”, “personale”,
“particolare” o “privato”) tende infatti ad appropriarsi delle sole verità che le sono congeniali (e che
può perciò “avere”) e a farne sfoggio, quasi si trattasse di “gioielli” spirituali e non di “bigiotteria”
ideologica. E’ la nostra natura personale a mal digerire altresì l’idea che ci sia del vero in ogni
“ismo” (ad esempio, nell’idealismo, nel materialismo, nel razionalismo, nell’empirismo o nel
realismo), e che il problema sia quindi quello di ricomporre le molteplici e parziali verità nell’unità
sintetica della realtà. L’ego, insomma, mal digerisce l’idea che la realtà sia l’Io e che l’Io sia la
realtà. Esso può pertanto, come Giuda, tradire l’Io e venderlo per “trenta denari”, oppure, come il
Battista, aprirsi all’Io e dire: “Bisogna che Egli cresca, ed io diminuisca”.
Dice ancora Steiner: “Il concreto essere dell’uomo non è soltanto determinato da quello che egli,
per mezzo del suo organismo, si pone davanti come percezione immediata, ma anche dal fatto che
c’è dell’altro che egli esclude da tale percezione immediata. Come per la vita è necessario lo stato
incosciente di sonno accanto a quello cosciente di veglia, così per l’auto-esperienza dell’uomo è
necessario che, accanto alla sfera della sua percezione sensibile, si trovi, nel medesimo campo dal
quale provengono le percezioni sensibili, una sfera, assai più grande dell’altra, di elementi non
percepibili sensibilmente” (pp.109-110).
Ebbene, immaginiamo che qualcuno dicesse: “Un uomo che dorme non è un “uomo” perché, per
essere uomini, bisogna vegliare”; “E se fosse invece - potremmo replicare - che un uomo dorme
proprio in quanto “uomo”, perché per essere uomini, bisogna anche dormire?”. È nell’ambito della
morte (minerale), del sonno (vegetale) e del sogno (animale) del mondo naturale che l’uomo infatti
si ritaglia la propria sfera di esperienza e di coscienza (di veglia).
Ma c’è di più. Nella realtà dello spettro elettromagnetico, ad esempio, ci sono, al di qua del
cosiddetto “estremo violetto” (400 nanometri), le radiazioni “ultraviolette” (UV) e, al di là del
cosiddetto “estremo rosso” (750 nanometri), le radiazioni “infrarosse” (IR), ma l’uomo
normalmente non le vede, in quanto, dell’intero spettro, i suoi occhi sono atti a recepire solo quella
parte che si dà loro come luce o colore (anche in campo acustico, vi è un cosiddetto “spettro
udibile” che va normalmente dai 16 ai 16000 Hertz). Ma questo che cosa vuol dire? Vuol
semplicemente dire che l’uomo, in tanto è uomo, in quanto esperisce e conosce quella parte di realtà
che gli è stata riservata e destinata. Come al di qua e al di là della luce ci sono infatti gli
“ultravioletti” e gli “infrarossi”, così al di qua e al di là degli uomini ci sono gli animali e gli Angeli
(o - direbbe Nietzsche - le “bestie” e i “Superuomini”); e come sarebbe un “delirio di potenza” il
credere di essere già Angeli (o “Superuomini”), così è un “delirio d’impotenza” il credere - come
per lo più avviene oggi - di essere ancora animali (o “bestie”).
Risposta a una domanda
Per farsi una prima idea dell’evoluzione dell’anima umana, basterebbe considerare le tre grandi
figure di Aristotele, di Tommaso d’Aquino e dello stesso Steiner. Aristotele (384 - 322 a.C.)
s’incarna poco dopo il passaggio dall’anima senziente (mitologica) all’anima razionale o affettiva
(filosofica) e può essere indubbiamente considerato il maestro di quest’ultima (“’l maestro - dice
appunto Dante - di color che sanno”). Teniamo presente che, se non fosse per la logica “dialettica”
(o “speculativa”) di Hegel, andremmo avanti, ancor oggi, con quella “analitica” di Aristotele.
Tommaso d’Aquino (1225 - 1274) s’incarna invece poco prima del passaggio dall’anima razionale
o affettiva all’anima cosciente (scientifica), e conduce, in nome dell’Io, una strenua lotta contro la
filosofia araba. Mentre quest’ultima sostiene infatti (in specie con Averroè) che l’anima individuale
è “mortale” perché si dissolve, dopo la morte, nella spiritualità del cosmo, egli sostiene, di contro,
che la stessa è “immortale” perché conserva, dopo la morte, il proprio carattere individuale. Con la
sua lotta, Tommaso ha dunque preparato l’avvento dell’anima cosciente. Steiner (1861-1925)
s’incarna infine in coincidenza del passaggio (1879) dalla prima fase evolutiva dell’anima cosciente
(scientifico-naturale) alla seconda (scientifico-spirituale), e impegna tutto il suo essere nello sforzo
di fornire agli uomini i mezzi conoscitivi che servono per affrontare questo passaggio in modo
libero e consapevole. Se è stato infatti necessario, un tempo, discendere dall’immaginazione (dal
mito) al concetto, è viceversa necessario, oggi, risalire dal concetto all’immaginazione (al Sé
spirituale).
Riprendiamo comunque la nostra lettura. Dice Steiner: “Occorre anche considerare che l’idea di
percezione, quale è svolta in questo libro, non va confusa con quella di percezione sensoria
esteriore, che della prima costituisce soltanto un caso particolare. Già da quanto precede, ma più
ancora da quello che verrà più oltre sviluppato, si vedrà che qui si considera percezione tutto ciò che
viene incontro all’uomo, sensibilmente e spiritualmente (…) Chi parla di percezione soltanto nel
senso di percezione sensoria non arriva a formarsi neppure su questa percezione sensoria un
concetto utilizzabile per la conoscenza” (p.110).
In effetti, quando si parla di “percezione” si allude quasi sempre alla percezione “sensibile”: ossia a
quella che si realizza mediante gli organi di senso fisici. Come abbiamo visto a suo tempo, l’atto
percettivo, quale atto dell’Io, è però indipendente da tali organi. L’Io li utilizza quando vuole farsi
incontro a ciò che si manifesta fisicamente, ma non quando vuole farsi incontro a ciò che si
manifesta animicamente (come avviene per esempio nei sogni). Nonostante l’Io sia l’artefice tanto
dell’atto percettivo che di quello pensante, quest’ultimo non viene tuttavia sperimentato
normalmente come un “atto” (né tantomeno come un atto dell’Io), perché, a causa della mediazione
cerebrale, se ne ha solo una coscienza riflessa o indiretta. Una cosa è infatti l’atto, altra la coscienza
dell’atto; e l’odierna natura della coscienza è talmente diversa da quella dell’atto, da produrne più
una “incoscienza” che una “coscienza”. Se è vero, d’altro canto, che “il simile conosce il simile”, è
vero allora che una coscienza statica o passiva non potrà mai fare diretta esperienza dell’atto del
pensare. A riprova di ciò, la coscienza “immaginativa” – nell’accezione di Steiner - in tanto è in
grado di svelarci la natura vivente dell’atto in quanto è essa stessa vivente, e quindi atto. Pensate ad
esempio alla pioggia: quella reale “cade”, mentre quella dipinta o fotografata è ferma. Allo stesso
modo, il pensare nella realtà si muove o si svolge, mentre nella rappresentazione è fermo. Per farne
diretta esperienza, occorre dunque superare o trascendere la sfera di quella coscienza
rappresentativa che, oltre a saperlo soltanto “fotografare”, si è andata pure convincendo che il
“fotografo” non sia l’Io, bensì il cervello o, per essere più precisi, che la “fotografia” (la
rappresentazione) sia scattata da una “macchina fotografica” (da un cervello) che è anche un
“fotografo” (un Io).
Proiettato inconsciamente sul cervello, l’atto pensante del soggetto viene quindi a trasformarsi in un
atto dell’oggetto. Ma anche l’atto percettivo del soggetto viene proiettato inconsciamente sullo
stimolo e attribuito all’oggetto dal quale proviene (in questo Dizionario di psicologia, lo “stimolo”
viene detto infatti un quid che “deve essere caratterizzato, o quanto meno essere caratterizzabile in
linea di principio, in termini fisici”).
Orbene, ditemi voi a cosa dovrebbe servire l’essere umano, se l’atto conoscitivo riguardasse
davvero gli oggetti e non i soggetti. Da una parte ci vengono infatti presentate delle cose che
“sfruculierebbero” il cervello, da un’altra la cosa-cervello che reagirebbe da par suo a tale
“sfruculiamento” e, da un’altra ancora, l’essere umano che, alla stessa stregua di un voyeur, non
farebbe che assistere allo spettacolo.
Vedete, al tempo in cui le discussioni sul “darwinismo” erano molto accese, pare che un pensatore
russo - del quale non ricordo purtroppo il nome - abbia detto: “L’uomo discende dalla scimmia,
ergo amiamoci gli uni con gli altri!”. Ebbene, se mi concedete la parafrasi, vorrei dire anch’io, in
rapporto ai problemi di cui ci stiamo occupando: “L’uomo è un voyeur, ergo amiamoci gli uni con
gli altri!”. Che è come dire: affrettiamoci dunque a ricavare, da un siffatto presupposto noetico,
un’indicazione o una direttiva etica. Tuttavia, come “chi semina vento - secondo quanto insegna il
proverbio - raccoglie tempesta”, così chi semina sul piano noetico la “menzogna”, raccoglie su
quello etico il “male”. Non c’è quindi da illudersi che le cose possano volgere al meglio finchè gli
uomini non troveranno il coraggio di ri-pensare i pensieri che oggi li ammorbano e di ri-considerare
in modo realmente nuovo tanto sé stessi che il mondo.
Ove studiassimo, tornando a noi, La logica contro l’uomo di Scaligero, presto ci accorgeremmo che
tanto l’atto pensante che quello percettivo, in quanto atti dell’Io, sono, all’origine, una stessa cosa.
A un determinato livello, si scopre infatti che il pensare è percepire e che il percepire è pensare o –
in altri termini - che il volere che è nel pensare è lo stesso volere in cui è il pensare e che il pensare
che è nel volere è lo stesso pensare in cui è il volere: si scopre, insomma, che il pensare e il volere
(ma anche il sentire) non sono, essenzialmente, che atti dell’Io. Potremmo perfino dire, in questa
luce, che, sul piano ordinario, il percepire è il pensare vivo, mentre il pensare è il percepire morto. È
sufficiente portarsi al primo dei gradi superiori di coscienza (quello immaginativo) per cominciare
dunque a sperimentare l’autocoscienza come autopercezione e l’autopercezione come
autocoscienza.
Risposta a una domanda
Occorre distinguere l’essere dall’essenza. Il pensare si dà però, abitualmente, come un non-essere.
Quando diciamo “astrazione” o “riflesso”, diciamo infatti “parvenza” o “non-essere” (la parvenza –
dice appunto Hegel - non è che l’essere del non-essere). Mai sarebbe d’altronde nato il nominalismo
se il pensiero umano non fosse a un certo punto passato dall’originario essere al moderno nonessere. Il problema non riguarda quindi il pensiero cosmico, bensì la coscienza umana di tale
pensiero o, più semplicemente, il pensiero umano. La coscienza attuale, avendo solo esperienza
indiretta dell’essere del pensiero, ma non sapendola tale, crede infatti che l’essere del pensiero sia
appunto quello che conosce: ossia, un non-essere. Cos’altro fare, dunque, se non trasformare tale
coscienza? E come trasformarla, se non esercitando in modo adeguato il pensare, il sentire e il
volere, ma in primo luogo il pensare e il sentire?
Si tenga comunque presente (mi preme sottolinearlo) che tale trasformazione comincia già con lo
studio della scienza dello spirito. Lasciatemi dunque concludere questo nostro incontro leggendo
ciò che afferma in proposito Steiner ne Lo sviluppo occulto dell’uomo nelle sue quattro parti
costitutive e ne Le entità spirituali nei corpi celesti e nei regni della natura.
Nel primo, dice: “Non soltanto per l’esoterista vero e proprio, ma anche per chi vuole accogliere
pensieri antroposofici nelle sue forze animiche, sarà importante venire a sapere qualcosa sui
mutamenti che l’intera entità umana sperimenta, sia che l’uomo esegua esercizi come quelli indicati
nel mio scritto L’iniziazione, oppure come sono brevemente riassunti nella seconda parte della mia
Scienza occulta, sia anche perché semplicemente, ma con il cuore e l’anima, si apprendono pensieri
antroposofici. L’antroposofia coltivata esotericamente o exotericamente e con serietà, determina
nella realtà certi mutamenti. Mediante l’antroposofia (lo si può affermare con coraggio) si diventa
diversi, si trasforma la propria intera struttura umana”.
E nel secondo aggiunge: “Non si può affermare semplicemente che acquisti un rapporto col mondo
spirituale solo chi abbia percorso la via di uno sviluppo esoterico. L’esoterismo non comincia
solamente con lo sviluppo occulto. Dal momento in cui si partecipa a uno studio scientificospirituale, partecipando con tutto il cuore e col sentimento agli insegnamenti della scienza dello
spirito, già ha inizio l’esoterismo: la nostra anima comincia a trasformarsi…”.