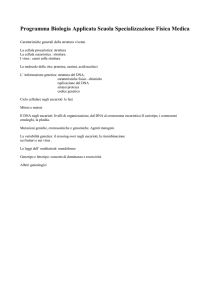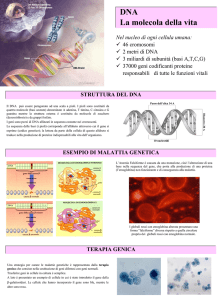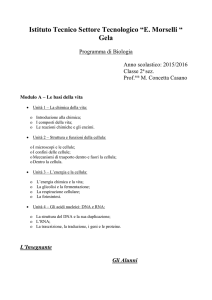N.6 – Giugno 2014
genetico, dove il singolo gene è parte di una rete costituita
dall’insieme degli altri geni e delle altre molecole (gli RNA
e le proteine). Questo sistema, inoltre, appare in costante
equilibrio con l’ambiente. Per esemplificare si può usare
un modello. Il DNA può essere paragonato ad una
biblioteca in cui ogni singolo libro rappresenta un gene. Il
DNA di una qualunque cellula umana è costituito da
30.000 geni, perciò secondo questo modello il corredo
genetico umano può essere visualizzato come una
biblioteca contenente 30.000 libri (un libro = un gene).
GENE, GENETICA,
EPIGENETICA, OGM
di P.S.P.
A che punto è la ricerca sui geni, le terapie genetiche,
gli organismi geneticamente modificati ? Quanto è
importante per ogni individuo portare l’attenzione a
tematiche di questo genere ? Sempre più spesso questi
argomenti irrompono nella vita quotidiana di ogni
individuo, obbligandolo a delle scelte di cui si ignorano
le possibili conseguenze nel tempo.
Ciascuno di noi può essere chiamato a prendere
posizione ed esprimere preferenze, pro o
contro, terapie genetiche, colture OGM nel territorio in
cui vive, proposte di acquisto di test genetici capaci di
prevedere la comparsa di malattie di cui è
inconsapevole portatore sano.
Per cui, ogni elemento di conoscenza in più
sull’argomento può risultare un utile contributo alla
riflessione personale e generale.
Ancora oggi sembra prevalere l’idea del DNA quale
“responsabile unico” dello stato di salute o di patologie
corporee, ereditate con precise e immutabili
caratteristiche dai genitori, che possono essere
modificate solo attraverso una “sostituzione” dei geni
ereditati o “innesto” di geni nuovi. Questo intervento
vale per la riparazione e sostituzione dei geni malati
dell’essere umano, così come per la modifica di
organismi, animali e vegetali, al fine di “migliorare” la
natura. Al punto in cui è giunta la ricerca (v. nota)
dovrebbe essere evidente il livello di complessità del
“sistema”
Una biblioteca per funzionare ha bisogno degli addetti che
catalogano i libri, li ripongono sugli scaffali, puliscono e
restaurano i libri periodicamente, sostituiscono i libri
spariti o danneggiati, tengono aggiornata la contabilità e
la catalogazione, e così via. Gli impiegati in questo
modello corrispondono all’RNA non codificante.
Gli utenti che si recano quotidianamente in biblioteca e
prendono in prestito i libri per leggerne le istruzioni e
applicarle in pratica, rappresentano gli RNA che
codificano per le proteine; queste ultime sono
rappresentate dagli oggetti realizzati e prodotti dagli
utenti a partire dalle istruzioni e progetti riportati nei libri
presi in prestito.
Nella biblioteca “modello”, perché tutto funzioni,
risultano necessari sia i libri che gli operatori e gli utenti;
analogamente, nella realtà microscopica della cellula, il
DNA ha un valore e può funzionare solo in presenza di
proteine ed RNA. Una biblioteca con 30.000 libri ma
senza alcun impiegato e non aperta agli utenti non ha
alcuna utilità e non sopravvive a lungo. L’importanza di
ogni singolo elemento e delle infinite correlazioni tra i vari
elementi del sistema è evidente. Il settore della genetica
ed epigenetica darà in futuro frutti concreti, ma al
momento i ricercatori stanno muovendo i primi passi.
Cosa succede se un gene estraneo viene introdotto nel
“sistema” di una cellula? Al momento, questa è una delle
tante domande a cui nessuno sembra poter dare risposte
certe.
N.6 – Giugno 2014
Un Organismo Geneticamente Modificato (in sigla
OGM) è un essere vivente (pianta o animale, escluso
l’uomo) a cui è stato modificato il DNA, tramite la
biotecnologia. Al momento solo alcune piante
transgeniche, (mais, soia, colza e cotone), sono state
finora autorizzate e commercializzate; in Italia,
nessuna di queste piante geneticamente modificate
viene coltivata a fini commerciali. Esistono però diversi
altri organismi sottoposti a sperimentazione genetica,
sia piante che animali. Questo settore biotecnologico è
in continua espansione e si sta sviluppando su più
livelli, nella ricerca sulle piante si possono ricordare tra
gli altri obiettivi, la produzione di biocombustibili, di
fibre vegetali più resistenti, una maggiore velocità di
crescita, una maggiore resistenza a climi estremi e ai
parassiti al fine di evitare o ridurre l’uso di pesticidi, e
molto altro ancora.
La risposta dell’organismo alla introduzione nella dieta
di piante o animali transgenici non risulta essere
prevedibile; i dati a disposizione sono discordanti.
Quasi sempre le pubblicazioni scientifiche
favorevolmente orientate verso gli OGM in agricoltura,
tendono a porre l’accento su alcuni dettagli tecnici
positivi, come i vantaggi della resa produttiva, il ridotto
uso di sostanze chimiche come insetticidi e fungicidi e
simili; viene però trascurata o minimizzata la questione
della reazione nel vivente che deve assimilare dei geni
diversi dal solito.
Anche il database della letteratura scientifica
biomedica del National Center for Biotechnology
Information (PubMed.gov), con oltre 23 milioni di
articoli, contiene relativamente poche pubblicazioni
sull’argomento degli OGM e gli effetti sulla salute
umana. Ad oggi (giugno 2014) cliccando su tale sito per
una ricerca generica (ad esempio riportando come
termini di ricerca: genetically modified organisms) si
apre una lista di oltre 40.000 articoli, se però si
restringe il campo di ricerca inserendo un filtro, ad
esempio aggiungendo il termine “human” (o simili) per
limitare la ricerca ai soli articoli riguardanti l’essere
umano, il numero delle ricerche si riduce
drasticamente. Comunque gli studi correlati all’essere
umano sono costituiti in gran parte da ricerche
riguardanti opinioni ed emozioni che i
cittadini/consumatori hanno verso questi prodotti
biotecnologici, oppure trattano dei vantaggi per la pianta
transgenica contro i diversi parassiti, una quota di studi
riguardano le metodiche per l’individuazione o l’analisi
dei geni modificati, infine vi sono esperimenti sui vari
animali di laboratorio, sulla resistenza ai parassiti dei
pesci transgenici in acquacolture, e così via. Molto poche
le ricerche riguardanti gli esseri umani che consumano
prodotti OGM e in genere focalizzate sul controverso
argomento delle allergie e infiammazioni.
Potrebbe risultare dirimente uno studio internazionale,
condotto sia da enti pubblici che da gruppi privati, su un
campione significativo di popolazione che consuma
abitualmente OGM messo in confronto con un gruppo
altrettanto numeroso ed omogeneo per età e condizione
socioeconomica che però non ingerisce organismi
transgenici; tale studio dovrebbe avere una durata
sufficientemente lunga (un periodo di dieci o quindici
anni, necessario a evidenziare patologie croniche e a
sviluppo lento) in modo da escludere o confermare i
sospetti e le paure correlate al consumo degli OGM. Ma
uno studio così costoso e lungo dovrebbe essere ripetuto
per i vari prodotti OGM correlati, direttamente o
indirettamente, alla nutrizione umana. Perché questi
costituiscono un caso a sé stante dal punto di vista
genetico e della possibile reazione di chi lo assimila.
Nel sito dell’organizzazione mondiale della sanità viene
precisato a proposito degli OGM, che gli studi sulla loro
sicurezza in genere sono basati sulla tossicità diretta del
prodotto, l’allergenicità, le proprietà tossiche o nutritive
del singolo specifico componente, la stabilità del gene
inserito, gli effetti nutrizionali associati alla modifica
genetica, gli effetti imprevisti che potrebbero derivare
dall’inserimento del gene. Il documento si focalizza solo
su tre problemi principali: l’allergenicità, il trasferimento
di geni alle cellule corporee o batteri della flora
intestinale, l’inquinamento genetico ambientale a causa
del trasferimento dei geni dalla pianta GM alle colture
convenzionali o specie naturali correlate (outcrossing).
Sull’allergenicità il giudizio è sintetico e rassicurante (“No
allergic effects have been found relative to GM foods
currently on the market”). Sul trasferimento di materiale
genetico, si ritiene che la probabilità di trasferimento sia
bassa e gli esperti FAO/WHO hanno incoraggiato l’uso di
geni senza antibiotico resistenza. A proposito dei
frammenti di DNA estraneo provenienti dalla dieta,
bisogna ricordare quanto assicurano i ricercatori: solo una
minima quantità di DNA può resistere al processo
digestivo, e non sembrano esserci prove che il suo
passaggio attraverso la mucosa gastrointestinale abbia
N.6 – Giugno 2014
portato ad un suo innesto stabile nel DNA di chi lo ha
ingerito o nel DNA dei batteri della flora intestinale. Il
problema non si esaurisce in questi termini.
L’introduzione di un singolo gene, non induce solo la
produzione della proteina desiderata, si verifica un
riverbero di azioni ad effetto domino sull’assetto
generale della cellula ricevente, analogamente ad un
sassolino lanciato in una bacinella d’acqua. Anche se
l’OCSE nel 1993 ha stabilito una “sostanziale
equivalenza” tra i prodotti OGM e non-OGM, ci si
rende conto alla luce di lavori recenti, quanto sia
modificato l’assetto dell’intera cellula che ha ricevuto
un gene estraneo.
In sintesi, le posizioni tra gli enti sanitari preposti al
controllo sulla sicurezza, le aziende produttrici di OGM
ed i singoli cittadini consumatori, sembrano rimanere
distanti. Poche sembrano al momento le soluzioni
possibili volte ad evitare che gli interessi contrapposti
possano collidere e scontrarsi tra loro. Difficilmente i
consumatori accettano il punto di vista delle
multinazionali, le quali hanno come obiettivo il
profitto, anche se ricorrono persino ad argomenti
filantropici per convincere l’opinione pubblica.
Note:
1) La genetica studia il materiale ereditario che si trova nella cellula.
L’oggetto principale dello studio è la molecola del DNA, la sua
struttura, il suo funzionamento, le informazioni che contiene e
trasmette alla cellula, al corpo di un individuo ed ai suoi discendenti.
L’informazione contenuta nel DNA (acido desossiribonucleico) viene
trasferita alla molecola dell’RNA (acido ribonucleico) che a sua volta
serve come istruzione per costruire nuove proteine. La singola cellula,
gli organi, il corpo intero risultano costituiti fondamentalmente dalle
proteine, costruite e disposte secondo le indicazioni del nostro
personale DNA. A motivo di tali informazioni si ereditano i caratteri
psicofisici dei genitori e avi ma anche i difetti e predisposizioni alle
malattie. Negli ultimi anni, la conoscenza del patrimonio genetico si è
notevolmente arricchita grazie a ricerche scientifiche come il “Progetto
Genoma” , che ha permesso di individuare circa 20.000 – 25.000 geni
nell’essere umano, oppure a gruppi di ricerca come quello di ENCODE
(Encyclopedia of DNA Elements) il cui obiettivo è quello di chiarire il
funzionamento dei geni. Oggi si sa che la maggioranza del DNA non
codifica delle proteine e quindi la sua funzione rimane in gran parte
ancora da chiarire. Nel recente passato è stato coniato il termine di
Junk DNA, tradotto impropriamente come DNA “spazzatura”.
La ricerca attuale pone le basi per nuove domande ed evidenzia i limiti
correlati agli studi precedenti; diventa importante capire la
collaborazione esistente tra le varie parti del DNA, anche tra porzioni
molto distanti tra loro, ed il collegamento tra DNA e le altre parti della
cellula, costituendo nel loro insieme un unico sistema. Confrontando il
numero totale dei geni dell’essere umano con quelli di altri organismi
(compresi gli esseri più semplici e piccoli) non sembrano esserci grandi
differenze; tra le varie specie animali lungo la scala evolutiva cambia
invece la quantità di Junk DNA che sembra aumentare con la
complessità dell’essere vivente. Adesso su un punto vi è chiarezza: il
cosiddetto DNA spazzatura non è inattivo, anzi sembra svolgere delle
Il singolo coltivatore che intravede un possibile
maggior guadagno, sostenuto dal tecnico
ideologicamente schierato, combatte la sua eroica
battaglia contro gli attivisti idealisti e preoccupati che
vigilano costantemente nell’interesse generale. Nel
frattempo il mercato avanza inesorabile verso una
maggiore unificazione delle regole e dei controlli tra
Europa e America, suscitando non pochi timori, anche
se il documento del Partenariato Transatlantico su
Commercio e Investimenti si mostra rassicurante sulla
questione degli OGM (“gli USA non costringeranno
l’UE ad accettare le proprie norme”). Che fare?
L’invito è a non distrarsi troppo da argomenti come
questi, apparentemente lontani dalla quotidianità.
Oggi sono disponibili numerose risorse in rete o in
libreria, adatte a coltivare e mantenere un pensiero
critico e indipendente, necessario per future scelte
consapevoli.
attività importanti, come ad esempio quella di funzionare da
“interruttore”, in grado di accendere o spegnere un gene. Tra le
funzioni di questa parte di DNA vi è quella di produrre un altro tipo di
RNA che non codifica per le proteine ed è quindi definito RNA non
codificante (ncRNA). Questa massa di molecole di RNA sembra avere la
funzione di regolare e modulare, sia il DNA che le proteine e l’altro
RNA, quello che permette la sintesi di queste ultime. In una prima fase
di studio queste scoperte sono apparse come scollegate tra loro;
successivamente si è consolidata l’opinione (non condivisa da tutti i
ricercatori) che questo RNA non codificante, potesse funzionare come
una sorta di apparato di sicurezza retroattivo nei confronti dello stesso
DNA da cui ha avuto origine; una probabile barriera contro un
eventuale DNA estraneo proveniente dall’ambiente esterno.
Oltre all’RNA non codificante esistono comunque altre molecole che
trasferiscono informazioni retroattivamente verso il DNA, modificando
il funzionamento di quest’ultimo. Ad esempio varie proteine funzionano
come segnali per l’avvio dell’attività del DNA (enzimi e fattori di
N.6 – Giugno 2014
trascrizione); senza questi segnali chimici di avvio il gene appare
conosciuti, può intervenire permettendo o inibendo l’espressione di
una sostanza inerte.
questa informazione. In pratica, questo significa che alcuni alimenti o
Vari enzimi intervengono ai livelli successivi di sintesi delle proteine
farmaci possono modificare il funzionamento del DNA, costituendo una
da parte del DNA. Da un unico gene possono essere prodotte
ulteriore possibilità terapeutica (terapia epigenetica) che affianca
diverse proteine grazie all’uso parziale e alternato delle
terapie più radicali in cui il gene malfunzionante viene eliminato o
informazioni contenute nelle varie porzioni del filamento unico di
sostituito (terapia genetica). Questo implica anche un’altra
RNA (in questo caso si tratta dell’RNA messaggero che permette la
conseguenza: l’introduzione di nuove sostanze nell’ambiente deve
sintesi delle proteine). In pratica, questo è possibile attraverso le
essere valutata anche dal punto di vista della possibile modifica del
varie combinazioni di porzioni di RNA selezionate per la
funzionamento del DNA; il riferimento è qui ai pesticidi, alle droghe e
traduzione (“splicing alternativo”).
ai farmaci, agli OGM. S
I diversi meccanismi che intervengono sulla attività dei geni, cioè
del DNA, costituiscono l’oggetto di studio dell’Epigenetica, una
Per eventuali approfondimenti:
branca della genetica che attraversa una fase di rapido sviluppo. Il
Progetto ENCODE :
termine Epigenetica, indica quelle variazioni ereditabili della
- genome.ucsc.edu/ENCODE/
espressione genica ottenuta senza la modifica della catena del DNA.
Epigenetica :
I geni sono sequenze di basi lungo una catena di DNA, lunga circa
- “L’epigenetica?”; pagina italiana di epigenome.eu/it/1,1,0
due metri, che appare avvolta attorno a delle proteine (gli Istoni).
- F. Bottaccioli “Epigenetica e PsicoNeuroEndocrinoImmunologia”
Ogni cellula presenta il proprio DNA compattato in modo diverso
(Ed. edra).
permettendo l’attivazione di alcuni geni e silenziandone altri. In un
OGM :
singolo individuo è presente lo stesso DNA all’interno delle cellule
- “OGM in generale” nel sito salute.gov.it
che lo costituiscono, ma mentre una cellula del fegato renderà
- Salute24.ilsole24ore.com/tags/1424-ogm
disponibili i geni utili a tale organo, vengono mantenuti silenziati i
- minerva.unito.it ).
geni necessari ad altri organi come il cuore, la pelle e così via).
- //prevenzione.ulss20.verona.it/ogm_rischi.html
Motivo per cui una dieta ricca di un aminoacido come la metionina
- PubMed.gov (database NCBI)
può aumentare la metilazione del DNA con possibili conseguenze
- who.int/foodsafety/publications/biotech/20questions/en/
sul decorso di alcune malattie psichiatriche. Viceversa
- greenreport.it/news/agricoltura/differenze-alimenti-ogm-e-
l’introduzione di sostanze che favoriscano l’acetilazione degli istoni
non/#prettyPhoto
possono migliorarne i sintomi. Diverse molecole presenti in
- greenreport.it/news/agricoltura/agricoltura-le-biotecnologie-in-
alimenti presentano delle capacità di modulazione di questi
aiuto-dei-
meccanismi. Le modifiche epigenetiche si possono “ereditare” da
piccoli-produttori/
una generazione all’altra, anche se non è stata modificata la
- Ec.europa.eu/trade/plicy/in-focus/ttip/questions-and-
struttura del DNA (attraverso cioè la perdita o l’alterazione di
answers/index_it.htm
porzioni del DNA). Le ricerche epigenetiche hanno portato la
biologia oltre il “Dogma centrale”, secondo cui l’informazione del
DNA procedeva in un solo senso (dal DNA alle proteine). Un punto
appare sempre più evidente: l’informazione del DNA può essere
modulata da un sistema che risente delle vicende personali a forte
impronta emotiva, delle abitudini come la dieta o la pratica di
attività sportiva, dell’uso di droghe o dell’esercizio mentale. Il DNA
contiene delle potenziali informazioni ma da solo conta poco
nell’economia della cellula; l’influenza dell’ambiente, attraverso
innumerevoli meccanismi cellulari ancora solo parzialmente

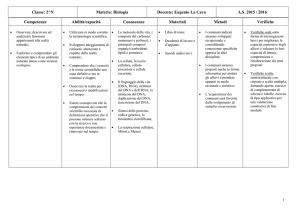
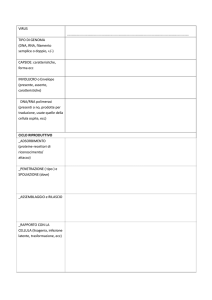
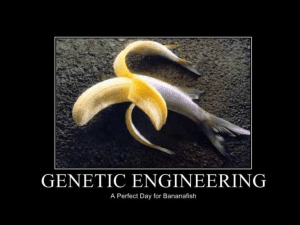
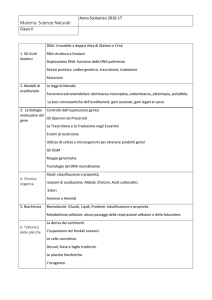

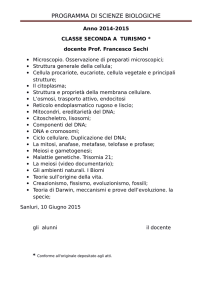
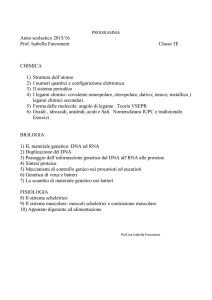
![mutazioni genetiche [al DNA] effetti evolutivi [fetali] effetti tardivi](http://s1.studylibit.com/store/data/004205334_1-d8ada56ee9f5184276979f04a9a248a9-300x300.png)