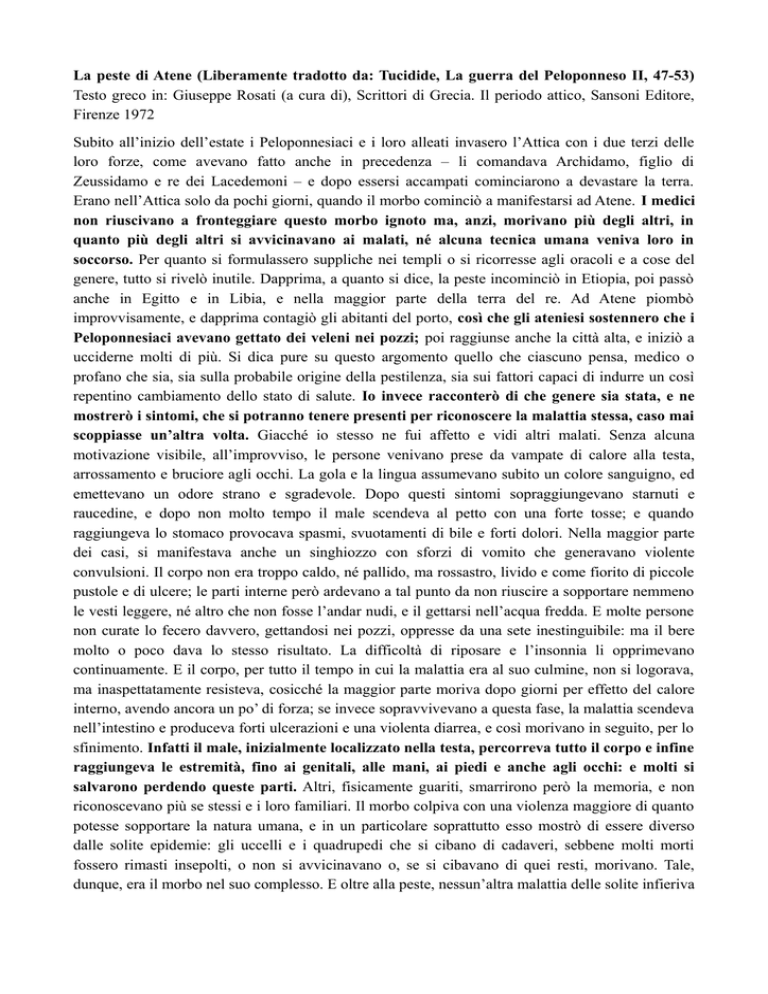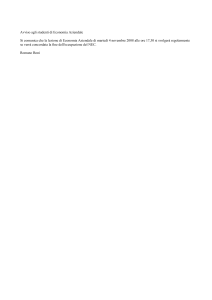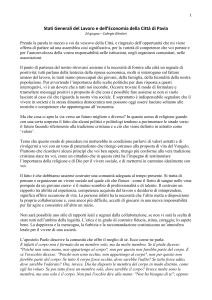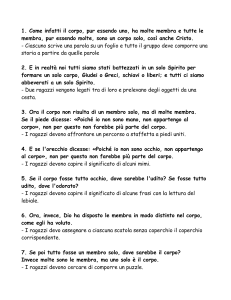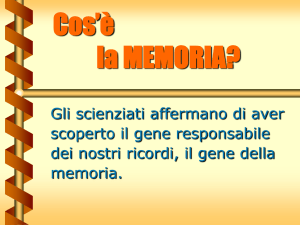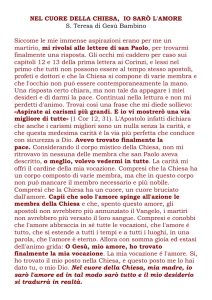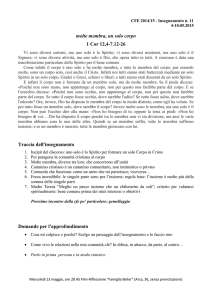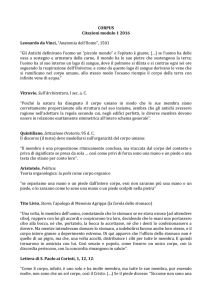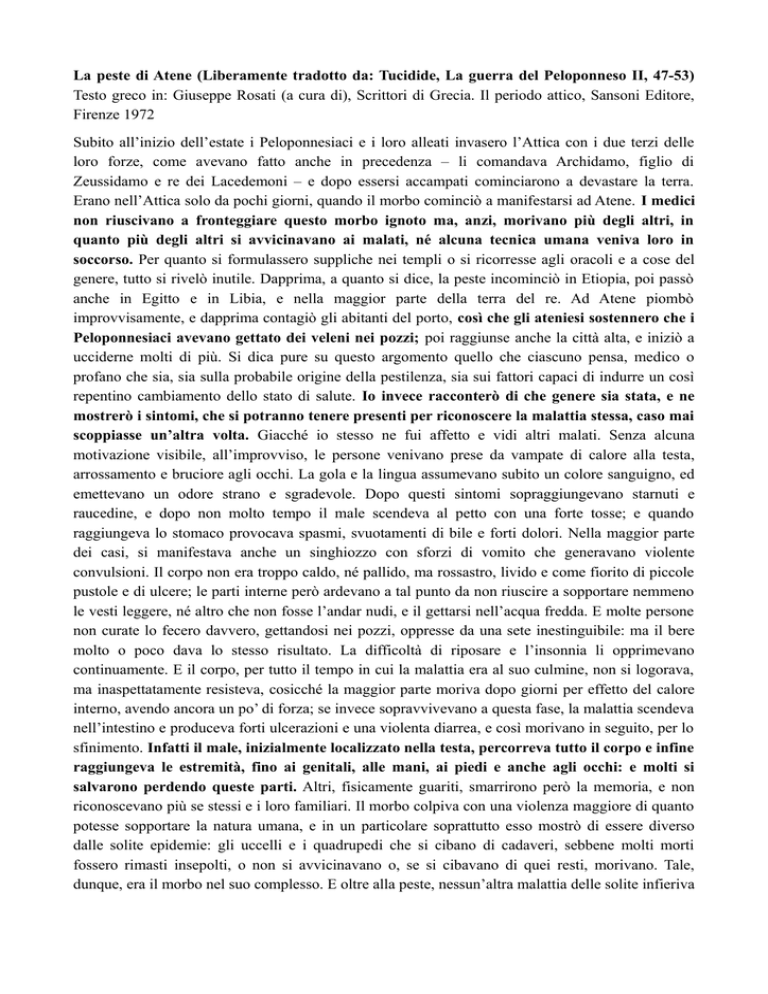
La peste di Atene (Liberamente tradotto da: Tucidide, La guerra del Peloponneso II, 47-53)
Testo greco in: Giuseppe Rosati (a cura di), Scrittori di Grecia. Il periodo attico, Sansoni Editore,
Firenze 1972
Subito all’inizio dell’estate i Peloponnesiaci e i loro alleati invasero l’Attica con i due terzi delle
loro forze, come avevano fatto anche in precedenza – li comandava Archidamo, figlio di
Zeussidamo e re dei Lacedemoni – e dopo essersi accampati cominciarono a devastare la terra.
Erano nell’Attica solo da pochi giorni, quando il morbo cominciò a manifestarsi ad Atene. I medici
non riuscivano a fronteggiare questo morbo ignoto ma, anzi, morivano più degli altri, in
quanto più degli altri si avvicinavano ai malati, né alcuna tecnica umana veniva loro in
soccorso. Per quanto si formulassero suppliche nei templi o si ricorresse agli oracoli e a cose del
genere, tutto si rivelò inutile. Dapprima, a quanto si dice, la peste incominciò in Etiopia, poi passò
anche in Egitto e in Libia, e nella maggior parte della terra del re. Ad Atene piombò
improvvisamente, e dapprima contagiò gli abitanti del porto, così che gli ateniesi sostennero che i
Peloponnesiaci avevano gettato dei veleni nei pozzi; poi raggiunse anche la città alta, e iniziò a
ucciderne molti di più. Si dica pure su questo argomento quello che ciascuno pensa, medico o
profano che sia, sia sulla probabile origine della pestilenza, sia sui fattori capaci di indurre un così
repentino cambiamento dello stato di salute. Io invece racconterò di che genere sia stata, e ne
mostrerò i sintomi, che si potranno tenere presenti per riconoscere la malattia stessa, caso mai
scoppiasse un’altra volta. Giacché io stesso ne fui affetto e vidi altri malati. Senza alcuna
motivazione visibile, all’improvviso, le persone venivano prese da vampate di calore alla testa,
arrossamento e bruciore agli occhi. La gola e la lingua assumevano subito un colore sanguigno, ed
emettevano un odore strano e sgradevole. Dopo questi sintomi sopraggiungevano starnuti e
raucedine, e dopo non molto tempo il male scendeva al petto con una forte tosse; e quando
raggiungeva lo stomaco provocava spasmi, svuotamenti di bile e forti dolori. Nella maggior parte
dei casi, si manifestava anche un singhiozzo con sforzi di vomito che generavano violente
convulsioni. Il corpo non era troppo caldo, né pallido, ma rossastro, livido e come fiorito di piccole
pustole e di ulcere; le parti interne però ardevano a tal punto da non riuscire a sopportare nemmeno
le vesti leggere, né altro che non fosse l’andar nudi, e il gettarsi nell’acqua fredda. E molte persone
non curate lo fecero davvero, gettandosi nei pozzi, oppresse da una sete inestinguibile: ma il bere
molto o poco dava lo stesso risultato. La difficoltà di riposare e l’insonnia li opprimevano
continuamente. E il corpo, per tutto il tempo in cui la malattia era al suo culmine, non si logorava,
ma inaspettatamente resisteva, cosicché la maggior parte moriva dopo giorni per effetto del calore
interno, avendo ancora un po’ di forza; se invece sopravvivevano a questa fase, la malattia scendeva
nell’intestino e produceva forti ulcerazioni e una violenta diarrea, e così morivano in seguito, per lo
sfinimento. Infatti il male, inizialmente localizzato nella testa, percorreva tutto il corpo e infine
raggiungeva le estremità, fino ai genitali, alle mani, ai piedi e anche agli occhi: e molti si
salvarono perdendo queste parti. Altri, fisicamente guariti, smarrirono però la memoria, e non
riconoscevano più se stessi e i loro familiari. Il morbo colpiva con una violenza maggiore di quanto
potesse sopportare la natura umana, e in un particolare soprattutto esso mostrò di essere diverso
dalle solite epidemie: gli uccelli e i quadrupedi che si cibano di cadaveri, sebbene molti morti
fossero rimasti insepolti, o non si avvicinavano o, se si cibavano di quei resti, morivano. Tale,
dunque, era il morbo nel suo complesso. E oltre alla peste, nessun’altra malattia delle solite infieriva
in quel tempo: e anche se sorgeva, andava a risolversi in questa. E gli uni morivano per mancanza di
cure, gli altri anche se erano molto ben curati. Non esisteva, per così dire, nessuna medicina che si
potesse applicare in generale: quello che a uno era di giovamento, per un altro era dannoso. Nessun
organismo, forte o debole che fosse, riusciva a combattere il morbo, ma la malattia portava via tutti
quanti, anche chi era curato con la maggiore attenzione. Ma la cosa più terribile in assoluto era lo
scoraggiamento da cui uno era preso quando si sentiva male – subito, datosi con il pensiero alla
disperazione, si lasciava andare e non resisteva – e il fatto che per curarsi a vicenda si contagiavano
e morivano l’uno dopo l’altro, come pecore: e questo causava la strage maggiore. Se per timore non
volevano recarsi l’uno dall’altro, morivano abbandonati, e molte case furono spopolate per la
mancanza di qualcuno che prestasse le cure necessarie; se al contrario si accostavano alle persone,
morivano per il contagio, e in particolar modo quelli che cercavano di agire con generosità: per un
senso di vergogna infatti costoro non si risparmiavano, ma si recavano dai loro amici, poiché anche
il compianto sui morenti alla fine era trascurato, per stanchezza, persino dai familiari, sopraffatti
dall’immensità della sciagura. Tuttavia i sopravvissuti avevano più compassione per chi stava
morendo o era malato, perché ne avevano già fatto esperienza ed erano ormai al sicuro: la
malattia infatti non colpiva due volte la stessa persona in modo grave. Oltre alla malattia,
aggravava il loro disagio l’afflusso della gente dai campi; e soprattutto questi nuovi arrivati erano in
difficoltà. Non essendoci case per loro, ma vivendo d’estate in baracche soffocanti, la strage
avveniva nel massimo disordine e, morendo l’uno sull’altro, si aggiravano strisciando per le strade e
intorno alle fontane, per il desiderio di acqua. Anche i santuari erano pieni di cadaveri: gli uomini
infatti, sopraffatti dalla disgrazia e non sapendo quale sarebbe stata la loro sorte, cadevano
nell’incuria del santo e del divino. Tutte le consuetudini che prima si seguivano nel celebrare gli
uffici funebri furono sconvolte, e si seppelliva come ciascuno poteva. E molti usarono modi di
sepoltura indecenti, per mancanza degli oggetti necessari, dato che numerosi erano i morti che
li avevano preceduti: prevenendo chi elevava la pira, gli uni, posto il loro morto su una pira
destinata a un altro, vi davano fuoco; altri, mentre un cadavere ardeva, vi gettavano sopra
quello che stavano portando, e se ne andavano. Anche in altri ambiti il morbo dette inizio, in
città, a numerosi infrazioni della legge. Più facilmente uno osava quello che prima si guardava
dal fare per il proprio piacere, perché vedeva che subitaneo e radicale era il mutamento di
sorte fra coloro che erano felici, e morivano improvvisamente, e coloro che prima non
possedevano nulla e poi avevano le ricchezze degli altri. Cosicché miravano a godere quanto
prima e con il maggior piacere possibile, giudicando effimere sia la vita che le ricchezze. E ad
affaticarsi per ciò che era sempre stato considerato nobile, più nessuno era disposto, poiché
pensava che era incerto se non sarebbe morto prima di raggiungerlo. Quello che era piacevole
già nel presente e che, da qualunque parte venisse, era vantaggioso per ottenere quel piacere,
tutto ciò era divenuto bello e utile. Nessun timore degli dei o legge degli uomini li tratteneva,
poiché da un lato consideravano indifferente essere religiosi o no, dato che tutti senza
distinzioni morivano, e dall’altro, poiché nessuno si aspettava di vivere fino a dover rendere
conto dei suoi misfatti; essi pensavano che una pena molto più grande era già stata sentenziata
ai loro danni e pendeva sulle loro teste, per cui era naturale godere qualcosa della vita prima
che tale punizione piombasse su di loro.
Lucrezio, De rerum natura, VI, 1138 - 1286
Haec ratio quondam morborum et mortifer aestus
finibus in Cecropis funestos reddidit agros
vastavitque vias, exhausit civibus urbem.
nam penitus veniens Aegypti finibus ortus,
aeëra permensus multum camposque natantis,
incubuit tandem populo Pandionis omni.
inde catervatim morbo mortique dabantur.
principio caput incensum fervore gerebant
et duplicis oculos suffusa luce rubentes.
sudabant etiam fauces intrinsecus atrae
sanguine et ulceribus vocis via saepta coibat
atque animi interpres manabat lingua cruore
debilitata malis, motu gravis, aspera tactu.
inde ubi per fauces pectus complerat et ipsum
morbida vis in cor maestum confluxerat aegris,
omnia tum vero vitai claustra lababant.
spiritus ore foras taetrum volvebat odorem,
rancida quo perolent proiecta cadavera ritu.
atque animi prorsum vires totius, omne
languebat corpus leti iam limine in ipso.
intolerabilibusque malis erat anxius angor
adsidue comes et gemitu commixta querella,
singultusque frequens noctem per saepe diemque
corripere adsidue nervos et membra coactans
dissoluebat eos, defessos ante, fatigans.
nec nimio cuiquam posses ardore tueri
corporis in summo summam fervescere partem,
sed potius tepidum manibus proponere tactum
et simul ulceribus quasi inustis omne rubere
corpus, ut est per membra sacer dum diditur ignis.
intima pars hominum vero flagrabat ad ossa,
flagrabat stomacho flamma ut fornacibus intus.
nil adeo posses cuiquam leve tenveque membris
vertere in utilitatem, at ventum et frigora semper.
in fluvios partim gelidos ardentia morbo
membra dabant nudum iacientes corpus in undas.
multi praecipites nymphis putealibus alte
inciderunt ipso venientes ore patente:
insedabiliter sitis arida corpora mersans
aequabat multum parvis umoribus imbrem.
nec requies erat ulla mali: defessa iacebant
corpora. mussabat tacito medicina timore,
quippe patentia cum totiens ardentia morbis
lumina versarent oculorum expertia somno.
multaque praeterea mortis tum signa dabantur:
perturbata animi mens in maerore metuque,
triste supercilium, furiosus voltus et acer,
sollicitae porro plenaeque sonoribus aures,
creber spiritus aut ingens raroque coortus,
sudorisque madens per collum splendidus umor,
tenvia sputa minuta, croci contacta colore
salsaque per fauces rauca vix edita tussi.
in manibus vero nervi trahere et tremere artus
a pedibusque minutatim succedere frigus
non dubitabat. item ad supremum denique tempus
conpressae nares, nasi primoris acumen
tenve, cavati oculi, cava tempora, frigida pellis
duraque in ore, iacens rictu, frons tenta manebat.
nec nimio rigida post artus morte iacebant.
octavoque fere candenti lumine solis
aut etiam nona reddebant lampade vitam.
quorum siquis, ut est, vitarat funera leti,
ulceribus taetris et nigra proluvie alvi
posterius tamen hunc tabes letumque manebat,
aut etiam multus capitis cum saepe dolore
corruptus sanguis expletis naribus ibat.
huc hominis totae vires corpusque fluebat.
profluvium porro qui taetri sanguinis acre
exierat, tamen in nervos huic morbus et artus
ibat et in partis genitalis corporis ipsas.
et graviter partim metuentes limina leti
vivebant ferro privati parte virili,
et manibus sine non nulli pedibusque manebant
in vita tamen et perdebant lumina partim.
usque adeo mortis metus iis incesserat acer.
atque etiam quosdam cepere oblivia rerum
cunctarum, neque se possent cognoscere ut ipsi.
multaque humi cum inhumata iacerent corpora supra
corporibus, tamen alituum genus atque ferarum
aut procul absiliebat, ut acrem exiret odorem,
aut, ubi gustarat, languebat morte propinqua.
nec tamen omnino temere illis solibus ulla
comparebat avis, nec tristia saecla ferarum
exibant silvis. languebant pleraque morbo
et moriebantur. cum primis fida canum vis
strata viis animam ponebat in omnibus aegre;
extorquebat enim vitam vis morbida membris.
incomitata rapi certabant funera vasta
nec ratio remedii communis certa dabatur;
nam quod ali dederat vitalis aeëris auras
volvere in ore licere et caeli templa tueri,
hoc aliis erat exitio letumque parabat.
Illud in his rebus miserandum magnopere unum
aerumnabile erat, quod ubi se quisque videbat
implicitum morbo, morti damnatus ut esset,
deficiens animo maesto cum corde iacebat,
funera respectans animam amittebat ibidem.
quippe etenim nullo cessabant tempore apisci
ex aliis alios avidi contagia morbi,
lanigeras tam quam pecudes et bucera saecla,
idque vel in primis cumulabat funere funus
nam qui cumque suos fugitabant visere ad aegros,
vitai nimium cupidos mortisque timentis
poenibat paulo post turpi morte malaque,
desertos, opis expertis, incuria mactans.
qui fuerant autem praesto, contagibus ibant
atque labore, pudor quem tum cogebat obire
blandaque lassorum vox mixta voce querellae.
optimus hoc leti genus ergo quisque subibat.
*
Praeterea iam pastor et armentarius omnis
et robustus item curvi moderator aratri
languebat, penitusque casa contrusa iacebant
corpora paupertate et morbo dedita morti.
exanimis pueris super exanimata parentum
corpora non numquam posses retroque videre
matribus et patribus natos super edere vitam.
nec minimam partem ex agris maeror is in urbem
confluxit, languens quem contulit agricolarum
copia conveniens ex omni morbida parte.
omnia conplebant loca tectaque quo magis aestu,
confertos ita acervatim mors accumulabat.
multa siti prostrata viam per proque voluta
corpora silanos ad aquarum strata iacebant
interclusa anima nimia ab dulcedine aquarum,
multaque per populi passim loca prompta viasque
languida semanimo cum corpore membra videres
horrida paedore et pannis cooperta perire,
corporis inluvie, pelli super ossibus una,
ulceribus taetris prope iam sordeque sepulta.
omnia denique sancta deum delubra replerat
corporibus mors exanimis onerataque passim
cuncta cadaveribus caelestum templa manebant,
hospitibus loca quae complerant aedituentes.
nec iam religio divom nec numina magni
pendebantur enim: praesens dolor exsuperabat.
nec mos ille sepulturae remanebat in urbe,
quo prius hic populus semper consuerat humari;
perturbatus enim totus trepidabat et unus
quisque suum pro re cognatum maestus humabat.
multaque res subita et paupertas horrida suasit;
namque suos consanguineos aliena rogorum
insuper extructa ingenti clamore locabant
subdebantque faces, multo cum sanguine saepe
rixantes, potius quam corpora desererentur.
Tale causa di malattie e mortifera emanazione, un tempo,
nel paese di Cecrope, rese funerei i campi
e spopolò le strade, svuotò di cittadini la città.
Venendo infatti dal fondo della terra d'Egitto, ove era nato,
dopo aver percorso molta aria e distese fluttuanti,
piombò alfine su tutto il popolo di Pandione.
Allora, a torme eran preda della malattia e della morte.
Dapprima avevano il capo in fiamme per il calore
e soffusi di un luccichìo rossastro ambedue gli occhi.
La gola, inoltre, nell'interno nera, sudava sangue,
e occluso dalle ulcere il passaggio della voce si serrava,
e l'interprete dell'animo, la lingua, stillava gocce di sangue,
infiacchita dal male, pesante al movimento, scabra al tatto.
Poi, quando attraverso la gola la forza della malattia
aveva invaso il petto ed era affluita fin dentro il cuore afflitto
dei malati, allora davvero vacillavano tutte le barriere della vita.
Il fiato che usciva dalla bocca spargeva un puzzo ributtante,
simile al fetore che mandano i putridi cadaveri abbandonati.
Poi le forze dell'animo intero e tutto il corpo
languivano, già sul limitare stesso della morte.
E agli intollerabili mali erano assidui compagni
un'ansiosa angoscia e un lamentarsi commisto con sospiri.
E un singhiozzo frequente, che spesso li costringeva notte e giorno
a contrarre assiduamente i nervi e le membra, li struggeva
aggiungendo travaglio a quello che già prima li aveva spossati.
Né avresti notato che per troppo ardore in alcuno
bruciasse alla superficie del corpo la parte più esterna,
ma questa piuttosto offriva alle mani un tiepido contatto,
e insieme tutto il corpo era rosso d' ulcere quasi impresse a fuoco,
come accade quando per le membra si diffonde il fuoco sacro.
Ma la parte più interna in quegli uomini ardeva fino alle ossa,
nello stomaco ardeva una fiamma, come dentro fornaci.
Sicché non c'era cosa, benché lieve e tenue, con cui potessi giovare
alle membra di alcuno, ma vento e frescura cercavano sempre.
Alcuni immergevano nei gelidi fiumi le membra ardenti
per la malattia, gettando dentro le onde il corpo nudo.
Molti caddero a capofitto nelle acque di pozzi profondi,
mentre accorrevano protendendo la bocca spalancata.
La sete che li riardeva inestinguibilmente e faceva immergere
i corpi, rendeva pari a poche gocce molta acqua.
E il male non dava requie: i corpi giacevano
stremati. La medicina balbettava in un muto sgomento,
mentre quelli tante volte rotavano gli occhi spalancati,
ardenti per la malattia, privi di sonno.
E molti altri segni di morte si manifestavano allora:
la mente sconvolta, immersa nella tristezza e nel timore,
le ciglia aggrondate, il viso stravolto e truce,
le orecchie, inoltre, tormentate e piene di ronzii,
il respiro frequente o grosso e tratto a lunghi intervalli,
e stille di sudore lustre lungo il madido collo,
sottili sputi minuti, cosparsi di color di croco
e salsi, a stento cavati attraverso le fauci da una rauca tosse.
Non cessavano, poi, di contrarsi i nervi nelle mani e di tremare
gli arti, e di montare su dai piedi a poco a poco il freddo.
Così, quando alfine si appressava il momento supremo,
erano affilate le narici, assottigliata e acuta la punta
del naso, incavati gli occhi, cave le tempie, gelida e dura
la pelle nel volto, cascante la bocca aperta; la fronte rimaneva tesa.
E non molto dopo le membra giacevano irrigidite dalla morte.
E generalmente quando raggiava il sole dell'ottavo giorno,
o anche sotto la luce del nono, esalavano la vita.
E se taluno d'essi, come accade, era sfuggito a morte e funerali,
per ulcere orrende e nero flusso di ventre
più tardi tuttavia lo attendevano consunzione e morte;
o anche molto sangue corrotto, spesso con dolore di testa,
gli colava dalle narici intasate: qui affluivano
tutte le forze dell'uomo e la sostanza del suo corpo.
Se poi qualcuno era scampato al terribile profluvio di sangue
ributtante, ciò nonostante la malattia gli penetrava nei nervi
e negli arti e fin dentro gli organi genitali.
E alcuni, gravemente temendo il limitare della morte,
vivevano dopo essersi mutilati del membro virile col ferro;
e taluni, pur senza mani e senza piedi, rimanevano
tuttavia in vita, come altri perdevano gli occhi:
tanto si era impadronito di loro un acuto timore della morte.
E inoltre un oblio di tutte le cose invase certuni,
sicché non potevano riconoscere neppure sé stessi.
E benché sulla terra giacessero insepolti mucchi di corpi
su corpi, tuttavia gli uccelli e le fiere o fuggivano
balzando lontano, per evitare l'acre puzzo,
oppure, se li assaggiavano, languivano per morte imminente.
E d'altronde in quei giorni non era affatto facile che qualche
uccello comparisse, e le stirpi delle fiere, abbattute,
non uscivano dalle selve. La maggior parte languiva
per la malattia e moriva. Soprattutto la fedele forza dei cani,
stesa per tutte le strade, spirava penosamente;
ché la forza della malattia strappava la vita dalle membra.
Funerali senza corteo, desolati, gareggiavano nell'esser affrettati.
Né c'era specie di rimedio che valesse sicuramente per tutti;
infatti ciò che ad uno aveva dato la possibilità di continuare
a respirare i vitali aliti dell'aria e a contemplare gli spazi
del cielo, ad altri era esiziale e cagionava la morte.
Una cosa, in tali frangenti, era miseranda, e molto,
sopra ogni altra, penosa: ognuno, quando si vedeva
assalito dalla malattia, come se fosse condannato a morte,
perdendosi d'animo giaceva col cuore addolorato
e, rivolto a visioni funeree, esalava l'anima in quel punto stesso.
E infatti il contagio dell'avida malattia non cessava
in alcun momento d'attaccarsi dagli uni agli altri,
come se fossero lanute pecore e torme di cornuti bovi.
E questo soprattutto accumulava morti su morti.
Giacché tutti quelli che evitavano di visitare i congiunti malati,
mentre troppo bramavano la vita e temevano la morte,
li puniva poco dopo con morte turpe e trista,
derelitti, privi di soccorso, la micidiale mancanza di cure.
Ma quelli che davano aiuto, se ne andavano per il contagio e la fatica,
cui allora li costringevano a sobbarcarsi il senso dell'onore
e la carezzevole voce dei languenti con mista una voce di pianto.
Questo genere di morte affrontavano, dunque, tutti i migliori
*
e l'uno sugli altri, gareggiando nel seppellire la folla
dei congiunti; tornavano spossati dal pianto e dal cordoglio;
poi, in gran parte s'abbandonavano sui letti per l'angoscia.
Né si poteva trovare alcuno che la malattia
o la morte o il lutto non colpissero in tale frangente.
Inoltre languiva ormai ogni pastore e custode di armenti
e insieme il robusto guidatore dell'aratro ricurvo;
e ammucchiati in fondo ai tuguri giacevano i corpi
che povertà e malattia avevano dati in balìa della morte.
Su esanimi fanciulli corpi inanimati di genitori
avresti potuto talora vedere, e viceversa figli
esalare la vita su madri e padri.
E in non minima parte dai campi quell'afflizione confluì
nella città: la portò la languente folla dei campagnoli,
che colpita dalla malattia conveniva da ogni parte.
Riempivano tutti i luoghi e le case: tanto più, quindi,
nell'arsura così ammassati la morte a caterve li accatastava.
Molti corpi prostrati dalla sete per via e stramazzati
presso le fontane giacevano distesi,
col respiro strozzato dal troppo deliziarsi d'acqua;
e in gran numero avresti potuto vedere, per i luoghi aperti
al popolo, qua e là, e per le vie, membra languide nel corpo
mezzo morto, orride per lo squallore e coperte di stracci,
perire nella sozzura del corpo, con sulle ossa la sola pelle,
ormai quasi sepolta sotto ulcere spaventose e lordura.
Tutti i santuari degli dèi la morte aveva infine riempiti
di corpi esanimi; e tutti i templi dei celesti
rimanevano ingombri di cadaveri dovunque,
perché i custodi avevano gremito di ospiti quei luoghi.
E infatti ormai né la religione, né la maestà degli dèi
contavano molto: il dolore presente aveva il sopravvento.
Né si serbava nella città quel rito di sepoltura
con cui prima quel popolo sempre aveva usato farsi inumare;
infatti, sconvolto, era tutto preso dal panico; e ognuno, mesto,
inumava il proprio morto composto secondo la circostanza.
E a molti orrori li indussero gli eventi repentini e la povertà.
Così con grande clamore ponevano i propri consanguinei
sopra roghi eretti per altri, e di sotto accostavano
le fiaccole, spesso rissando con molto sangue
piuttosto che lasciare i corpi in abbandono.