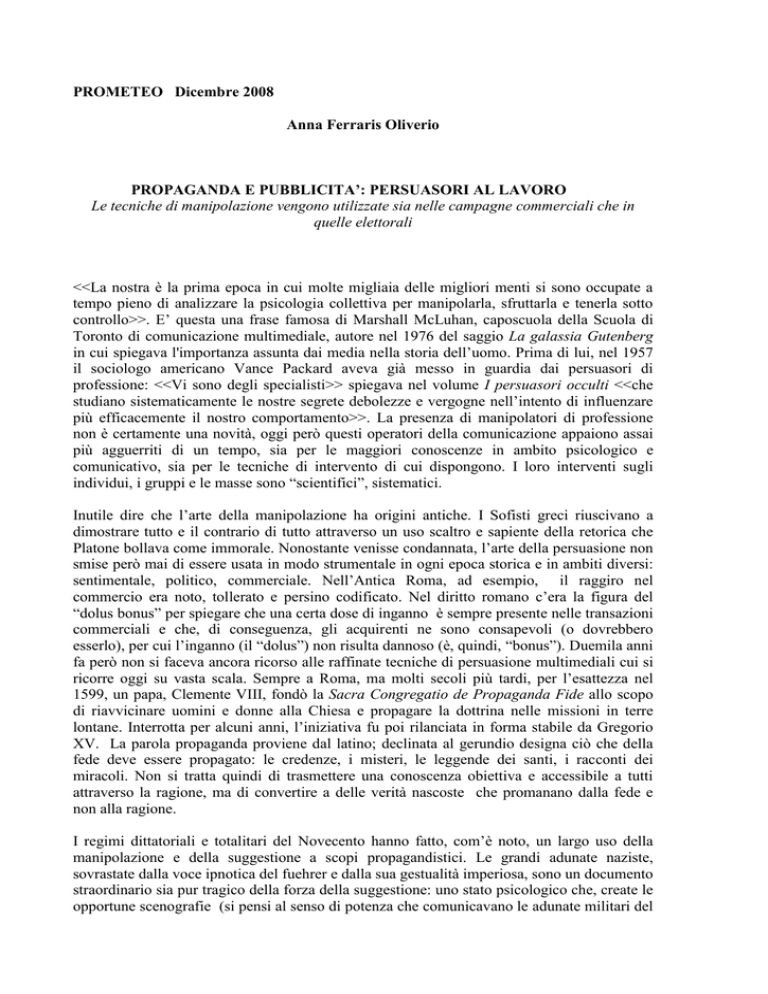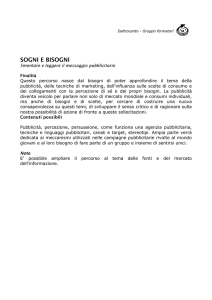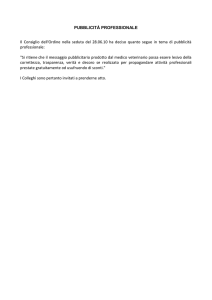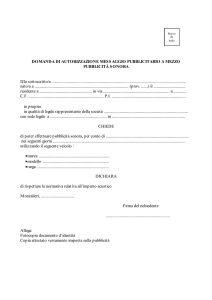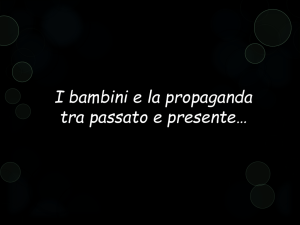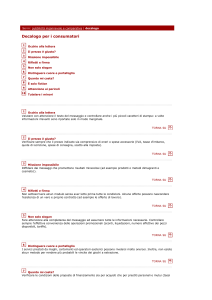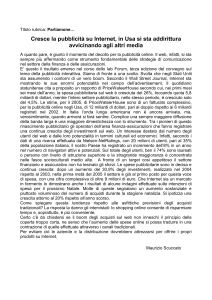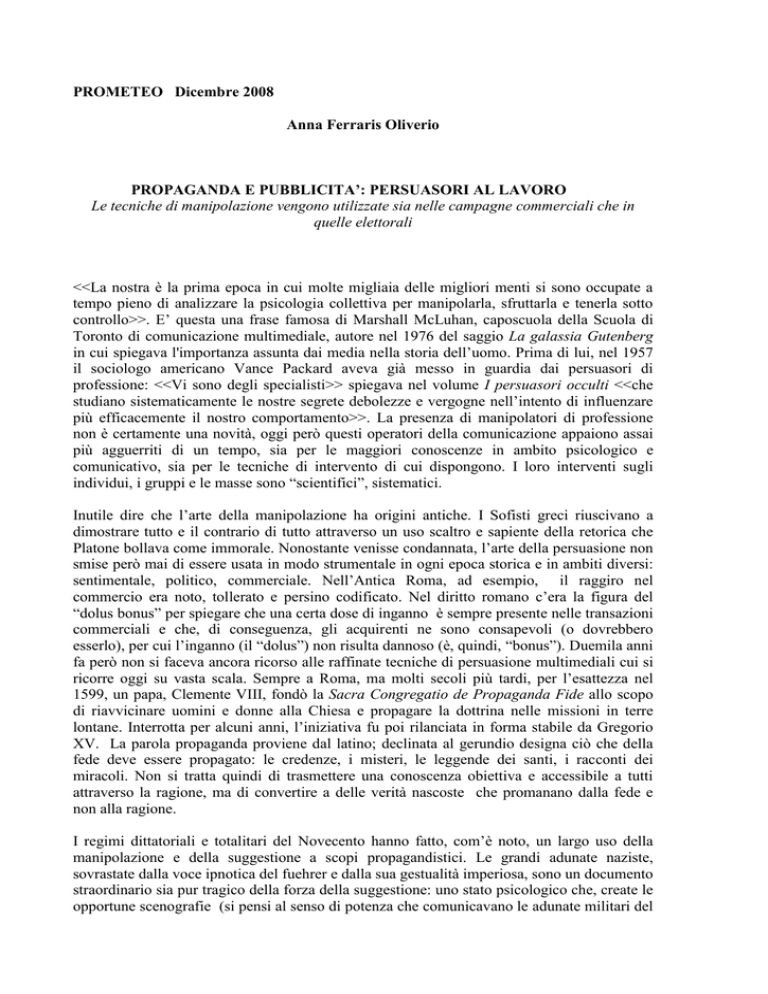
PROMETEO Dicembre 2008
Anna Ferraris Oliverio
PROPAGANDA E PUBBLICITA’: PERSUASORI AL LAVORO
Le tecniche di manipolazione vengono utilizzate sia nelle campagne commerciali che in
quelle elettorali
<<La nostra è la prima epoca in cui molte migliaia delle migliori menti si sono occupate a
tempo pieno di analizzare la psicologia collettiva per manipolarla, sfruttarla e tenerla sotto
controllo>>. E’ questa una frase famosa di Marshall McLuhan, caposcuola della Scuola di
Toronto di comunicazione multimediale, autore nel 1976 del saggio La galassia Gutenberg
in cui spiegava l'importanza assunta dai media nella storia dell’uomo. Prima di lui, nel 1957
il sociologo americano Vance Packard aveva già messo in guardia dai persuasori di
professione: <<Vi sono degli specialisti>> spiegava nel volume I persuasori occulti <<che
studiano sistematicamente le nostre segrete debolezze e vergogne nell’intento di influenzare
più efficacemente il nostro comportamento>>. La presenza di manipolatori di professione
non è certamente una novità, oggi però questi operatori della comunicazione appaiono assai
più agguerriti di un tempo, sia per le maggiori conoscenze in ambito psicologico e
comunicativo, sia per le tecniche di intervento di cui dispongono. I loro interventi sugli
individui, i gruppi e le masse sono “scientifici”, sistematici.
Inutile dire che l’arte della manipolazione ha origini antiche. I Sofisti greci riuscivano a
dimostrare tutto e il contrario di tutto attraverso un uso scaltro e sapiente della retorica che
Platone bollava come immorale. Nonostante venisse condannata, l’arte della persuasione non
smise però mai di essere usata in modo strumentale in ogni epoca storica e in ambiti diversi:
sentimentale, politico, commerciale. Nell’Antica Roma, ad esempio, il raggiro nel
commercio era noto, tollerato e persino codificato. Nel diritto romano c’era la figura del
“dolus bonus” per spiegare che una certa dose di inganno è sempre presente nelle transazioni
commerciali e che, di conseguenza, gli acquirenti ne sono consapevoli (o dovrebbero
esserlo), per cui l’inganno (il “dolus”) non risulta dannoso (è, quindi, “bonus”). Duemila anni
fa però non si faceva ancora ricorso alle raffinate tecniche di persuasione multimediali cui si
ricorre oggi su vasta scala. Sempre a Roma, ma molti secoli più tardi, per l’esattezza nel
1599, un papa, Clemente VIII, fondò la Sacra Congregatio de Propaganda Fide allo scopo
di riavvicinare uomini e donne alla Chiesa e propagare la dottrina nelle missioni in terre
lontane. Interrotta per alcuni anni, l’iniziativa fu poi rilanciata in forma stabile da Gregorio
XV. La parola propaganda proviene dal latino; declinata al gerundio designa ciò che della
fede deve essere propagato: le credenze, i misteri, le leggende dei santi, i racconti dei
miracoli. Non si tratta quindi di trasmettere una conoscenza obiettiva e accessibile a tutti
attraverso la ragione, ma di convertire a delle verità nascoste che promanano dalla fede e
non alla ragione.
I regimi dittatoriali e totalitari del Novecento hanno fatto, com’è noto, un largo uso della
manipolazione e della suggestione a scopi propagandistici. Le grandi adunate naziste,
sovrastate dalla voce ipnotica del fuehrer e dalla sua gestualità imperiosa, sono un documento
straordinario sia pur tragico della forza della suggestione: uno stato psicologico che, create le
opportune scenografie (si pensi al senso di potenza che comunicavano le adunate militari del
Terzo Reich, allo stato di esaltazione provocato dalla musiche guerresche, alla sapiente
sceneggiatura delle olimpiadi del ‘38…), emerge quasi automaticamente e si autoalimenta
grazie al contesto in cui gli individui si trovano ad essere inseriti. Joseph Goebbels, che a
fianco di Hitler gestì con successo la macchina propagandistica del Terzo Reich, sapeva che
in una folla le emozioni obnubilano la mente e si diffondono per contagio. Sapeva anche
come incanalarle e trasformarle, a seconda del momento, in devozione sottomessa al fuehrer
oppure in rabbia e risentimento verso delle minoranze più esposte e attaccabili. D’altro canto
esisteva già in quegli anni un sapere su come mescolare la fiction alla realtà per
suggestionare e persuadere.
Nel 1928, negli Stati Uniti, era stato pubblicato un libro di Edward Louis Bernays (americano
d’adozione ma viennese di nascita) dal titolo Propaganda che associava le idee di Gustave
Le Bon sulla psicologia delle folle a quelle di Sigmund Freud sull’inconscio. Benché
televisione e internet fossero molto al di là da venire, in quel saggio Bernays intuiva lo
sviluppo che le tecniche della comunicazione avrebbero avuto nel corso del XX secolo sia in
campo economico che politico e militare e riportava un esempio significativo: <<Se la
Cecoslovacchia ha ufficialmente acquisito lo statuto di stato indipendente il lunedì 28 ottobre
1918, non domenica 27, è perché il professor Masaryk, aveva capito che all’inizio della
settimana il mondo avrebbe recepito meglio la proclamazione della libertà del suo paese.
Dalla conversazione che abbiamo avuto su questa questione>> continuava Bernays
<<Masaryk mi ha detto “Se cambio la data di nascita della Cecoslovacchia come nazione
indipendente, confezionerò la storia per il telegrafo”. Questo aneddoto illustra il ruolo della
tecnologia nella nuova propaganda. Il telegrafo fa la storia, e la data fu modificata>>. Per
Bernays però l’uso della propaganda non aveva nulla di reprensibile era bensì al servizio
delle “relazioni pubbliche”, di cui egli è considerato l’inventore. Altri avevano però ben
chiaro, sin da allora, l’uso che si poteva fare della propaganda. Per esempio, Serge
Tchakhotine, sociologo di origine russa, scrisse nel 1922 un libro dal titolo inequivocabile Lo
stupro delle folle da parte della propaganda politica in cui attaccava un autore tedesco, Kurt
Hesse, autore del libro Maresciallo Psicologo in cui veniva tracciato il ritratto (profetico) di
un Fuehrer che attraverso la parola sapeva agire sugli animi umani e portare il popolo
tedesco, umiliato dalla sconfitta, verso il riscatto e la vittoria.
Nei paesi occidentali attuali i dittatori sono considerati obsoleti, un archetipo del passato, e in
Europa come negli Stati Uniti, in Canada come in Australia l’unica forma di governo
possibile è la democrazia. Ciò non significa però che le tecniche di persuasione e di
manipolazione siano state accantonate. La verità è che se ne fa un uso continuo e martellante,
assai più che in passato anche se in altre forme, con altri obiettivi e in diversi contesti. Le
tecniche si sono evolute, la comunicazione è in tempo reale, lo strumento non è più il
telegrafo ma il satellite. <<Le parole, signor Bond, ecco le nuove armi>> spiega un magnate
della stampa a James Bond nel film Il domani non muore mai (1997) <<Cesare aveva le sue
legioni, Napoleone la sua grande armata. Io ho le mie divisioni: televisioni, giornali,
magazine… Da qui a mezzanotte, avrò raggiunto più persone di chiunque altro nella storia, a
parte Dio!>>. Ma la comunicazione non passa solo attraverso la parole, ci sono anche le
immagini (in movimento, scioccanti, seduttive, sostenute da suoni, musiche, rumori…) che
rappresentano un valore aggiunto di grande impatto, sia in campo pubblicitario che
propagandistico.
Il cosiddetto neuromarketing deve la sua fortuna alla forza delle immagini. <<Si deve
riconoscere che il pubblicitario, per certi versi, è un manipolatore di cervelli quanto un
neurochirurgo, anche se i suoi attrezzi e i suoi strumenti sono diversi>> scriveva nel lontano
1957 Advertising Age la più importante rivista di pubblicità a livello mondiale. L’autore di
queste righe usava la metafora del neurochirurgo come un’iperbole, nello stile esagerato
tipico della pubblicità che per vincere la concorrenza deve cercare di colpire. A distanza di
cinquant’anni però questo paragone non sembra più tanto iperbolico. Nel 2003 Read
Montague, un neurologo che lavora a Huston, riuscì a dimostrare l’esistenza di un divario
sorprendente tra gusto e vista. Invitate ad indicare ad occhi bendati una preferenza tra due
bibite concorrenti, la Coca-Cola e la Pepsi, la maggior parte delle persone che si sottoposero
al test si dissero più favorevoli al gusto della Pepsi che a quello della Coca-Cola. La stessa
cosa però non si verificò quando quelle stesse persone non più bendate espressero
nuovamente il loro parere: molti di coloro che alla prima prova avevano scelto la Pepsi, alla
seconda affermarono di preferire la Coca-Cola. Montague ne dedusse che il logo della CocaCola, era più radicato di quello della Pepsi nell’immaginario dei consumatori e che la Pepsi
doveva accontentarsi del secondo posto. La Coca-Cola, nata molto prima della concorrente e
tramandata da una generazione all’altra, si era conquistata una “quota mente” nel cervello dei
consumatori.
Questa conclusione non spiega però il motivo di un divario così sorprendente tra gusto e
vista. Per capirne di più Montague è ricorso ad una tecnica sino ad allora utilizzata soltanto
per scopi medici (individuazione dei tumori e di lesioni cerebrali): la cosiddetta risonanza
magnetica. Seguendo l’attività cerebrale dei suoi “pazienti” con l’aiuto di questa tecnologia,
il professore osservò che quando una persona guarda l’immagine di un prodotto viene
sollecitata una regione precisa del suo cervello caratteristica dei mammiferi: la corteccia
prefrontale mediana. Mentre il test con gli occhi bendati coinvolge l’area cerebrale del
cosiddetto nucleo accumbes (o “striato ventrale”) - una struttura cerebrale legata alla
sensazione del piacere - la corteccia prefrontale mediana si avvale della memoria, ossia di
tutti i ricordi, le immagini, le sensazioni, i sentimenti che in una persona sono connessi a quel
prodotto (abitudini quotidiane, ricordi infantili, pubblicità ecc.). La Coca-Cola è in
circolazione da molto più tempo rispetto alla Pepsi e non ha mai smesso di fare pubblicità di
ogni tipo: da quelle a carattere sessuale a quelle natalizie.
Tre anni prima, ad Atlanta, l’istituto Brighthouse, fondato dal pubblicitario Joe Reyman,
aveva costituito un gruppo di studio, il Brighthouse Neurostrategies, col compito di
commercializzare le scoperte ottenute nel campo delle neuroscienze. Il suo direttore
scientifico, Clint Kilts, giunse alle stesse conclusioni di Montague: anche lui affermò di avere
localizzato nella corteccia prefrontale mediana la zona del cervello reattiva alla immagini
pubblicitarie; ma aggiunse che questa reazione è tanto più significativa quanto più il soggetto
visualizza una immagine in cui si identifica e che lo spinge a riconoscersi in quel prodotto. E’
come se dicesse “quello sono esattamente io!”. E in effetti, la regione prefrontale mediana è
anche associata all’immagine di sé e alla conoscenza intima che uno ha di sé stesso; i
pazienti, infatti, la cui corteccia prefrontale mediana è stata danneggiata soffrono spesso di
un cambiamento di personalità. Convinto di avere trovato “la regione chiave del
neuromarketing” Kilts non ha esitato ad affermare che i “neuromarketers” come lui sono in
grado di certificare ad una azienda se i prodotti che intende lanciare sul marcato possono
avere un successo di vendita oppure no.
Verità scientifica o ciarlataneria ad uso delle aziende? Alcuni neuroscienziati sono scettici
sulla possibilità di disporre di uno strumento scientifico così preciso. Ciò però non significa
che questo genere di studi sia stato accantonato. E’ vero invece il contrario. Per esempio, a
Ulm, in Germania, uno psichiatra, Henrik Walter, ha fatto un esperimento per conto della
Daimler Chrysler per vedere come reagiscono gli uomini di fronte ad una serie di autovetture
nuove. Ne è emerso che le autovetture vengono guardate come se si trattasse di un oggetto
amato (nel fronte dell’auto molti vi vedono un viso: i fari sono gli occhi...). La conclusione è
stata che una pubblicità ben riuscita non deve limitarsi a far sì che il consumatore si rifletta o
si riconosca nel prodotto ma, nel caso dell’automobile, deve anche mobilitare in lui una
volontà “arcaica” di appropriarsi di un oggetto di seduzione. Si tratta dunque di rinforzare la
classica associazione tra desiderio sessuale e pulsione all’acquisto, già presente in moltissime
pubblicità. <<Il consumatore deve poter sentire la marca, e aggrapparvisi come ad un
amante>> è la filosofia espressa da un noto pubblicitario della agenzia Saatchi & Saatchi.
La pubblicità che parla del prodotto e ne esalta la qualità è roba d’altri tempi, oggi il
pubblicitario lavora, insieme allo psicologo, sull’inconscio delle persone, cerca cioè di
evocare le loro memorie infantili, di risvegliare gli impulsi, di suscitare stati emotivi diversi.
Ne sono consapevoli gli “esperti” e ne sono consapevoli anche coloro che in televisione
mandano gli spot pubblicitari. Nel corso di un seminario, un dirigente della tv di stato
francese si è espresso in questi termini: <<Perché un messaggio pubblicitario sia percepito,
bisogna che il cervello dello spettatore sia disponibile. Le nostre trasmissioni hanno come
obiettivo di renderlo disponibile: ossia di divertirlo, di rilassarlo per prepararlo nell’intervallo
tra due messaggi. Quello che vendiamo allo sponsor è del tempo disponibile del cervello
umano>>. Campando sul denaro degli inserzionisti, chi fa televisione è perfettamente
consapevole dello stretto legame che deve esistere tra programmi e pubblicità. Un passo
ulteriore nella creazione di un’amalgama tra i contenuti dei vari programmi e gli spot che in
essi sono inseriti è stato compiuto dalle cosiddette “promofiction” o “promoserial”, dove la
separazione tra pubblicità e narrazione risulta sempre meno evidente in quanto il
pubblicitario utilizza personaggi o aspetti salienti della fiction nella pubblicità. Per esempio,
in uno spot inserito nella fiction del Dr. House, il dottore non compare per intero, si sente
però la sua voce, si vedono i suoi jeans, le sue scarpe da tennis, la sua canna… Il classico
stacco tra programma e pubblicità è, in pratica, abolito. Spot e fiction si fondono e si
confondono. L’obiettivo è trasferire le emozioni, che gli spettatori provano quando guardano
la “loro” fiction, sulla marca (o logo) dei prodotti che compaiono nello spot.
<<Una marca è essenzialmente una relazione>> spiega Steve Denning, un guru della
pubblicità, in un libro recente (The Leader’s Guide to Storytelling): questa relazione può
essere tenue, fragile, limitarsi ad una vaga familiarità del consumatore col nome della marca,
oppure durare nel tempo. Il paradosso del marketing contemporaneo è che deve fidelizzare
dei comportamenti d’acquisto divenuti mutevoli, labili, imprevedibili. In più, molti prodotti
concorrenti sono estremamente simili tra loro nella sostanza se non addirittura uguali (per es.
i detersivi). Si tratta quindi di trovare il modo di ingaggiare il consumatore in una relazione
emotiva con una determinata marca, che duri nel tempo. L’ultima strategia del “marketing
relazionale” consiste nell’inserire le pubblicità nelle fiction e/o realizzare dei minifilm di due
o tre minuti che raccontano una storia in cui il consumatore possa identificarsi, riconoscersi o
vivere delle emozioni coinvolgenti. Per esempio alcuni anni fa la Disney ebbe l’idea di
commercializzare dei video pedagogici intitolati Baby Einstein. La “storia” che raccontò alle
mamme dei neonati in quell’occasione fu che quel video avrebbe stimolato le capacità
mentali dei loro bambini facendoli diventare dei piccoli Einstein. Un storia di successo che
fruttò alla Disney 14 milioni di dollari malgrado il video non avesse alcun impatto positivo.
Se si ricorre sempre più alle “storie” per convincere è perché il racconto ha una sua forza
intrinseca che, dalle parabole alle favole, dai poemi antichi alle narrazioni moderne, non è
mai stata smentita. Vedremo più avanti come a questa strategia non ricorra solo il marketing
ma anche la politica.
Un target ambito dalle multinazionali sono i bambini. Le multinazionali spendono oltre due
miliardi di dollari ogni anno in pubblicità rivolte all’infanzia, ossia oltre venti volte in più di
quanto spendessero quindici anni fa. Ma la novità è che ora queste aziende non si
accontentano di raggiungere gli adolescenti e i bambini della scuola materna: oggi vogliono
catturare anche le menti e i cuori dei piccoli al di sotto dei tre anni. I motivi per cui bambini
di tutte le età sono diventati un target pubblicitario molto ambito sono fondamentalmente tre.
Il primo è che essi rappresentano già di per sé un mercato importante. A loro sono destinati
giocattoli, dolciumi, bibite, alimenti eccetera. A fare gli acquisti sono i genitori, ma i bambini
possono “assillarli” per ottenere ciò che vogliono. Questo fenomeno è stato definito dai
pubblicitari stessi nag factor, fattore assillo. Una sorta di cuneo fatto di capricci, lagnanze,
malumori con cui i bambini cercano di spezzare le difese dei genitori. Il secondo motivo è
che, con le loro assillanti richieste, i bambini non solo chiedono i prodotti a loro destinati ma
anche altri tipi di prodotti di cui hanno visto le pubblicità in televisione. Il che significa che al
supermercato il bimbo indicherà alla mamma i biscotti “più freschi”, la pasta “migliore”, il
riso che “non scuoce”, l’acqua minerale del campione di calcio. Il terzo motivo, più
importante di tutti è la fedeltà alla marca, definita dai pubblicitari il “Santo Gral”. I bambini
di oggi rappresentano il mercato adulto di domani. I loro gusti vanno coltivati e orientati in
modo da “fidelizzarli” precocemente ad un marchio prima ancora che a un prodotto. Ed è qui
che il contributo degli psicologi diventa prezioso per i pubblicitari, i quali hanno bisogno di
penetrare sempre meglio e sempre più a fondo nella mente dei piccoli consumatori, seguire
passo passo i tempi dello sviluppo intellettivo ed emotivo, lavorare sui bisogni e sugli affetti.
Poiché la concorrenza è sempre più agguerrita, chi arriva prima nella creazione di uno slogan
efficace ha maggiori probabilità di riuscire a imprimere nella mente del consumatore il
proprio logo come un tatuaggio (vedi il caso della Coca-Cola), chi riesce a inventare una
confezione che faccia sognare oppure a creare un jingle simpatico, realizzerà un vantaggio
sulla ditta avversaria misurabile in centinaia di migliaia di euro.
Questa offensiva della pubblicità nei confronti dei più piccoli, in atto ormai da svariati anni,
non può che creare disagio in chi conosce gli effetti che il condizionamento e il modellaggio
possono avere su delle menti in via di sviluppo. Se è innegabile infatti che alcuni spot sono di
pregevole qualità e intelligenti, ciò non toglie che il loro obiettivo sia la seduzione di soggetti
in tenera età, la cui mente è sicuramente molto plastica e recettiva ma anche estremamente
ingenua e come tale priva di difese. <<Ciò che rende i bambini bersagli così attraenti per le
corporation e gli esperti di marketing è la loro estrema recettività alla pubblicità>> scrive
Joel Bakan autore del volume The Corporation e sconsolato conclude: <<Nell’universo
psicopatico delle corporation, la vulnerabilità è una sollecitazione allo sfruttamento, non un
motivo di tutela>>.
Il lavoro che i “creativi” fanno sulle emozioni di adulti e bambini è subdolo e continuo. Per
loro si tratta di attività lavorativa. Per altri invece di fredda strumentalizzazione. I media
promettono emozioni e ne abusano. Non c’è nulla di male, ovviamente, nel vivere delle
emozioni attraverso uno spettacolo, una fiction o una notizia del TG. Dalla drammaturgia
greca al romanzo ottocentesco ai racconti contemporanei le emozioni sono sempre state al
centro delle narrazioni umane. Il problema nasce quando si confonde emozione con
informazione. Il messaggio, insidioso, che implicitamente inviano programmi di
informazione che cedono al fascino dello spettacolo e strumentalizzano le emozioni è il
seguente: <<Se l’emozione che provi di fronte a questa notizia è vera, è vera anche la
notizia>>. <<Se ti commuovi e le tue lacrime sono vere, l’evento che ha causato quelle
lacrime è vero anch’esso>>. Ma il fatto di provare un’emozione, anche molto intensa, non
garantisce – ahimè! – che l’informazione sia vera. Può esserlo ma anche non esserlo. Ecco un
esempio famoso, che forse alcuni ricordano, di come le emozioni possano essere del tutto
disgiunte dalla realtà dei fatti. Il 5 febbraio del 1990 Gianni Minoli nel corso di una puntata
di Mixer, un settimanale di informazione della Rai, esibì un documentario d’epoca in cui il
giudice Sansovino confessava di avere truccato, d’accordo con altri membri del tribunale
elettorale, i risultati del referendum del 1946 con cui venne abolita la monarchia in Italia,
sostituita dal sistema repubblicano. Molti spettatori, soprattutto coloro che nel ’46 avevano
partecipato al referendum, seguirono il programma in preda ad un’emozione crescente.
Soltanto al termine della proiezione Minoli rivelò l’inganno: il giudice che compariva nel
filmato era in realtà un attore, il “vecchio” documentario, in bianco e nero, era stato girato in
studio qualche settimana prima con dei figuranti. Tutto era falso ad eccezione della profonda
emozione vissuta da milioni di spettatori. <<Abbiamo voluto mostrare>> spiegò in
conclusione il giornalista <<come si possa manipolare l’informazione televisiva. Bisogna
ormai imparare a diffidare della televisione e delle immagini che ci vengono presentate>>.
Le stesse tecniche che vengono utilizzate per indurre le persone a comprare dei prodotti
vengono usate nelle campagne elettorali. Si lavora sui manifesti stradali, sugli spot e
direttamente sul look dei candidati insegnando loro come muoversi, vestirsi, parlare. Poiché
compaiono sugli schermi, la cura dell’immagine mediatica è diventata una preoccupazione
che non riguarda più soltanto gli attori ma anche i politici che per avere più attenzione e
successo si affidano ai professionisti dell’immagine. Il corpo ha assunto un’importanza
crescente. Significativi, a questo proposito, sono i consigli e le osservazioni di un’agente che
ha a lungo lavorato con i politici che vanno in tv. <<La prima cosa che notiamo di qualcuno
in televisione è la sua faccia e la sua pettinatura o acconciatura. Se siete un politico e prima
dell'intervista avete dormito poco, state attenti a non presentarvi stanchi e con il viso
impastato di sonno. Apparire in forma è importante per chiunque, ed è a questo che serve una
buona mano di make-up prima di andare in onda! Può sembrare insignificante ma i capelli in
disordine, il viso teso, la cravatta storta, distolgono l'attenzione dello spettatore da ciò che
state dicendo. L'immagine creata dalla televisione ha un effetto enorme sull'opinione che gli
spettatori si fanno di colui che sta parlando>>. E prosegue con queste inquietanti
osservazioni: <<Ciò che voi dite quando siete in televisione è certamente importante, ma gli
analisti sostengono che la reazione dell'audience alle vostra presenza sullo schermo può
essere così sintetizzata:
58 per cento dall'apparenza
35 per cento dal timbro della voce
7 per cento al significato delle parole.
Il tono di voce è molto importante. Il piglio con cui si dà una notizia o si inizia un discorso
serve a creare un clima e preparare l'umore dell'audience>> (Mather, 1995).
I fatti, le statistiche, i programmi, i piani di spesa, hanno un impatto assai meno rilevante
sullo schermo del look, del corpo, dei riferimenti alla vita privata che, apparizione dopo
apparizione, possono trasformare un politico in personaggio familiare, affidabile,
carismatico. <<La gente non vuole avere più informazioni>> scrive Annette Simmons
autrice del volume The Story Factor (2002) <<vuole credere in voi, nei vostri obiettivi, nel
vostro successo, nella storia che gli raccontate. E’ la fede che fa muovere le montagne, non i
fatti. I fatti non fanno nascere le fede. La fede ha bisogno di una storia che la sostenga.>> Di
qui l’importanza delle pratiche di autolegittimazione, di autovalutazione e del cosiddetto
“storytelling” ossia racconti o parabole che assumono un valore simbolico e che per la loro
concretezza si impongono all’attenzione collettiva più delle cifre, dei ragionamenti o di una
compilazione di fatti. Il leader/guru non fa riferimento ad un sapere ragionato e consapevole,
cerca invece di raggiungere l’immaginazione e il cuore della sua audience con storie
commoventi. Gli spin doctors che organizzano le campagne elettorali negli Stati Uniti,
puntano molto su questo aspetto perché sanno che coloro che ricercano motivazioni valide,
che hanno un bagaglio culturale solido e sono abituati a ragionare, costituiscono una
minoranza. E’ questa una delle fragilità delle democrazie che molti cinicamente sfruttano. Gli
Stati Uniti hanno svolto in quest’ambito il ruolo di apripista grazie anche al kow-how
accumulato dall’industria cinematografica hollywoodiana. E non è un caso che il primo
presidente ad avvalersi di questa modalità di comunicazione in forma sistematica e
consapevole sia stato proprio Ronald Reagan, ex attore di Hollywood che spesso nei suoi
discorsi evocava episodi tratti da vecchi film di guerra come se appartenessero realmente alla
storia degli Stati Uniti. Bill Clinton, appena eletto, assunse lo stesso direttore della
comunicazione di Reagan, il quale gli insegnò a raccontare le storie che piacciono alla gente
e ad inserire episodi della sua infanzia nei discorsi ufficiali. Anche George Bush imparò la
lezione e ne fece un uso spregiudicato. Nel primo anniversario dell’11 settembre, per
esempio, nelle tv locali fu mandato in onda, decine di migliaia di volte, un videoclip in cui un
uomo spiegava come la figlia sedicenne si fosse chiusa in se stessa dopo l’assassinio della
madre alle torri gemelle e come soltanto la visita di Bush le avesse restituito la speranza e la
voglia vivere. <<E’ l’uomo più potente del mondo ed è venuto di persona ad accertarsi che io
stia bene>> spiegava poi la ragazza mostrando una foto in cui la si vedeva stretta al
presidente. Il clip terminava con Bush inquadrato di profilo, in una attitudine di
raccoglimento, avvolto dalle forti note di una melodia.
Secondo gli spin doctors, riuscire a raccontare delle buone storie è uno dei fattori che può
aiutare un uomo politico a diventare popolare. Secondo un esperto in storytelling e celebre
guru del marketing americano, Seth Godin, John Kerry perse le elezioni pur godendo di una
popolarità superiore al suo rivale perché non aveva raccontato una storia coerente, toccante.
Kerry, troppo intellettuale, <<non ha voluto raccontare una menzogna che la gente avrebbe
ricordato. Che piaccia o no Bush invece ha incarnato con straordinario talento il personaggio
del dirigente forte, convinto e infallibile.>> Un’idea condivisa anche da Richard Nixon che
anni prima nelle sue memorie aveva scritto che i presidenti postmoderni <<devono essere dei
maestri nell’arte di manipolare i media, non solo per vincere le elezioni, ma per portare a
buon fine la loro politica e sostenere le cause in cui credono. Devono al tempo stesso evitare
a tutti i costi di essere accusati di manipolare i media>>. Di lui è rimasto famoso il cosiddetto
"discorso di Checkers", pronunciato nel 1952 quando era candidato alla vicepresidenza degli
USA. Poiché era stato accusato di essersi indebitamente appropriato di denaro per la sua
campagna elettorale, Nixon affittò mezz'ora di televisione per spiegarsi alla nazione. Le sue
parole, in realtà, non chiarirono le accuse che gli erano state rivolte, ma l'aspirante
vicepresidente ebbe modo di spiegare che egli era un buon padre, un buon marito, un buon
cittadino, un buon americano. E mentre parlava, la telecamera si soffermava sul suo fedele
cane Checkers, accucciato davanti al camino... La trasmissione si concluse con un appello ai
telespettatori: Nixon li invitò a scrivere al comitato nazionale del partito repubblicano per
stabilire se doveva restare candidato al vicepresidenza o dimettersi. L'effetto fu immediato e
massiccio: al comitato del partito repubblicano giunse una valanga di lettere, telegrammi e
telefonate in suo favore. Nixon fu premiato non perché avesse dimostrato di essere onesto,
ma perché la sua immagine televisiva, la storia del buon padre di famiglia che aveva
raccontato accanto al caminetto e il muso “onesto” di Checkers avevano fatto breccia nel
cuore degli spettatori.
Le tecniche americane di personalizzazione e narrazione hanno attraversato l’oceano e ora
vengono applicate anche in Europa. Secondo il francese Christian Salmon, autore del volume
Storytelling, durante il confronto elettorale tra Nicolas Sarkozy e Ségolène Royal <<gli
uomini politici e i media, i giornalisti e gli esperti hanno bruscamente cambiato il loro modo
di esprimersi e si sono messi a raccontare delle storie. Per la prima volta, la destra non
rivendicava più l’indipendenza nazionale né la sinistra il progresso sociale. Da entrambi i lati
è trionfato il kitsch. L’opinione pubblica l’ha capito d’istinto, propagando allegramente i
pettegolezzi sui menage familiari, le rotture e infedeltà coniugali […]. Il dibattito televisivo
tra i due candidati non ha visto il confronto tra due progetti della società ma, fino alla
caricatura, due posture, due intrighi. Questo tipo di confronto è culminato nell’episodio della
scolarizzazione dei bambini portatori di handicap: un soprassalto di compassione, una lotta al
coltello dei due candidati per le vittime… Nello stesso modo, spiega ancora Salmon, in cui
gli spin doctors repubblicani avevano costruito la campagna elettorale di George W. Bush nel
2000 a partire dalla sua vittoriosa storia personale contro l’alcool, Nicolas Sarkozy ha
adattato i temi della sofferenza e della redenzione per elaborare la sua versione francese del
conservatorismo passionale: “ho cambiato perché le prove della vita mi hanno cambiato. Lo
voglio dire con pudore ma lo voglio dire…”>>. E Ségolène non gli fu da meno nel raccontare
storie strappalacrime che arrivassero al cuore degli elettori.
Il politico “comunicatore” che mette in scena narrazioni promozionali su di sé e sulla propria
vita privata, che trae vantaggi dai gossip come dai siparietti televisivi preparati ad hoc è
presente, ormai da tempo, anche nel nostro Paese. (Si veda ad esempio lo sketch in un Porta
a Porta del 15/9/2008 realizzato dalla campionessa olimpionica di fioretto e il presidente del
consiglio in cui, sotto l’occhio compiaciuto del famoso conduttore, il presidente viene
celebrato sia come leader “carismatico” che come maschio ambito da ogni donna.) D’altro
canto, le televisioni e i magazine sono affamati di storie, emozioni, gossip e scoop, mentre il
lavoro di schiere di agenti, curatori di immagine e consiglieri della comunicazione è proprio
quello di fornire ai mass-media storie in grado di “formattare” i desideri e le scelte della
gente, standardizzare le emozioni di fasce sempre più ampie di pubblico. Non tutto è perduto,
però. La buona notizia è che non sempre ci riescono, sia perché anche i guru della
comunicazione sono fallibili e sia perché contrastati dalla concorrenza. Un’altra buona
notizia è che le persone hanno tutte quante un cervello che possono sempre decidere di usare,
anche quando sembrano ormai totalmente omologate.
Bibliografia:
Bakan J., The Corporation. La patologica ricerca del profitto e del potere. Fandango, Roma
Godin S. (2007), Tous les marketeurs sont des menteurs. Maxima, Paris
Mather D. (1995), Surviving the Media. Harper Collins, London
Oliverio Ferraris A. (2008), La sindrome Lolita. Rcs, Milano
Salmon C. (2007), Storytelling. La Découverte, Paris
Simmons A. (2002), The Story Factor. Basic Book, Cambridge
Biografia:
Psicologa e psicoterapeuta è nata a Biella e ha studiato a Milano e a Torino. Dal 1980 è
professore ordinario di Psicologia dello sviluppo all'Università "La Sapienza" di Roma. E'
autrice di saggi, articoli scientifici e testi scolastici in cui affronta i temi dello sviluppo,
dell'educazione, della famiglia, della scuola, dei rapporto con la tv e i nuovi media. E' stata
membro della Consulta Qualità della Rai e del Comitato Nazionale per la Bioetica. Collabora
con Il Messaggero, Prometeo, Scuola dell'infanzia e altre riviste. Dirige Psicologia
Contemporanea. L’ultimo libro, pubblicato nel 2008, è La sindrome Lolita (RCS).