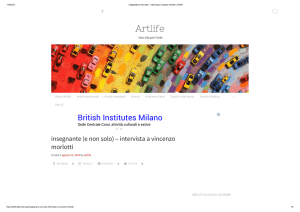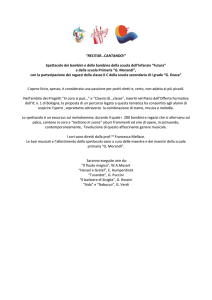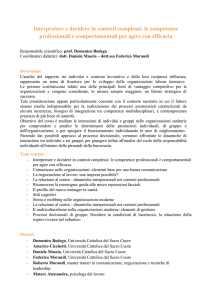A Lecco i pittori italiani nel vettore Cézanne
- Massimo Romeri, 13.03.2016
A Lecco «Morandi, Morlotti e il paesaggio italiano tra le due guerre», a cura di Francesco
Guzzetti. Incentrata su Ennio Morlotti, una mostra scelta di «paesi» naturali e urbani: il motivo
portante è come viene italianizzata le lezione sintetica cézanniana
Intorno a Morandi, Morlotti e il paesaggio italiano tra le due guerre è aperta in questi giorni a Lecco,
fino al 3 aprile, una scelta mostra a cura di Francesco Guzzetti: Natura e città. L’esposizione nasce
intorno a un evento importante per la piccola e discosta città lariana: il deposito, dalle Civiche
Raccolte di Milano ai Musei Civici di Lecco, di un capolavoro di Ennio Morlotti, l’Adda a Imbersago
del 1955. Si è sanata in questo modo una situazione particolare: le collezioni civiche lecchesi erano
infatti sprovviste di opere del pittore, di fatto uno degli artisti più celebri nati in città. I trenta dipinti
esposti spiegano quindi i precedenti e il contesto nel quale il quadro va calato per una corretta
lettura, seguendo l’approccio alla pittura di paesaggio di più generazioni, dal divisionismo in chiave
futurista di Boccioni fino a Morandi. La mostra si percorre agevolmente anche grazie agli apparati
predisposti dal curatore insieme a un gruppo di giovani studenti del Liceo Manzoni, in una civile ed
esemplare esperienza pedagogica, che va dalla creazione di un sito web (www.naturaecittalecco.it),
alla cura delle schede presenti nelle sale, alle visite guidate.
Tutto è correlato dalle parole di Morlotti, che da autentico pittore parlava poco, salvo lasciare, in
una bellissima lettera del 1947 a Ernesto Treccani interamente pubblicata nel catalogo, una
profonda riflessione sul proprio lavoro, sui propri modelli e sul futuro dell’arte italiana in un
momento delicato della storia nazionale e della propria vicenda personale. Guzzetti ne fa una vera e
propria introduzione, così che persino la scelta e la disposizione delle opere nelle sale, dopo la
lettura, sembrano essere naturalmente aderenti al flusso di pensiero dell’artista.
Intanto, con ordine: la prima sezione è dedicata al paesaggio naturale. Ci sono opere di Aldo Carpi,
Umberto Lilloni, Achille Lega, ma il tema, affrontato da Carlo Carrà, diventa uno studio dai toni
intimi, nel quale l’amore per i cosiddetti primitivi, cioè i pittori italiani del Trecento e Quattrocento,
è codificato in una sintesi poetica di forme e luce. Così il covone, l’albero, il verde dell’erba e
l’azzurro del cielo ne Il leccio del Museo del Novecento, 1925, sembrano prelievi da uno dei
paesaggi di Piero della Francesca riletti attraverso la geometria sentimentale di Cézanne perché
«tutto nella natura è sferico o cilindrico». Morlotti, nella lettera del ’47, cita il dipinto: «Ma ci pensi
Ernesto a cos’è quel suo leccio al museo d’arte moderna?». In mezzo a tutta la polvere di quel museo,
Il leccio suscita in lui «un sentimento profondo della luce», ed è «realtà vera, integra». Cézanne è
nelle corde di tutta quella generazione, specie dopo la sua retrospettiva alla Biennale del 1920, e la
sua influenza si vede bene in una sala come questa, nei paesaggi di Emilio Gola, Ottone Rosai,
Armando Spadini. L’epitaffio l’appone Roberto Longhi: «il più grande artista dell’età moderna» (in
Breve ma veridica storia della pittura italiana, 1914). Anche Morlotti, sui tavoli della Biblioteca
d’Arte del Castello, prima dei restauri BBPR, passava i pomeriggi a sfogliare cataloghi, «a guardare
un po’ di Cézanne».
Nella seconda sala sono raccolte opere che richiamano, per dimensione e formato, il vedutismo e la
cultura figurativa tardo ottocentesca. È una pittura adatta agli interni borghesi, dove gli artisti, tutti
diversi tra loro per stile e risultati, sotto la protezione di Margherita Sarfatti provano a dare forma al
paesaggio di Novecento: Piero Marussig e Cesare Monti almeno, più isolato il cézanniano Arturo
Tosi; ed Ennio: «Forse ora, qui a Parigi, riuscirò a capire meglio quei pittori, non guardando Picasso,
ma il Jeu de Paume». Il museo, con la sua ricca collezione di pittura francese del diciannovesimo
secolo, aveva riaperto proprio all’inizio del ’47.
È una generazione impegnata a superare il «chiacchiericcio impressionista» – ancora Longhi, in
Carlo Carrà, 1937 – attraverso una «solidificazione». Si tenta cioè di riassestare il proprio linguaggio
esercitandosi con lo studio delle forme, siano derivate da Cézanne o da Giotto, e arricchendo i
soggetti, del tutto evasivi, di un afflato morale. In questo senso, i panorami cittadini funzionavano
per certi versi meglio di paesi e marine. È Mario Sironi il vero inventore del paesaggio di Novecento:
dalle sue vedute urbane, come quella esposta, di collezione privata, 1920 – o quelle, sempre
accessibili, concentrate nella Casa Museo Boschi Di Stefano a Milano –, emerge una potenza cupa.
Gli edifici sono grandi scatole metafisiche di fronte alle quali l’osservatore è solo e annichilito; più
città delle macchine, che degli uomini. Un senso di opprimente solitudine che sarà riscosso dai colori
di Renato Birolli, ammiratore entusiasta delle opere di Matisse, o, più avanti, dall’ironia delle
cubature milanesi nei disegni di Saul Steinberg e dalle architetture di Aldo Rossi.
A Roma, nel frattempo, la città ha tutto un altro aspetto. Non ci sono la luce e il clima di Milano, non
ci sono la Ca’ Brutta, la via Pisacane dove vive Sironi e un’intera città in costruzione intorno al
Politecnico di quel grigio, scrive Morlotti, «che solo Milano ha. “Grigio Sironi”». La Roma dipinta da
Scipione, da Mario Mafai e dalla moglie Antonietta Raphäel è colorata, liquida, sognante, e muta in
un’«allucinazione espressionista, in cabala e magia» – ancora Longhi, nel ’29. Lo si coglie bene nel
Paesaggio romano di Mafai, collezione privata, 1929, ora nella terza sala dell’esposizione.
Per gli artisti riuniti nel movimento di Corrente come Birolli, Treccani, Raffaele De Grada, la Scuola
romana è importante. Così come lo studio dell’impressionismo e del post-impressionismo, che
assume un valore etico, oltre che estetico, in aperta polemica con il neoclassicismo arcaista di
Novecento – o del «novecentaccio», dirà Guttuso –, lungo una strada criticamente aperta all’inizio
degli anni trenta dall’antifascista Lionello Venturi. La retrospettiva di Scipione a Brera nel 1941, con
allestimento di Franco Albini, colpisce quindi molti amici di Morlotti come Aligi Sassu, Birolli,
Giovanni Testori. Ma Morlotti continua a guardare la Scuola romana con diffidenza e di quegli anni
ricorda, piuttosto, l’impressione ricevuta dalle opere di Giorgio Morandi: «il nodo costruttivo del
colore nella rielaborazione della natura del quadro è il legame più forte che sento con Morandi, con
quei suoi paesaggi impastati di materia». I colori sono «“intarsiati” l’uno con l’altro» e i paesaggi,
pur senza prospettiva, danno un senso di grandezza e «la stessa sensazione che mi ha dato vedere i
primi Corot». La metabolizzazione di Morandi è cruciale nella maturazione di Morlotti: «con Morandi
è arrivata l’ispirazione vera», scrive a Treccani.
È un’ossessione, quella per il pittore bolognese e la sua «umana sostanza», che trova una sponda in
Longhi: «Morandi non sarà secondo a nessuno» (Exit Morandi, 1964). E apparteneva a Longhi un
dipinto, oggi in collezione Merlini a Busto Arsizio, nell’ultima sala della mostra, in cui Morandi ha
rappresentato il cortile di casa visto dalla camera da letto. L’abitazione è quella di via Fondazza a
Bologna, nella quale il pittore passò gran parte della vita. Una sovrapposizione materica di verdi
scuri, ocra, bianchi, rende il quadro una ricerca profonda e sentimentale di un’espressione interiore.
Accanto è esposta una veduta di Grizzana, la meta prediletta dei soggiorni estivi. Tutto è costruito
attraverso il colore, senza disegno o forme, come se la realtà oggettiva subisse un tracollo e Morandi
riproponesse una visione rigenerata in un impasto percettivo, costruita e ricostruita al variare non
della luce, ma delle sensazioni, in quadri diversi con soggetto identico. È un modo di approcciarsi
alla pittura imprescindibile per il «morandiano» Morlotti, che nei paesaggi dell’Adda spingerà i suoi
amalgami cromatici a un dinamismo estremo, fino all’informale. Ne scriverà molto il vecchio
compagno di Corrente, Testori, per il quale la «cosciente e meditata lombardità» di Morlotti si
giocava tra rievocazioni manzoniane e un legame profondo con i luoghi d’origine. E nell’impegnativa
ricerca formale del pittore lecchese la natura non è una cosa da vedere, «è una cosa da partecipare,
in cui entrare, in cui andar dentro, in cui perdersi», per capirla totalmente (in Morlotti o la rivincita
della pittura, 1978).
© 2017 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE