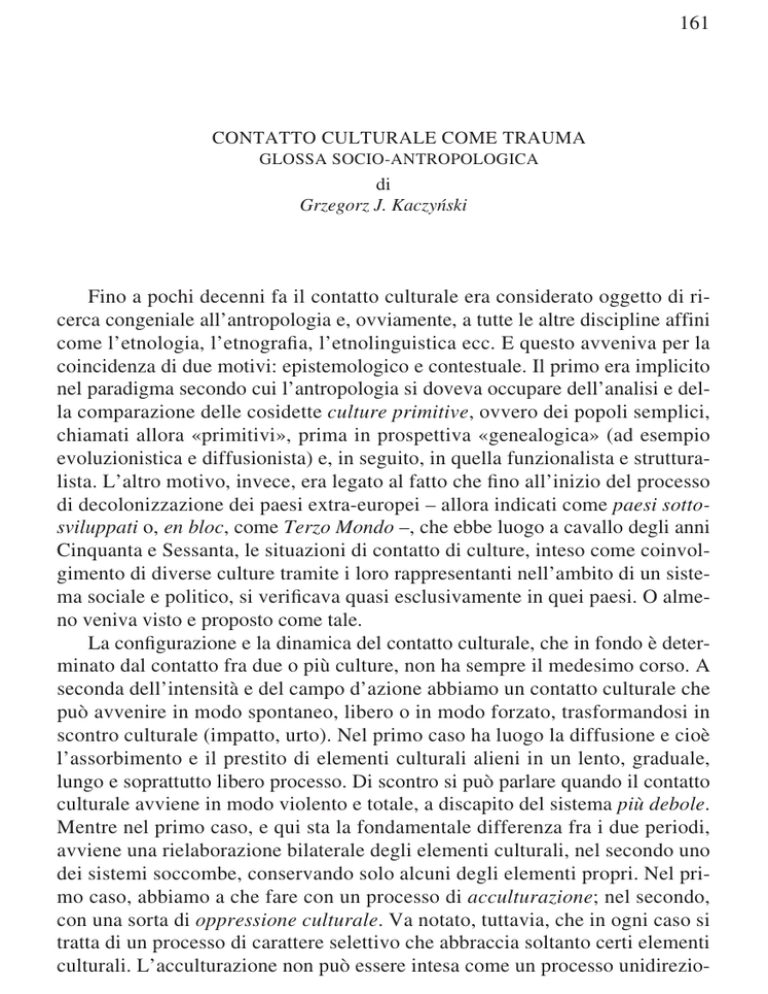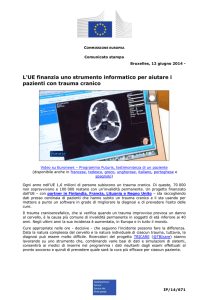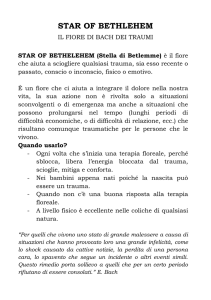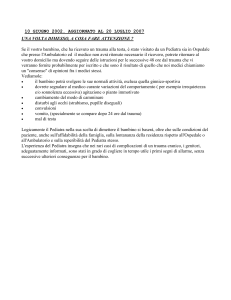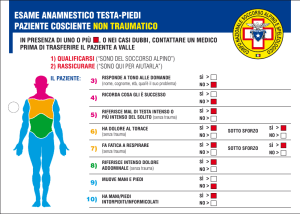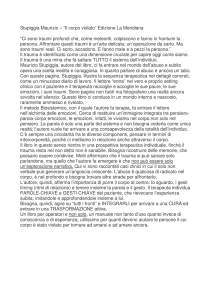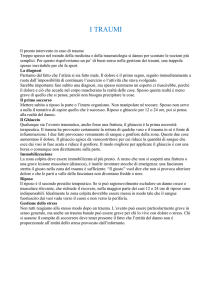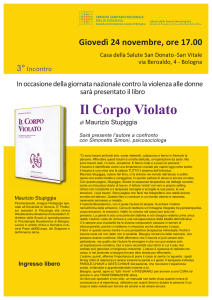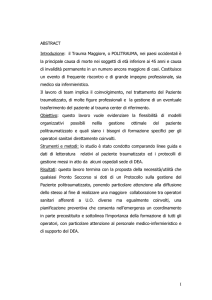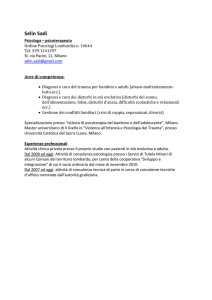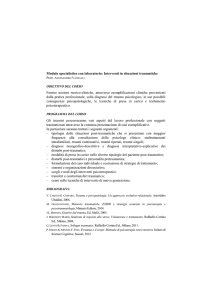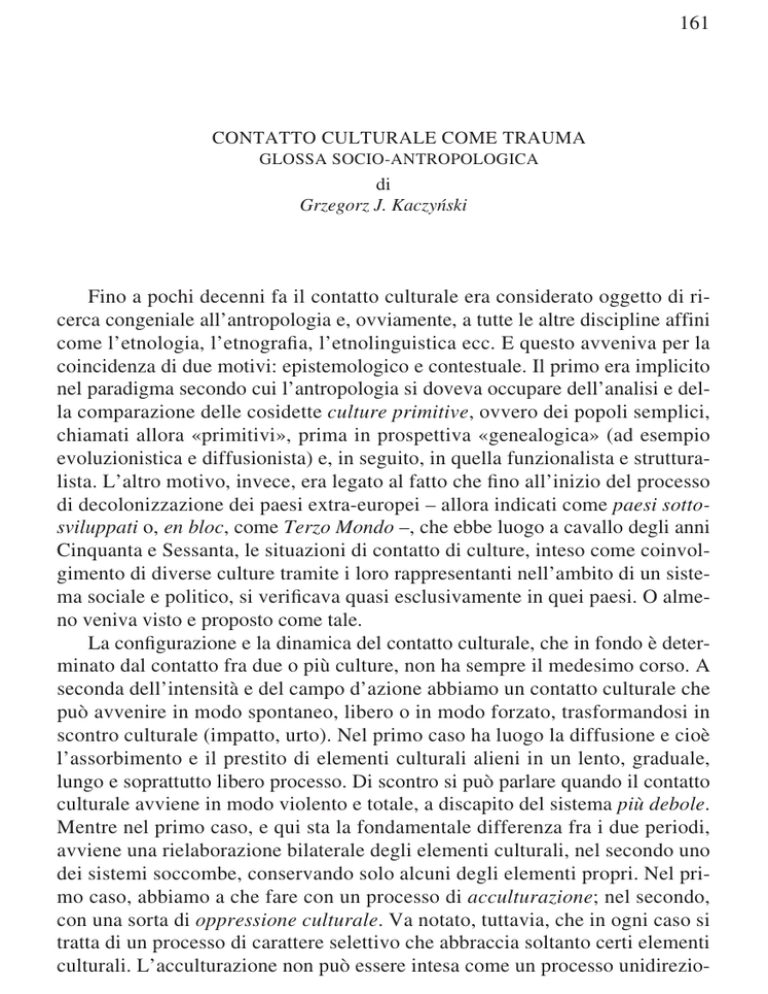
161
CONTATTO CULTURALE COME TRAUMA
GLOSSA SOCIO-ANTROPOLOGICA
di
Grzegorz J. Kaczyński
Fino a pochi decenni fa il contatto culturale era considerato oggetto di ricerca congeniale all’antropologia e, ovviamente, a tutte le altre discipline affini
come l’etnologia, l’etnografia, l’etnolinguistica ecc. E questo avveniva per la
coincidenza di due motivi: epistemologico e contestuale. Il primo era implicito
nel paradigma secondo cui l’antropologia si doveva occupare dell’analisi e della comparazione delle cosidette culture primitive, ovvero dei popoli semplici,
chiamati allora «primitivi», prima in prospettiva «genealogica» (ad esempio
evoluzionistica e diffusionista) e, in seguito, in quella funzionalista e strutturalista. L’altro motivo, invece, era legato al fatto che fino all’inizio del processo
di decolonizzazione dei paesi extra-europei – allora indicati come paesi sottosviluppati o, en bloc, come Terzo Mondo –, che ebbe luogo a cavallo degli anni
Cinquanta e Sessanta, le situazioni di contatto di culture, inteso come coinvolgimento di diverse culture tramite i loro rappresentanti nell’ambito di un sistema sociale e politico, si verificava quasi esclusivamente in quei paesi. O almeno veniva visto e proposto come tale.
La configurazione e la dinamica del contatto culturale, che in fondo è determinato dal contatto fra due o più culture, non ha sempre il medesimo corso. A
seconda dell’intensità e del campo d’azione abbiamo un contatto culturale che
può avvenire in modo spontaneo, libero o in modo forzato, trasformandosi in
scontro culturale (impatto, urto). Nel primo caso ha luogo la diffusione e cioè
l’assorbimento e il prestito di elementi culturali alieni in un lento, graduale,
lungo e soprattutto libero processo. Di scontro si può parlare quando il contatto
culturale avviene in modo violento e totale, a discapito del sistema più debole.
Mentre nel primo caso, e qui sta la fondamentale differenza fra i due periodi,
avviene una rielaborazione bilaterale degli elementi culturali, nel secondo uno
dei sistemi soccombe, conservando solo alcuni degli elementi propri. Nel primo caso, abbiamo a che fare con un processo di acculturazione; nel secondo,
con una sorta di oppressione culturale. Va notato, tuttavia, che in ogni caso si
tratta di un processo di carattere selettivo che abbraccia soltanto certi elementi
culturali. L’acculturazione non può essere intesa come un processo unidirezio-
162
Grzegorz J. Kaczyński
nale, né lineare, e «abbraccia fenomeni che nascono quando due gruppi di uomini di diversa cultura si trovano in contatto diretto e continuo, prendendo in
considerazione i mutamenti che si verificano nei modelli culturali dell’una o
dell’altra cultura o di ambedue»1. Nel caso di scontro culturale i dominati subiscono la cultura dei dominatori anche se esiste sempre una reciprocità. In ogni
modo si crea una situazione sfavorevole a qualsiasi integrazione culturale e
mutamento sociale non-conflittuale; una situazione definita da Gregory Bateson
come scismogenesi 2.
Quasi di regola, e parliamo del periodo indicato poc’anzi, il contatto culturale aveva luogo nel contesto coloniale che è stato teorizzato da Georges Balandier3 (che del resto si serve di un termine già usato da O. Mannoni4 ) e proposto come categoria epistemologica in proposito. Secondo il teorema di Balandier la situazione coloniale costituisce una situazione profondamente determinata dalla dominazione di una minoranza estranea, diversa per razza e cultura, imposta ad una minoranza autoctona più povera in nome di una superiorità
di razza (o etnica) e culturale, intesa come dogma. In breve, si potrebbe affermare che la situazione coloniale era composta da un insieme di fenomeni e di
condizioni economiche, politiche, sociali e culturali che scaturivano dalla dominazione della società europea (colonizzante) sulla società extra-europea (colonizzata); tutto ciò sorretto dall’incrollabile convinzione di una superiorità europea per razza, cultura e civiltà.
L’impatto, ovvero lo scontro culturale, era, quindi, proprio di tale situazione con tutte le manifestazioni che essa generava e che sono scaturite sotto diversi tipi di movimenti di protesta, fra i quali i movimenti religiosi occupano
un posto di prima importanza in quanto la più diffusa socialmente e la più
profonda dal punto di vista culturale. Secondo Malinowski5, che si riferiva alla
sua esperienza di studio in Africa, il mutamento culturale determinato da fattori
esogeni scaturiti dal contatto culturale va visto nella sua globalità processuale
che comprende tre fasi: la fase della cultura tradizionale in contatto con la cultura europea, la fase della cultura europea in contatto con quella africana e la
fase del configurarsi di una nuova cultura, una cultura di contatto, un tertium
1 R. Redfield, R. Linton, M. J. Herskovits, Memorandum for the Study of Acculturation,
«American Anthropologist», 1936, vol. 38, pp. 149-152.
2 G. Bateson, Naven, Cambridge University Press, Cambridge 1936.
3 G. Balandier, Sociologie actuelle de l’Afrique Noire, PUF, Paris 1963, pp. 34-35. Cfr. altresì I. Wallerstein, ed., Social Change, The Colonial Situation, New York 1966.
4 O. Mannoni, Psychologie de la colonisation, Paris 1950.
5 B. Malinowski, Introductory Essay: The Anthropology of Changing African Culture,
in: Methods of Study of Culture Contact in Africa, Oxford University Press, London 1938, pp.
XIV-XVII.
Contatto culturale come trauma
163
quid, che non è una miscela, semplice e meccanica di elementi, ma un nuovo
fenomeno culturale distinto dal proprio determinismo. È un determinismo che,
pur configurandosi tramite compromessi e collaborazione, si manifesta soprattutto in modo conflittuale, sicché il contatto culturale in Africa ha la dinamica
dell’impatto condizionato sì dal contesto coloniale, ma in prima istanza dall’estrema divergenza delle culture in contatto e dalla totalità e rapidità del contatto
stesso. «In realtà» – nota Malinowski – «il contatto culturale in sé non porta al
cambiamento. Il cambiamento come regola significa disadattamento quanto
meno temporaneo. La vera natura del fenomeno consiste nelle interazioni di
due mondi culturali diversi, che non sono solo separati da un arco di tempo
evolutivo ampio, ma si trovano l’uno di fronte all’altro nell’abisso del pregiudizio razziale e della politica discriminatoria»6. In altri termini, il contatto culturale crea una tensione tra due culture strutturate diversamente per il fatto che
esse contengono diversi elementi contrastanti. Di conseguenza il sistema più
vulnerabile cede; il mutamento diventa decisamente conflittuale, deviante ed
aberrante. Tale processo rimane attivo anche dopo il mutamento della situazione socio-politica che faceva da contesto determinante, come il colonialismo nel
caso dell’Africa. In tal senso le affermazioni di Malinowski si sono rivelate
profetiche7, purtroppo per le culture native. Fino ad oggi il contatto culturale
iniziato nella situazione coloniale si rivela attivo; in esso credenze, valori e regole occidentali prendono il sopravvento, creando disagio alle culture autoctone. Al dopo-colonialismo doveva succedere la decolonizzazione. Per i suoi effetti, però, qualcuno la chiama la quarta invasione dell’Africa, dopo la schiavitù, il colonialismo e il neocolonialismo. Penso che sia una prospettiva che va
presa in considerazione anche quando si parla di globalizzazione.
Per essere più convincenti, vale la pena riportare qualche autorevole affermazione di Vittorio Lanternari in proposito. «Totale e frustrante s’è resa la delusione per una decolonizzazione apportatrice di ulteriore sottosviluppo, abbandono alla deriva, crescita a forbice dello sbilancio rispetto alle nazioni sviluppate. I modelli occidentali apparsi all’orizzonte, e fatti propri dalle élites locali,
restavano sostanzialmente nient’affatto fruibili per la maggioranza degli abitanti, per i quali peraltro si creava una nuova e deludente influenza d’attrazione
per quei nuovi modelli culturali, visti come esponenti e simboli d’una condizione mitizzata, quasi ‘paradisiaca’. D’altra parte s’è venuta creando una crescente
consapevolezza del declino delle tradizioni ancestrali, divenute nell’immaginaB. Malinowski, Introductory Essay: The Anthropology of Changing African Culture, cit.,
p. XIV.
7 Cfr. B. Malinowski, The Dynamics Cultural Change, Yale University Press, New Haven
1945.
6
164
Grzegorz J. Kaczyński
rio collettivo inadeguate e inefficaci a soccorrere rispetto ai bisogni nuovi, all’ormai affermato richiamo verso la ‘modernità’»8.
La condizione culturale, descritta da Lanternari, viene spesso indicata oggi
con il termine di scontro culturale. Sembra che G.H. Pitt-Rivers sia stato il primo autore ad usare il termine scontro culturale (clush of cultures)9. Le sue elaborazioni al riguardo partono da un presupposto ormai superato, vale a dire che
la diversificazione delle culture si basa sulla diversificazione psico-somatica
delle razze. La conflittualità del contatto culturale ha trovato diverse teorizzazioni, le più interessanti delle quali dal punto di vista euristico ritengo che siano quelle già citate, che sono formulate come quadro epistemologico dell’esplicazione dei movimenti religiosi10 nati in tale contesto. È da sottolineare il fatto
che tali proposte sono state avanzate, non solo nell’ambito strettamente antropologico, ma anche nella prospettiva delle altre scienze sociali in cui quella sociologica sembra più significativa11.
In altri termini, si può affermare che il comune interesse di studio verso lo
stesso fenomeno e cioè il contatto culturale ha fatto avvicinare l’antropologia e
V. Lanternari, Presentazione, in P. Schirripa, Profeti in città. Etnografia di quattro chiese indipendenti del Ghana, Editoriale Progetto 2000, Cosenza 1992, pp. 9-10.
19 G.H. Pitt-Rivers, The Clush of Cultures and the Contact of Races, Routledge, London
1927.
10 Cfr. V. Lanternari, Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei popoli oppressi, Editori
Riuniti, Milano 1960 (III ed. 2003); P. Worsley, La tromba suonerà, Einaudi, Torino 1977 (trad.
it. di The Trumpet Shall Sound: A Study of “Cargo” Cults in Melanesia, London 1957); J.S.
Slotkin, The Peyote Way, in: L.A. Williams, E. Vogt, ed., Reader in Comparative Religion: an
Anthropological Approach, Evanstone 1958; D. Aberle, A Note on Relative Deprivation Theory
as Applied to Millenarian and Other Movements, in L. Thrupp, ed., Millenial Dreams in Action.
Essays in Comparative Study, Mouton and Co., The Hague 1962, pp. 209-214; Idem, The Peyote
Religion among the Navaho, «Viking Fund Publication in Anthropology», vol. 42, New York
1966; F.W. Voget, The American Indian in transision: reformation and accomodation, «American Anthropologist», 1956, v. 58, n. 2, pp. 249-263; G.E. Simpson, The Ras Tafari movement in
Jamaica in its millenial aspect, in Sylvia Thrupp, ed, Millenial dreams in action. Essays in comparative study, The Hague 1962; A.F.C., Wallace, Revitalization Movements, «American Anthropologist», 1956, vol. 58, n. 2, pp. 264-281; R. Linton, Nativistic Movements, «American Anthropologist», 1943, vol. 46, pp. 230-240; J.M. van der Kroef, Culture contact and culture conflict in
Western New Gwinea, «Anthropological Quarterly», 1959, v. 32, n. 3; E. Willems, Dictionnaire
de sociologie, M. Rivère, Paris 1970; C.H. Madden, Clush of cultures: Management in the age of
changing values, National Planing Assembly, 1976; R. Bastide, Anthropologie appliquée, Payot,
Paris 1971; M.I. Pereira de Queiroz, Réforme et révolution dans les sociétés traditionnelles,
Anthropos, Paris 1968; D.B. Barrett, Schism and Renewal in Africa, Oxford University Press,
Nairobi, Addis Abebe, Lusaka 1968; E. Nowicka, Bunt i religia. Zderzenie kultur i ruchy społeczne, PWN, Warszawa 1922; B.R. Wilson, Magic and the millennium, Heinemann, London 1973.
11 Cfr. il mio volume Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa
(Bonanno ed., Acireale-Roma, I ed. 2005, II ed. 2006) da cui provengono certi frammenti attinenti alla questione del presente saggio.
18
Contatto culturale come trauma
165
la sociologia; anzi riavvicinare, se vogliamo far tornare alla memoria la storica
convivenza concettuale di queste discipline ai tempi di Tylor e Spencer, Frazer
e Durkheim, che si è dissolta con la dissoluzione del paradigma evoluzionistico. La sostanziale differenza che si era creata fra di esse stava nel tipo di società a cui si rivolgevano; l’antropologia alle società primitive, la sociologia invece alle società moderne. Inoltre, ciò che differenziava e differenzia queste
due discipline è il concetto di cultura: secondo il paradigma antropologico, la
cultura viene intesa come totalità dell’opera umana, quindi comprende anche la
società; secondo quello sociologico, cultura e società sono due realtà distinte.
Di conseguenza, le due discipline hanno elaborato adeguate metodologie di ricerca; metodologie distinte, ma non in maniera rigida. Infatti, Raymond Firth
definiva l’antropologia come un tipo di «micro-sociologia» che si serve di metodi olistici e comparativi12.
Oggi però queste distinzioni non sono del tutto plausibili, in quanto non esistono più società primitive, o forse meglio: le differenze culturali e sociali non
si possono classificare seguendo la tassonomia geo-politica. Secondo e Terzo
Mondo non esistono più, quindi neanche il Primo. Semmai esistono il Nord e il
Sud, il mondo dei ricchi e il mondo dei poveri, ovvero il mondo dei paesi industriali (o perfino post-industriali) e il mondo dei paesi in via di sviluppo. Quest’ultimo termine, considerando la preoccupante pauperizzazione dei paesi in
questione, sembra un beffa semantica motivata dalla cosiddetta correttezza politica. Ad ogni modo, il processo di modernizzazione, che oggi si effettua tramite la globalizzazione, le migrazioni di massa e la rivoluzione mediatica, abbraccia tutte le società, creando un mondo globale in cui realtà sociale e realtà
culturale vengono determinate da due tipi di fattori, moderni e tradizionali, di
provenienza endogena ed esogena, ovvero locale e globale, se vogliamo seguire
il linguaggio en vogue. In altre parole, tutte le società di oggi sono in effetti
niente altro che un complesso dinamico e dialettico di tali fattori. E questo, seguendo il nostro percorso indicato dal titolo, significa che il contatto culturale
costituisce un elemento intrinseco di ogni società. Esso non avviene più soltanto nei paesi extra-europei, non più nella situazione coloniale, ma si verifica anche in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, ecc., nei rapporti istituzionali e
quotidiani, soprattutto come effetto delle migrazioni. È un continuo contatto
culturale che, sì, porta certi vantaggi, ma anche, non di rado, che si trasforma in
scontro culturale. È una questione che, possiamo dire, è sfuggita dalle mani sia
agli antropologi, sia ai sociologi. Infatti, a questo discorso partecipano sempre
di più gli altri; a volte esso assume toni tragici, perfino apocalittici, esprimendo
12 R. Firth, Human Types, Nelson, London 1945, p. 201; Idem, Elements of Social Oragnization, Watts, London 1951, pp. 17-18.
166
Grzegorz J. Kaczyński
un’ipotesi secondo la quale il futuro del mondo intero dipende dal contatto culturale. Samuel Huntington, un politologo americano, è l’autore più noto da questo punta di vista. Con un suo articolo del 1993, pubblicato sulla rivista «Foreign Affairs», in cui esponeva la tesi secondo la quale era cominciata una nuova
fase della storia dove un ruolo fondamentale avrebbero avuto i conflitti culturali
e non più quelli economici o ideologici, egli scatenò una discussione inaudita.
Il posto della rivalità delle superpotenze è stato occupato dallo scontro delle civiltà – è questa la tesi di fondo che sviluppò nel famoso libro The Clush of Civilisations and the Remaking of the World [1996]. Huntington non è isolato nel
suo parere, è soltanto più famoso. Lui stesso cerca di farlo dimostrare riportando citazioni di qualche personaggio di rilievo; fra queste citazioni, quella di
Jacque Delors: «La causa dei conflitti futuri saranno piuttosto i fattori di carattere culturale che economici o ideologici»13. In definitiva, di fronte a questo ed
altri casi, la tradizionale e rigida divisione fra antropologia e sociologia non ha
più ragione d’esistere in tale realtà; il loro riavvicinamento in quanto contestuale è necessario, senza dover perdere la propria identità disciplinare.
Ma per la verità, una simile idea non è del tutto nuova; basti ricordare il
Saggio sul dono (Essai sur le don) scritto da Marcel Mauss nel 1924, che si è
ispirato all’opera di Malinowski Argonauts of the Western Pacific (1922), saggio assai lodato da tutti gli antropologi; basta rammentare un’iniziativa di Parsons e Kroeber del 1958 di formulare un sorta di manifesto socio-antropologico
che è stato publicato con il titolo The Concepts of Culture and of Social System
(«American Sociological Review»). Anni prima lo stesso Parsons disse, non
senza ironia: «Nella teoria antropologica non esiste qualcosa che si possa chiamare un comune accordo in questione della definzione del termine cultura»14.
Se Alfred Kroeber e Clyde Klukhohn hanno pubblicato l’ormai famoso saggio
Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions 15, la loro iniziativa doveva essere una risposta anche alla provocazione di Parsons.
È il momento opportuno per evocare un volume di Florian Znaniecki pubblicato nel 1963 con un titolo, Cultural Science. Their Origin and Devolopment
(University of Illinois Press, Urbana), che chiaramente si iscrive in questo di13 J. Delors, Questions Concerning European Security, discorso pronunciato all’Istituto Internazionale degli Studi Strategici a Bruxelles il 10 settembre 1993; cit. da S.P. Huntington, Lo
scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano 1997, p. 42 (ed. orig. The Clush of Civilisations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, New York 1996).
14 Cit. da A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, pp. 46-47, trad. pol. di Culture. The Anthropologists’ Account, Harvard University Press, 1999.
15 A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions,
Harvard University Press, Cambridge 1952.
Contatto culturale come trauma
167
scorso. Una volta la cultura era per gli antropologi un termine che distingueva
il loro mestiere, ma adesso, possiamo dire, lo stesso termine è diventato un filo
integrante di carattere interdisciplinare.
Ebbene, Vittorio Lanternari affronta tale questione in modo esplicito nella
Prefazione alla terza edizione dell’ormai classica opera Movimenti religiosi di
libertà e salvezza (2003). «I numerosi movimenti religiosi africani d’epoca postcoloniale» – egli scrive – «pongono certe subculture – per esempio quella tribale e rurale – in contrapposizione con altre – per esempio quella urbana borghese – entrambe provenienti da una cultura-madre unitaria. Per lo stesso motivo l’approccio antropologico sembra sempre meno separabile da quello sociologico, l’uno e l’altro presentandosi come complementari e reciprocamente utili
al fine d’intendere in una luce più ampia e unitaria il significato, la portata e la
funzione dei movimenti social-religiosi, sia quelli delle società semplici sia
quelli delle società complesse. Tanto più che, nel contesto della comparazione
incoraggiata e perseguita dagli studi odierni, sia gli uni che gli altri sono visti
come risposte a delle situazioni di crisi, squilibrio, anomia, e come vie attraverso le quali i gruppi e le società in crisi recuperano la propria autoconsapevolezza e autoidentità comunitaria»16.
È un’eco di ciò che aveva scritto prima in un altro volume: «Il caso dei movimenti social-religiosi, e del resto lo studio dei fenomeni di contatto culturale
in genere, forse come nessun altro caso, mostrano che solo la fusione di un’analisi volta alla genesi, alle trasformazioni, agli sviluppi (analisi ‘storica’ in
senso tradizionale) con l’analisi – d’altro lato – funzionale e comparativa (cioè,
in senso tradizionale, ‘sociologica’ e ‘antropologica’) può condurre ad una conoscenza relativamente soddisfacente degli aspetti multiformi e complessi di
questi fenomeni sociali»17. Tuttavia, la voce di Lanternari non era solitaria; ad
esempio, alla sociologia antropologica come scienza comparativa e storica ha
dedicato Peter Worsley uno dei paragrafi dell’Appendice del suo libro La tromba suonerà 18. Qualche sua osservazione in proposito vale d’essere ricordata per
completare il nostro percorso.
«I tentativi di definire antropologia» – egli scrive – «soltanto lo studio della
società primitiva oppure delle società ‘non-letterate’ non hanno avuto successo,
dal momento che i grandi regni dell’Africa occidentale e le antiche civiltà
orientali sono stati per lungo tempo oggetto degli studi antropologici, per quan-
16
V. Lanternari, Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei popoli oppressi, cit. (2003),
p. 14.
17 V. Lanternari, Occidente e Terzo mondo. Incontri di civiltà e religioni differenti, Dedalo
libri, Bari 1972. p. 422.
18 P. Worsley, La tromba suonerà, cit., p. 328.
168
Grzegorz J. Kaczyński
to non siano né ‘primitivi’, né ‘non-storici’, né siano sorti in epoca ‘pre-letteraria’, e neppure siano ciò che indicano gli altri epiteti coniati nel corso dei vari
tentativi, senza successo, di evitare di ricorrere ai concetti dell’evoluzione.
Ma dopo tutto, è principalmente negli ultimi anni (gli anni Cinquanta –
GJK) che gli antropologi si sono occupati in misura notevole delle società più
complesse e si sono persino volti a studiare, servendosi di metodi antropologici, le loro proprie società. Ed è una gran verità che l’antropologia ha portato allo studio non tanto dei popoli arretrati e primitivi, quanto piuttosto dei popoli
coloniali»19.
Infatti, l’antropologia, soprattutto essa, è stata in seguito indicata, dagli anni
Sessanta in poi, come una delle «scienze coloniali» che erano caratterizzate dall’intrinseca dicotomia nel trattare diversi popoli, come Nostri e come Altri. Gli
altri erano considerati selvaggi, violenti, superstiziosi, irrazionali ecc. Questo tipo di approccio, denominato orientalismo (cfr. l’opera di Edward Said, Orientalism, del 1978), era una sorta di proiezione occidentale sull’Oriente con il
chiaro intento di subordinarlo e di giustificare il colonialismo. La generazione
degli antropologi di quel periodo riteneva che «le scienze sociali erano strumenti di Wall Street e del Pentagono» e che «l’antropologia è rimasta al servizio del
colonialismo»20. In tal modo è stata anche essa stessa coinvolta nella sindrome
conflittuale del contatto culturale fra l’Occidente e (allora) il Terzo Mondo.
Anche questa esperienza postcoloniale, assieme a quella attuale legata alla
globalizzazione, ha fatto avvicinare le due scienze, soprattutto al livello dell’oggetto della ricerca. Il contatto culturale come questione di studio ha fatto da
contatto fra l’ambiente antropologico e quello sociologico in cui tutti parlano di
multicultura, intercultura e transcultura, di clush, shock e stress culturali e così
via21. In altri termini, possiamo dire che oggi la cerchia socio-antropologica 22 è
assai ricca.
***
In questo campo epistemologico si iscrive perfettamente il concetto di trauma culturale formulato da Piotr Sztompka23. È un concetto per eccellenza soIbidem, pp. 330-331.
A. Kuper, Kultura. Model antropologiczny, cit., p. 174.
21 Cfr. G. J. Kaczyński, Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa,
cit., pp. 38-44, 50-83.
22 Cfr. lavori di M. Augé, V. Turner, H. Turner, R. Horton, J. Fernandez, J. Fabian, W. De
Craemer, M. Daneel, M. West, J. Comaroff, J.-P. Dozon, B. Wilson, A. Zajączkowski, P. Schirripa.
23 P. Sztompka, Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, «Przegląd Socjologiczny», 2000, v. XLIX/1, pp. 9-29; Idem, Trauma wielkiej zmiany: społeczne i kulturowe koszty
transformacji, Wydawnictwo Instytutu Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000; Idem,
Socjologia, Znak, Kraków 2002, pp. 454-472.
19
20
Contatto culturale come trauma
169
cio-antropologico, formulato da un sociologo ma nel quale c’è molta antropologia. Sztompka si serve del termine precedentemente proposto da Neil Smelser24, con cui aveva collaborato ad un progetto di ricerca all’università di
Stanford. Egli parte dal presupposto che non tutte le metamorfosi sociali portano ad un miglioramento; alcune possono sfociare in crisi. Con tutto ciò ogni
metamorfosi può avere un bilancio ambivalente, cioè complessivamente negativo e quindi traumatico. Sztompka introduce così il concetto di discorso del
trauma, come terzo approccio al mutamento sociale accanto a quello di discorso del progresso e discorso della crisi. Causa del trauma possono essere la violenza, l’ampiezza e la profondità del mutamento, specie quando toccano la sfera dei valori, delle istituzioni, delle idee e delle regole. Si tratta di mutamenti
traumatici che influenzano negativamente il gruppo sociale, instaurando disorganizzazione e squilibri di sorta. Risulta evidente che per Sztompka il più sensibile tessuto sociale è la cultura – l’universo di valori, norme, regole, modelli,
simboli, significati – perché fortemente inerziale, continua, ancorata alla tradizione o alla memoria collettiva, ai rituali, alle pratiche, alle abitudini e ai costumi. La cultura è il dominio della codificazione della continuità e dell’identità
sociale. A livello di personalità individuale, le più sensibili sono le corde che
toccano l’intimo legame con la propria cultura. In altre parole, il trauma culturale, secondo Sztompka, consiste nelle situazioni di mutamento sociale che
coinvolgono la cultura, quindi le identità culturali collettive ed individuali.
Il ventesimo secolo, secondo l’autore, può essere definito come il secolo
dei grandi mutamenti, che, oltre ai mutamenti moderni – l’industrializzazione,
l’urbanizzazione, i cambiamenti politici, l’inquinamento ambientale, ecc. –, sono soprattutto quelle importanti trasformazioni che hanno intaccato profondamente il tessuto culturale. Trasformazioni spesso a carattere di scontro, scaturite dal pluralismo culturale e dalla mescolanza di culture dovuta alle migrazioni.
Inoltre si sono verificati significativi mutamenti interpretativi della realtà sia
storica che contemporanea, nuove definizioni (sotto forma di una riscrittura
della storia nuova di avvenimenti noti sulla base di nuovi paradigmi scientifici
o della formazione di opinioni basate su stereotipi, miti, pettegolezzi, mode,
ecc.) che, secondo la definizione situazionale di Thomas, hanno avuto una reale
influenza traumatica nonostante le irrealistiche ragioni. L’influenza del trauma
culturale può manifestarsi a tre livelli: individuale, collettivo e storico. Nel primo caso, i suoi effetti possono manifestarsi sotto forma di disturbo dell’identità
individuale; nel secondo, della cultura collettiva e di perdita dell’identità di
gruppo; nel terzo, del totale mutamento dell’identità sociale dal significato per24 N. Smelser, Il comportamento collettivo, Vallecchi, Firenze 1968 (ed. ingl.: Theory of
collective behavior, New York 1963).
170
Grzegorz J. Kaczyński
manente, storico appunto. Se la sequenza traumatica si sviluppa, sopraggiunge
la disintegrazione della cultura dominante e ciò si manifesta sul piano sociale
(istituzionale) come disorganizzazione, caos (anomia), e sul piano individuale
come disorientamento culturale, che si traduce in un sentimento di «incompetenza di civiltà», la perdita di certi modelli di comportamento. Se una data società non dispone di efficaci meccanismi di difesa che attutiscono il trauma, essa diventa realtà. I sintomi del trauma culturale possono manifestarsi sotto forma di apatia individuale o sociale, aggressività, nostalgia del passato, paura,
sottomissione ai miti o ai pettegolezzi, in panico o anche in tentativi di difesa
collettiva. Secondo l’autore, il movimento sociale è una strategia per affrontare
il trauma e può manifestarsi in forma passiva o attiva, sotto la forma di attiva
contestazione o pragmatica accettazione, se vogliamo seguire la terminologia
di Anthony Giddens25.
Il suo scopo primario è effettuare una reinterpretazione della realtà per fornire un nuovo modello di percezione degli stati e delle situazioni traumageniche. Ciò accade con l’ausilio di nuovi e disponibili mezzi nell’ambito della cultura, della struttura sociale, delle istituzioni e dell’economia. Se le strategie sono sufficientemente efficaci, si può giungere alla risoluzione della sequenza
traumatica. La soluzione del trauma si traduce nella formazione di un sistema
uniforme e compatto di valori, norme, regole, simboli, credenze, e quindi di
una nuova cultura e della sua decodificazione in una nuova tradizione da trasmettere alla generazione seguente. A livello individuale si traduce nella diffusione di una nuova competenza culturale, ossia conoscenza, accettazione e applicazione automatica delle regole e dei modelli della nuova cultura. Il consolidamento della cultura conclude la sequenza traumatica. In tal modo il trauma
diventa un elemento importante della morfogenesi culturale 26, una trasformazione creativa27. Ma il trauma può continuare a lungo e l’effetto finale del trauma può significare anche la disgregazione culturale.
***
Ritengo che il valore epistemologico del concetto di trauma culturale, oltre
al valore euristico intrinseco, consiste nel carattere generale e inclusivo che
permette di concretizzarlo inserendo certe variabili attinenti al particolare
obiettivo di ricerca, ad esempio inserendolo nel quadro epistemologico dei movimenti religiosi in Africa, come abbiamo fatto in un altro luogo28. Questo vuol
A. Giddens, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge 1990.
Il termine morfogenesi uso nel senso originalmente formulato da Margaret Archer.
27 Cfr. P. Sztompka, Society in Action: The Theory of Social Becoming, Polity Press, Cambridge 1991.
28 G. J. Kaczyński, Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa, cit.
25
26
Contatto culturale come trauma
171
dire focalizzare la sua ultilità cognitiva nell’esplicazione del legame che si crea
fra idee religiose e protesta sociale, di cui i movimenti in questione sono
espressione per eccellenza. Sappiamo, però, che il campo religioso in proposito, se vogliamo servirci del concetto di Bourdieu29, ha molte entrate, ma è altrettanto vero che l’entrata religiosa è epistemologicamente più plausibile. Per
questo considero che fra i fattori della morfogenesi del trauma culturale quello
che è determinante nella comparsa della protesta sociale (movimento) di carattere religioso debba essere ricercato soprattutto nei valori religiosi, o forse meglio, sacrali, intesi nel senso non tanto durkheimiano quanto in quello fenomenologico (G. Van der Leeuw, M. Eliade) con innegabili debiti alla teoria di
Rudolph Otto. Riformulando in questi termini i presupposti evidenziati da
Sztompka, possiamo affermare che nella sequenza e nei sintomi del trauma culturale che si rivelano religiosi, il ruolo determinante spetta ad un insieme di fattori che potremmo definire come sindrome sacrale del trauma e che in fondo
costituisce un trauma sacrale ovvero un tipo sacrale di trauma culturale. Il
trauma sacrale è quindi legato ad una metamorfosi sociale di crisi che investe
l’ordine sacrale, cioè le regole sacrali che stanno alla base di una cultura. Più
un ordine sociale è legittimato sacralmente, più è probabile che qualsiasi fattore
che minacci la sua stabilità venga interpretato in termini religiosi e, in caso di
metamorfosi, in termini di trauma sacrale; più un’ontologia sociale è plausibile
sacralmente, più è probabile che i pericoli che deve affrontare vengano formulati in linguaggio sacrale.
Il trauma sacrale trova una configurazione congeniale soprattutto nel contesto della società sacrale 30 o in quella del fato, secondo Peter Berger, in cui,
in virtù dell’unico mondo sacrale, «le istituzioni e le identità tradizionali sono date per scontate, certe e oggettive quasi come i fatti della natura»31. In tale
tipo di società, che di solito viene indicata come primitiva, tradizionale, premoderna o perfino teocratica, la religione costituisce il più importante universo
simbolico, quindi il mezzo più importante di legittimazione e di conseguenza
un’enorme forza nella costruzione sociale della realtà. Lo è perché espressione per eccellenza del cosmo sacro che è contrapposto al caos. In tal modo la
religione forma una sorta di cupola protettiva della realtà costruita e cioè una
Sacra Volta, come afferma Berger. Il sacro diventa realissimum. Fornisce il
senso delle esperienze della vita collocandole nell’ordine dei significati ultimi
29 P. Bourdieu, Gènése et structure du champ religieux, «Revue Française de Sociologie»,
1971, 12, pp. 295-334.
30 H.P. Becker, Current Sacred/Secular Theory and Its Development, in H. P. Becker and
A. Boskoff, Modern Sociological Theory in Continuity and Change, Dryden Press, New York
1957, cap. VI, pp. 133-185.
31 P.L. Berger, L’imperativo eretico, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1987, p. 51.
172
Grzegorz J. Kaczyński
e, quindi, assume una caratteristica antropologica come un riferimento indipendente al bisogno umano di trovare il senso della propria esistenza. Fornisce anche una teodicea ovvero una spiegazione dei fenomeni anomici (dolore, sofferenza, morte ecc.). In tale contesto, possiamo ripetere, con Peter Berger32, «andare contro l’ordine della società giustificato dalla religione, significa fare un
patto con le potenze delle tenebre» e inoltre possiamo affermare che anche tutte
le insidie contro l’ordine stabilito vengono intese come espressione di tali potenze, che si traducono in trauma sacrale manifestato tramite i movimenti collettivi.
Per esemplificare tale tipo di società ci serviamo delle affermazioni di John
Mbiti33, teologo keniano, contenute nel suo «magistrale libro sulle religioni
africane»34, argomento che occupa un posto particolare nel mio interesse di studio. «È noto a tutti che gli africani sono profondamente religiosi: ogni popolo
dell’Africa ha il proprio sistema religioso con un insieme di credenze e pratiche. La religione permea talmente ogni settore della vita che non è facile né
sempre possibile scinderla dal resto. […] La religione è l’elemento più forte del
tessuto sociale tradizionale ed esercita probabilmente la maggiore influenza sul
pensiero e sulla vita delle popolazioni del continente. […] Poiché le religioni
tradizionali permeano tutti i settori della vita, non esiste distinzione formale tra
sacro e profano, religiosità e mancanza di religiosità, sfera materiale e spirituale della vita. Ovunque si trovi un africano, là è la sua religione: la porta con sé
nei campi dove semina o raccoglie i prodotti della terra; essa lo accompagna a
una festa o a una cerimonia funebre; se studia, è con lui durante gli esami a
scuola o all’università; se è un politico, lo accompagna al parlamento. […] Con
i cambiamenti attuali, non è possibile che queste religioni tradizionali rimangano intatte, ma non sono nemmeno estinte. In periodi di crisi ritornano spesso in
superficie, o le persone vi si rivolgono in segreto.
Le religioni tradizionali non sono principalmente per l’individuo, ma per la
comunità di cui egli è parte. Capitoli interi delle religioni africane vengono
scritti nella vita della comunità, ovunque e quotidianamente, e nella società tradizionale non esistono persone irreligiose. Far parte del genere umano significa
appartenere all’intera comunità e, perché sia così, bisogna partecipare alle credenze, cerimonie, rituali e festività di quella comunità. Una persona non può
distaccarsi dalla religione del suo gruppo perché altrimenti spezzerebbe ogni
32 P.L. Berger, The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, Garde City 1967.
33 J.S. Mbiti, Oltre la magia, SEI, Torino 1992 (versione originale: African Religions and
Philosophy, Penguin, London 1969).
34 È un’espressione di Antonio Leva (Un libro magistrale sulle religioni africane, «Africa»,
1970, 2, pp. 213-218).
Contatto culturale come trauma
173
legame con le sue radici, le sue fondamenta, il suo contesto di sicurezza, la sua
parantela e l’intero gruppo di coloro che gli permettono di rendersi conto della
propria esistenza. Essere privi di uno di questi elementi collettivi della vita significa l’esclusione totale. Dunque, essere privi di religione è come una sorta di
autoscomunica dall’intera vita della società, e i popoli africani non sono capaci
di esistere senza religione.
Una delle cause di gravi conflitti per gli africani esposti alle moderne trasformazioni è il processo sempre più in aumento (attraverso l’istruzione, l’urbanizzazione e l’industrializzazione) per cui gli individui si distaccano dal loro ambiente tradizionale. Ciò li lascia in un vuoto privo di una solida base religiosa»35.
Molte società extra-europee si presentano come una concreta espressione
del tipo di società delineato poc’anzi. La trasformazione in atto, condizionata
dal contatto culturale, che si trasforma in uno scontro culturale, e dalla modernizzazione imposta politicamente, e in alcuni casi militarmente, investe profondamente il tessuto valoriale della cultura, quindi le identità collettive e individuali, che in fondo sono legittimate sacralmente. Nei termini epistemologici
proposti da Sztompka, possiamo quindi affermare che si viene a creare una situazione di trauma culturale che contiene tutti i requisiti fenomenologici per essere definita come trauma sacrale; precisamente, le modalità locali di trauma
sacrale.
Proprio in virtù di queste considerazioni epistemologiche abbiamo formulato l’afro-modello esplicativo dei movimenti religiosi in Africa nati nel contatto
fra la cultura europea e quella africana. Precisamente si tratta dei movimenti di
protesta sociali nel contesto di contatto del cristianesimo con le religioni tradizionali africane, quindi di carattere sincretico e per questo chiamati come afrocristiani o post-cristiani 36. La sequenza ermeneutica del modello l’abbiamo basata sull’africanizzazione delle variabili generali contenute nel teorema di trauma culturale e, di seguito, di trauma sacrale. Questo ci ha portati alla considerazione che i movimenti religiosi africani (precisamente nel Congo e nei paesi limitrofi) costituiscono un sintomo del trauma sacrale in cui si trova la società
tradizionale africana (le società etniche) per causa dell’urto culturale e della
modernizzazione. Ciò, in termini socio-antropologici, significa che c’è in atto
un processo in cui la visione tradizionale del mondo costruita in riferimento all’universo sacro perde la propria plausibilità e quindi ovvietà, creando una situazione di disorganizzazione e disorientamento culturale, uno stato di confu35
36
p. 8.
J.S. Mbiti, Oltre la magia, cit., pp. 1-3.
G. J. Kaczyński, Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti religiosi in Africa, cit.,
174
Grzegorz J. Kaczyński
sione identitaria e di dissonanza cognitiva. La religiosità dei movimenti corrisponde e risponde alla sacralità del cosmo tradizionale; è una proposta di riproduzione e ricostruzione del senso sacrale in un ambiente in cui il sacro è dominante nelle definizioni della realtà. Per questo le proposte di riordinamento del
mondo espresso tramite il linguaggio sacrale non devono essere intese come un
camuffamento linguistico, verbale; non è una falsificazione della realtà, ma una
rappresentazione simbolica della realtà. È il più plausibile in un cosmo sacralizzato come quello africano. Pertanto non è una sorta di fuga dal mondo, ma
un tentativo di comprenderlo e riordinarlo37; non è un modo simbolico di falsare le proprie condizioni esistenziali, come vorrebbe la dialettica marxiana, ma
la sua costruzione critica, che a livello sociale non è meno efficace di quella razionale, perfino scientifica, delle società moderne in quanto è adeguata al vigente sistema semantico. Il trauma sacrale deve necessariamente esprimersi in
linguaggio sacrale, il quale va inteso come strumento sia della comprensione
che dela contestazione e costruzione del mondo38.
«I neri non avrebbero potuto inventare un proprio linguaggio liberatorio
che descrivesse la loro esperienza, fintanto che avessero continuato a dipendere da quello dei bianchi e dai concetti da loro usati per descrivere l’esperienza
dei neri. Linguaggio e concetti che raccontavano la realtà attraverso il filtro
delle esperienze dei bianchi. Ma se i neri usano il proprio linguaggio e i propri
concetti per descrivere la propria condizione, se creano una ‘teologia nera’,
possono essere accusati di separarsi dal resto dell’umanità. Questo è il rovescio
della medaglia. Infatti, se i neri si adoperano per non rinunciare al loro senso
critico, pur continuando a usare il linguaggio dei bianchi per risolvere i loro
problemi esistenziali, potrebbero sentirsi abbandonati»39. Anche se l’autore di
queste considerazioni, Zolle Mbali, si rivolge alle cosiddette chiese indipen-
37 J. Comaroff, J. Comaroff (ed.), Modernità and its malcontents. Ritual and power in postcolonial Africa, The University of Chicago Press, Chicago-London 1993.
38 È un problema ben presente nella riflessione antropologica, anche quella italiana. «Che il
linguaggio religioso» – osserva Pino Schirripa – «sia stato, nei paesi colonizzati così come anche
spesso nella storia del nostro Occidente, un mezzo attraverso cui riflettere e mettere in discussione l’ordine sociale prospettando un mondo diverso, è sicuramente un dato acquisito oramai da
tempo nella tradizione antropologica italiana. Anche recentemente le antropologie africaniste
hanno lavorato su questi temi, apportando contributi innovativi e di indubbio valore, mostrando
come i simboli cristiani non siano stati solo una forma forte della penetrazione coloniale, ma anche un mezzo di cui i popoli assoggettati si sono appropriati per una loro propria produzione di
discorsi e di rituali di resistenza» (Salute, salvezza, resistenza. Per una lettura politica die rituali
di guarigione nel Ghana contemporaneo, «Religione e Società», 2004, anno XIX, gennaio-aprile, p. 58).
39 Z. Mbali, The Churches and racism: a black south-african perspectives, SCM Press Ltd.,
London 1987, pp. 4-5.
Contatto culturale come trauma
175
denti del Sud Africa, in sostanza esprime ciò che è comune a tutti i movimenti
afro-cristiani.
E la ricchezza del nuovo linguaggio basato sulla lettura africana della Bibbia, dobbiamo notare, è particolarmente innovativa e suggestiva. Spesso non si
tratta tanto di transduzione 40 africana del testo, quanto della sua struttura, esponendo quei frammenti biblici i quali possono riferire un significato alla condizione africana. Per tale motivo, frammenti come il Discorso della montagna o
Magnificat si prestano bene a tale operazione; come pure un frammento del profeta Isaia (62, 1-2) qui citato, in cui il nome «Sion» è stato sostituito (tradotto)
da «poveri» (in prima riga) e «Gerusalemme» da «piccoli» (in seconda riga):
Per amore dei poveri non tacerò,
per la causa dei piccoli e degli oppressi
non mi darò pace,
finché non sorga come stella
la loro giustizia, e la loro liberazione
non risplenda come lampada.
In altri termini, possiamo affermare che ogni movimento religioso in questione è un tentativo collettivo di riorganizzazione e di riorientamento culturale
e sociale in un passaggio in atto da una società del fato ad una società della
scelta, diremmo seguendo Berger41, in cui la prima, in ogni caso, rimane scossa
violentemente e frantumata nelle sue basi valoriali. La dimensione del consenso sociale ottenuta da un movimento religioso circonscrive la valenza della sua
proposta sia in termini di influenza che di legittimità che, in certi casi, si traduce nella sua istituzionalizzazione, che può essere intesa come partecipazione alla rimozione del trauma e quindi nel consolidamento della propria cultura. È
una proposta di salvezza globale alla globale crisi di comunità, d’identità culturale e dei modelli cognitivi tradizionali, crisi sentita in modo profondamente
conflittuale.
Come vediamo, la nascita dei movimenti religiosi dell’Africa non si discosta, in fondo, dal modello esplicativo generale indicato dal teorema del trauma
culturale; è una conseguenza del discorso del trauma. Invece il loro carattere
religioso può essere spiegato nei termini del nostro afro-modello ovvero del
trauma sacrale e che è determinato da tratti particolari, e cioè sacrali, della cultura africana tradizionale. Inoltre, suppongo che il fatto che questi movimenti
sono stati spesso uno strumento della protesta attiva (ribellione) debba essere
40 Cfr. G. Bettetini, Capirsi e sentirsi uguali. Sguardo sociosemiotico al multiculturalismo,
Bompiani, Milano 2003, p. 52 sgg.
41 P.L. Berger, L’imperativo eretico, cit. pp. 49-52.
176
Grzegorz J. Kaczyński
spiegato con un insieme di fattori interni e contestuali, perché le risposte religiose, di per sé, non sono mai violente ed appartengono alla contestazione passiva; è cioè cognitiva, in quanto proposta di reinterpretazione del mondo, e semantica, in quanto proposta di ridefinizione dei significati. Esse entrano nel
percorso attivo, spesso violento, solo quando vengono spinte da elementi interni e cioè dalla propria predisposizione culturale al comportamento belligerante
o/e da elementi contestuali e cioè dalla violenza da parte di chi si sente o si impone come detentore del controllo sociale, politico e così via, appartenente o
non alla stessa società. In linea generale, quindi, possiamo affermare che la
morfologia culturale del contesto dei movimenti religiosi in Africa ci induce all’esclusione dei fattori di natura interna; mentre la configurazione del contatto
culturale nella situazione coloniale e post-coloniale fornisce i fattori contestuali. Ad ogni modo, così come esiste un’indefinibile soglia il cui superamento fa
scattare il trauma culturale (sacrale), esiste anche un’altra imprecisabile soglia
il cui superamento determina il passaggio di un movimento religioso dalla protesta passiva a quella attiva, alla ribellione. Ma anche se dietro queste reazioni
e trasformazioni si cela sempre un uomo concreto, ovvero una cultura, delle
credenze religiose, un gruppo sociale in un dato momento e luogo, sembra che
le origini e la dinamica di ogni protesta sociale espressa in forma religiosa abbiano sempre le proprie radici nel trauma sacrale; a maggior ragione in un contesto di scontro culturale. «Le sette religiose islamiche» – annotava Edward
Evans-Pritchard mezzo secolo fa nel noto volume sui Senussi di Cirenaica –
«sono state comunemente espressione di un sentimento di esclusivismo sociale
o culturale […], furono tutte reazioni alla dominazione straniera oltre che rivolte contro l’ortodossia. La deviazione religiosa era espressione del forte desiderio di un popolo di vivere secondo la propria tradizione e le proprie istituzioni»42. Parole quanto mai attuali.
42 E.E. Evans-Pritchard, Colonialismo e resistenza religiosa nell’Africa settentrionale. I Senussi di Cirenaica, Edizioni del Prisma, Catania 1979, p. 13-14 (trad. it. di The Sanussi of Cyrenaica, Oxford University Press 1949).