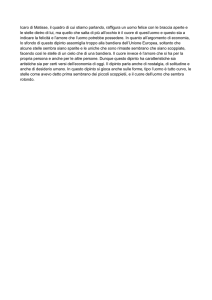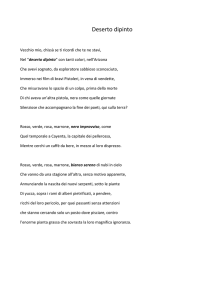Ventiquattro dipinti di
Caravaggio
Il Caravaggio in un ritratto a matita opera di Ottavio Leoni (1621)
a cura di Valerio
Varriale
Ragazzo con canestro di frutta
Il Ragazzo con canestro di frutta, è databile al
periodo1593-4 ed è conservato presso la Galleria Borghese.
Si tratta di una delle prime opere romane, realizzata quasi
sicuramente dopo il cosiddetto Bacchino malato anch’esso
presso la Borghese. Ambedue i dipinti, infatti, facevano
originariamente parte della collezione di Giuseppe Cesari
detto il Cavalier D’Arpino, uno dei protagonisti della
pittura romana dell’epoca presso il quale il giovane pittore
lombardo aveva lavorato per qualche mese producendo
soprattutto nature morte per i collezionisti. Nel 1607, con il
pretesto di un porto d’armi abusivo, i dipinti vennero
sequestrati al pittore romano per ordine di papa Paolo v
Borghese, e subito incamerati nella collezione del nipote,
l’appassionato collezionista d’arte cardinale Scipione
Borghese. L'immagine è quella di un giovane venditore, un fruttaiolo dai riccioli scuri e dallo
sguardo languido, che si protende dal fondo di una parete scura e ci offre il suo canestro di frutta.
Proprio quest'ultimo può essere considerato il vero centro della rappresentazione: la resa del rustico
cesto di vimini, la brillantezza e la verità dei frutti fanno riferimento alla tradizione fiamminga, ma
anche a quella leonardesca e lombarda, per la minuziosa attenzione ai particolari della realtà. In
mezzo a questa esplosione di vitalità, rappresentata dai frutti e dalla bellezza del giovane venditore,
l’appassire di alcune delle foglie sembra ricondurre anche questa rappresentazione al tema cristiano
della vanitas: la caducità, la temporaneità della vita e di tutte le cose secondo la lettura che qualche
decennio fa ne diede il critico Maurizio Calvesi ma anche secondo la valutazione di un
contemporaneo del Caravaggio, il cardinale Ottavio Parravicino, il quale ritrovava nelle opere del
lombardo un significato “in quel mezzo tra il devoto e il profano”. Il modello è forse Mario Minniti,
il giovane pittore siciliano conosciuto dal Caravaggio all’inizio delle sue vicende romane. A
dispetto della tradizione che voleva il Caravaggio abituato a creare le sue figure direttamente sulla
tela, in questo caso, secondo gli studi più recenti, abbiamo tracce consistenti di disegno sotto la
pittura. Nel venditore di frutta alcuni hanno voluto vedere una rappresentazione della figura dello
Sposo del biblico Cantico dei Cantici, altri quella dell’antico Vertumno, arcaica divinità romana
collegata al ciclo della vegetazione.
A sinistra, Ritratto del cardinale Scipione Borghese di Gian Lorenzo Bernini
A destra, Ritratto di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino, di Ottavio Leoni
La venditrice di frutta (1580), conservata presso la Pinacoteca di Brera a Milano, opera del
cremonese Vincenzo Campi, ben rappresenta l’attenzione dei pittori lombardi verso i dati della realta’
Venditrice di pollame, frutta e verdure (1564) opera del pittore fiammingo Joachim Beuckelaer
Canestra di frutta
Lo sviluppo successivo della ricerca del
pittore nell’ambito dlla natura morta è
costituito dalla famosissima Canestra di
frutta, detta anche La Fiscella (1595-96 ca).
L’opera regalata dal cardinale Francesco
Maria Bourbon Del Monte al cardinale
Federico Borromeo, che il Manzoni avrebbe
fatto protagonista dei suoi Promessi Sposi,
venne ceduta nel 1607 all’Accademia
Ambrosiana ed è tuttora conservata nella
Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Si tratta
della prima vera natura morta della pittura
italiana, una semplice cesta di vimini
ricolma di frutta appoggiata su un tavolo e
non collegata ad alcuna figura come invece
accadeva ancora per l’opera della Galleria Borghese.
È da sottolineare l’eccezionalità della cosa nell’ambiente culturale italiano che, a differenza di
quello fiammingo, presupponeva la superiorità a priori della pittura di figura, in specie della
cosiddetta pittura di storia (delle opere, cioè, dedicate alle storie di santi e monarchi) rispetto alle
nature morte. Nella Lettera sulla pittura a Teodoro Amideni scritta nel periodo 1620-30 al
fiammingo Dirk van Ameyden, il marchese Vincenzo Giustiniani riportò che il Caravaggio ebbe a
dire « che tanta manifattura gli era a fare un quadro buono di fiori come di figure». Il cardinale
Borromeo, grande intenditore di libri e d’arte, apprezzò grandemente quest’opera e scrisse che
«Questa canestra la fece in Roma Michelangelo da Caravaggio e avrei voluto accompagnarla con
un’altra simile, ma poiché nessuna raggiungeva la bellezza di questa e la sua incomparabile
eccellenza, rimase sola». Sullo sfondo di una parete chiara ed astratta il pittore ci presenta
un’immagine di raro equilibrio e si diffonde nell’analisi di ogni dettaglio degli elementi che
costituiscono questa rappresentazione.
L’effetto di profondità dell'immagine è accentuato dal lieve sporgere del canestro al di fuori del
tavolo. Si tratta del punto più alto raggiunto dal Caravaggio durante la sua prima fase romana: il
congiungimento della tradizione lombarda, leonardesca e fiamminga del dipingere dal vivo e dello
studio della realtà, con lo studio della classicità, sia di quella ricreata da discepoli di Raffaello come
Giovanni
da
Udine
nelle
decorazioni naturalistiche della
loggia di Psiche alla Farnesina, sia
di quella antica esemplata dai resti
degli antichi mosaici romani, i
cosiddetti
emblemata,
che
ricreavano vivaci nature morte e
animali per decorare i pavimenti
delle ricche dimore patrizie.
Ancora una volta, la mela perforata
dal baco che campeggia al centro
A sinistra, mosaico romano, a destra, festoni vegetali dipinti da
Giovanni da Udine nella decorazione della Loggia di Psiche
della composizione, le foglie e gli acini d’uva che pendono vizzi, sembrano alludere al trascorrere
del tempo e al contrasto tra pienezza di vita e disfacimento di tutte le cose.
In alto a destra, Natura morta del Maestro di
Hartford, autore dietro il quale, secondo Federico
Zeri, sarebbe da riconoscere l’attività giovanile del
Caravaggio presso il Cavalier d’Arpino
A sinistra, Jan Brueghel, Cesto di fiori e vaso di
fiori National Gallery of Art Washington Dc
In basso a destra, una tipica composizione floreale
secentesca di Mario Nuzzi, detto Mario dei Fiori,
I musici
Il famoso I musici, appartiene al Metropolitan Museum of Art di New York. Si tratta forse della prima opera
realizzata dal Merisi per il cardinale Del Monte, quando, intorno al 1595, era ospite a Palazzo Madama del
coltissimo prelato appassionato d’arte e di musica. Il dipinto, ricco di fascino e di mistero, venne citato nel
1642 nella biografia redatta dal Baglione il quale fece riferimento a modelli ritratti dal vivo e lo definì
Musica di alcuni giovani. Un gruppo di ragazzi, abbigliati all’antica, viene colto nel momento che precede
l’inizio di un concerto: a destra uno di essi, di spalle, ha appoggiato il suo violino e sta studiando uno
spartito, al centro un secondo ragazzo, dall’aria trasognata, sta accordando il suo liuto, mentre dietro di essi
se ne intravede un terzo che guarda verso di noi reggendo un corno e nel quale si è voluto vedere un
autoritratto del pittore. I tre sono affiancati, sulla sinistra, da un Eros alato e munito di faretra, intento a
staccare dei grappoli d’uva bianca e nera. La composizione appare ispirata alle immagini dei bassorilievi
antichi e la stessa figura dell’Eros pare rifarsi agli amorini vendemmiatori dei sarcofagi della tarda antichità (
come nel caso del sarcofago di Giunio Basso e in quello di Costantina). Del resto la congiunta presenza
simbolica di musica e vino nei dipinti venne codificata dall’erudito Cesare Ripa nella sua Iconologia (1593)
perché : “ il vino si pone, perché la Musica fu ritrovata per tener gli Uomini allegri, come fa il vino, e ancora
perché molto aiuto dà alla melodia della voce il vino bianco, e delicato; però dissero gli antichi scrittori
vadino in compagnia di Bacco”. Così pure per quanto riguarda la presenza del Cupido il Vasari, descrivendo
nelle sue Vite un dipinto nel quale tre belle donne con strumenti simboleggiavano la musica, aggiunse
“accanto alle donne è un Cupido senz’ale, che suona un gravicembalo, dimostrando che dalla musica nasce
amore, ovvero che amore è sempre in compagnia della musica, e perché mai non se ne parte, lo fece
senz’ale” Il cattivo stato di conservazione dell’opera impedisce di decifrare, caso unico nel repertorio
caravaggesco, il contenuto degli spartiti che probabilmente riaffermavano la connessione musica- amore che
costituisce il motivo centrale di questo dipinto.
Il calco del sarcofago di Giunio Basso (Museo della Civilta’ Romana)
Suonatore di liuto
Il Suonatore di liuto, (1595 ca) è esposto nel
Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo. Vi è
rappresentato, a mezza figura, un giovane
androgino, dagli occhi dolci e le
labbra
leggermente dischiuse a intonare un canto. Il
ragazzo indossa una tunica bianca e sta
suonando un liuto. Dinanzi a lui, sul tavolo, è
una caraffa di vetro con fiori nella quale si
riflette la luce di una finestra, un violino in
perfetta prospettiva e alcuni spartiti musicali. Tra
questi si nota, in particolare, quello di un
madrigale del 1539 del compositore parigino
Jacob Arcadelt dal titolo Voi sapete ch’io v’amo.
Nel 1642 il Baglione scrisse che il Caravaggio
dipinse per il Cardinale Francesco Maria
Bourbon Del Monte “un giovane che suonava il Lauto, che vivo , e vero il tutto parea con una caraffa di fiori
piena d’acqua (...) E questo fu il più bel pezzo che facesse mai”. La studiosa Franca Trincheri Camiz, alla
quale si deve l’individuazione dei brani musicali relativi agli spartiti raffigurati nelle opere caravaggesche, ha
proposto di identificare il giovane, che nei secoli successivi venne lungamente scambiato per una donna, con
il castrato Pedro Montoya all’epoca cantore della Cappella Sistina. L’esaltazione della bellezza efebica
associata all’armonia del canto e della musica facevano parte della cultura raffinata dei committenti
dell’artista. Palazzo Madama, al tempo abitazione del cardinale Del Monte, fiduciario del Granducato di
Toscana, alchimista, giocatore, esponente del partito filo-francese, era un luogo riservato a elitari cenacoli
culturali con una apposita camera della musica. L’alto prelato, che conosceva e proteggeva alcuni dei più
importanti musicisti dell’epoca, si vantava di essere egli stesso esperto di “chitarriglia et canto alla
spagnuola”.
Agli intrattenimenti musicali partecipava anche il nobilissimo dirimpettaio, il marchese Vincenzo Giustiniani
banchiere, discendente dalla dinastia genovese dei signori dell’isola di Chios, il quale, a dispetto delle
informazioni del Baglione, fu forse il vero committente di quest’opera intesa come rappresentazione del
concetto di Armonia condiviso dai partecipanti al cenacolo. Tale concetto era stato codificato dall’erudito
perugino Cesare Ripa nella sua Iconologia, apparsa una prima volta nel 1593 priva di illustrazioni e
successivamente, a partire dal 1603, corredata con immagini. Anni dopo, nel 1628, a conferma della sua
profonda passione per l’arte musicale, il Giustiniani avrebbe scritto un Discorso sopra la musica de’ suoi
tempi che viene considerato come uno dei primi testi di storia della musica. Il tema del concerto, di schietta
ascendenza veneta, rappresentazione del desiderio di bellezza e di armonia come accordo tra le parti, venne
trattato da Tiziano nel Concerto di Palazzo Pitti e nel Concerto campestre del Louvre, quest’ultimo
attribuito a Tiziano come a Giorgione.
Nel Suonatore di liuto, presso la Galleria Sabauda a Torino, opera di Antiveduto Gramatica, amico di
Caravaggio e protetto del cardinale Del Monte, è visibile sul tavolo una chitarriglia spagnola
In alto a sinistra, la raffigurazione dell’Armonia codificata da Cesare Ripa nella sua Iconologia
A destra, il cardinale Francesco Maria Bourbon Del Monte ritratto da Ottavio Leoni
In basso a sinistra, il Concerto (1510-12) variamente attribuito a Giorgione o a Tiziano
Riposo dalla fuga in Egitto
Il Riposo dalla fuga in Egitto,
una delle tele più celebri della
Galleria Doria Pamphilj a Roma
che originariamente fece parte
della collezione di Olimpia
Aldobrandini. Si tratta di un olio
dipinto su tovaglia di lino di
Fiandra dipinto intorno al 1595,
dopo la rottura con il Cavalier
d’Arpino, quando era ospite di
monsignor Fantin Petrignani.
L’immagine è riferita a quello che
G. C. Argan definiva il “motivo
religioso-sociale del rivelarsi del
divino nelle persone, nelle cose
più umili”. Mentre la Vergine e il
Bambino
sono
dolcemente
assopiti ai margini di un bosco, un
angelo di rara bellezza, dalle ali
d’aquila, appare a Giuseppe e con
il suo violino intona una lode alla
Vergine. Il santo, seduto sulle
masserizie e quasi attonito, gli
regge lo spartito e dietro un albero si intravede la presenza muta ed innocente di un asino. Sullo spartito retto
da Giuseppe leggiamo le note d’inizio del mottetto Quam pulchra et quam decora, opera del musicista
fiammingo Noel Bauldewijn, collegato con il biblico Cantico dei Cantici. La modella che impersona Maria
pare essere la medesima della Maddalena convertita, esposta anch’essa presso la Galleria Pamphilj. Il pittore
accentua il colore rosso dei capelli della donna, la stessa modella utilizzata per la Maddalena penitente della
Galleria Doria Pamphilj, con evidente richiamo a quelli della Bella Sulamita, l’amata cantata dal Cantico dei
cantici, “Il tuo capo si eleva come il Carmelo/e la chioma del tuo capo sembra di porpora;/un re è incatenato
dalle tue trecce!” La precisa descrizione del paesaggio, sulla scia della tradizione veneta e lombarda di
Lotto, di Savoldo, e del Campi, è un caso unico nella pittura caravaggesca. Si è fatto notare che, come nel
Cristo risorto di Piero della Francesca o nel Temporale di Giorgione, il paesaggio si scinde secondo
caratteristiche opposte: a sinistra, presso il santo, esso è spoglio, fatto di sassi e terra, mentre a destra, presso
la madre e il figlio, la natura fiorisce e ai piedi di Maria vediamo il tasso barbasso, simbolo antico della
Terra Promessa. L’allusione è alla storia prima e dopo l’avvento del Salvatore, alla corrispondenza tra
Vecchio e Nuovo Testamento, al passaggio dalla morte alla resurrezione e dalla caduta alla grazia. Ma oltre
al dono divino della salvezza, il dipinto, comunque collegato a quella poetica degli affetti già espressa
da pittori del XVI secolo quali il Barocci, pare suggerirci la rappresentazione di un’umanità affannata e
stanca, colta qui nel suo torpore quasi animale, che scopre un balsamo agli affanni e alle fatiche
dell’esistenza: il dono supremo della musica, dell’armonia, dell’arte.
In alto a sinistra, anche nella Resurrezione di Piero della Francesca, il paesaggio è ripartito secondo
un significato di morte e rinascita
In alto a destra, la misteriosa raffigurazione della Tempesta dipinta da Giorgione
In basso a sinistra, la Maddalena penitente presso la Galleria Doria Pamphilj
In basso a destra, il Riposo durante la fuga in Egitto di Federico Barocci (1570/73), conservato
presso la Pinacoteca Vaticana, è un esempio di quella poetica degli affetti tesa a far breccia nel cuore
dei fedeli
I bari
La tela del Kimbell Art Museum di Fort Worth in Texas raffigurante I bari è databile al 1595. Si
tratta di una delle opere del Caravaggio più apprezzate e imitate dai suoi seguaci nel corso del XVII
secolo e che nel 1672 fu accuratamente descritto dal biografo Giovan Pietro Bellori. Realizzata
probabilmente per il cardinal del Monte, passò poi ai Barberini e ai Colonna di Sciarra. Nel 1899, a
causa della sua gravissima situazione economica, Maffeo Barberini-Colonna di Sciarra, principe di
Carbognano, incluse l’opera nel gruppo di beni che mise in vendita. Della tela si persero le tracce e
quasi un secolo dopo toccò al grande esperto inglese sir Denis Mahon di ritrovare in Svizzera
l’opera del Merisi che nel 1987 venne acquistata dal museo texano. Attorno ad un tavolo vediamo
tre personaggi: a sinistra, un bel giovane pallido ed elegantemente vestito di scuro si concentra sulle
carte che tiene nella mano, sul lato opposto, un altro giovane, dagli abiti chiassosi illuminati dalla
luce che taglia trasversalmente la scena, sta protendendosi nervosamente con il braccio sinistro sul
tavolo mentre con la mano destra, nascosta dietro la schiena, sta estraendo una carta falsa dalla
cintura. Alle spalle del primo giovane, un terzo personaggio sbircia le sue carte e le indica
silenziosamente al compare con un cenno della mano. I due lestofanti hanno abiti colorati e
pretenziosi che da alcuni particolari, vedi la consunzione delle maniche, la sommarietà della
confezione, o i polpastrelli che fuoriescono dai guanti bucati del baro che suggerisce il punteggio,
lasciano intuire le miserie delle loro vite. Il giovane alla moda, concentrato sulle sue carte, non ha
saputo leggere tutto questo prima di accettare il gioco, non si accorge del raggiro che sta subendo
ora e neppure della minaccia potenziale costituita dall’aguzzo pugnaletto che pende al fianco del
suo avversario. Sul lato sinistro del tavolo, a sporgere verso lo spettatore, un’altro brano di natura
morta: una tavola da tric-trac o tavola reale, l’attuale backgammon, con sopra tre piccoli dadi e il
bussolotto per lanciarli. Si tratta di una ripresa del tema morale dell’ingenuo raggirato dai manigoldi
come nel caso della Buona ventura, in cui un giovane sprovveduto, sedotto dallo sguardo amiccante
di una zingarella, si fa sfilare un anello dalle dita si tratta di vere e proprie rappresentazioni teatrali a
sfondo morale, un teatro delle passioni e dei caratteri che avrebbe avuto molto seguito soprattutto
in Europa settentrionale.
La buona ventura, (1595 ca) Roma, Musei Capitolini
Sopra, Valentin de Boulogne, Soldati che giocano a carte (1622)
A destra, Una rappresentazione di piazza in un’incisione del XVII secolo
Sotto,:Wouters Pietersz Crabeth il giovane I bari (XVII secolo)
.
Bacco coronato da pampini
Il Bacco coronato di pampini della
Galleria degli Uffizi a Firenze, databile
al 1595/96 e realizzato su una tovaglia
in lino di Fiandra, raffigura un giovane
vestito all’antica, sdraiato su una sorta
di triclinio e con il gomito poggiato su
cuscino costituito dallo stesso sacco già
utilizzato per far sedere il san Giuseppe
del Riposo dalla fuga in Egitto. Il
ragazzo ha il capo coronato d’uva e
foglie autunnali, e ci fissa, con lo
sguardo un pò pesante, forse intorpidito
dal vino, porgendoci un calice colmo.
Sulla tavola vediamo una terrina carica
di frutti in parte guasti, tra i quali
notiamo della castagne e una
melograna. Probabilmente il dipinto fu
donato dal Del Monte a Ferdinando I
de’ Medici, granduca di Toscana,
intorno al 1609. L’opera venne
riscoperta soltanto nel 1916 da Roberto
Longhi, nei depositi degli Uffizi, in precario stato di conservazione. Anche in questo dipinto prevale
l’attenzione ai particolari, alla descrizione del momento: la luminosità del volto acceso, le unghie
sporche della mano che ci porge il calice, i cerchi concentrici del vino appena versato e che ancora
ondeggia nella caraffa. L’apparente istantaneità dell’esecuzione è in realtà frutto di studio e di
ripensamenti. È evidente il rapporto con la tradizione classica, con la figura di Bacco inteso come
simbolo di Cristo: l’equazione vino-eucaristia configura questa immagine come una
rappresentazione dell’offerta della salvezza. Nel 1642 Giovanni Baglione scrisse che il Merisi
«Fece alcuni quadretti da lui nello specchio ritratti. Et il primo fu un Bacco con alcuni grappoli
d’uve diverse». Molto s’è detto circa l’uso caravaggesco di dipingere davanti ad una immagine
riflessa allo specchio, e questo ha fornito la spiegazione al fatto che il Bacco regge la sua coppa con
la mano sinistra. Di recente la studiosa fiorentina Roberta Lapucci è andata oltre e, insieme ad altri
colleghi americani, ha ipotizzato che gli specchi di Caravaggio fossero in realtà le parti di una
camera oscura. Dalle testimonianze dei contemporanei pare infatti di capire che Caravaggio, almeno
per un certo periodo della sua attività, avesse trasformato il suo studio in un’enorme camera ottica:
l’artista aveva fatto un foro nel soffitto del suo studio per consentire la penetrazione di un fascio di
luce e, attraverso l’uso combinato di uno specchio concavo e di una lente biconvessa, riusciva a
proiettare sulla superficie della tela le immagini dei modelli. Le informazioni tecniche, a quanto
sembra, gli erano venute proprio dalla frequentazione del salotto del cardinale Del Monte, crocevia
dei dottiv toscani residenti a Roma. Una ulteriore prova di questi esperimenti potrebbe forse essere
il fatto che, durante uno dei vari processi che funestarono la vita del pittore, la sua padrona di casa
lamentò di essere stata vituperata dal lombardo e di dover essere ancora pagata «della pigione di sei
mesi e di un suffitto mio di detta casa che esso ha rotto». Del resto, già nel 1568, Daniele Barbaro,
scrittore veneziano e studioso di architettura, consigliava la camera oscura come ausilio per gli
artisti: «Vedendo nella carta i lineamenti delle cose, tu puoi con un pennello segnare sopra la carta
tutta la Perspettiva, che apparirà in quella. E ombreggiarla. E colorirla teneramente secondo la
natura che ti mostrerà, tenendo ferma la carta, finché haverai fornito il disegno».
Questa, secondo i sostenitori della tesi dell’utilizzo di apparecchiature ottiche durante la realizzazione del
Bacco, doveva essere la reale posizione del modello
La camera oscura in una stampa esplicativa del XVII secolo
Giuditta e Oloferne
Giuditta e Oloferne, dipinto ad olio facente parte dell’esposizione della Galeria Nazionale d’Arte
Antica di Palazzo Barberini a Roma e databile al periodo 1598-99 raffigura l’episodio biblico della
giovane e ricca vedova ebrea Giuditta che, durante l’assedio della città ebraica di Betulia, riesce a
farsi ricevere dal generale assiro Oloferne e lo decapita, mentre giace ubriaco nel suo letto, salvando
il suo popolo. Secondo alcuni ad ispirare l’opera può essere stata la figura di Beatrice Cenci,
giovane nobildonna romana che finì sotto la mannaia per aver asassinato il padre violento e
dissoluto. Modella per la figura dell’eroina fu la cortigiana di origine senese Fillide Melandroni che
appare in altre opere del pittore. Al posto dell’ancella citata nel testo biblico l’eroina è
accompagnata nella sua impresa da un’anziana dai tratti grotteschi in cui il pittore recupera
l’esperienza della fisiognomica leonardesca. L’opera fu esposta per la prima volta al pubblico nella
mostra che Milano dedicò al Caravaggio nel 1951 al Palazzo Reale suscitando grande clamore e
qualche riserva ma venne fermamente difesa dal Longhi “l’opera non tarderà ad entrare nel corpus
autografo del grande lombardo”. Il dipinto, che allora faceva parte della collezione di Vincenzo
Coppi, era stata recuperata dal celebre critico Roberto Longhi sulla base della segnalazione di un
restauratore. La prima menzione dell’opera è nel testamento del 1632 e poi del 1639 di Ottavio
Costa, nobile di Alberga che trascorse gran parte della sua vita a Roma. L’inventario descrive “ un
quadro grande con l’immagine di Judit fatta da Michelangelo Caravaggio con la sua cornice e
taffettà dinanzi. L’appartenenza del dipinto alla famiglia Costa è confermata dal Baglione.
Contrariamente alle disposizione di Ottavio i beni non vennero mai trasferiti ad Albenga ma
passarono ai parenti romani. A metà Ottocento il quadro, presentato come replica da originale,
venne acquistato insieme a un blocco di dipinti rimasti invenduti ad un’asta dell’epoca dal marchese
Antonio De’ Cinque Quintili avo per parte materna del Coppi. Nel 1971 lo Stato acquistò la
Giuditta. Il restauro del 1999 ha fatto ritrovae le iniziali C.OC. riferite al conte Ottavio Costa.
La drammatica rappresentazione della Giuditta che decapita Oloferne di
Artemisia Gentileschi (1620 ca) Firenze, Galleria degli Uffizi
Leonardo da Vinci, Fisionomie di vecchi
Presunto ritratto di Beatrice Cenci, attribuito a Guido Reni (1599)
Roma, Galleria Nazionale d’Arte antica
Conversione di Saulo
Rarissimo caso di opera caravaggesca non eseguita su tela è l’olio su tavola di cipresso appartenente
da una collezione privata romana, la collezione Odescalchi, che raffigura la Conversione di Saulo.
Si tratta della prima versione della Conversione di san Paolo che, insieme alla Crocifissione di san
Pietro, vennero commissionati da monsignor Tiberio Cerasi, tesoriere generale di papa Clemente
VIII Aldobrandini, per le pareti laterali della sua cappella in S. Maria del Popolo realizzata
dall’architetto Carlo Maderno. Il contratto, datato 24 settembre 1600, prevedeva la realizzazione di
due scene su tavole di cipresso delle dimensioni di dieci palmi per otto, e la consegna delle opere
entro otto mesi. Secondo il Baglione le due opere «non piacquero al padrone» e pasarono ad un
altro collezionista, il cardinale marchigiano Giacomo Sannesio. Successivamente il Caravaggio
realizzò le due notissime tele La crocifissione di san Pietro e La conversione di S. Paolo che ora,
insieme all’Assunzione della Vergine di Annibale Carracci, adornano la cappella. Le due nuove
versioni, su tela, vennero consegnate nel novembre del 1601 agli amministratori dellOspedale della
Consolazione, erede delle fortune del Cerasi, morto improvvisamente sei mesi prima. Questa prima
versione è caratterizzata da una vivace gestualità e teatralità: il santo sopraffatto e accecato, il
cavallo sullo sfondo che si aggira terrorizzato e schiumante, il soldato che pare quasi tentare una
difesa e Gesù che discende dal cielo sorretto da un angelo. Fu forse questo eccesso di concitazione
che spinse la committenza al rifiuto, oppure, come sostengono altri, fu la necessità di una maggiore
adesione letterale alla narrazione avangelica che non fa riferimento all’apparizione di Cristo ma
parla soltanto di una luce divina: «Or avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a
Damasco, all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno.. » (Atti degli Apostoli cap. 9 v. 3).
I tempi erano maturi per un più rigido controllo della produzione artistica da parte delle autorità
ecclesiastiche: nel 1603, il cardinal vicario di Roma Camillo Borghese, che due anni dopo sarebbe
divenuto papa con il nome di Paolo V, emanò un editto, detto “specimina et designationem
figurarum et aliorum”, che obbligava gli artisti a sottoporre ad esame preventivo i disegni e gli
abbozzi per verificarne l’idoneità. Tutto questo finì per creare problemi ai sostenitori della pittura
dal vero, privilegiando i bozzetti e gli studi preventivi realizzati usando manichini e pose
stereotipate. Della prima versione della Crocifissione di S. Pietro si sono perse le tracce in Spagna a
partire dal XVIII secolo.
In alto a sinistra, una immagine della Cappella Cerasi in S. Maria del Popolo
In alto a destra, La Conversione di S. Paolo posta su una delle pareti laterali della cappella
In basso a sinistra, un ritratto di papa Paolo v che fu tra i maggiori fautori del controllo della produzione
artistica da parte delle autorità ecclesiastiche
In basso a destra, lo Scudo con la testa di Medusa, presso la fiorentina Galleria degli Uffizi, è, insieme alla
Conversione di Saulo, l’unica altra opera del Caravaggio realizzata su tavola di legno
Cena in Emmaus
Nel libro contabile dei Mattei, alla data del 7 gennaio 1602, viene riportato l’avvenuto pagamento di
150 scudi per un’opera raffigurante «Nostro Signore in fractione panis». Dipinta dunque nel 1601,
la prima versione della Cena in Emmaus, oggi conservata a Londra presso la National Gallery,
descrive l’attimo in cui finalmente il Cristo risorto viene riconosciuto dai discepoli a cui si era
accompagnato in viaggio: « Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con
noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (Luca XXIV,30-32). La luce penetra in profondità
nella spazio della sacra rappresentazione evidenziando i personaggi con grande realismo. Al centro
è il Cristo benedicente, imberbe come nei sarcofagi antichi, la cui androginia allude all’ermetica
unione dei contrari. L’apostolo di sinistra fa per alzarsi dalla sedia per la meraviglia, quello di
destra, che porta sul petto la coquille Saint Jacques, il segno del pellegrinaggio a Santiago de
Compostela, allarga le braccia quasi a fare ala al prodigio del Cristo. Sulla tavola coperta dalla
tovaglia bianca, riappare in primo piano la canestra di frutta, che sporge lievemente dal bordo,
colma «d’uve, fichi, melagrane, fuori di Stagione» come annotò pedantescamente il Bellori nella
seconda metà del Seicento vedendo frutta non appartenente al periodo pasquale. Assieme alla
canestra troviamo il pane e il vino simboli del sacrificio di Cristo, e quella reiterazione di natura
morta data dal galletto con le zampe stecchite e abbrustolite. A sinistra della rappresentazione, in
piedi, è il ritratto di un oste con la cuffia sul capo, forse di quell’oste di origine lombarda che,
secondo le fonti, fu uno dei primi soggetti ritratti dal Caravaggio appena giunto a Roma.
Deposizione di Cristo
La Deposizione di Cristo è un olio su tela che originariamente ornava il primo altare di destra di S.
Maria in Vallicella, chiesa degli oratoriani di s. Filippo Neri. Il dipinto vnne commissionato da
Girolamo Vittrici nel 1602, per la cappella di famiglia, e venne posto nella chiesa alla fine del 1604.
Si tratta di una importante opera pubblica del pittore nella quale mostra un duplice approccio al
tema sacro: da una parte l’adesione al classicismo romano, ai modi della pittura di storia, alle
istanze di Carracci e dei bolognesi, e dall’altra il legame profondo con il realismo di matrice
lombarda. Lo scrittore d’arte Giovanni Pietro Bellori (1613-96), avvezzo a valutare le opere
secondo il metro della classicità, e spesso critico nei confronti del Caravaggio, scrisse molti anni
dopo: «Ben tra le migliori opere, che uscissero dal pennello di Michele si tiene meritatamente in
istima la Deposizione di Cristo nella chiesa nuova de’ Padri dell’Oratorio» Il dipinto fu requisito al
tempo delle guerre napoleoniche e nel 1797 fu trasferito a Parigi. Recuperato nel 1815, non tornò a
Maria in Vallicella, al cui interno si trova ora una copia ottocentesca dell’opera, e venne destinato
alla Pinacoteca Vaticana. Il vertice della composizione, un triangolo di figure che scende fino al
corpo di Cristo, è costituito dalle braccia di Maria di Cleofa, aperta nel gesto degli antichi oranti
paleocristiani; accanto a lei sono la Maddalena con una tipica acconciatura di popolana romana,
Maria anziana e muta nel suo dolore, san Giovanni. Chiude il corteo la pietosa fatica di Nicodemo,
l’unico appartenente al Sinedrio che volle onorare Gesù defunto con la sua presenza, il quale si
presenta a noi chino, i muscoli e le vene delle gambe gonfi nello sforzo di sostenere il corpo del
Cristo. Intenso il raffronto del Merisi con la Pietà michelangiolesca, ma anche con il raffaellesco
Trasporto di Cristo al sepolcro. Il braccio destro del Salvatore, che pende inerte, ha precedenti
antichi, appare per la prima volta nei sarcofagi classici che raffigurano i funerali dell’eroe Meleagro
e arriverà sino alla Rivoluziona francese con la Morte di Marat di J.L. David. Fondamentale, alla
base della rappresentazione, quella pietra squadrata che sporge verso lo spettatore, con il suo
richiamo alla simbologia della pietra angolare, riferita ad un salmo biblico poi citato nel Nuovo
Testamento, cioè di Cristo prima base e sostegno dell’edificio della Chiesa.
In alto a sinistra, Michelangelo, Pieta’, Roma, S. Pietro
In alto a destra, Raffaello, Trasporto di Cristo al sepolcro, Roma, Galleria Borghese
In alto, Simone Peterzano Deposizione, Milano, San Fedele
Nell’opera del primo maestro di Caravaggio sono visibili
molti degli elementi poi riutilizzati dall’artista lombardo
In basso a destra, Resurrezione di Cristo, Roma, Musei Vaticani,
Anche in questo arazzo fiammingo di ispirazione raffaellesca
vediamo il Cristo risorto che poggia sulla pietra angolare
Amore vincitore
L’Amore vincitore è visibile a Berlino, dallo Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz,
Gemaldegalerie. Realizzato nel per il marchese Vincenzo Giustiniani, in un inventario redatto dopo
la morte del mecenate, venne catalogato come “Amor ridente in atto di dispregiare il mondo che
tiene sotto con i diversi strumenti, corone, scettri e armature chiamato per fama il Cupido del
Caravaggio”. Nel 1815 il dipinto fu venduto al re di Prussia Federico Guglielmo III passando
stabilmente a Berlino. Nel Novecento si sono avute varie interpretazioni del dipinto, in gran parte
riferite al tradizionale Omnia vincit amor et nos cedamus amori virgiliano (Egloghe X, 69) con
l’Amore profano ridente che trionfa, superandole, sulle arti e virtù umane e sugli attributi
dell’amore sacro. Può essere sorprendente ricordare che al contrario, al tempo del Caravaggio, le
rime del poeta mariniano Gaspare Murtola, che nel 1603 dedicò all’opera del lombardo tre
madrigali, facciano invece riferimento all’Amore che si mostra vincitore (forse alludendo al
significato del nome del Giustiniani, Vincenzo, cioè colui che vince: Omnia vincit amor / Omnia
vincit Vincentius) attorniato dagli strumenti materiali della sua potenza. L’estremo attaccamento del
Giustiniani a questo dipinto ha fatto ipotizzare una rapporto più sottile tra il committente e l’opera e
il fatto che il tema potrebbe essere una rappresentazione della complessa personalità del mecenate
ligure. Gli oggetti raffigurati, infatti, potrebbero alludere agli interessi del marchese: strumenti e
spartiti a sinboleggiare la passione per la musica, la penna, il libro e l’alloro gli interessi letterari e
poetici, la squadra e il globo gli studi di astronomia e geometria, la corazza e lo scettro il retaggio
nobiliare e militare della famiglia che aveva avuto il dominio sull’isola greca di Chios. Su tutto
troneggia l’Eros ridente a richiamare l’ideale neoplatonico ficiniano. Come testimoniò il pittore
toscano Orazio Gentileschi nel 1603, durante il famoso processo per diffamazione che contrappose
Giovanni Baglione al Merisi, il Giustiniani volle commissionare anche all’accusatore, al Baglione,
su un tema analogo, l’opera Amor sacro e Amor profano, oggi conservata a Palazzo Barberini.
In alto a sinistra, Ritratto del Marchese Vincenzo Giustiniani
In alto a destra, G. Baglione Amor Sacro e Amor Profano (1602) Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Antica, Palazzo Barberini
In basso,la posa di uno degli Ignudi michelangioleschi della Cappella Sistina è stata messa in
relazione con l’immagine dell’Amore Vincitore
San Giovanni Battista
Di questo notissimo San Giovanni Battista,
appartenente alla Pinacoteca Capitolina, si è scritto
molto soprattutto per chiarirne il rapporto con la copia,
di minore qualità, conservata nella Galleria Doria
Pamphilj. Quest’ultima era stata inclusa come originale
da Roberto Longhi nella prima esposizione di tutte le
opere conosciute del Merisi tenutasi nel 1951 a Milano.
Tuttavia il grande studioso britannico sir Denis Mahon
non riteneva che quella esposta fosse l’opera originale
ed era alla ricerca di una tela della quale aveva trovato
menzione tra i documenti dell’Archivio di Stato. Nel
1952, accompagnato dal direttore dei Musei Capitolini
Carlo Pietrangeli, riuscì a individuare al Campidoglio,
addirittura nell’ufficio del sindaco di Roma, un dipinto
con la stessa immagine, offuscato dalla polvere e dalla
vernice, nel quale riconobbe la mano del maestro
lombardo. La tela fa parte di quel gruppo di opere che
Caravaggio produsse per Ciriaco Mattei, gentiluomo di
antica nobiltà capitolina legato all’ordine dei Filippini, e
che comprende anche la Cena in Emmaus oggi a Londra.
Commentando malignamente la capacità del Caravaggio
di fare “romore” cioè di interessare i ricchi collezionisti alla novità della sua pittura, e inserendo
erroneamente nella lista anche l’Incredulità di S. Tommaso commissionata in realtà dal marchese
Giustiniani, Giovanni Baglione ci dice «Anzi fe’ cadere al romore anche il signor Ciriaco Mattei, a
cui il Caravaggio avea dipinto un S. Giov. Battista, e quando N. Signore andò in Emaus, ed all’ora
che S. Tommaso toccò co’ il dito il costato del Salvatore; ed intaccò quel signore di molte centinaia
di scudi». La datazione dell’opera può essere desunta dai documenti che attestano i pagamenti del
Mattei al 1602 senza che tuttavia sia specificato il titolo dell’opera. In documenti del decennio
successivo, nel 1616, il dipinto venne per la prima volta messo in relazione con il nome del figlio di
Ciriaco, Giovanni Battista, il quale nel 1624 decise di donare l’opera al cardinale Del Monte. Il
giovanetto, dalle movenze derivate anche in questo caso dagli Ignudi della Sistina, si rivolge con
grande vivacità e quasi con sfrontatezza allo spettatore mentre stringe a sé un ariete. L’assenza di
una parte dei tradizionali attributi iconografici ha portato alcuni studiosi a dubitare del fatto che si
tratti realmente di una rappresentazione del santo precursore di Cristo facendo persino ipotizzare la
possibilità che si tratti di una raffigurazione di Isacco scampato al coltello di Abramo con accanto la
vera vittima sacrificale. Maurizio Calvesi ha invece individuato nella pelle di cammello posta sopra
il panno rosso un tipico attributo di S. Giovanni Battista presente anche nel dipinto con lo stesso
soggetto conservato a Kansas City e nella presenza dell’ariete l’allusione al sacrificio di Cristo.
Presa di Cristo
Ha qualcosa di romanzesco la
storia del ritrovamento di questo
dipinto, tanto che nel 2005 venne
narrata nel libro Il Caravaggio
perduto
dello
statunitense
Jonathan Harr. Nel 1989 la
studiosa Francesca Cappelletti
ritrovò nell’archivio di famiglia
dei Mattei alcuni documenti
riguardanti un quadro che si
riteneva perduto, La presa di
Cristo. Riuscì a comunicare la
sua scoperta al famoso Denis
Mahon e a rintracciare una pista
di vendite novecentesche, sempre
nell’ambito
delle
isole
britanniche, di un Tradimento di
Cristo attribuito al fiammingo
Gerrit van Hontorst. A questo filone di ricerche si agiunse la scoperta, un anno dopo, di Sergio
Benedetti, restauratore alle dipendenze della National Gallery di Dublino, il quale riuscì a
identificare il prezioso dipinto in una tela che, da circa settanta anni, si trovava presso la comunità
gesuita di St. Ignatius a Leeson Street nella capitale irlandese. Restaurata, l’opera venne infine
donata alla National Gallery di Dublino. Il dipinto, infatti, era stato realizzato per i Mattei sul finire
del 1602, nel 1672 era stato precisamente descritto dal Bellori e fino alla fine del XVIII secolo era
rimasto nelle mani della famiglia romana. All’inizio dell’Ottocento era invece stato acquistato dal
collezionista inglese William Hamilton Nisbet e, dopo essere passato per vari proprietari, era stato
donato alla comunità gesuita dublinese come opera attribuita a van Hontorst. La commessa era
venuta dal nobile Ciriaco Mattei, e il tema della cattura di Cristo nell’orto dei Getsemani venne
scelto dal fratello, il cardinale Girolamo. La rappresentazione è frutto di una regia molto accurata:
mentre a sinistra san Giovanni fugge terrorizzato, al centro Giuda bacia il Cristo il cui volto
esprime la dolorosa accettazione del sacrificio. Nel contempo la spalla di Gesù viene afferrata
rudemente dalla mano guantata di ferro di una delle due guardie che stanno per arrestarlo. Sullo
sfondo, a destra, troviamo un autoritratto di Caravaggio stesso che assiste alla scena e la illumina
reggendo una lanterna. Anche in questo caso Caravaggio non si accontente di una descrizione
sequenziale dei fatti ma li concentra nel momento in cui raggiungono il loro culmine e risoluzione.
Il particolare della mano ferrata dello sgherro fu grandemente ammirato dai contemporanei del
Merisi. Nel Museo d’arte occidentale e orientale di Odessa, in Ucraina, è conservata una copia del
dipinto.
San Giovanni Battista
Attualmente conservato a Kansas city, presso la Nelson Gallery, questo S. Giovanni Battista
venne dipinto su commissione del nobile e banchiere genovese Ottavio Costa, personaggio
collegato con la cerchia del cardinale Federico Borromeo. Uno degli usuali modelli del Caravaggio
è qui ritratto drappeggiato in un ampio mantello di ispirazione classicista su un fondale di denso
fogliame. Il personaggio ha gli attributi titpici del Battista: stringe nella mano destra una canna e ha
i fianchi cinti da una pelle di cammello. Sulla tela sono state rilevate tracce di incisioni
sull’imprimitura fresca a conferma di quanto si sapeva dell’uso del Merisi di tratteggiare
sommariamente i contorni delle figure con il manico del pennello prima di iniziare a dipingerle.
Nell’inventario Costa del 1639 figurano infatti la famosa Giuditta, un’Estasi di S. Francesco e un S.
Giovnni Battista nel deserto. Il dipinto venne acquistato da un collezionista e portato a Malta, poi
in Inghilterra e infine fu comprato negli Stati Uniti. Dopo varie teorie circa la datazione espresse da
Longhi, Berenson, e altri un ritrovamento ha confermato l’ipotesi espressa dallo studioso inglese
Denis Mahon. Nel 2005, infatti, una ricevuta del Caravaggio proveniente dall’ Archivio di Stato di
Siena, ha consentito di situare correttamente l’opera nel periodo 1602-03.
San Giovanni Battista
Il San Giovanni Battista, conservato a Roma presso la Galleria Nazionale d’Arte Antica a Palazzo
Corsini,
è da attribuirsi al periodo 1602-1603 ed è dunque in stretto rapporto con l’opera
conservata a Kansas City. Così lo descrisse nel 1927 Roberto Longhi che per primo lo attribuì al
maestro lombardo: «Il giovane compagnaccio che più volte aveva servito di modello all’artista
siede ora scompostamente nel bosco tra tronchi venosi, la mano sulla cannuccia scortecciata e, lì
accanto, la ciotola svuotata dal pennello vorticoso e infallibile come da un Velázquez di vent’anni
dopo» Nell’assenza di documenti che permettano di situarlo con certezza, in generale il dipinto
viene considerato coevo al san Giovanni di Kansas City per i molteplici elementi che accomunano
le due realizzazioni. Passò forse ai Corsini alla metà del Settecento a seguito di una unione
matrimoniale con i Barberini e venne catalogato come Caravaggio originale insieme ad altre tre tele
andate perdute. Entrò a far parte dei beni dello Stato nel 1883 a seguito dell’acquisto del palazzo
alla Lungara della famiglia fiorentina.
Il tema del S. Giovanni Battista venne affrontato più volte dal Caravaggio. In basso a sinistra,
la tela conservata presso il Museo della Cattedrale di Toledo (1598 ca) e quella molto nota,
datata al 1610, presso la Galleria Borghese a Roma
Sacrificio di Isacco
Il Sacrificio di Isacco appartiene alla Galleria degli Uffizi, alla quale fu donato nel 1917 dal
collezionista John Fairfax Murray. Nel repertorio documentario abbiamo una descrizione, sia pure
imprecisa, del Bellori che ne parla come di opera realizzata per Maffeo Barberini, futuro papa
Urbano VIII, insieme al ritratto del prelato oggi presso una collezione privata fiorentina. Sorta di
istantanea del momento saliente in cui un angelo dai tratti apollinei ferma Abramo un attimo prima
che affondi il colpo fatale nel collo di Isacco. Documenti di pagamento dei Barberini lo situerebbero
nel periodo 1603-4. Realizzato in un periodo nel quale, come già nel Riposo dalla fuga in Egitto e
nella Conversione Saulo, l’artista mostra di essere influenzato dalla tradizione norditaliana e più
precisamente giorgionesca del paesaggio.
Ritratto di monsignor Maffeo Barberini, Firenze, collezione privata
Incoronazione di spine
L’Incoronazione di spine, è un olio su tela esposto al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il
dipinto, databile al 1604, originariamente apparteneva alla collezione del marchese Vincenzo
Giustiniani ma, a seguito delle difficoltà economiche dei discendenti della nobile famiglia di origine
genovese, il dipinto venne ceduto nel 1804 all’ambasciatore austriaco presso la Santa Sede per
essere incluso nella raccolta d’arte dell’imperatore Francesco I. A causa delle guerre napoleoniche il
dipinto poté raggiungere Vienna soltanto nel 1816. Addosso ad uno dei personaggi si nota la
medesima armatura utilizzata dall’artista per la Presa di Cristo, realizzata per Ciriaco Mattei e ora a
Dublino. Impossibile trascurare di riferire l’evidente riferimento compositivo di quest’opera a un
precedente del Tiziano che molto probabilmente il Merisi ebbe modo di studiare negli anni della
formazione: quella Incoronazione di spine, oggi conservata al Louvre, che il maestro di Pieve di
Cadore realizzò nel periodo 1542-44 per la chiesa milanese di S. Maria delle Grazie. Varie in
passato le tesi relative al periodo d’esecuzione di quest’opera che qualche critico voleva situare nel
periodo napoletano anche se paiono da escludere acquisti del Giustiniani al di fuori del mercato
romano.
Tiziano, Incoronazione di spine, (1544) Parigi, Louvre
Cena in Emmaus
La Cena in Emmaus, della Pinacoteca di
Brera a Milano, Venne eseguita dopo
l’omicidio di Ranuccio Tommasoni del 28
maggio 1606 e l’inizio della fuga da Roma.
Secondo le fonti più affidabili venne
dipinta mentre l’artista era nei feudi dei
Colonna a Zagarolo e venduta a Roma al
banchiere ligure Ottavio Costa, oppure al
marchese Costanzo Patrizi nella cui
collezione si trovò ad essere registrata a
partire dal 1624 e dove fu vista dal Bellori
nel 1664. Il tema era già stato affrontato
nell’opera conservata alla National Gallery
di Londra ma viene qui essenzializzato e
concentrato, rinunciando alla policromia
del modello precedente. Gesù appare con
un aspetto più convenzionale come pure i personaggi che siedono al suo tavolo. Sul bianco della
tavola popolato da dense ombre anche il pasto eucaristico è più povero rispetto alla profusione della
Cena eseguita per i Mattei: due pani, delle erbe e una brocca di vino. le uniche caratterizzazioni
sono date dalla presenza dell’oste, nel quale riconosciamo lo stesso personaggio già apparso nella
Cena londinese e della donna anziana il cui volto profondamente segnato ha qualcosa in comune
con la sant’Anna della Madonna dei Palafrenieri presso la Galleria Borghese.
Nella Madonna dei Palafrenieri (1606), presso la Galleria Borghese a Roma, appare a destra la figura
di sant’Anna ritratta con le fattezze di un’anziana simile a quella della Cena in Emmaus
Flagellazione
La datazione di questa opera, che dal 1972, per
motivi di sicurezza, è in deposito presso il Museo
Nazionale di Capodimonte a Napoli, viene situata
nel periodo 1606-07, data del primo passaggio a
Napoli dell’artista. La committenza gli venne dalla
famiglia dei de’ Franchis per adornare la cappella
gentilizia che stavano realizzando all’interno della
chiesa di S. Domenico Maggiore. Documenti certi
datano il pagamento dell’opera al maggio del 1607.
Curiosamente non esistono nelle fonti riferimenti
critici alla Flagellazione che siano precedenti alla
fine del XVII secolo; circostanza dovuta
probabilmente al fatto che l’opera caravaggesca
venne esposta tardivamente nella chiesa
domenicana visto che i lavori di sistemazione della
cappella non terminarono prima del 1652. Una
volta visibile, ci racconta il De Dominicis, una
delle fonti dell’epoca che non trascura di esercitare
le consuete critiche, il dipinto « trasse a sé tutti gli
occhi dei riguardanti, benché la figura del Cristo sia
presa da un naturale ignobile e non gentile, come
era necessario, per rappresentare la figura di un Dio
per noi fatto uomo». De Dominicis prosegue
dicendo che l’opera «fece rimaner sorpresi non solo i dilettanti ma i Professori medesimi in buona
parte, e la fama del Caravaggio tanto altamente suonava laonde da’ dilettanti si desideravano a gara
le opere sue». Gran parte della critica ha collegato il dipinto al precedente romano di scuola
michelangiolesca costituito dalla Flagellazione di Sebastiano del Piombo conservata nella chiesa di
S. Pietro in Montorio a Roma. Alcuni critici ritengono che il Caravaggio abbia notevolmente
rimaneggiato l’opera durante il suo secondo passaggio a Napoli, nel periodo 1609-10.
La Flagellazione di Cristo di Sebastiano del Piombo (1518) olio su muro, forse su disegno di
Michelangelo, conservato nella prima cappella di destra della chiesa romana di S. Pietro in Montorio
Amore dormiente
L’Amore dormiente visibile a Firenze nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti, venne sicuramente
dipinto a Malta, come attesta l’attendibile iscrizione sul retro che lo data al 1608. Il committente fu
il cavaliere di Malta fiorentino Francesco dell’Antella coadiutore del Gran Maestro dell’ordine il
piccardo Alof de Wignacourt. Dell’Antella fu uno dei principali artefici dell’entrata del Caravaggio
nell’Ordine di Malta e si adoperò per ottenere da papa Paolo V la dispensa necessaria affinché il
pittore potesse essere investito del cavalierato come sappiamo dai documenti conservati
nell’Archivio Segreto Vaticano: «Beatissmo padre. Desiderando il gran maestro della sacra
religione gerosolimitana d‘honorar alcune persone virtuose, e meritevoli, c‘hanno desiderio e
divotione di dedicarsi al suo servigio, e della sua religione; né avendo per hora altro modo da poter
più commodamente farlo. Supplica humilmente la santità vostra, che, con un suo breve, si degni di
concedergli autorità e facultà, per una volta tanto, di poter decorare et ornare dell‘habito di
cavaliero magistrale due persone a lui ben viste e da lui nominande. Non ostante ch‘uno di essi
habbia, altre volte in rissa, commesso un‘homicidio». La figura del dio addormentato, con a fianco
le sue armi, le frecce, la faretra e l’arco con la corda slegata, emerge da una densa oscurità e
costituisce l’ultima citazione mitologica nella storia pittorica del lombardo. Originariamente l’ala di
destra si stagliava più nettamente sul fondo oscuro. Probabilmente il dipinto simboleggia il voto di
castità fatto dai Cavalieri di Malta. Alla fine del Seicento l’opera passò dai dell’Antella ai Medici
Giovanni Baglione ci narra lo sfortunato epilogo della breve esperienza del Caravaggio come
cavaliere: «Poscia andossene a Malta, e introdotto a far riverenza al gran maestro, fecegli il ritratto;
onde quel principe in segno di merito dell‘abito di S. Giovanni il regalò e creollo cavaliere di
grazia. E quivi avendo non so che disparere con un cavaliere di giustizia, Michelagnolo gli fece non
so che affronto, e però ne fu posto prigione; ma di notte tempo scalò le carceri e se ne fuggì, e
arrivato all‘isola di Sicilia operò alcune cose in Palermo».
Il Gran Maestro del’Ordine di Malta, Alof de Wignacourt, ritratto dal Caravaggio
Annunciazione
Opera purtroppo in cattivo stato di conservazione
dipinta durante il soggiorno a Malta, nell’anno 1608,
questa Annunciazione venne commissionata dal
duca di Lorena Enrico II perchè adornasse l’altare
della chiesa del vescovo primate di Nancy allora in
costruzione . In quell’anno infatti sia il fratello
Francesco che il figlio del duca, Carlo conte de Brie,
si trovavano sull’isola ed ebbero la possibilità di
prendere in consegna l’opera del maestro italiano.
spiritualità intrisa di quiete e d’umiltà l’angelo
scende dall’alto, su una nube, accompagnato dalla
luce divina Nella sinistra, in ombra, tiene il giglio,
mentre il braccio destro, lungo il quale corre la luce,
si ferma poco sopra il capo della Vergine nel gesto
eloquente della mano. In basso, la Vergine, raccolta
nel suo mantello scuro, ascolta quietamente
l’annuncio di Gabriele. Nel 1742 il dipinto venne
spostato nella cattedrale che prese il posto della
chiesa più antica; a partire dalla fine del XVIII secolo
passò per vari musei finchè nel 1829 passò
definitivamente al Musée des Beaux Arts di Nancy.
Riscoperto nel secondo dopoguerra da critici
francesi fu definitivamente riconosciuto nel 1959.
Ignazio Danti, Veduta di Malta durante l’assedio del 1561, Roma, Musei Vaticani
Adorazione dei pastori
Databile al 1609, l’ Adorazione dei pastori fa parte delle opere esposte al Museo Regionale di
Messina. Venne dipinta per la chiesa di S. Maria la Concezione poi distrutta nel rovinoso terremoto
del 1908. L’opera, citata più volte dal Bellori, fu forse commissionata dal senato cittadino del
comune messinese. Il dipinto è connotato da una grande essenzialità compositiva e da una
iconografia marcatamente pauperistica che ha fatto ipotizzare che la commissione potesse provenire
dagli ambienti degli ordini minori. Al centro della composizione, all’interno di una capanna d’assi e
travi, troviamo la Vergine con il Bambino distesa in una posizione tipica delle raffigurazioni più
antiche, attorno alla quale si stringono i pastori adoranti. Sullo sfondo gli animali della stalla e, a
sinisra, in primo piano, una natura morta costituita da poveri oggetti: un tovagliolo, una pagnotta e
una pialla da falegname Il dipinto è giunto sino a noi in precario stato di conservazione perché già
nel 1670 fu sottoposto a un rovinoso intervento di restauro. Anche in questo caso, come già per il
Ragazzo con la canestra di frutta della Borghese, sono state trovate tracce di disegni preparatori.
F. Hogenberg, Veduta di Messina, (1599)
David con la testa di Golia
David con la testa di Golia venne realizzata quasi sicuramente durante l’ultimo passaggio
dell’artista a Napoli (1609-10), tanto che ne venne fatta una copia per il Vicerè Juan Alonso
Pimentel de Herrera. L’opera raffigura il giovane eroe che regge con mano ferma, ma con il volto
atteggiato ad una pietosa commiserazione, la testa sfigurata del gigante sconfitto e decapitato.
Secondo il Bellori il dipinto venne eseguito per il cardinale Scipione Borghese per accompagnare la
richiesta di grazia dopo la condanna a morte comminata al Merisi per l’uccisione di Ranuccio
Tomassoni. Dal 1613 figura registrato nell’inventario della collezione del prelato. Ancora il Bellori
è tra i primi a parlare di un autoritratto del pittore nella testa del gigante ucciso, elemento che è stato
considerato espressione del desiderio di espiazione e simbolo di autopunizione. Alcuni, più di
recente, si sono spinti a considerare questo dipinto come una sorta di doppio autoritratto: il
Caravaggio giovane, vincente e pieno d’energia, nella figura di David, ci sta mostrando il volto
dell’artista nel momento della sua caduta. Anche qui prevale il ricorso a quella pittura semplificata
che è tipica dell’ultima ultima fase del Caravaggio anche se Sgarbi rinviene nella figura del giovane
eroe elementi pertinenti al periodo 1606-07. Sulla lama della spada che il giovane tiene nella destra
e che pare spuntare dal buio, è visibile una serie di segni che che sono stati variamente interpretati:
da alcuni come H-AS OS, sigla che riassume il motto agostiniano "Humilitas Occidit Superbiam"
(l'umiltà uccide la superbia); da altri come MACO , da intendersi più semplicemente come le iniziali
dell’autore seguite dal termine latino opus, opera.
Se siete interessati a partecipare a visite guidate a carattere archeologico e storico
artistico a Roma e provincia, consultate il calendario delle iniziative della
Associazione culturale Mirabilia Urbis
www.mirabiliaurbis.it