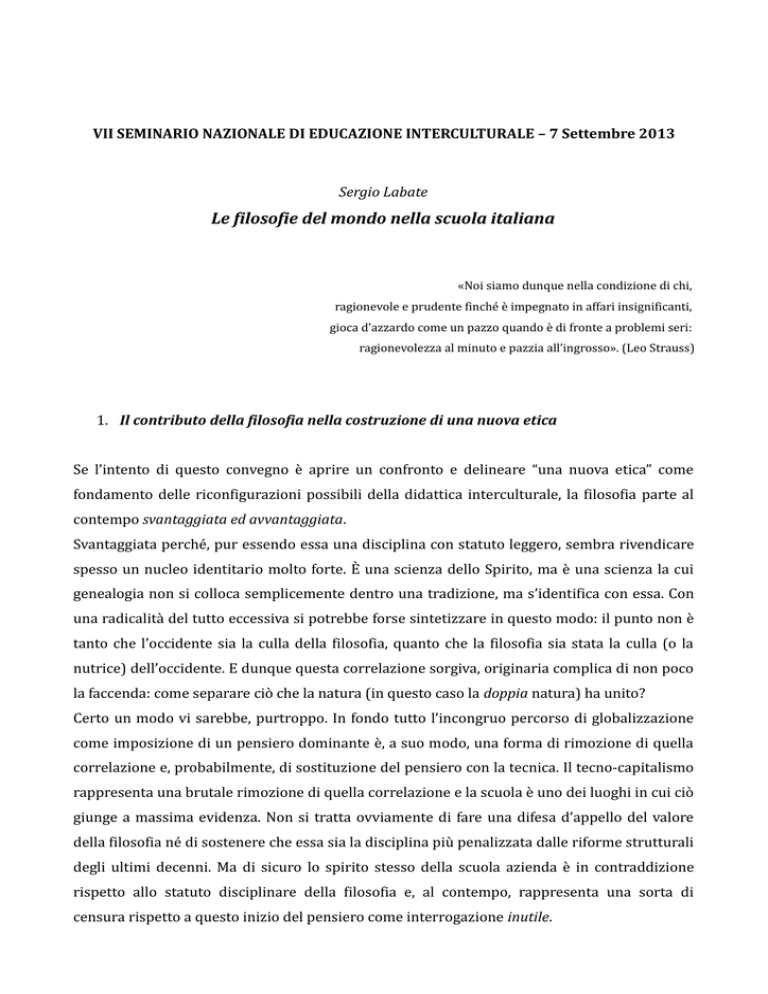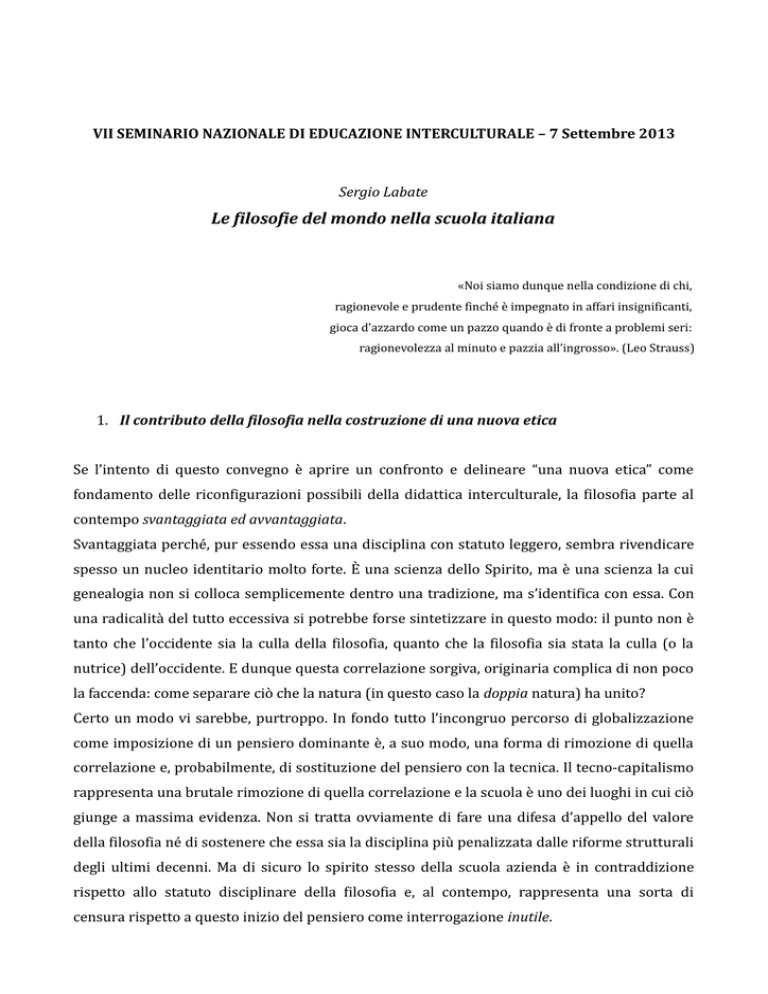
VII SEMINARIO NAZIONALE DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE – 7 Settembre 2013
Sergio Labate
Le filosofie del mondo nella scuola italiana
«Noi siamo dunque nella condizione di chi,
ragionevole e prudente finché è impegnato in affari insignificanti,
gioca d’azzardo come un pazzo quando è di fronte a problemi seri:
ragionevolezza al minuto e pazzia all’ingrosso». (Leo Strauss)
1. Il contributo della filosofia nella costruzione di una nuova etica
Se l’intento di questo convegno è aprire un confronto e delineare “una nuova etica” come
fondamento delle riconfigurazioni possibili della didattica interculturale, la filosofia parte al
contempo svantaggiata ed avvantaggiata.
Svantaggiata perché, pur essendo essa una disciplina con statuto leggero, sembra rivendicare
spesso un nucleo identitario molto forte. È una scienza dello Spirito, ma è una scienza la cui
genealogia non si colloca semplicemente dentro una tradizione, ma s’identifica con essa. Con
una radicalità del tutto eccessiva si potrebbe forse sintetizzare in questo modo: il punto non è
tanto che l’occidente sia la culla della filosofia, quanto che la filosofia sia stata la culla (o la
nutrice) dell’occidente. E dunque questa correlazione sorgiva, originaria complica di non poco
la faccenda: come separare ciò che la natura (in questo caso la doppia natura) ha unito?
Certo un modo vi sarebbe, purtroppo. In fondo tutto l’incongruo percorso di globalizzazione
come imposizione di un pensiero dominante è, a suo modo, una forma di rimozione di quella
correlazione e, probabilmente, di sostituzione del pensiero con la tecnica. Il tecno-capitalismo
rappresenta una brutale rimozione di quella correlazione e la scuola è uno dei luoghi in cui ciò
giunge a massima evidenza. Non si tratta ovviamente di fare una difesa d’appello del valore
della filosofia né di sostenere che essa sia la disciplina più penalizzata dalle riforme strutturali
degli ultimi decenni. Ma di sicuro lo spirito stesso della scuola azienda è in contraddizione
rispetto allo statuto disciplinare della filosofia e, al contempo, rappresenta una sorta di
censura rispetto a questo inizio del pensiero come interrogazione inutile.
C’è dunque un primo modo di reagire a questa deriva che, se da un lato enfatizza
nostalgicamente il ruolo e la funzione trascendentale della filosofia, dall’altro ne irrigidisce
proprio quel legame originario con la storia dell’occidente. È evidente allora che una nuova
etica interculturale deve recuperarsi, per ciò che concerne la filosofia, schivando queste due
derive: la deriva tecnocapitalista e la deriva neoclassicista. Ecco perché, spesso, la didattica
della filosofia appare più sensibile alla svolta tecnologica piuttosto che alla svolta
interculturale: perché la prima può apparire, al limite, come una patologia dell’occidente;
mentre la seconda mette in discussione quell’intrigo naturale di libertà di pensiero e sua
necessaria contestualizzazione storica. In fondo la presunzione occidentale è anche una sorta
di rifugio per la filosofia, rifugio a cui ancorare l’ansia di rivalutazione contemporanea.
È evidente che l’approccio che voglio seguire sia del tutto differente. Più chiaramente: se la
filosofia si fa mettere in discussione dall’esperienza interculturale lo fa radicalmente, non
conservativamente. Da questo punto di vista mi pare si possa riconoscere un dato di partenza
assai salutare. Mentre tutte le altre “svolte” sistemiche (mi riferisco all’aziendalizzazione,
all’introduzione della tecnologia, all’egemonia dei modelli quantitativi di valutazione della
didattica) sono state imposte, la svolta interculturale è giunta del tutto involontaria, malgrado
sé, si potrebbe aggiungere. Il che vuol dire che mentre le altre svolte sistemiche acquisiscono
perlomeno il sospetto di essere dei “dispositivi di controllo sociale”, l’intercultura appare come
un paradigma necessario quanto incontrollato e non strumentale. Ecco, se penso al
mutamento di scenario degli ultimi decenni mi appare questa evidenza: qualche decennio fa il
paradigma interculturale era un contenuto ideale verso cui tendere (e far tendere i processi
didattici). Oggi esso è un’esperienza estesa e inconfutabile pur essendo diventato dal punto di
vista della percezione culturale e sociale (dei modelli etici presupposti) un contro-ideale.
Meglio così, in fondo. La forza del reale è molto più forte della contraffazione ideologica. E
anche la didattica della filosofia può salvarsi partendo da questo dato empirico generalizzato
che contesta l’ideologia dominante.
Si tratta allora di ripensare la genealogia della filosofia, per poter poi modulare le metodologie
didattiche di conseguenza. Per quanto scritto finora, ciò non solo è possibile ma è necessario.
Ma il punto decisivo è un altro: disancorare la filosofia alla sua origine occidentale vuol dire
compiere un’operazione classicamente filosofica. Non modificare la propria storia, ma
rileggerla criticamente per autocomprendersi in forma innovativa, valorizzando alcuni punti
d’ombra e ridimensionando alcuni caratteri che sono stati finora amplificati.
La filosofia parte allora avvantaggiata, perché la propria geneaologia – collocata storicamente
– non si risolve nella propria storia. Lo statuto disciplinare della filosofia è già una via eretica,
una messa a distanza da ogni storicismo egemonico (e già qui s’intravede la crisi dei modelli
didattici storicisti, che sono ancora prevalenti nell’insegnamento della filosofia).
Nello statuto disciplinare della filosofia vi sono tre caratteri che, a mio avviso, permettono di
contribuire alla costruzione di una nuova etica al servizio del compito formativo della scuola.
Questi tre caratteri sono: quello di essere un’interrogazione inutile, di offrire una saggezza
fronetica, di addestrare al pensiero critico.
a. La filosofia come interrogazione inutile. L’inutilità della filosofia la interpreto qui nel segno di
un addestramento teleologico. Non è necessario recuperare tutta la riflessione sulla tecnica
della filosofia del novecento, è sufficiente ritornare ad Aristotele. La filosofia insegna
l’intelligenza dell’azione, in quanto ogni azione tende ad un fine.
Ora, perché questo carattere dovrebbe essere rimesso al centro della pratica didattica della
filosofia sensibile alle esperienze interculturali? Per due motivi correlati, essenzialmente. Il
primo è che l’ideologia dominante è antiteleologica (con un po’ di provocazione – e senza
considerar troppo le analisi ultimative di Horkheimer-Adorno - si potrebbe addirittura
sostenere che sia anti-occidentale!). Se c’è un contesto in cui l’educazione sembra risolversi in
una analitica dei mezzi è proprio l’occidente. Basta leggersi l’ammonimento di Leo Strauss, per
comprenderne l’estensione attuale e l’applicazione di questa analitica dei mezzi:
la nostra scienza sociale è in grado di renderci sapientissimi ed ingegnosissimi circa i mezzi con cui raggiungere
questo o quel fine propostoci; ma si confessa incapace di aiutarci nella distinzione tra fini legittimi ed illegittimi,
tra fini giusti e ingiusti. Una tale scienza è strumentale, e nulla più che strumentale: è nata a servire qualsiasi
potere e qualsiasi interesse. La nostra scienza, se alla coerenza preferisse (e Dio solo sa perché) un generoso
liberalismo, farebbe oggi quello che scopertamente fece il Machiavelli: darebbe consigli, con uguale competenza e
zelo, tanto ai tiranni quanto ai popoli liberi. Per la nostra scienza sociale, noi possiamo essere o diventare sapienti
in tutti gli argomenti di secondaria importanza, ma dobbiamo rassegnarci alla totale ignoranza riguardo alla cosa
più importante: nulla ci è dato sapere rispetto ai principi ultimi delle nostre scelte, cioè rispetto alla loro validità
o mancanza di validità; i nostri principi ultimi non hanno fondamento che le nostre arbitrarie, e quindi cieche,
preferenze1.
La mia convinzione è che questo carattere teleologico – decisivo per lo statuto disciplinare
della filosofia – sia oggi un deposito immanente ad altre tradizioni, ad altre culture, ad altre
concezioni del mondo. Basti pensare, per fare un esempio, alla tradizione africana. Ecco un
paradosso interculturale ricco di benefici, per la didattica della filosofia: dis-identificarsi con
l’occidente per trovare depositate nell’alterità parti essenziali di sé.
1 L. Strauss, Diritto naturale e storia, il Melangolo, Genova 2009, pp. 34-35.
b. La filosofia come saggezza fronetica. Si tratta allora di lavorare concretamente su tratti di
attualità di altre tradizioni per riappropriarci anche della nostra, secondo un movimento di
andata e ritorno. Tra pochissimo farò alcune proposte applicative per questa rieticizzazione
del mondo, cui la formazione filosofica può contribuire. Voglio però sottolineare un altro tratto
a mio avviso essenziale, che discende facilmente dal primo. In fondo proprio la filosofia
classica occidentale ha rappresentato bene il contromovimento rispetto alla ragione
strumentale che l’occidente ha imposto come paradigma antropologico ed etico. Si può
interpretare la saggezza fronetica proprio in questo modo: essa era originariamente un invito
a non separare scienza dei fini e scienza dei mezzi: «il fine appartiene alla stessa scienza cui
appartengono i mezzi»2. La faccenda, per certi versi, può apparire banale. A ben guardare ha
però delle ricadute assai radicali rispetto alla configurazione della didattica della filosofia.
Essa è infatti tutta strutturata in una sorta di progressismo o di architettura delle scienze, per
cui il contenuto della filosofia è essenzialmente filosofia teoretica e la forma della sua
esposizione è storicamente situata. Ma in questo modo ciò che si sacrifica è precisamente la
natura maieutica del metodo filosofico: la filosofia come comunità di ricerca avente come
oggetto non se stessa ma la ricerca e l’espressione del senso. Un ritorno della filosofia a un
“buon uso classico” della saggezza fronetica servirebbe così non solo ad ammettere come
contenuto filosofico tutto ciò che è “esperienza del pensiero” e ad estendere il registro delle
metodologie filosofiche, lavorando sul rigore argomentativo come autorappresentazione di un
sistema o di una tradizione piuttosto che come sigillo di certificazione esterna (questo è
filosofico, quest’altro non lo è) 3. Servirebbe anche a orientare le pratiche d’aula, per esempio
mettendo definitivamente fuori gioco l’uso prevalente della lezione frontale, una
rappresentazione del primato della contemplazione sull’azione. Molto semplicemente, se la
domanda è: esiste un’etica nella filosofia? I greci davano già una risposta precisa: la filosofia è
un’esperienza etica del mondo in quanto è esperienza che connette i mezzi e i fini attraverso la
co-implicazione del senso.
c. Il pensiero critico. Poiché non credo – come ho avuto modo già di spiegare – che la saggezza
fronetica sia stata solo smentita dal discorso filosofico della modernità, mi pare corretto
menzionare, come ultimo contributo specifico della filosofia ad una nuova etica e ad una
nuova scuola il ricorso e la prevalenza del pensiero critico. Esso, che ha segnato la stagione
2 Aristotele, Fisica, 194a 26-27.
3 Sul tema cfr. E. Ruffaldi - M. Trombino, L’officina del pensiero. Filosofia in aula, Led, Milano 2004; E. Ruffaldi,
Insegnare filosofia, Edizioni del Giardino dei Pensieri, Bologna 2012.
della modernità, mi appare un’eredità precisa della saggezza fronetica. Che vuol dire oggi
insegnare la filosofia come una gigantesca (e non esclusiva) storia del pensiero critico (e
dunque storia delle culture e delle loro smentite, delle religioni e delle sue eresie, dei metodi
didattici e delle loro disdette)? Provo a mostrarlo ricorrendo ancora a Leo Strauss il quale,
chiedendosi che cosa sia questa scienza politica che ha sostituito la filosofia politica, ci
suggerisce questa soluzione, che sia molto più semplice passare «dal governo degli uomini
all’amministrazione delle cose»4. A parte che questa mi appare un’intuizione che si applica a
molte sfere (per esempio spiega benissimo la vita interiore deprivata dell’inconscio), ma che
cosa ha comportato questo passaggio che ha ridotto sia l’economia sia la politica ad una
crematistica? Tutto il progetto di destrutturazione dell’istituzione scolastica si basa su questo
scivolamento. Penso banalmente ai processi di valutazione che sono, anche nella scuola, una
semplice amministrazione oggettiva. I passaggi di questo scivolamento sono trasparenti: la
scuola era, un tempo, una comunità di persone. Ma, nell’istante in cui anche il governo delle
persone è diventato definitivamente e assolutamente amministrazione delle cose, non c’è stata
più una comunità dove situare la comunità scolastica: è possibile situare una comunità in un
mercato5? È molto più probabile che anche quel pezzo di comunità diventi esso stesso a
misura del mercato che lo domina, lo sovrasta, lo sopraffà, soprattutto lo finanzia. Altro
esempio: il nostro costante richiamo alle competenze. Ma che sono le competenze se non le
specifiche forme attraverso cui il sapere viene giudicato sulla base della sua prevedibilità
fattuale? Il saper fare è anche un prevedere (ancora di più: un pregiudicare) che cosa si farà
con quel sapere. Tutta la nostra scienza diventa una buona pratica: il cui valore è riproducibile,
universalizzabile, insomma perfettamente prevedibile. Diventa un’amministrazione delle cose,
senza che vi sia più alcun governo delle persone. La competenza è - ovviamente esagero! l’opposto categoriale del pensiero critico. Ecco, la filosofia si oppone a questo dispositivo, il
pensiero critico si oppone a ogni dogmatismo valutativo. Non c’è alcun saper fare che certifica
il sapere, se non altro perché c’è sempre un evento del sapere che sorprende ciò che avevamo
previsto di saper fare con quel sapere. Se la pratica educativa è essenzialmente una pratica di
liberazione, l’ipertrofia delle competenze è una pratica di cattività.
4 Leo Strauss, Diritto naturale…, cit., p. 145. L’affermazione di Strauss è una critica alla società moderna e
un’apologia della polis greca: «Per raggiungere la sua più alta statura, l’uomo deve vivere nella migliore specie di
società, in quella che meglio conduce all’umana eccellenza. I classici chiamavano la società ideale politeia. Con
questa espressione essi indicavano, innanzitutto, che, per essere buona, la società deve essere società civile o
politica, una società in cui esiste un governo degli uomini e non solo un’amministrazione delle cose».
5 Sul tema rimando a R. Mancini, La logica del dono. Meditazioni sulla società che credeva di essere un mercato,
EDB, Bologna 2011.
L’ultimo esempio è legato precisamente al paradigma interculturale. Mi ha sempre colpito,
almeno in Italia, questo acefalo stare al passo coi tempi. In fondo, lo scrivo brutalmente e avrei
bisogno di più agio, la scuola ha dovuto fare i conti con almeno due svolte: quella tecnologica e
quella interculturale. Che la tecnologia abbia modificato le pratiche di studio è un dato
empiricamente evidente quanto il fatto che le nostre aule sono diventate laboratori di
convivenza. Però mentre la prima svolta è stata da subito vissuta come un’opportunità, la
seconda svolta è stata da subito rimossa o, ancor di più, osservata con diffidenza. Di certo i
programmi scolastici si sono modificati in funzione della rivoluzione digitale, ma nessuno
davvero vuole modificarli per ciò che concerne l’intercultura. La filosofia continua a essere la
filosofia occidentale. l’ora di religione continua ad essere storia della religione (quando va
bene!) ma non certo storia delle religioni. Non parliamo poi della storia.
Ora, oltre ad una pletora di pregiudizi e interessi economici, io credo che uno dei motivi
cognitivi di questa dissonanza sia rintracciabile nella suggestione di Strauss. Il nostro incanto
nei confronti della tecnologia è dovuto in buona parte al fatto che esso ci aiuta
nell’amministrazione delle cose, ci rende la vita scolastica più facile, più “accessibile”. Ma,
contemporaneamente, essa non si occupa affatto del governo delle persone, persino quando
potrebbe facilitarlo. Non se ne occupa non per un difetto di fabbricazione ma per un suo
specifico limite epistemologico.
Lo stesso discorso, rovesciato, si può applicare alla svolta interculturale. Essa viene rimossa
perché concerne inevitabilmente il governo delle persone e non può essere gestita, controllata
e valutata attraverso una semplice amministrazione delle cose. Ecco tutto.
2. Applicazioni
Molte sono le conseguenze applicative di questi caratteri appena esposti (e non solo di essi)
per l’insegnamento della filosofia. Si tratta, con questa accortezza sistemica, di eludere alcuni
pregiudizi piuttosto semplificatori.
Il primo lo definirei pregiudizio dell’aggiunta. Esso consiste nel sostenere che l’intercultura
sarebbe in fondo un argomento tra gli altri da aggiungere alla sequela storico-filosofica del
programma. Essa sarebbe certo un modo per illudersi di contenere le alterità che si
manifestano nelle aule senza mettere in discussione se stessi e l’autocomprensione della
filosofia occidentale, senza cioè andare alla radice della questione che è precisamente di
(cercare di) dis-identificare l’intrigo tra filosofia e occidentalizzazione (ciò che Mancini
definisce come la messa in discussione «delle fonti della coscienza filosofica»). Ma non è
soltanto questo. È anche e soprattutto un’opera di sussunzione, un ritorno al colonialismo
nella forma apparentemente tenue dell’addomesticamento.
Il secondo lo definirei pregiudizio dell’estensione comparativa. L’idea che per stare al passo con
la svolta interculturale si tratta di estendere i confini fisici della filosofia, immagazzinando una
serie di tradizioni e comparandole 6. È la versione didattico-filosofica del modello
multiculturalista. Essa però comporta alcune conseguenze deteriori non di poco conto.
Innanzitutto un’idea meramente quantitativa della filosofia, come se essa fosse semplicemente
una scienza dei contenuti e non piuttosto una scienza dei nessi. In secondo luogo una forma
insoddisfacente di sinossi delle tradizioni senza che esse s’incontrino davvero. È
un’intercultura senza meticciato, si potrebbe dire. E al contrario credo che l’opzione più
feconda per la filosofia sia proprio quella di meticciarsi. Per dirla in termini più tradizionali, la
filosofia deve scegliere tra il paradigma della ripetizione (nella forma dell’estensione
comparativa) e quello della disseminazione (nella forma della contaminazione) 7.
Infine, il pregiudizio della propedeutica dell’intenzione. Intendo con ciò riferirmi a quel
particolare pregiudizio per cui l’attenzione interculturale sia per la filosofia una sorta di
propedeutica buona intenzione da applicare al proprio mondo particolarissimo. Come
insomma se, nei fatti, l’intercultura richiedesse una semplice trasfigurazione dell’intenzione
che opera nelle nostre pratiche didattiche. Fosse niente altro che una buona intenzione. Dei tre
pregiudizi è di sicuro quello più in buona fede ma non per questo è quello che fa meno danni.
C’è infatti in esso un residuo di paternalismo. Su questo la mia convinzione è molto salda: un
eccesso di stilizzazione non rende ragione della rivoluzione materiale che l’intercultura ha
apportato. Sono cambiati i processi d’interazione e di apprendimento e questa mutazione non
è una pia intenzione ma una modificazione della struttura sociale e dei suoi equilibri. Si tratta
in fondo di uno slittamento analogo a quanto fatto per l’associazionismo: dal concetto di
volontariato a quello di lavoro sociale. Allo stesso modo si tratta di passare dal principio
interculturale alla pratica interculturale. La cosa è particolarmente interessante per la
filosofia. Perché in fondo nella convinzione prevalente dei filosofi essa contiene in sé
un’intenzione di apertura che la rende naturalmente interculturale. Al contrario, la mia
convinzione è l’idea che la filosofia sia già aperta in sé, seppure sia una buona intenzione, non
6 Cfr. Per esempio C. J. Falicov, Insegnare a pensare secondo cultura. Una convincente comparativa
multidimensionale, in «Psicobiettivo», 20 (2000), 1, pp. 61-86.
7 Cfr. F. Laplantine, Identità e meticciato, Elèuthera, Milano 2011; P. Gomarasca, Meticciato: convivenza o
confusione?, Marcianum Press, Venezia 2009.
basti ad accogliere l’elemento perturbante delle pratiche interculturali. Aprirsi da sé è un
consolatorio lavoro di appropriazione, riconoscersi aperti da altri comporta un meno semplice
processo di alterazione.
Per schivare davvero questi pregiudizi, c’è bisogno di quel che prima ho definito una
“accortezza sistemica”. L’affacciarsi de «il mondo a scuola»8 richiede un ripensamento
complessivo dell’intera filiera didattica: dalla predisposizione degli obiettivi formativi, alla
stesura di nuovi programmi e di supporti innovativi non solo nel formato digitale, ai processi
di insegnamento e di valutazione dei percorsi.
Rimando a un’altra occasione alcuni di questi nodi e, in particolare, il nodo assai complesso e
assai attuale che concerne proprio le pratiche di valutazione e mi concentro brevemente su tre
temi che mi appaiono di forte rilevanza.
a. la trasformazione dei metodi didattici. È evidente che per evitare i pregiudizi appena
menzionati, la dimensione dialogale della filosofia debba diventare preponderante. Ricordo
solo, per correttezza, che già Socrate insegnava l’arte della dialettica dialogale come una delle
forme di distinzione dalla sofistica. La lotta per la supremazia tra lezione frontale e scene
dialogali riproduce così la lotta per la supremazia tra contemplazione e dialeghestai. Solo che
contemplazione e dialeghestai non erano all’origine in opposizione ma del tutto
complementari. È così paradossale che proprio la filosofia diffidi dell’utilizzo più ampio del
metodo dialogale, come se esso fosse riservato alle arti, cioè a tutto ciò che non abbisogna di
regole rigorose. È questa una considerazione del tutto falsa. Già in Platone e poi in Aristotele lo
statuto dell’arte non si distingue per la mancanza di rigore ma per la natura differente
dell’oggetto di riferimento. Per imitare la realtà, per esempio, vi è una necessità di esercitare
un metodo assai forte. Insomma, la filosofia deve uscire da questo paradosso per cui il dialogo
sembra una degradazione del proprio metodo e dunque una trasgressione del proprio statuto
epistemologico. Torniamo a Socrate piuttosto e alle sue scuole: il dialeghestai ha una sua
metodologia (peraltro assai filosofica, la dialettica), delle sue regole e si deve imparare. Un
docente di filosofia che conosca bene tutta la storia della filosofia ma non sia in grado di
condurre un dialogo filosofico ha un limite che non è soltanto didattico, è anche filosofico. Il
dialogo, oltre tutto, consente di elaborare didattiche della filosofia attente a due “frontiere
epistemologiche” decisive per la sensibilità contemporanea.
La prima frontiera è rappresentata dall’unificazione del soggetto coinvolto. Se anche la
filosofia occidentale contemporanea si mette in discussione per ciò che riguarda il pregiudizio
8 È il titolo dell’importante convegno tenutosi recentemente presso l’Università di Macerata e dedicato proprio a
questo tema.
dualista, possiamo riconoscere che le altre tradizioni e culture, da questo punto di vista,
possono apportare degli stili ricorrenti ben differenti e che riescano a tener salda invece il
calore dell’essere umano unificato. L’intercultura non auspica ma richiede necessariamente il
congedo dal paradigma dualista. Al contrario, la didattica della filosofia è ancora costruita e
pensata presupponendo il dualismo: disconosce la funzione conoscitiva del corpo e la
differenza di genere come criterio di selezione delle informazioni apprese, canalizza la
relazione d’apprendimento della filosofia in forma puramente mentalistica. L’idea insomma
che non possano esistere (se non eccentricamente) dei “laboratori di filosofia” 9. Al contrario,
io credo che una forza che la filosofia può trarre dalla svolta interculturale sia precisamente
quella di immaginarsi nella forma del laboratorio, esattamente quanto le scienze empiriche.
Mi verrebbe da dire che una definitiva messa a parte del metodo tradizionale in favore di una
svolta dialogica permetta una didattica sensibile della filosofia: una didattica finalmente
incarnata e attenta alle differenze (siano essere generazionali, di genere, ecc…). La scuola
appare oggi un contesto in cui le uniche differenziazioni vengono ipotizzate prendendo in
considerazione esclusivamente la differenza sociale e/o la differenza cognitiva.
La seconda frontiera si riconosce laddove noi valorizziamo l’originaria natura dialettica della
filosofia. Essa, lungi dall’essere immunizzata dall’alterità ne è da sempre attraversata. E la
dialettica non è mai stata (quasi mai) un metodo per addomesticare l’altro ma,
principialmente, un metodo per far apparire l’altro senza averne paura. L’alterità che il metodo
dialettico della filosofia ospita non è dunque un’alterità sotto condizione: è lo straniero,
l’ospite, colui che appartiene ad altre tradizioni di pensiero, ecc.
b. Né storia né concetti, ma questioni. La didattica della filosofia ha ancora un’impronta
storicistica. È inevitabile ma non è affatto inemendabile. Si tratta molto semplicemente di non
fare del tempo storico uno spazio unico (l’errore di Hegel: «il tempo è lo spazio della storia»)
ma di spazializzare la storia in modo plural10e. Su questo varrebbe la pena approfondire
ulteriormente oltre quel che posso fare adesso. Ma a volte mi pare che la didattica della
filosofia abbia scelto per uscire da questa impasse la via breve della sostituzione della storia
9 Sul tema F. C. Manara, Comunità di ricerca e iniziazione al filosofare. Appunti per una nuova didattica della
filosofia, Lampi di stampa, Milano 2004, pp. 157-178.
10 Basti pensare, a titolo di esempio, come un’opera che ha come suo compito esplicito proprio la
spazializzazione della filosofia per via didattica si dimentichi però di compiere tale esercizio in forma plurale,
limitandosi preventivamente all’occidente. Cfr. M Pancaldi - M. Trombino – M. Villani, Atlante della filosofia,
Hoepli, Milano 2006.
con i concetti. Anche questa svolta lungimirante e che ha portato tanti vantaggi. Io credo però
che la filosofia abbia ereditato uno stile specifico che può essere utile nel contesto
interculturale. La filosofia non parte da concetti ma parte da questioni. Il suo metodo è
interrogativo, in prima battuta. È probabile che questo metodo interrogativo sia
particolarmente utile rispetto all’interlocuzione tra filosofie del mondo. Perché le storia delle
risposte alle questioni si sono ipostatizzate nelle differenti culture e tradizioni; i concetti che
hanno definito tali risposte si sono rappresi in metodi e forme di argomentazione differenti.
Ma sia le storie sia i concetti partono probabilmente da una radice comune che si può mettere
a fuoco didatticamente attraverso una ricorsività delle questioni. Un suggerimento didattico
potrebbe addirittura spingersi oltre: la ricorsività delle questioni, oltre che punto di partenza,
non può essere anche un punto di arrivo per esempio della valutazione? Voglio con questo dire
che, se si è inevitabilmente costretti a un programma e a una delineazione delle posizioni
filosofiche più rilevanti, nulla vieta di comprendere la storia della filosofia non soltanto come
storia delle risposte ma anche come storia delle domande sempre possibili, sempre rilanciate,
sempre dette in molti modi. Inoltre, questa preferenza accordata permette di ripensare il
profilo complessivo della didattica della filosofia: essa deve essere ripensata non solo come
didattica della filosofia già data, ma anche come didattica del filosofare (ancora la rilevanza dei
laboratori filosofici)11.
c. la rivalorizzazione dei testi. Credo infine che, accanto alla preferenza per le questioni, si
debba fare tesoro dell’unica vera e propria novità dei manuali di storia della filosofia degli
ultimi decenni: la mediazione necessaria dei testi. Perché la svolta interculturale richiede
un’ulteriore accelerazione di tale mediazione? Molto semplicemente, perché ogni cultura e
ogni pensiero comune, pur basandosi su metodi differenti, risponde a medesime questioni e si
deposita prevalentemente in testi magistrali. La scrittura finisce così per diventare un
11 «Se si crede nell’insostituibile efficacia dello studio della filosofia, bisogna prendere la filosofia per quello che
veramente è, e non surrogarla con meri e perciò fatalmente dogmatici nozionismi sociologici, psicologici,
antropologici, economici, con illusorie e presunte “metodologie didattiche”, con scorciatoie “operative” (i
famigerati “percorsi” all’insegna del “taglia e cuci” e del “fai da te scopiazzando qua e là”, dell’informazione
multimediale che sostituisce il pensare con il gioco dell’oca, e di altri alibi innumerevoli, purché evitino la fatica di
leggere e di capire, e poi di ripetere e di esprimere in modo corretto ed efficace), infine con testi scolastici
indigeribili da parte dei ragazzi e in realtà scritti per il comodo dei docenti, sempre più restii o addirittura
incapaci di studiare, inventare, sintetizzare, spiegare, cioè di amare e frequentare davvero la filosofia (il che non
potrà mai essere stabilito con decreto legge o monte ore, o suggerito dai cosiddetti corsi di aggiornamento, il cui
livello è sovente quanto di più umiliante, vergognoso e cinicamente finto si possa immaginare). La filosofia va
presa tutta intera e per quella che veramente è. Essa non è né agevolmente né proficuamente ripetibile in
maniera metodologica (come se si trattasse di studiare la mineralogia, ecc.). […] Si tratta di fare bene quello che si
fa. Cioè si tratta di varcare la soglia della comprensione autentica, il che, come è noto, non è in diretta o
automatica relazione alla quantità delle nozioni apprese» (C. Sini, Il Manifesto della città dei filosofi, in
«Informazione filosofica» n. 32 [1997], p. 32).
irriducibile interculturale. La conseguenza più urgente di questa consapevolezza è la necessità
di ripensare i manuali in uso nella scuola avendo cura di inserirci più fonti possibili della
coscienza filosofica12. Manuali che contengano testi fondamentali per le differenti culture del
mondo e che permettano, a partire dalla loro presentazione, un adeguato lavoro comune di
traduzione degli intraducibili13.
Da questo punto di vista aggiungerei un’ultima annotazione: se la svolta ermeneutica ha avuto
sufficiente riguardo in questi decenni, incrementando indubbiamente la mediazione dei testi
(seppure nel limitato perimetro della tradizione occidentale) nell’esperienza didattica della
filosofia, credo che essa debba accompagnarsi a un contestuale incremento dell’utilizzo della
scrittura filosofica. Testi scritti e testi da scrivere, insomma: in modo che il paradigma della
traduzione degli intraducibili offra tutte le sue potenzialità.
In questo compito infinito l’intercultura trasforma anche la filosofia e diviene essa stessa
pratica interfilosofica. Del resto, non è questa traduzione degli intraducibili l’origine stessa
della filosofia, il suo stupore dinanzi alle cose prime?
12 E’ assai apprezzabile, da questo punto di vista, la nascita di una collana presso la casa editrice specializzata de
Il Giardino dei Pensieri dedicata proprio alle “Guide allo studio delle filosofie non occidentali”. Resta da capire se
quest’opzione sia sufficiente in relazione all’attuale tendenza della scuola italiana ad ospitare sempre più culture.
Per quel che mi consta, l’unico volume per ora uscito della collana è F. Dipalo, Introduzione al pensiero buddhista,
Edizioni del Giardino dei Pensieri, Bologna 2012.
13 Sul tema. Cfr. C. Canullo, La traduzione come esperienza di mediazone nel dialogo tra le culture, in F. Mora – L.
Ruggiu, Soggettività, ontologia, linguaggio, Cafoscarina, Venezia 2010, pp. 83-102.