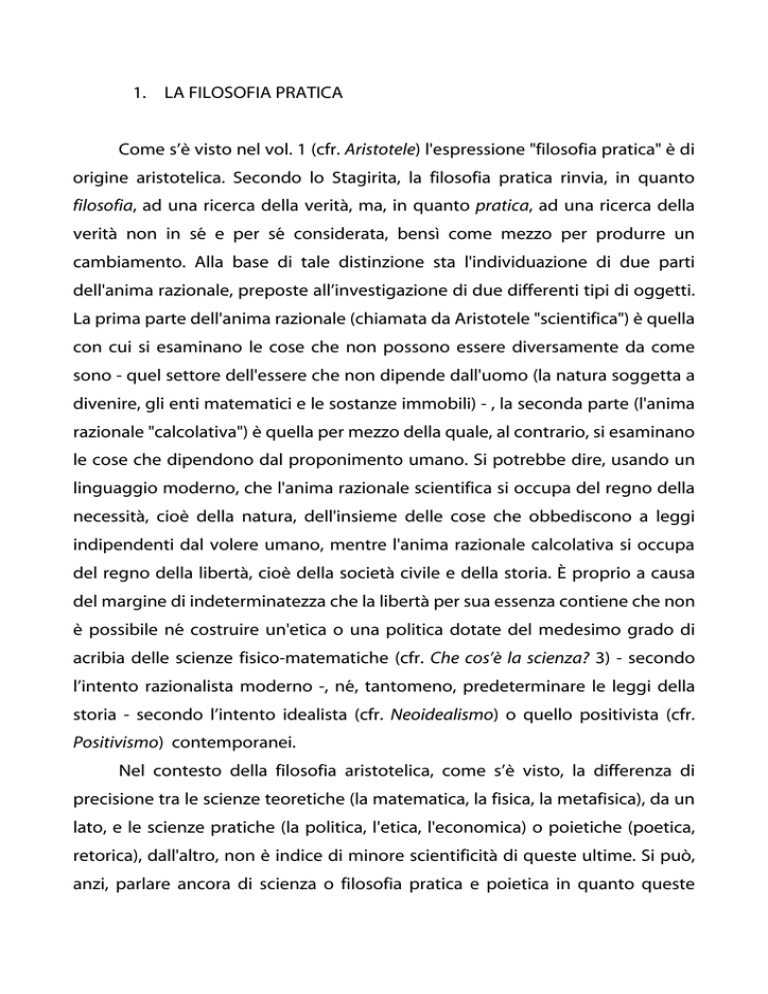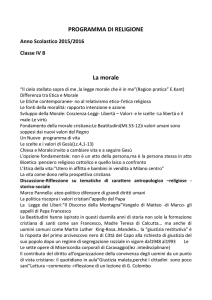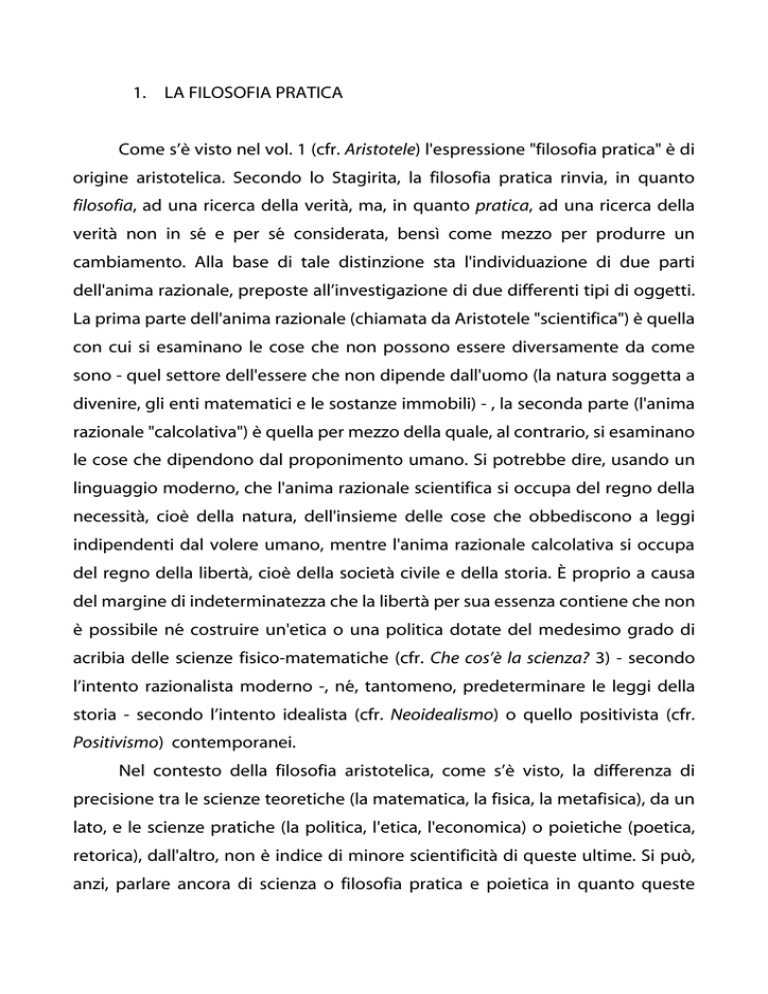
1.
LA FILOSOFIA PRATICA
Come s’è visto nel vol. 1 (cfr. Aristotele) l'espressione "filosofia pratica" è di
origine aristotelica. Secondo lo Stagirita, la filosofia pratica rinvia, in quanto
filosofia, ad una ricerca della verità, ma, in quanto pratica, ad una ricerca della
verità non in sé e per sé considerata, bensì come mezzo per produrre un
cambiamento. Alla base di tale distinzione sta l'individuazione di due parti
dell'anima razionale, preposte all’investigazione di due differenti tipi di oggetti.
La prima parte dell'anima razionale (chiamata da Aristotele "scientifica") è quella
con cui si esaminano le cose che non possono essere diversamente da come
sono - quel settore dell'essere che non dipende dall'uomo (la natura soggetta a
divenire, gli enti matematici e le sostanze immobili) - , la seconda parte (l'anima
razionale "calcolativa") è quella per mezzo della quale, al contrario, si esaminano
le cose che dipendono dal proponimento umano. Si potrebbe dire, usando un
linguaggio moderno, che l'anima razionale scientifica si occupa del regno della
necessità, cioè della natura, dell'insieme delle cose che obbediscono a leggi
indipendenti dal volere umano, mentre l'anima razionale calcolativa si occupa
del regno della libertà, cioè della società civile e della storia. È proprio a causa
del margine di indeterminatezza che la libertà per sua essenza contiene che non
è possibile né costruire un'etica o una politica dotate del medesimo grado di
acribia delle scienze fisico-matematiche (cfr. Che cos’è la scienza? 3) - secondo
l’intento razionalista moderno -, né, tantomeno, predeterminare le leggi della
storia - secondo l’intento idealista (cfr. Neoidealismo) o quello positivista (cfr.
Positivismo) contemporanei.
Nel contesto della filosofia aristotelica, come s’è visto, la differenza di
precisione tra le scienze teoretiche (la matematica, la fisica, la metafisica), da un
lato, e le scienze pratiche (la politica, l'etica, l'economica) o poietiche (poetica,
retorica), dall'altro, non è indice di minore scientificità di queste ultime. Si può,
anzi, parlare ancora di scienza o filosofia pratica e poietica in quanto queste
discipline posseggono una razionalità propria, cioè un metodo. Nel caso della
scienza o filosofia pratica tale metodo è quello dialettico.
A sua volta la filosofia pratica si distingue in pratica in senso stretto e in
poietica: la prima ha come scopo la perfezione dell'azione, la buona condotta,
mentre la seconda ha come scopo la perfezione dell'oggetto prodotto
dall'azione.
Si ricorderà anche che la capacità della ragione umana di guidare l'azione
in maniera retta, cioè di riconoscere quali azioni sono buone e quali cattive, è
chiamata da Aristotele phronesis. Su tale facoltà si sono recentemente
incentrate le attenzioni di un insieme molto variegato di studiosi: si tratta del
movimento
della
cosiddetta
“Riabilitazione
della
filosofia
pratica”
(Rehabilitierung der praktischen Philosophie), sviluppatosi in Germania tra gli anni
Sessanta e gli anni Settanta. Franco Volpi - uno degli studiosi italiani piú attento
agli sviluppi di questo movimento - afferma che l'espressione riabilitazione della
filosofia pratica "designa in generale la rinascita in ambito filosofico di un
interesse per i problemi della morale, della società e della politica, la cui finalità
più o meno esplicitamente dichiarata è la riproposizione filosofica del problema
dell'agire moralmente giusto, del problema del buon vivere in ambito privato e
in ambito politico, nonché del problema del buon ordinamento politico
fondamentale".
1.1 Verso una scienza dell’agire
La maggioranza degli esponenti di questo movimento di riabilitazione
della filosofia pratica aristotelica ha ritenuto di individuare nella nozione di
phronesis una preziosa risorsa cui attingere per risolvere le aporie che, a loro
giudizio, affliggono irrimediabilmente le teorie etiche e politiche formatesi
all'interno del grande alveo del razionalismo moderno, sia esso di carattere
innatistico o empiristico.
Per comprendere meglio tale mossa, sarà utile
2
prendere ora le mosse proprio da uno dei principali ispiratori della
riattualizzazione della filosofia pratica aristotelica: Erich Voegelin. Nell'opera che
l'ha imposto all'attenzione della comunità scientifica, La nuova scienza politica
(1952), Voegelin esordisce indicando il compito del filosofo politico oggi:
occorre restaurare la scienza politica, tornando alla consapevolezza dei suoi
principi, prendendo le mosse dalla concreta situazione storica della nostra
epoca. Se la scienza politica va restaurata, ciò significa che essa è stata in
precedenza danneggiata da qualcosa; secondo Voegelin, infatti, grandi sono
stati i danni prodotti in particolare dal cosiddetto positivismo (cfr.), il quale
muoveva dall’assunto che i metodi delle scienze naturali sono criteri di validità
teorica in generale, cioè che se una disciplina non applica i metodi delle scienze
fisico-matematiche non possiede alcun rigore scientifico. Tale assunto
subordina la validità teorica di una disciplina al metodo che essa usa. Ciò è
sbagliato, in quanto il metodo non può essere assolutizzato, essendo
dipendente dalla sua capacità di svelare ciò che è ignoto e chiarire ciò che è
confuso. In altre parole, una disciplina è scientifica se coglie la verità, non se
applica un certo metodo. Voegelin ricorda che nell'impostazione filosofica
aristotelica di taglio realistico il metodo è imposto dall'oggetto e, quindi, vi sono
tanti metodi quanti tipi di oggetti si danno.
Il positivismo ottocentesco e novecentesco cui fa riferimento Voegelin è
strettamente dipendente da una concezione della filosofia impostasi con la
modernità: l'idea che solo i metodi tipici delle scienze fisico-matematiche siano
scientifici è rintracciabile infatti nei fondatori della filosofia moderna e, in
particolare, nella filosofia morale e politica di autori quali Hobbes (cfr. ) e
Spinoza (cfr.), i quali coltivano il sogno di rifondare queste discipline applicando
il metodo geometrico. Un esito importante di tale impostazione è che le scienze
umane hanno sempre più dimostrato una grande capacità applicativa nello
studio di fenomeni macroscopici, grazie all'applicazione di metodologie
empiriche e/o matematiche (pensiamo alla sociologia contemporanea, alle sue
statistiche e ai suoi sondaggi), ma hanno perso la capacità di descrivere e
3
orientare la prassi individuale. L'etica e la politica moderne hanno perso la
capacità di dire qualcosa al singolo individuo che si trova di fronte a un
dilemma morale o a un problema politico, sono qualcosa percepito come
astratto dai non specialisti.
Avendo del tutto identificato la razionalità con la scientificità delle scienze
fisico-matematiche, insomma, il razionalismo moderno nega a tutti quegli
ambiti del reale che non sono approcciabili tramite metodi deduttivi o
sperimentali la possibilità di essere illuminati dalla ragione. La prassi umana
rientra all'interno di questi ambiti, a causa della sua casualità o imprevedibilità. Il
risultato è la sfiducia nei confronti della possibilità di guidare razionalmente la
prassi, che viene considerata come opera delle facoltà a-razionali dell'uomo,
innanzitutto della volontà. L'azione umana non è più illuminata da ragioni, da
fini giustificabili razionalmente; non è più possibile comunicare le proprie
intenzioni, mettere in discussioni i fini, discutere. La prassi umana appare come
tensione verso uno scopo non giustificabile; al limite, si può discutere intorno ai
mezzi, ma il fine è dato. La ragione - per usare una terminologia cara a Max
Horkheimer e alla Scuola di Francoforte (cfr.) - è puramente strumentale. Non
potendo più discutere i fini, la prassi umana - in cui l'individuo entra
necessariamente in rapporto con altri individui - appare come incontro/scontro
di azioni strategiche mutuamente incomprensibili, come una interazione di
corpi opachi. La convinzione della fondamentale irrazionalità delle azioni
umane contribuisce indubbiamente a creare un contesto sociale caratterizzato
da mancanza di comprensione e di rispetto per le opinioni e le scelte altrui e
favorisce la diffusione dell'intolleranza. L'irrazionalismo che caratterizza il
panorama culturale occidentale tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del
Novecento appare - in questa linea interpretativa - come l'esito della parabola
involutiva compiuta dal razionalismo moderno. Da questo punto di vista,
dunque la proposta avanzata dagli esponenti della cosiddetta Rehabilitierung è
fondamentalmente solidale con le istanze francofortesi.
4
1.2 La saggezza in senso aristotelico
A parere di tutti gli interpreti, momento decisivo per la Rehabilitierung è
stata la pubblicazione di Verità e metodo da parte di Hans Georg Gadamer nel
1960 (cfr. Le filosofie dell’interpretazione). Nella seconda parte di quest'opera, in
un paragrafo intitolato L'attualità ermeneutica di Aristotele, Gadamer propone il
recupero della nozione aristotelica di phronesis, intesa come sapere morale. La
phronesis è il sapere che guida l'azione (praxis), che la indirizza verso ciò che si
presenta come bene. Ora, il bene si presenta sempre nella concretezza delle
singole situazioni e, viceversa, colui che agisce deve vedere la situazione
concreta alla luce di ciò che in generale si esige da lui. Con ciò Gadamer non
intende negare la possibilità di un'indagine sul bene autonoma rispetto alla
prassi, cioè - per usare il linguaggio aristotelico - di una scienza pratica o - come
diremmo noi oggi - di un'etica filosofica, capace di chiarificare i fenomeni e
aiutare la coscienza morale a chiarificare se stessa. Il sapere teoretico (sophia) è
infatti distinto e autonomo rispetto al sapere morale. Egli sottolinea, però, che
tale etica filosofica deve partire dall'analisi della prassi per come essa
effettivamente si attua e deve ritornare infine a essa come orientamento della
deliberazione e dell'azione, pena la ricaduta nella situazione di astrattezza in cui
versano la maggior parte delle teorie etiche moderne.
Inoltre, così come ha distinto e messo in relazione il sapere pratico da
quello teoretico, altrettanto Gadamer ritiene opportuno distinguere il sapere
pratico da quello tecnico (cioè dal sapere che guida la poiesis, l'attività
produttiva, ovvero la techne). Al sapere tecnico la phronesis assomiglia in
quanto sapere, cioè in quanto guida dell'azione, che non è attuata in maniera
casuale. La differenza fondamentale sta invece nel fatto che l'uomo non
dispone di sé come il produttore della materia prima che egli plasma; l'uomo,
infatti, non si è fatto da solo e non può plasmarsi a suo piacimento. Detto in altri
termini: l’uomo è una creatura finita. La phronesis è un sapere che riguarda sé ai
5
fini di un cambiamento di sé, dove però l'oggetto della prassi, dell'azione, è solo
parzialmente disponibile. Inoltre, mentre il sapere tecnico si può avere o non
avere (io posso non saper costruire dei mobili senza che ciò mi impedisca di
essere pienamente uomo), il sapere pratico non si può non avere, in un grado o
in un altro, poiché l'uomo è sempre costretto a scegliere e ad agire. Un’ulteriore
differenza riguarda, infine, il rapporto tra mezzi e scopi. Il sapere tecnico sceglie
i mezzi particolari (le materie prime, le azioni che costituiscono le fasi
intermedie di un processo produttivo) per un fine definito e predeterminato
rispetto ai mezzi (il prodotto finale); il saper morale non ha fini particolari, ma
concerne la vita giusta nel suo insieme, di cui non si può avere - come nel caso
della produzione - una conoscenza ideale precedente l'azione, così come anche
dei mezzi non si può avere una conoscenza predeterminata rispetto alla
situazione concreta. La phronesis non si limita ad applicare un processo
idealmente predeterminato per raggiungere il proprio fine - il prodotto - come
fa la techne, ma sceglie i mezzi dall'interno della situazione concreta,
considerata alla luce di ciò che è giusto. In tal modo tra sapere morale e
esperienza morale risulta esserci una stretta interconnessione: la phronesis
aristotelica sembra effettivamente in grado di orientare la prassi individuale o
comunitaria e di assistere l'uomo di fronte a dilemmi morali o problemi politici.
1.3 Una vita attiva
Un posto indubbiamente importante nella riattualizzazione della filosofia
pratica aristotelica occupa l’opera pubblicata in Italia col titolo Vita activa, della
filosofa tedesca Hannah Arendt (l’originale, edito nel 1958 negli Stati Uniti,
porta il titolo The Human Condition, La condizione umana). L'istanza
fondamentale messa in campo dalla Arendt consiste nella riscoperta delle
caratteristiche della "vita activa", spesso dimenticate dai filosofi che
generalmente guardano alla condizione umana dal punto di vista della "vita
6
contemplativa". I filosofi non si limitano a sottolineare il primato della seconda
sulla prima, ma, all'interno della vita activa, stabiliscono il primato della
dimensione "poietica", produttiva, rispetto a quella "pratica" in senso stretto dell’"opera" sull'"azione", cioè, per usare il linguaggio arendtiano. Ciò è dovuto
al fatto che la produzione comincia sempre con un atto teoretico: la
contemplazione dell'idea-modello dell'oggetto che si intende produrre. La
produzione risulta così subordinata rispetto alla vita contemplativa, come
qualcosa di controllabile, cioè di prevedibile e ripetibile - come in effetti è la
produzione. La diffidenza del filosofo nei confronti dell'azione è determinata da
considerazioni analoghe, seppur di segno opposto. L'azione, infatti, essendo
caratterizzata da imprevedibilità e irreversibilità, sfugge a ogni controllo, anche
a quello dell'agente medesimo. L'azione non è il prodotto di una tecnica che
opera alla luce di un modello cui uniformarsi; essa obbedisce a un'esigenza
diversa, riconducibile in ultima istanza alla ricerca di una risposta alla domanda
"Chi sono io?". L'identità dell'individuo umano non è infatti, secondo questa
prospettiva filosofica, qualcosa di dato, che si possa cogliere mediante
un'intuizione intellettuale o che si possa racchiudere in una definizione; essa si
definisce proprio nell'azione, che la manifesta agli altri individui umani
attraverso molteplici segni, di tipo verbale o corporeo. Non è un caso che H.
Arendt leghi strettamente l'azione al discorso: entrambi concorrono alla
manifestazione dell'identità dell'agente, la quale è sempre parzialmente
sconosciuta agli altri come a lui stesso. L'uomo non può non agire, in quanto
non può non voler rispondere alla domanda circa la propria identità e una
risposta la può avere solo nello spazio pubblico del discorso e dell'azione, nel
rapporto con gli altri individui umani. Mediante l'azione l'uomo si distingue
dagli altri uomini dando luogo a quella "pluralità di esseri unici" che caratterizza
il mondo umano.
Agire significa dunque innanzitutto prendere un'iniziativa, cominciare
qualcosa (come indica il verbo greco archèin), mettere in movimento qualcosa
(che è il significato originale del latino agere). Essa si sottrae alle catene causali e
7
ai ragionamenti che procedono da premesse e giungono a conclusioni.
Attraverso di essa si manifesta quella spontaneità che è uno degli aspetti
fondamentali della libertà umana. L'azione è imprevedibile: essa - afferma
Arendt -, "dal punto di vista dei processi automatici che sembrano determinare
il corso del mondo, assomiglia a un miracolo". La nostra autrice ricorda spesso
un passo della Città di Dio di S. Agostino (cfr.), dove il padre della chiesa afferma:
"perché ci fosse un inizio, fu creato l'uomo".
L'azione, inoltre, è anche irreversibile in quanto, una volta pronunciata
una parola o compiuta un'azione, i loro effetti si comunicano nello spazio
pubblico senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'agente o di altri.
La riscoperta degli aspetti peculiari dell'azione è, quindi, effettuata dalla
Arendt in funzione polemica nei confronti del razionalismo presente in diverse
manifestazioni della modernità, il quale ha sempre puntato ad eliminare
l'imprevedibilità
e
l'irreversibilità
dell'azione,
riducendola
a
processo
metodologicamente controllabile. L'apoteosi di tale esigenza si sarebbe di fatto
realizzata grazie al totalitarismo novecentesco - di cui Arendt è stata tra i primi
studiosi con il suo famoso saggio sulle Origini del totalitarismo del 1951 - il quale
ha programmaticamente tentato di eliminare ogni spontaneità dall'agire
umano attraverso il sistema del terrore. Secondo Arendt, il sistema dei gulag
sovietici, così come dei lager nazisti, lungi dall'essere un aspetto accidentale di
regimi violenti, rappresenta il modello ideale di società che Stalin e Hitler
intendevano realizzare.
2. L’ETICA DELLE VIRTU'
2.1 Oltre la metaetica
8
Un’altra importante forma di ripresa della filosofia pratica aristotelica si
riscontra nel mondo filosofico di lingua inglese. Se si getta uno sguardo
sull'evoluzione della filosofia morale anglosassone nel secondo dopoguerra,
non si può evitare di scorgere un movimento vivace e difficile da catalogare in
correnti. Si può dire, comunque, che sino alla fine degli anni '60 il filone
prevalente, accanto a quello utilitaristico più tradizionale (vedi scheda), è stato
quello metaetico. La metaetica analitica si muove a partire dalla tesi della non
esistenza delle proprietà morali: gli enunciati morali non descrivono stati del
mondo e quindi non hanno alcun valore conoscitivo. La metaetica, di
conseguenza, si concentra sullo studio del linguaggio. Si sente ancora l'onda
lunga dell'interpretazione rigida della cosiddetta "grande divisione" humiana
tra essere e dover-essere (cfr. Hume), con cui il filosofo scozzese aveva messo in
serio dubbio la possibilità di attribuire un valore descrittivo, e quindi
conoscitivo, agli enunciati contenenti termini morali. Se tale impostazione
aveva portato negli anni '30 i neopositivisti logici (cfr. Neopositivismo) a negare
alcun significato agli enunciati morali, che vengono così considerati come mere
espressioni di emozioni (“emotivismo”), i filosofi morali analitici, soprattutto
quelli di scuola non positivista, incoraggiati dalla liberalizzazione semantica
operata dal secondo Wittgenstein (cfr.), vengono ad attribuire un significato
agli enunciati morali, pur negando loro un valore conoscitivo.
Verso gli anni '70 l'insoddisfazione verso tale approccio divenne sempre
più esplicita: quanto i filosofi morali contemporanei dicono ha poca o nessuna
rilevanza pratica ed è avulso dalla vita. È proprio in questo periodo che comincia
a manifestarsi un cambiamento del clima filosofico: in breve tempo le ricerche
in campo propriamente metaetico diminuiscono, mentre si diffondono gli studi
di etica normativa e applicata. Tale cambiamento non implica necessariamente
un abbandono della tradizione analitica, in cui l'etica normativa è presente sin
dalle origini. Si tratta, piuttosto, soprattutto negli USA, di un cambiamento nella
concezione del compito del filosofo, il quale viene considerato capace di dare
indicazioni rispetto a problematiche che la società solleva a partire da situazioni
9
concrete quali la moralità della guerra e la legittimità della disobbedienza civile,
il problema dell'aborto, del razzismo, i problemi di etica sessuale o ambientale.
In campo strettamente filosofico, è da ricordare la pubblicazione sempre nel
1971 di Una teoria della giustizia da parte di John Rawls (cfr. ?), un'opera la cui
influenza sul clima filosofico analitico è difficilmente sopravvalutabile.
L'approccio metaetico è messo in discussione da un insieme di autori di
formazione analitica che non necessariamente intendono rompere con la
propria tradizione di provenienza. In genere essi si dimostrano sostenitori
dell'attualità dell'approccio etico aristotelico o perlomeno dell'attualità di
alcune sue tipiche istanze. Tali autori non costituiscono un movimento
omogeneo: alcuni si fermano solo alla pars denstruens, altri hanno una strategia
di più largo respiro; alcuni criticano l'etica analitica dall'interno, altri si pongono
esplicitamente contro l'impostazione analitica prevalente; alcuni pensano di
poter inserire nell'etica analitica alcune istanze aristoteliche, altri ritengono di
dover inaugurare un nuovo approccio etico.
2.2 Agire in prima persona
Nel 1949 - in un articolo dal titolo assai significativo (“Errori nella filosofia
morale”) che possiamo considerare profetico rispetto agli sviluppi dell’etica
contemporanea – il filosofo inglese Stuart Hampshire addossava a Kant (cfr.) la
responsabilità di aver introdotto, con tutto il peso della propria autorevolezza,
la distinzione tra giudizi morali e giudizi fattuali e di aver così allontanato la
filosofia morale da ciò che per sua essenza le è più proprio: la guida della
condotta
umana.
In
altre
parole,
con
Kant
si
inaugurerebbe
quell'atteggiamento, destinato a divenire prevalente nella filosofia morale
contemporanea, che riconduce l'etica all'ambito dell'espressione di giudizi e
che - usando una terminologia coniata da Giuseppe Abbà - possiamo
caratterizzare mediante l'espressione etica della terza persona, in quanto si pone
10
da un punto di vista esterno rispetto a quello dell'agente. A tale modello di etica
possiamo contrapporre un approccio, d’ascendenza aristotelica, incentrato
sull'analisi dei problemi dell'agente morale, in particolare del problema della
deliberazione - una figura di etica ponentesi dal punto di vista dell'agente e
quindi detta della prima persona. Aristotele è interessato alla comprensione
dell’azione, cioè egli “descrive e analizza i processi di pensiero, o i tipi di
argomentazione, che conducono alla scelta di un corso di azione, o di un modo
di vita, a preferenza di un altro […] mentre la maggior parte dei filosofi
contemporanei descrive le argomentazioni [...] che conducono all’accettazione
o al rifiuto di un giudizio morale sulle azioni” (St. Hampshire). In altre parole,
laddove Aristotele è preoccupato di guidare colui che agisce, i filosofi
contemporanei sembrano intenti esclusivamente a fornire strumenti a coloro
che devono giudicare l’azione.
Si possono già enucleare le principali esigenze che stanno dietro tale
movimento di ripresa di un’etica della prima persona.
La prima esigenza è quella di una aderenza all’esperienza morale effettiva,
che è, innanzitutto, quella di un individuo che si trova di fronte al problema di
conoscere e di deliberare per agire.
La seconda esigenza, strettamente dipendente dalla prima, è quella di
recuperare il legame tra giudizi prescrittivi (quelli del “tu devi…”) e giudizi
fattuali (quelli che descrivono il mondo). Le nostre deliberazioni, infatti, sono
dettate anche e soprattutto dal fatto che percepiamo cose che ci attirano o
meno, e spesso le discussioni morali nascono da un mancato accordo riguardo
a queste cose. Ciò significa che la deliberazione pratica - che, cioè, guida
l’azione – ha un carattere ermeneutico, perché dipende dall’interpretazione
della situazione.
Una terza esigenza riguarda l’impossibilità di separare l’etica dalla
psicologia morale, cioè dallo studio della psiche individuale, nei suoi aspetti non
solo cognitivi (percettivi e intellettuali), ma anche emozionali e volitivi. In altre
parole, l’etica deve ricominciare a occuparsi del carattere. Ci sono caratteri che
11
favorisce la percezione delle differenze qualitative tra le cose, cioè dei valori;
altri che rendono gli individui docili alle indicazioni della volontà. In questi casi
v’è una predisposizione alla bontà che rende l’individuo virtuoso. Viceversa, ci
sono caratteri che rendono gli individui insensibili alle differenze qualitative;
altri che li rendono riottosi nei confronti di ogni direttiva che non soddisfi la
voglia del momento.
Una quarta esigenza, solo implicita nel discorso di Hampshire, richiama
l’etica al tema dell’identità del soggetto agente: non è possibile parlare dei fini
dell’agente senza affrontare il problema di ciò che tale agente desidera e vuole,
a partire da una certa concezione di ciò che è bene in sé.
Facciamo un esempio molto concreto: ho un amico ricoverato in ospedale
a causa di una grave malattia; so che è molto depresso; l’unico pomeriggio
libero che ho durante la settimana è una splendida giornata, assai adatta per
una gita in moto con la mia ragazza. Che cosa devo fare? Assumiamo il punto
di vista del giudice: un’etica della terza persona giudica buono un individuo se
questo agisce in conformità a principi generali, in questo caso quello di aiutare i
propri amici. Da questo punto di vista, è molto facile stabilire la mia bontà: se
andrò a trovare il mio amico sarò buono, in caso contrario sarò cattivo. Se,
invece, assumo il punto di vista dell’agente, le cose sono molto più complesse.
Innanzitutto si tratta di cogliere il bisogno del mio amico, si tratta, cioè, di
possedere una capacità di immedesimazione con la sua condizione che
dipende dalla mia capacità di immaginazione, dalle mie esperienze passate,
dalla mia educazione ecc.
Senza la percezione di tale bisogno, molto
probabilmente non mi porrei neanche il problema su che cosa fare. Tale
capacità di immedesimazione mi permette di considerare il mio amico nella sua
concretezza, rendendo evidente la sua situazione di sofferenza e il mio amore
per lui, cioè quelle particolari qualità o valori che caratterizzano la circostanza e
la rendono mia. In tal modo può nascere in me un moto spontaneo – una
“voglia”, come si suol dire – che mi spinge a fare visita al mio amico in maniera
cordiale e non forzata. Ciò non mi basta, però, per essere buono: anche la gita in
12
moto con la mia ragazza presenta, infatti, delle qualità o valori interessanti per
me. Si tratta allora di avere la capacità di deliberare in base a una gerarchia o a
un ordine di valori che mi consenta di scegliere tra le due possibilità: anche
l’amore deve avere un ordine per poter vivere in un mondo pieno di cose che ci
attirano, di beni che desideriamo possedere.
Tale ordo amoris, che
generalmente si assume nel corso del processo educativo e di cui spesso non
siamo consapevoli, può essere più o meno vero. La mia bontà dipende, quindi,
dalla verità dell’educazione che mi è stata impartita e dal tipo di uomo che io
voglio diventare, dal modello di vita che ho scelto. Ma non basta. Occorre che
la mia volontà sappia anteporre la scelta di un bene che presenta
indubbiamente anche degli aspetti non piacevoli (la visita all’amico) alla scelta
di un altro bene che si presenta in una prospettiva di esclusivo godimento (la
gita in moto con la ragazza). La presenza o la mancanza di uno di questi fattori
genera le seguenti possibilità, che elenchiamo in un ordine crescente di bontà:
a) so che il mio amico è in ospedale, ma sono talmente rozzo che non riesco
minimamente a immedesimarmi con lui e, quindi, parto spensieratamente con
la mia ragazza (prima ancora che mancanza di una gerarchia di valori e di forza
di volontà, c’è qui una totale mancanza di sensibilità, che rende inutile ogni
richiamo al senso del dovere); b) so che il mio amico è in ospedale, mi spiace per
lui ma vado in gita con la mia ragazza senza neanche pormi il problema di
andarlo a trovare (mancanza di una gerarchia di valori + mancanza di forza di
volontà); c) so che il mio amico è in ospedale, mi spiace per lui ma vado in gita
con la mia ragazza anche se so che il mio dovere sarebbe di andarlo a trovare
(mancanza di forza di volontà); d) so che il mio amico è in ospedale, vado a
trovarlo rinunciando alla gita perché so che è mio dovere farlo, ma lo faccio
forzatamente, rischiando di rendere così la mia visita puramente formale
(mancanza di sensibilità); e) so che il mio amico è in ospedale, vado a trovarlo
rinunciando alla gita perché so che ciò sarà di sollievo per lui, riuscendo a
resistere alla tentazione di andare in gita in parte perché mi sono
immedesimato con lui, in parte perché so che è mio dover farlo; tornando a casa
13
scopro che tale scelta mi ha reso migliore di quanto fossi, avvicinandomi così al
tipo di uomo che voglio essere.
Per essere buoni occorre, quindi, essere
sensibili, avere una buona forza di volontà, possedere una vera gerarchia di
valori e un vero modello di uomo cui aspirare.
Questo esempio mostra che, se si assume il punto di vista di colui che si
trova ad agire, il problema morale si presenta con una ricchezza e molteplicità
di aspetti sconosciute a colui che assume il punto di vista del giudice. Non si
tratta solo di stabilire la conformità di una decisione o di un’azione rispetto ad
una norma: la bontà di una decisione o di un’azione dipende, nei suddetti
esempi, anche dalla capacità di percepire i valori e dal carattere dell’agente. Per
essere buoni è necessario, anche se non sempre sufficiente, conoscere il bene e
avere una predisposizione caratteriale a indirizzare le proprie deliberazioni e le
proprie azioni verso esso. Si tratta di possedere ciò che Aristotele chiamerebbe
le virtù dianoetiche e le virtù etiche (cfr.).
2.3 L'etica delle virtù'
Negli anni '80 il moto di insoddisfazione nei confronti degli approcci etici
analitici ha portato alla diffusione di ricerche incentrate sull'etica di
impostazione aristotelica e, in particolare, sul concetto di virtù. E' stato
soprattutto con la pubblicazione nel 1981 di Dopo la virtù da parte di Alasdair C.
MacIntyre che questa tendenza ha cominciato a giocare un ruolo centrale nel
dibattito etico-filosofico.
Come s’è visto nell’esempio suddetto, l’etica delle virtù è capace di fornire
un quadro comprensivo dell'effettiva esperienza morale in modo da avvicinarsi
alle istanze della vita quotidiana. Ciò è reso possibile dal fatto che – come ha
messo in luce uno dei più importanti studiosi italiani di etica, Giuseppe Abbà – il
filosofo morale che sposa un approccio etico della virtù guarda alla pratica
morale con gli occhi del lettore di opere letterarie.
14
Ciò gli permette di
considerare la pratica morale da un punto di vista interno, “dal punto di vista del
soggetto che è autore della pratica e attore mediante la pratica”, cioè dal punto
di vista della prima persona. L’atto narrativo, difatti, è la presentazione di un
personaggio visto in una prospettiva interiore.
Il vero problema in un’etica di prima persona non è scoprire se e come un
soggetto possa adeguare la propria azione ad una regola di bontà o giustizia,
bensì di ricercare come il soggetto agente possa essere autore della propria
condotta. Il soggetto agente, infatti, è autore non di singole azioni separate, ma
di una condotta: “il soggetto approda ad azioni diverse sì, ma considerate da lui
come
esemplificazioni
successive,
complementari,
variate
di
interessi
permanenti, di intenzioni generali, che a loro volta articolano per lui la sua
concezione di vita buona e la sua volontà di realizzarla” (G. Abbà). Rinunciare al
punto di vista interno al soggetto agente vorrebbe dire, ricorda Abbà,
precludersi la strada a quel “sapere pratico originale, non riducibile al sapere del
legislatore, del giudice o del critico [e] centrato sul problema del senso da dare
alla propria vita”.
Considerata dal punto di vista della prima persona, la pratica morale
appare come intimamente narrativa e drammatica: essa, infatti, “si svolge
secondo lo schema tipicamente narrativo della ricerca d’un esito da una
situazione problematica; e poiché nella ricerca il soggetto interviene con un suo
carattere complesso, è intrecciato in una rete di rapporti con altri soggetti dal
carattere diverso, è coinvolto in eventi incontrollabili e contingenti, la pratica
morale stessa presenta quei forti contrasti che ne fanno un dramma” (G. Abbà).
Essendo la drammaticità uno dei fenomeni peculiari dell’esperienza morale, il
fatto di consentirne la considerazione costituisce un elemento a favore
dell’approccio etico di prima persona.
In questo approccio è inevitabile considerare la dimensione emozionale e
quelle della deliberazione e della scelta all’interno della condotta morale. Ciò
implica una maggiore attenzione alla psicologia morale e all’antropologia, in
quanto la scelta non può essere considerata senza una teoria del bene rispetto a
15
cui la scelta è compiuta.
In un’etica della prima persona, comunque, il ricorso alle opere letterarie
non è meramente esemplificativo, bensì ha un valore metodologico
imprescindibile. Come ha evidenziato uno dei principali esponenti dell’etica
delle virtù, Martha Nussbaum, le opere letterarie presentano al filosofo morale
la migliore rassegna delle concezioni e delle credenze comuni in campo etico,
incarnate in trame e personaggi. Il filosofo morale ha bisogno delle opere
letterarie per poter guardare la vita concreta, in quanto la letteratura gli fornisce
quella distanza dal flusso vitale, quel simbolismo protettivo che gli permette di
riflettere sulla vita.
2.4 Verso un’etica narrativa
L’approccio etico di prima persona ha fatto emergere – come s’è visto – la
categoria di narrazione come categoria centrale non solo nella riflessione etica,
ma nella stessa prassi quotidiana. È questo uno degli aspetti più interessanti del
dibattito etico contemporaneo, poiché va verso un superamento delle
separazioni disciplinari in nome di una maggiore concretezza dell’analisi della
vita umana. Se vogliono raggiungere tale obiettivo, i filosofi morali sono oggi
costretti a recuperare in ambito etico i risultati della critica letteraria, della
psicologia e della sociologia dei mezzi di comunicazione, nonché della
semiologia.
Una conferma della centralità della categoria di narrazione, ad esempio, è
venuta anche da parte di chi ha affrontato la questione del rapporto tra etica e
narrazione non tanto dal punto di vista della filosofia morale, quanto da quello
delle storie, in particolare dal punto di vista delle storie scritte, cioè della
letteratura.
Wayne Booth – un importante critico letterario americano,
proveniente dalla cosiddetta “scuola aristotelica di Chicago” di studi letterari ha ricordato come ogni opera richieda al lettore l’impegno di un confronto tra
16
le sue convinzioni e quelle dell’autore.
Anche la vita che consideriamo
esperienza primaria è raramente vissuta senza alcuna sorta di mediazione
narrativa: le composizioni narrative producono e riproducono ciò che da un
punto di vista realista sono considerate le esperienze più elementari e di
conseguenza producono e riproducono noi stessi. Il passaggio da ciò che
consideriamo come più originario (perché “reale”) all’esperienza di storie che
parlano di esso è così automatica e frequente che rischiamo di perdere il senso
di quanto i mondi creati dalle storie siano potenti nell’aggiungere “vita” alla
“vita”, nel bene e nel male. Noi tutti viviamo gran parte della nostra vita in un
abbandono alle storie sulla nostra vita e su altre possibili vite; viviamo più o
meno nelle storie, a seconda di quanto resistiamo nell’arrenderci a ciò che è
“solo” immaginato. La vita, insomma, necessita di una mediazione narrativa per
fare esperienza di se stessa, cioè per divenire cosciente di sé.
Le parole di Booth confermano i risultati della ricerca di alcuni autori, quali
A. MacIntyre e Ch. Taylor, i quali identificano la moralità della vita umana con il
fatto che ogni azione, magari confusamente e in maniera solo parzialmente
consapevole, rimanda ad un’immagine articolata del bene, generalmente
incarnata in figure e storie esemplari e costitutiva di un’identità individuale e
comunitaria, senza cui la nostra conoscenza pratica sarebbe come monca.
Questi autori intendono dire che, in genere, la riflessione etica nasce in
momenti di crisi e si costituisce come una autoriflessione che ha il compito di
collegare il problema del “che fare?” con la visione globale della propria
esistenza; ebbene, la scoperta affascinante di tali autori è che ciò avviene, di
solito, tramite un racconto interpretativo.
Se ogni essere umano si crea e ricrea all’interno di storie, ciò significa che,
riguardo alle storie, tutti gli uomini sono esperti. L’etica narrativa, allora, ha una
struttura riflessiva, circolare, poiché chi giudica le storie è formato da altre storie.
Il dibattito etico che si sviluppa intorno alla narrazione, inoltre, coinvolge
sempre e quasi istantaneamente le domande ultime, poiché coinvolge il livello
della visione antropologica; è per questo che l’attenzione non è tanto rivolta
17
alle conseguenze delle azioni quanto al tipo di esistenza che esse manifestano o
indicano. L’effetto più importante che la lettura ha sul lettore, insomma, riguarda
l’orientamento dei suoi desideri e delle sue paure verso una soddisfazione futura.
Nella vita reale, quindi, tutti noi imitiamo abitualmente e necessariamente
le imitazioni narrative della vita reale. Ciò significa da un lato che, per costruire
il nostro proprio carattere, dobbiamo rappresentarci dei personaggi,
identificarci, anche se solo immaginativamente, con loro, e in tale dinamica
educativa l’esperienza letteraria occupa una posizione centrale; dall’altro lato
che l’io è, seppur indirettamente, una costruzione sociale.
2.5 Visione e narrazione
Alcuni autori – Iris Murdoch e Martha Nussbaum in particolare, ma anche
MacIntyre, Taylor e Booth - hanno approfondito il problema degli effetti della
narrazione sull’ascoltatore o sul lettore di storie, effetti che si possono
individuare essenzialmente in un cambiamento della «visione», in una sorta di
riorientamento epistemologico individuale e/o comunitario. Il cambiamento
morale non è mai repentino; esso accade piuttosto come modificazione della
percezione della realtà, resa possibile in genere e soprattutto dagli effetti che
una narrazione o un’opera d’arte, con la propria forza retorica e poetica,
producono sull’ascoltatore o sul lettore.
MacIntyre ha posto in luce come il riorientamento ruoti attorno alla messa
in questione di storie, in genere a sfondo religioso, le quali - in quanto pratiche
sociali, cioè, nel linguaggio macintyriano, narrative - incarnano un certo
atteggiamento nei confronti delle questioni fondamentali della condizione
umana, comprendente allo stesso tempo asserzioni fattuali e prescrizioni
morali. Una narrativa, inoltre, attribuisce agli individui e ai gruppi sociali un
ruolo nel dramma cosmico che racconta, attraverso cui essi entrano in una
relazione dinamica, cioè drammatica, con tutti gli esseri che popolano il cosmo 18
relazione che può anche contenere e dischiudere il senso dell’esistenza. La crisi
morale per MacIntyre segue la dinamica delle crisi epistemologiche studiate da
Th. Kuhn (cfr.) e, quindi, si apre di fronte a resoconti narrativi della propria
esistenza alternativi e rivali rispetto a quello predominante in precedenza. Una
narrativa, cioè, entra in crisi solo nel confronto con una o più altre narrative che
sembrano rendere l’esistenza più intellegibile - e ciò ricorda quello che altri
autori incontrati, soprattutto Taylor e Booth, dicono rispetto al fatto che la
migliore correzione o critica di una storia è un’altra storia. La peculiarità di
MacIntyre sta nell’insistenza sull’aspetto sociologico di quelle che egli chiama
narrative: queste non sono semplici storie, ma sono pratiche sociali incarnate in
individui e comunità. Conseguenza di ciò è che una narrativa non può proporsi
senza un gruppo sociale che già la pratichi e la manifesti.
Si può così concordare con Booth laddove afferma che l’effetto più potente
della lettura sul lettore è il riorientamento dei desideri, delle paure e delle
aspettative, il quale porta con sé una ridefinizione del proprio compimento, cioè di
ciò che si identifica con la felicità.
Martha Nussbaum ha mostrato che, per comprendere la dinamica di tale
riorientamento esistenziale, è molto utile riferirsi alla poetica aristotelica e, in
particolare, alla dottrina della catarsi. Tale dottrina è estesa da Nussbaum dalla
tragedia all’opera letteraria in generale - rispettando in ciò, del resto, lo spirito
della poetica aristotelica. In realtà l’approccio poetico aristotelico può essere
esteso a tutte le arti narrative, cinema compreso – come hanno dimostrato
recentemente due autori italiani, Gianfranco Bettetini e Armando Fumagalli, in
un bel libro dal titolo Quel che resta dei media (1999).
19