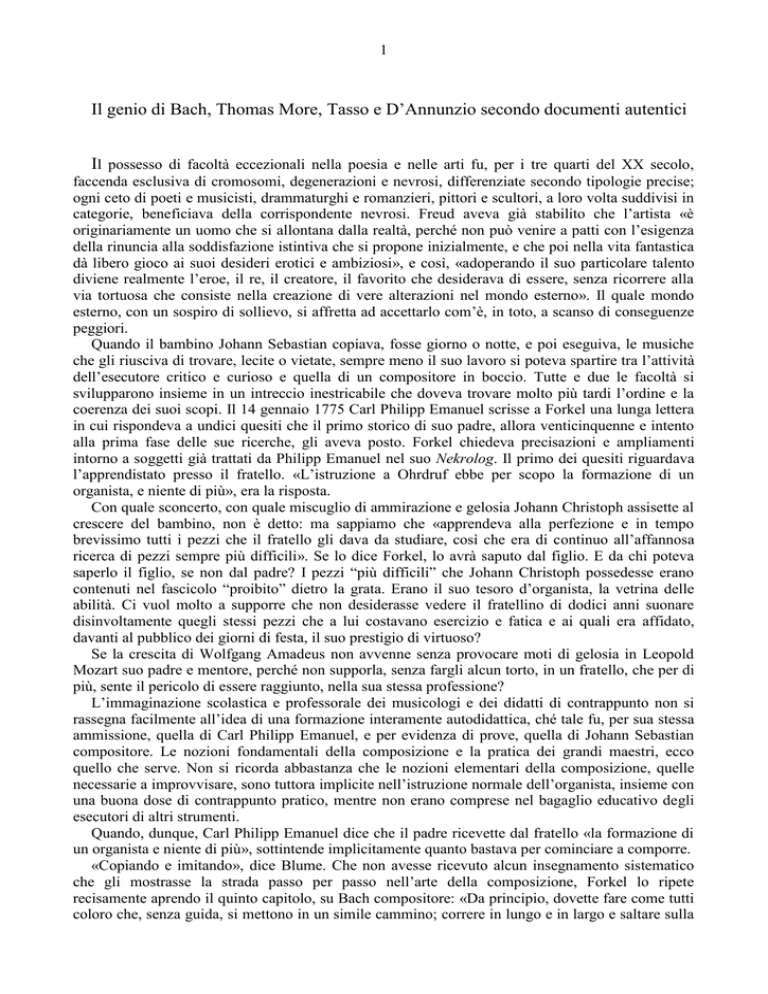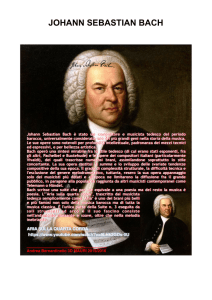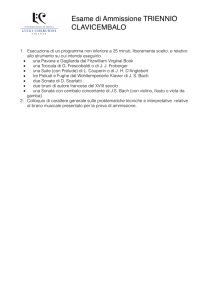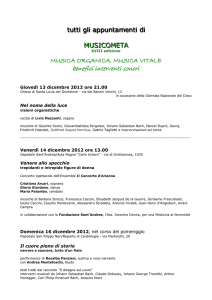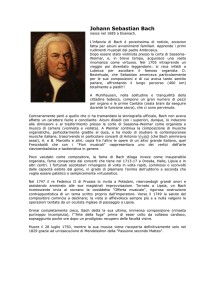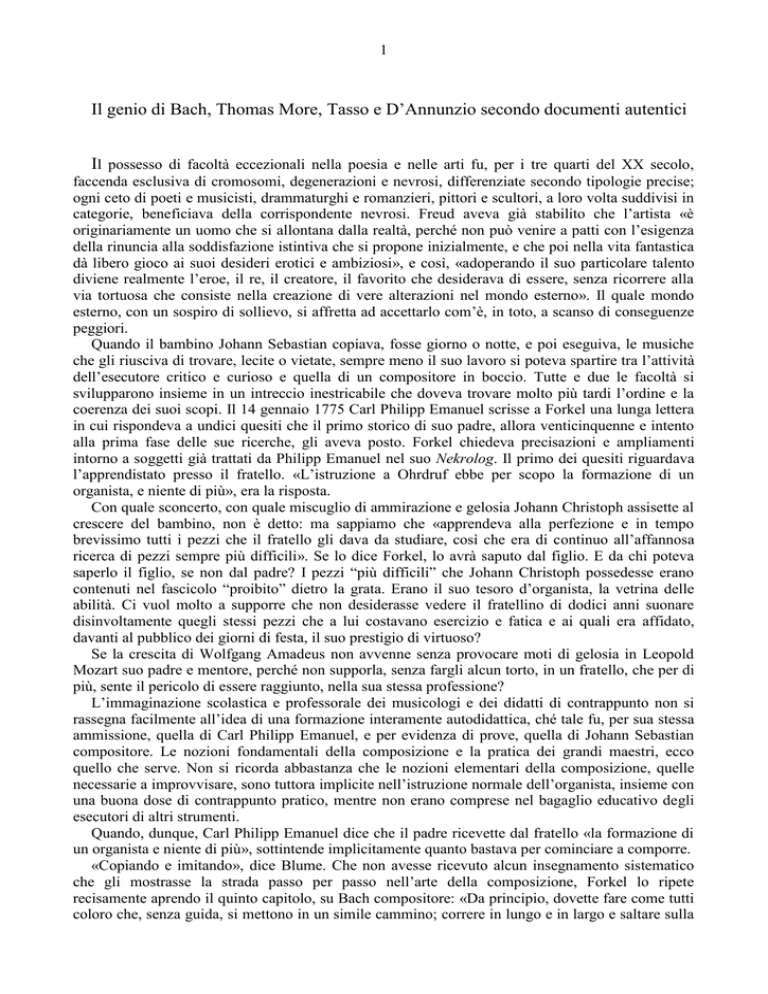
1
Il genio di Bach, Thomas More, Tasso e D’Annunzio secondo documenti autentici
Il possesso di facoltà eccezionali nella poesia e nelle arti fu, per i tre quarti del XX secolo,
faccenda esclusiva di cromosomi, degenerazioni e nevrosi, differenziate secondo tipologie precise;
ogni ceto di poeti e musicisti, drammaturghi e romanzieri, pittori e scultori, a loro volta suddivisi in
categorie, beneficiava della corrispondente nevrosi. Freud aveva già stabilito che l’artista «è
originariamente un uomo che si allontana dalla realtà, perché non può venire a patti con l’esigenza
della rinuncia alla soddisfazione istintiva che si propone inizialmente, e che poi nella vita fantastica
dà libero gioco ai suoi desideri erotici e ambiziosi», e così, «adoperando il suo particolare talento
diviene realmente l’eroe, il re, il creatore, il favorito che desiderava di essere, senza ricorrere alla
via tortuosa che consiste nella creazione di vere alterazioni nel mondo esterno». Il quale mondo
esterno, con un sospiro di sollievo, si affretta ad accettarlo com’è, in toto, a scanso di conseguenze
peggiori.
Quando il bambino Johann Sebastian copiava, fosse giorno o notte, e poi eseguiva, le musiche
che gli riusciva di trovare, lecite o vietate, sempre meno il suo lavoro si poteva spartire tra l’attività
dell’esecutore critico e curioso e quella di un compositore in boccio. Tutte e due le facoltà si
svilupparono insieme in un intreccio inestricabile che doveva trovare molto più tardi l’ordine e la
coerenza dei suoi scopi. Il 14 gennaio 1775 Carl Philipp Emanuel scrisse a Forkel una lunga lettera
in cui rispondeva a undici quesiti che il primo storico di suo padre, allora venticinquenne e intento
alla prima fase delle sue ricerche, gli aveva posto. Forkel chiedeva precisazioni e ampliamenti
intorno a soggetti già trattati da Philipp Emanuel nel suo Nekrolog. Il primo dei quesiti riguardava
l’apprendistato presso il fratello. «L’istruzione a Ohrdruf ebbe per scopo la formazione di un
organista, e niente di più», era la risposta.
Con quale sconcerto, con quale miscuglio di ammirazione e gelosia Johann Christoph assisette al
crescere del bambino, non è detto: ma sappiamo che «apprendeva alla perfezione e in tempo
brevissimo tutti i pezzi che il fratello gli dava da studiare, così che era di continuo all’affannosa
ricerca di pezzi sempre più difficili». Se lo dice Forkel, lo avrà saputo dal figlio. E da chi poteva
saperlo il figlio, se non dal padre? I pezzi “più difficili” che Johann Christoph possedesse erano
contenuti nel fascicolo “proibito” dietro la grata. Erano il suo tesoro d’organista, la vetrina delle
abilità. Ci vuol molto a supporre che non desiderasse vedere il fratellino di dodici anni suonare
disinvoltamente quegli stessi pezzi che a lui costavano esercizio e fatica e ai quali era affidato,
davanti al pubblico dei giorni di festa, il suo prestigio di virtuoso?
Se la crescita di Wolfgang Amadeus non avvenne senza provocare moti di gelosia in Leopold
Mozart suo padre e mentore, perché non supporla, senza fargli alcun torto, in un fratello, che per di
più, sente il pericolo di essere raggiunto, nella sua stessa professione?
L’immaginazione scolastica e professorale dei musicologi e dei didatti di contrappunto non si
rassegna facilmente all’idea di una formazione interamente autodidattica, ché tale fu, per sua stessa
ammissione, quella di Carl Philipp Emanuel, e per evidenza di prove, quella di Johann Sebastian
compositore. Le nozioni fondamentali della composizione e la pratica dei grandi maestri, ecco
quello che serve. Non si ricorda abbastanza che le nozioni elementari della composizione, quelle
necessarie a improvvisare, sono tuttora implicite nell’istruzione normale dell’organista, insieme con
una buona dose di contrappunto pratico, mentre non erano comprese nel bagaglio educativo degli
esecutori di altri strumenti.
Quando, dunque, Carl Philipp Emanuel dice che il padre ricevette dal fratello «la formazione di
un organista e niente di più», sottintende implicitamente quanto bastava per cominciare a comporre.
«Copiando e imitando», dice Blume. Che non avesse ricevuto alcun insegnamento sistematico
che gli mostrasse la strada passo per passo nell’arte della composizione, Forkel lo ripete
recisamente aprendo il quinto capitolo, su Bach compositore: «Da principio, dovette fare come tutti
coloro che, senza guida, si mettono in un simile cammino; correre in lungo e in largo e saltare sulla
2
tastiera, afferrare con le due mani tante note quante le dita possono stringere, e continuare in questa
maniera selvaggia fino a che non si trovi, per qualche caso, un punto di riposo: questi sono gli
artifìci comuni a tutti i principianti, che così possono divenire soltanto compositori con le dita
(Fingercomponisten), o Ussari della tastiera, come li chiamava Bach nella maturità; il che significa
ch’essi devono lasciarsi comandare dalle dita ciò che scriveranno, invéce di ordinare, di loro
autorità, alle dita, ciò che debbono suonare».
Nel 1695, a dieci anni, Johann Sebastian aveva infatti perduto il padre, Johann Ambrosius,
ottimo didatta e inventore di strumenti, che certamente avrebbe potuto avviare il figlio verso una
completa formazione musicale gradualmente, secondo la prassi pedagogica allora in voga. Johann
Sebastian mantenne sempre un alto concetto delle composizioni del padre Johann Ambrosius,
alcune delle quali portava sempre con sé, nei suoi numerosi – e snervanti – trasferimenti di
residenza.
Questa norma della pèrdita del padre come parte della regola aurea dell’umana grandezza,
sembra esser stata perfettamente nota ai biografi di Bach. Il gigante bambino non li commuove.
Sebbene appartengano all’Ottocento Charles Dickens e David Copperfield, non giudicano di dover
spremere ai loro lettori lacrime sui sentimenti di un decenne che in pochi mesi vede morti la madre
e il padre, il focolare spento, la dolce casa sprangata e venduta. Perfetto manichino della luterana
predestinazione, il loro Sebastian raccoglie gli straccetti e, a ciglio asciutto, trasmigra verso il letto e
il posto a tavola nella casa di un fratello quasi sconosciuto, Johann Christoph Bach. Se è normale
due volte, e per l’età che viveva e per l’età che aveva, che nulla conosciamo dei sentimenti di
Johann Sebastian quando lasciò la casa paterna per la vita nuova, ci inquieta l’assenza, pressoché
totale, di notizie sui cinque anni nella casa del fratello, gli anni in cui si formarono la personalità, il
carattere, il gusto. Ci restano le deduzioni, le congetture. In tutto, sugli anni di Ohrdruf, ci restano il
Catalogus Discipulorum della Scuola, le notizie fornite da Carl Philipp Emanuel, quelle del
Nekrolog e quelle comunicate a Forkel, oltre alla notizia, che Walther conobbe direttamente
dall’interessato, sui Principia della tastiera appresi dal fratello, suo solo maestro. Il fatto che Johann
Christoph fosse allievo di Pachebel ci consente alcune deduzioni sulla sua genealogia estetica.
Quando morì, non ancora cinquantenne, fu scritta accanto al suo nome, nel registro della chiesa,
l’annotazione «optimus artifex» che, assicura C. Freyse, studioso della famiglia Bach, non si trova
accanto ai nomi degli altri musicisti. Questo termine, artifex, dovrebbe indicare un’attività di
compositore, di cui nulla sappiamo. Johann Sebastian gli dedica, nella Genealogie dei propri
antenati, una delle voci più fredde, e più secche. Lo chiama «il più anziano figlio di Joh. Ambrosio
Bachen». Lascia in bianco il luogo della nascita (Erfurt) e gli anni di nascita e di morte,
evidentemente perché mentre compila il suo elenco non se li ricorda. Il che appare quasi incredibile.
Su Johann Christoph e la nostra idea della sua persona pesa da gran tempo l’aneddoto che Carl
Philipp Emanuel raccontò nel Nekrolog e poi passò nel lavoro pionieristico di Forkel, più di
vent’anni dopo: segno che Carl Philipp Emanuel ci teneva, e la sua memoria di figlio vi si era
appresa, forse per reiterati racconti, durante la vita del padre.
Molto attenti a queste rare memorie della tradizione familiare, svalutate dalla sufficienza erudita
e storpiate dalle parafrasi dei commentatori, riprodurremo la storia intéra, senza mutilarla neppure
del paragone che Carl Philipp Emanuel suggerisce col ricco mercante, né dell’evidente errore con
cui anticipa di vent’anni la morte dello zio: «La passione del nostro piccolo Johann Sebastian per la
musica era, già in questa età tenera, straordinaria. In breve tempo, egli imparò a padroneggiare
completamente tutti i pezzi per tastiera che suo fratello aveva giudicato di fargli studiare. Gli aveva
rifiutato, invéce, nonostante le sue preghiere e chissà per quali ragioni, un volume, pieno di pezzi
dei più rinomati maestri di allora, come Froberger, Kerll, Pachebel. La sua ansia insaziabile di
progredire gli suggerì allora l’innocente inganno che segue. Stava il libro in uno stipo chiuso da un
semplice sportello a griglia. Infilando le sue piccole mani nelle stecche della griglia, riuscì a
raggiungerlo, e siccome aveva solo una copertina di carta, ad arrotolarlo dentro l’armadio, ed
estrarlo, nella notte, quando tutti erano a letto; e come non poteva disporre d’un lume, poté
copiarselo nelle notti di luna. Dopo sei mesi, quel bottino musicale era tutto nelle sue mani.
3
Nonostante la sua cupidigia divorante, cercò di farne uso soltanto in segreto; ma col suo più cocente
dolore, il fratello se ne accorse, e gli tolse senza misericordia la copia che gli era costata tanta fatica.
Uno speculatore cui sia affondata, nella rotta verso il Perù, una nave da centomila talleri, potrebbe
darci una convincente idea della tristezza provata dal nostro piccolo Johann Sebastian a quella
perdita. Non gli riuscì di rientrare in possesso del quaderno, se non dopo la morte del fratello. Ma
non è stata proprio questa ansia di avanzare sempre oltre, nella musica, e dunque anche
l’entusiastica destrezza che impiegò nel procurarsi quel quaderno, la prima origine della causa che
dobbiamo attribuire alla sua morte? Lo vedremo più avanti».
Molto più avanti, infatti, nel Nekrolog, prima di riferire della rovinosa operazione di cataratta
eseguita dall’inglese Taylor (che operò anche Händel, con èsiti altrettanto infausti), Carl Philipp
Emanuel collega, in un deciso rapporto di causa ed effetto, la malattia d’occhi di suo padre con le
notti che passò da ragazzo, al chiaro di luna, sulle pagine, bramate e proibite, di quel quaderno.
Desta meraviglia che nessuno dei biografi abbia sottoposto a qualche indagine critica questa
informazione, che la scienza oculistica considera leggenda; e che, invéce, buona parte di costoro
abbiano guardato con sufficiente fastidio l’aneddoto, come indegno di un Bach “scientifico”.
Perfino Friedrich Blume, il miglior biografo del Maestro, nel profilo biografico del 1947 taglia
corto e definisce l’episodio «unzuverlässig», inattendibile, correggendosi poi, molto più avanti,
evidentemente con una riflessione identica a quella che lo fa apparire a noi assolutamente autentico:
non solo perché l’affermazione del più scrupoloso dei figli, ripetuta, con il suo evidente assenso, dal
primo biografo Forkel, non è contraddetta da alcuna prova contraria. Ma perché quella sete del
bambino corrisponde perfettamente all’idea che ci siamo fatti di Johann Sebastian, della sua
curiosità, della sua cocciutaggine, della sua indocilità, della sua prontezza a servirsi anche di mezzi
obliqui e illeciti, quando si senta spinto da quella che, a ragione o a torto, gli appare una necessità.
«Gli uomini operono per necessità o per elezione», dice Machiavelli (Discorsi, I, 1), e nessuno
dei grandi artisti che conosciamo fu costretto quanto Johann Sebastian a “operare” sotto la sferza
della necessità. Mai, da ragazzo, o da giovane, gli si presentò, anche se l’avesse voluta,
l’opportunità di una scelta, di un rifiuto. Non perché l’epoca dei rifiuti, in nome di una vocazione
individuale, della situazione offerta dalla vita e/o dalla famiglia, non fosse ancóra sorta, come si è
suggerito. La scelta e la carriera di Händel ne sono eloquente, anzi magniloquente testimonianza.
Ma perché la predestinazione artigiana che la famiglia gli aveva approntato fu, per il bambino e poi
per il ragazzo, una scelta obbligata. Nel solco di quella direzione obbligata, tuttavia, il raptus
ansioso e nervoso gli suggerì poi diverse Mutationen, come le chiamava lui, e un contegno
mutevole, sempre alla ricerca di miglioramenti, un’ansia incontenibile, la determinazione di opporsi
innovando, alla mansueta accettazione della propria sorte tipica delle precedenti generazioni Bach:
diventato adulto, si sfogò a mostrare la sua autonomia non solo nello “scrivere” (musica, nel suo
caso), ma proprio nel “fare” (machen). Se non poté decidere, al principio, la strada da percorrere,
decise poi sempre, anche a caro prezzo, dove e come percorrerla.
L’episodio del libro proibito si presta a una seconda spremitura che non tralasceremo, in quanto
ci consente una serie di osservazioni sul rapporto col fratello e l’insegnamento che poté riceverne.
Scrivendo vent’anni dopo, Blume attenua il giudizio negativo sull’episodio: «Sia questo vero o non,
bisogna affermare recisamente che non si può parlare di alcun progresso, metodico o rapido, della
formazione di Bach, finché visse con suo fratello. Cantò nel coro della Scuola e nel Currende-Chor,
dove guadagnò un po’ di soldi, ma è escluso che abbia imparato molto qui. Evidentemente, non fu
iniziato nell’arte della composizione. Johann Christoph era stato allievo di Johann Pachebel, e se
compose qualcosa per l’organo o il clavicordo, si deve supporre che si attenesse allo stile di
Pachebel. Ma niente di ciò è rimasto, e, seppure esistette, in ogni caso lo stile di Pachebel era a quel
tempo diffuso tra gli organisti della Turingia. Se il giovane Sebastian sentì in sé l’urgenza di
comporre, si sarà aiutato copiando musica altrui e imitandola, come sappiamo che fece più tardi
nella sua vita: e in questo fatto si trova forse il nocciolo della verità di quell’aneddoto».
L’aneddoto contiene la non trascurabile indicazione dei maestri di cui Johann Sebastian poté
trovare musiche nello scartafaccio di suo fratello: Froberger, Kerll, Pachebel: ossia la linea
4
meridionale dell’arte organistica tedesca, di lontana ascendenza frescobaldiana, una maniera intima
e pudìca, quanto mai guardinga nello sfruttamento delle risorse foniche dell’organo e parsimoniosa
nell’uso della pedaliera: tutte cose che il “sanguigno” Bach apprese poi dai più esplosivi e possenti
organisti del Nord. Che non fosse avviato alla composizione non meraviglia perché non risulta,
nonostante quell’artifex nel libro dei defunti, che il fratello componesse. Di certo, come ogni
organista, improvvisava. Sia Walther che il Nekrolog sono molto chiari nell’assegnargli il fratello
come solo maestro, ed evidentemente quanto Johann Christoph gli insegnò della tastiera gli bastò
per intraprendere quello studio, “matto e disperatissimo”, che doveva fare di lui, attraverso un
tirocinio da autodidatta, un compositore.
Il vero esordio da compositore, chiaramente diretto a impressionare gli intenditori esigenti non
meno che il pubblico più vasto, è rappresentato dalle Cantate eseguite il 30 maggio e il 6 giugno
1723 a Lipsia. La Nicolaikirche e la Thomaskirche ebbero due composizioni assolutamente pari per
peso musicale, ricercatezza artistica, struttura e durata: le “gemelle” N. 75, Die Elenden sollen
essen, e N. 76, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, entrambe su quattordici pezzi e divise in due
parti, da eseguirsi prima e dopo la predica. Le occasioni scelte e la vastità le designano come
modelli di quella che Bach considerava la Cantata «totale», la regina della sua forma, la Music da
chiesa d’intenzioni monumentali.
Fra il suo primo esordio d’ufficio come compositore a Lipsia e il principio della nuova annata
liturgica, corrono sei mesi giusti. Un periodo che tradizionalmente è assunto come terreno di prova
per mettere in movimento quella «lunga schiera delle Cantate da chiesa per Lipsia, che lascia
scorgere una certa consistenza per i primi cinque anni, e le cui propaggini si trascinano fino a circa
il 1738», come scriveva Blume, ancora smarrito, al pari della sua generazione di studiosi, davanti
all’abisso interpretativo che la nuova cronologia dell’opera vocale aveva spalancato.
Da quando furono pubblicati i testi di tre sue conversazioni per la radio di Basilea, che restano il
solo abbozzo di un riassestamento, nessun autore si è seriamente dedicato a modificare l’assetto
biografico tradizionale secondo la realtà, davvero sconvolgente (l’aggettivo, tanto lógoro, si può qui
sopportare), che i nuovi dati rivelavano: quella che generazioni di studiosi avevano contemplato
come la calma e maestosa creazione accumulatasi in un ventennio, era l’opera di tre anni febbrili o,
considerando integrazioni e aggiunte, tutt’al più, di cinque.
Il materiale storico che ancóra sussiste copioso, interrogato nel modo giusto, ha emesso un
responso, fitto, coerente, esauriente. Chi esamini i criteri oggettivi con cui Dürr e Dadelsen hanno
dedotto la cronolgia lipsiense, secondo le concordanze delle date rintracciate delle esecuzioni,
singole o plùrime nel corso degli anni, le filigrane delle carte, l’identificazione dei copisti, dentro la
famiglia e fuori, tutti materiali sintetizzati negli inoppugnabili ordini delle tavole riepilogative,
comprende perché non sia stata neppure tentata una resistenza a così chiare evidenze; e, in ogni
caso, perché, se velleità di opposizione si manifestarono, si siano, nel corso del trentennio, spente.
Nello stesso trentennio, la critica bachiana ha messo in mostra la sua paralizzante artrosi,
rivelandosi incapace di fronteggiare il doppio ordine di problemi posti dalla nuova realtà: con
l’ammasso angosciante che ingombra i primi due, tre anni di Lipsia, e trasforma quella che appariva
una calma e pausata architettura in una barricata frettolosamente affastellata; e il non meno
angosciante effetto improvviso di vuoto, per cui una lunga tratta di anni, bruscamente spogliata
dell’operosità laboriosa e pensosa che in precedenza le apparteneva, s’illumina di un raggio
repentino a ritroso, come una terra desolata, e peggio, una voragine i cui lembi restano aperti, da
raccordare e ricoprire con nuove spiegazioni e sistemazioni.
Il «vecchio Bach» che credevamo non esiste, è un altro, la «tarda opera» non è più quella. Il
genio raggiunge il suo culmine a quarant’anni, e non a cinquanta, o cinquantacinque. Il tumulto
creativo più intenso sommuove la sua esistenza tra i trentotto e i quarant’anni: tanto repentino e
inesplicabile, che Blume, posto all’improvviso davanti all’evidenza di un’eruzione febbrile, così
prolungata da ridicolizzare ogni altra leggenda di opere nate per incanto in pochi giorni, ricorse alla
spiegazione irrazionale, e disse: «un incomprensibile raptus». Un raptus organizzato, costante,
metodico.
5
Il modesto momento di respiro goduto a Lipsia dopo la presentazione delle prime otto nuove
Cantate, durato una ventina di giorni con quattro feste passate senza consumo di musica nuova,
prelude al terrificante sforzo che si apre la prima Domenica dopo la Trinità del 1724 (11 giugno) e
si prolunga con quaranta Cantate interamente nuove, di fortissima struttura, concepite secondo un
modello unico, rigorosamente seguìto in una sbalorditiva varietà di realizzazioni, fino alla Pasqua
dell’anno successivo.
Questa serie, la più lunga e coerente che Bach abbia condotto nella sua intera opera vocale, cui
appartiene quasi completo il nostro patrimonio di Cantate sui Corali, suggerì a Blume una
annotazione che pare voler spostare la data d’inizio delle “annate” dall’oggettività liturgica al
personale bachiano.
«Con l’inizio della sua seconda annata a Lipsia (1724-1725), Bach manifesta una inattesa
perseveranza e introduce un tipo assolutamente nuovo, la cosiddetta “Madrigalische Choralkantate”.
Comincia puntuale, la prima Domenica dopo la Trinità…» L’intento di solennizzare il proprio
anniversario come l’avvento di una ars nova della musica di chiesa a Lipsia è chiaro. Di quell’ars
nova, il secondo anno deve costituire la fase più abbagliante. Quando vuol far notare una cosa, Bach
non ha mano leggera, anche se poi tanta solennità, e la scelta dell’anniversario personale (un anno
dall’esordio compositivo a Lipsia) rendono ancora più evidente ed enigmatica la brusca interruzione
della serie, al cui modello tornerà più tardi, a intervalli diversi, per riempire le lacune rimaste.
A voler insistere negli anniversarî, troveremo che questo «raptus» di quaranta opere omogenee a
scadenza settimanale s’interrompe con la Cantata 127, eseguìta l’11 febbraio 1725, la Domenica
«Esto mihi», a due anni liturgici perfetti dalla Probe (“Esame d’Ammissione”) del 1723. Volle
sottolineare anche la conclusione della nuova età?
Alla fine di quel ciclo, la potenza creativa era intatta, e basterebbe a dirlo il colossale movimento
sinfonico con cui si apre la Cantata 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern, eseguita il 25 marzo
1725 per l’Annunciazione di Maria. Ma l’unità del modello era abbandonata. Se mai Bach si era
lasciato sedurre dalla tentazione di comporre cicli omogenei di Cantate, sui testi dello stesso
librettista e sullo stesso schema, un anno dopo l’altro, seguendo l’uso del tempo come tanti
implacabili ripetitori di luoghi comuni in note, da Telemann a Graupner a Fasch, l’illusione si
squarcia senza che la prima annata veda il compimento. La “perseveranza” ha ceduto alla noia? O
forse hanno ceduto le forze? Forse è meglio riconoscere qualcosa che forse neppur Bach aveva
chiaro come l’abbiamo noi: quelle filze di altrui confezioni, le “organiche annate”, nulla avevano in
comune con lo scavo, l’energia, la varietà, la finezza della sua sfilata di capolavori. Quanto egli
aveva creato in quaranta pezzi era già uno sforzo inaudito, non una «annata incompleta» come la si
chiama nel gergo dei magazzinieri, ma un solo gigantesco capolavoro, completo in sé.
Per la Pasqua 1725 riesce ottima, con un solo pezzo aggiunto, la Cantata «pastorale» composta
poche settimane prima per il compleanno del duca Christian di Sassonia-Weissenfels, e la cui
Sinfonia, in due movimenti, con il duetto che le segue, si rivela, sotto la leggera maschera, un intero
concerto strumentale: questo, e non altro, è il celebre “Oratorio di Pasqua”.
Se alcune opere di questo periodo, la 68, o la 175 con i suoi interminabili vocalizzi, suggeriscono
un’impressione di stanchezza sostenuta da vigoroso mestiere, ecco ancóra due potenti Cantate: la
137, per la dodicesima Domenica dopo la Trinità, e la 79, per la festa della Riforma, a confermare
che il vigore creativo è immutato, ma che soltanto ha cessato di perseguire fini sistematici nella
musica da chiesa. Con le nuove aggiunte, pare a Bach di avere costituito quel minimo di repertorio
che gli basta. Ma, soprattutto, la forma della Cantata, dopo la rapinosa spremitura cui l’ha
sottoposta, ha ormai perduto fascino e interesse per lui.
A questo 1725, segue un 1726 pieno di salti e di sorprese, in cui Bach farà fronte ai suoi obblighi
di musicista di chiesa con venticinque “nuove” composizioni: due almeno, vecchie o riutilizzate, e
diciassette cantate del cugino di Meiningen, Ludwig Bach, lasciando dodici delle feste prescritte
senza Music, stando a quello che ci risulta. Ugualmente silenziosa appare la prima Domenica
d’Avvento in cui avrebbe dovuto cominciare l’annata liturgica 1726-1727.
6
È scoraggiante avvicinarsi alla più amata opera di Bach superando la faticosa montagna di detriti
critici e cronologici che ora abbiamo. Non c’è concordia tra gli esegeti. Né taceremo il disagio nel
constatare come nessuno degli indizî che ci permettono di attribuire una data alla Matthäuspassion
venga, se si esclude un riferimento indiretto, che tuttavia sfrutteremo, dalla sua mano o dalle sue
carte. La partitura autografa e le parti separate, che sotto diverse segnature (P. 25, St. 110) si
trovano alla Biblioteca di Berlino, furono ereditate da Carl Philipp Emanuel, e sono descritte
nell’inventario del suo Nachlass, ma contengono la versione del venerdì santo 1736, replicata nel
1744 (o 1745) e forse anche nel 1749. Non possediamo alcuno dei materiali usati per la prima
esecuzione, e la forma originaria ci è ignota. La stessa data, tradizionalmente considerata come
sicura, del 1729, si è rivelata all’analisi talmente labile, che perfino Carl Friedrich Zelter, alla cui
Notiz del 1829, in occasione della ripresa diretta da Mendelssohn, risalgono le nostre scadute
certezze, considerava possibile (fonadtamente, come vedremo) che nel 1729 si avesse una replica, e
non una prima esecuzione.
Nel 1965, Detlev Gojowy, «attraverso una sottile investigazione del testo e della musica», che
convinse anche Blume, dimostrò che la musica dei dieci pezzi che la Matthäuspassion e la
Markuspassion hanno in comune era già stata prima utilizzata in una “secolare” Trauermusik scritta
per Cöthen, per le esequie del giudice e consigliere aulico Johann Christoph von Ponickau, nel
1727, e così la Matthäuspassion risultava perdente, sia pure di venti giorni, nella gara delle
riutilizzazioni-parodie, con disperazione di Smed e di quanti facevano quadrato intorno alla
«priorità» della Passione, anche a costo d’infrangere per una volta la «regola» del senso unico dal
profano al sacro.
Infine si concluse che Bach, dopo aver ricevuto la notizia della morte del Principe, si fosse
limitato a «prestare» alla Cantata delle esequie pezzi già composti per la Matthäuspassion, e
l’astrusa e macchinosa soluzione apparve impareggiabile, in quanto soddisfaceva insieme le due
istanze, apparentemente inconciliabili. Per poco, tuttavia, perché nel 1969 l’americano Paul
Brainard dimostrò che la polemica sulla priorità della Trauermusik o della Matthäuspassion era
tempo sprecato, perché «i dieci pezzi che hanno in comune, o almeno una buona parte, derivano
tutti da precedenti composizioni che non conosciamo»1. Questa circostanza renderebbe definitiva la
sottrazione dei dieci pezzi dal conto complessivo dei numeri originali per la “Passione”, vanificando
il grottesco tiro alla fune, il cui accanimento era tuttavia giustificato in quanti non si rassegnassero a
considerare anche la “Passione secondo Matteo” come il più imponente risultato dell’infaticabile
lavoro di riutilizzazioni e parodie, che appare il principale carattere dell’opera di Bach per la chiesa.
Benché il librettista di Bach Henrici (in arte Picander), ligio alla moda letteraria, pubblicasse e
ripubblicasse i testi della Matthäuspassion non solo senza il Vangelo, ma anche senza i Corali,
Bach pretese (e in quale abbondanza!) l’uno e gli altri, e li ottenne, e alla successiva prova riuscì a
piegare le fisime del librettista alla sua volontà, se Picander si decise a pubblicare il secondo testo
della Passione allestito insieme col Vangelo e coi Corali, che non lui aveva scelto (è incredibile,
eppure si è scritto persino questo), ma Bach in persona, che non avrebbe lasciato una simile
decisione a nessuno.
Questa superiorità, che Bach mantenne, con tante ragioni, di età e di prestigio, nel rapporto col
librettista, è il primo dei caratteri che consente di leggere questo rapporto come un’esperienza viva,
e non come accostamento di due nomi in un annuario.
Inebriato dal successo, che si riflesse anche su di lui dopo l’esecuzione della Matthäuspassion (a
saperlo cogliere, un gran frèmito si sente vibrare ancóra) il giovane poeta espresse pubblicamente la
speranza che il grande maestro avrebbe messo in musica tutte le sue edificanti poesie per le
domeniche e le feste dell’anno. Non aveva fatto i conti con l’incostanza, e forse anche stanchezza,
del suo collaboratore.
Quando appare Henrici-Picander, colui che sarà il suo librettista, Bach ha concluso la maggior
parte delle sue Cantate. Non è un caso. Bach non era uno da prendersi una qualsiasi raccolta di
P. Brainard, Bach’s Parody Procedure and the Saint Matthew Passion, in «Journal of American Musicological
Society», XXII (1969), pp. 241-260.
1
7
pensieri sentimentali scritti secondo i Vangeli per le feste dell’anno, e metterli in musica l’uno dopo
l’altro con la regolarità di una macchina da cucire, senza pretendere di buttare all’aria, tagliare,
aggiungere, e ficcarci dentro altri pezzi e i Corali preferiti. Se il grandioso torso dell’annata delle
Cantate sui Corali è stato possibile, se altri brevi cicli ebbero séguito, si dovette a collaboratori
docili, alle prime armi, o alla prontezza dei proprî interventi.
Il rapporto con Henrici si svolge, in buona parte, nel senso opposto rispetto a quello usuale tra
librettista e compositore. Siccome è anche musicista, Henrici-Picander riesce a comporre poesia
nuova, inalveandola entro musica già composta. È, prima di tutto, un poeta per parodie, quello che
Bach cerca e si educa. Tra i due valori in questo rapporto di solito la musica è la “vox prius facta”,
cui bisogna adattare le parole, secondo un’usanza che nel melodramma settecentesco fu tanto
diffusa da suscitare critiche e satire. Ma con Bach il gioco ha una posta artistica molto più alta.
Il legame con Bach è ostentato nella Prefazione al libretto della Matthäuspassion, accompagnato
da numerosi «Saggi di Cantate», che Picander sperava Bach avrebbe prima o poi messo in musica.
La Prefazione reca la data 24 giugno 1728: «Per l’onore di Dio, per soddisfare il desiderio dei buoni
amici e incoraggiare una maggior devozione, mi sono accinto all’impresa, in quanto posso
lusingarmi che forse l’insufficienza della poetica eleganza possa essere compensata dalla
squisitezza dell’incomparabile Signor Cappelmeister Bach, e che questi canti saranno intonati nelle
principali chiese della devota Lipsia».
L’unità e l’originalità, che tanto premevano ai musicologi dei secoli scorsi, appariranno
naturalmente intatte a chiunque, non turbato dalla tormentata sua storia esterna, contempli la
Matthäuspassion come opera d’arte: non per miracolo, o altri incantesimi, ma per la forza di
volontà, di lavoro, di scelte estetiche unificanti, che sono tutte del solo Bach. È vero che Picander
gli ha fornito un testo progettato con una unità di concezione che non poteva avere la raccogliticcia
Johannespassion. Ma le aggiunte dei pezzi precedenti, l’inserzione della sublime Fantasia su Corale
O Mensch, l’imperativa pretesa del testo evangelico, la frequente dislocazione dei Corali pasquali
della Passione, che conferiscono all’opera quell’immediata tinta tenera e patetica, il timbro della sua
atmosfera unica, prima ancora che si possa parlare di struttura in qualsiasi senso, tutti gli
accorgimenti e gli interventi che dissolvono le differenze fra le vecchie categorie di Passioni,
vengono da Bach, e da lui solo. È inutile affannarsi a ripetere che Bach torna indietro nel passato, in
quanto ripristina la totalità del testo scritturale; per poi disperarsi a conciliare questo ritorno con la
vastità delle parti concertanti e “contemplative” dell’opera: quindici arie, di cui due per coro, e
quattro per solista e coro, a fronte delle otto arie della Johannespassion. Undici ariosi qui, e due soli
nell’altra. Qui la concentrazione sull’istante è legata a un’inaudita vastità, l’immediato compimento
nel momento si combina con un dominio dell’insieme veramente sovrano.
Con il suo vivo senso della vicinanza e della lontananza insieme, con la realizzazione, libera da
costrizione, dell’hic et nunc e di un sentimento, sempre sotterraneamente desto, della struttura, del
trascorrere del tutto, con il suo “vivere da vicino”, come col suo “udire di lontano”, la musica di
Bach per la Matthäuspassion è un esempio di sicurezza biologica e di energia naturale, quali, in
musica, non troviamo in altri.
Tali sicurezza ed energia determinano la sua posizione particolare, che pure non è avvertibile
nella sfera del conscio. Da un lato, questa musica è certamente spontanea, immediata, plastica,
serrata; dall’altro, rimane sempre ciò che è, non esce mai da se stessa, non abbandona mai il suo
mistero: forza e indolenza, tensione e distensione, ondeggiante vita e profondissima quiete sono in
essa uniti in modo unico e incomparabile. Bach stesso fornì una commuovente e geniale traduzione
grafica di questo sentimento di duplicità, dell’intima consapevolezza di sommuovere due strati
dell’essere e dell’udire, l’irrimediabilmente lontano, e l’incombente vicino, quando, nel 1736, o nel
1740 (secondo diverse ipotesi), accingendosi alla partitura definitiva, «accuratamente perfetta, unica
perfino tra i suoi splendidi autografi», prese la riga e gli inchiostri colorati, e tracciò le parole della
Scrittura in rosso, «così che il messaggio divino spiccasse sugli altri testi» (Geiringer).
Mettendo in copia definitiva la partitura, Bach esterna, per quanto può, il contrasto di soggettivo
e oggettivo di che si alimenta la tensione tragica intima di questa “Passione”.
8
Ogni esuberanza soggettiva è in lui quasi scomparsa; si spiega la tremenda gravità di una forza
costruttiva continua e inesorabile, di un divenire musicale oggettivo. Bach non è soltanto il grande
“oggettivo”. È anche, e altrettanto, come Dante, la persona, l’uomo della suprema personalità, che
colma e alimenta, e, per così dire, “càrica” ogni espressione. Nelle Cantate, nelle Passioni, negli
Adagi dei Concerti, è lo spirito più soggettivo che la musica abbia ispirato.
Ha saputo rivivere nella sua anima le sofferenze del Figlio di Dio, la storia sacra del Cristo, tanto
da saper creare, nella sua ultima e maggior “Passione”, la Matthäuspassion appunto, un’opera
gigantesca che, per l’unità maestosamente soggettiva dell’ispirazione che la pervade, si può
paragonare soltanto all’opera monumentale dell’epoca romantica, il Tristano di Wagner, o all’opera
monumentale dell’epoca decadente, la Turandot di Puccini.
Ma ora vogliamo scoprire qualcosa di più profondo sull’uomo che ebbe nome Johann Sebastian
Bach. Paragoniamo la vita a un’orbita fatta di carboni ardenti, con pochi spazî freddi, orbita che a
noi è dato senza fine percorrere: a chi in quell’orbita è preso dà conforto il piccolo spazio freddo,
sul quale per il momento egli si trova, o che vicino innanzi a sé egli vede, e continua a percorrere
l’orbita. Ma il vero artista che, come Bach, Wagner o Puccini, sa guardare oltre il principium
individuationis e conosce l’essenza delle cose in sé, e quindi il tutto, non è più sensibile a quel
conforto: vede se stesso contemporaneamente su tutta l’orbita, e ne viene fuori. La sua volontà muta
indirizzo, non afferma più la sua propria essenza, che si rispecchia nel mondo fenomenico, ma la
rinnega. Il processo con cui ciò si manifesta è il passaggio dalla virtù all’ascesi. Non basta più a
quell’uomo amare altri come se stesso, e far per essi quanto fa per sé; ma sorge in lui un orrore per
l’essere, per la volontà di vivere, per il nocciolo e l’essenza di quel mondo riconosciuto pieno di
dolore, «valle di lacrime», ecc. Quest’essenza appunto, in lui medesimo palesantesi e già espressa
mediante il suo corpo, egli rinnega; il suo agire sbugiarda ora la sua transitorietà corporea, entra con
essa in aperto contrasto. Egli, che altro non è, se non se un’apparizione della volontà di vivere,
cessa di volere, approda alla noluntas, dalla quale solamente è stato generato il miracolo
dell’Alcyone dannunziano, lo stato di grazia della «sensualità rapita fuor dai sensi», e fattasi lirismo;
egli, il vero artista, si guarda bene dall’attaccare la sua volontà a una cosa qualsiasi, cerca di
rinsaldare in se stesso la massima indifferenza per ogni cosa, fatta eccezione per l’arte e per il
perfezionamento morale. Il suo corpo, forte e sano, esprime per mezzo dei genitali l’istinto sessuale,
ma egli rinnega la sua volontà e sbugiarda il suo corpo – ed ecco farsi strada nell’ultimo Bach uno
“strano” fenomeno: non vuole la soddisfazione del sesso, a nessun patto. Volontaria, perfetta castità
è il primo passo nell’ascesi, ovvero nella negazione della volontà di vivere. La castità raggiunta dai
grandi artisti, dai mistici e dai santi rinnega l’affermazione della volontà, che va oltre la vita
individuale, e che si chiama istinto di conservazione della specie; e con ciò la volontaria castità dà
segno che con la vita di questo corpo, la volontà, di cui esso è espressione, è soppressa.
L’ascesi si rivela inoltre nella volontaria, meditata povertà di Bach, povertà che non è
sopravvenuta per accidens, in quanto il patrimonio venga donato per lenir mali altrui, ma è già
scopo a se stessa, serve di permanente mortificazione della volontà, affinché l’appagamento dei
desiderî e la mollezza della vita non tornino a risvegliare la volontà di vivere, della quale la vera
conoscenza ha concepito orrore. Chi è pevenuto a tal segno, sente ancor sempre, seppure sempre più
flebilmente, come corpo animato, come espressione della mai del tutto debellata volontà di vivere,
l’inclinazione al volere nelle sue molteplici forme, tutte in grado di arrecar sofferenza: ma
deliberatamente, con atto pur sempre di volontà (ma di volontà al negativo, meglio definibile come
«non-volontà», o noluntas), soffoca tale inclinazione, costringendosi a nulla fare di quanto
vorrebbe, e viceversa a tutto fare quanto non vorrebbe, anche se non abbia altro fine, che quello di
servire alla mortificazione della carne. Così Sir Thomas More finì i suoi giorni. Giacché egli
medesimo rinnega la volontà di vivere che si manifesta nella sua persona, non opporrà resistenza se
altri fa lo stesso, ossia se gli reca un torto: ogni sofferenza, che gli venga dall’esterno, sia per caso,
sia per altrui malvagità, sia come conseguenza di passati errori, è la benvenuta; e così ogni danno,
ogni smacco, ogni offesa. Tutto accoglie gioiosamente, come occasione di dare a se medesimo la
certezza, che egli non afferma più la volontà, bensì lieto prende le parti di ciascun nemico sorto
9
contro quella manifestazione di volontà, che è la sua propria persona. Tale onta e dolore sopporta
quindi con inesauribile pazienza e dolcezza, paga senza ostentazione il male col bene, e non tollera
che il fuoco dell’ira si risvegli in lui, più che non tolleri il fuoco della brama. Come mortifica la
volontà di vivere, così mortifica la sua forma visibile, l’oggettività di lei: il corpo.
Scarsamente lo nutre, affinché il suo rigoglioso fiorire e prosperare non torni a far più viva e
forte la vitalità, di cui esso è semplice espressione e specchio. Similmente pratica il digiuno, anzi la
macerazione, l’autoflagellazione e il cilicio, per sempre più uccidere mediante perenne privazione e
sofferenza la volontà di vivere, che egli conosce e aborrisce qual sorgente del proprio doloroso
essere come di quello del mondo. Viene finalmente la morte, a disciogliere il manifestarsi di quella
volontà, la cui essenza qui, già da gran tempo, per libera negazione di se medesima, fuori del fioco
resto che ne appariva nel mantenere in vita il corpo, era spenta. E la morte, come invocata
liberazione e redenzione, è altamente benvenuta, e lietamente viene accolta. Per quegli, che così
finisce, è il mondo insieme finito. Sparisce insieme l’odiosa, variegata, e al contempo insulsa scena
di questo mondo. E non resta che il Nulla, l’ottimo, il traguardo estremo.
E ciò, ch’io qui con debole lingua e solo in termini generali ho de-scritto, non è per avventura
una fiaba filosofica di mia invenzione, e che solo da oggi duri: no, era invéce l’invidiabile vita di
numerosi santi e di belle anime tra i Cristiani, tra cui spicca quella di San Tommaso Moro, che sotto
l’ampia e sontuosa veste di Cancelliere della città di Londra durante il regno di Enrico VIII, portava
il cilicio e mortificava così la sua carne, lungi dagli occhi degli indiscreti, all’insaputa di tutti.
Forse qui adunque per la prima volta, in forma astratta e pura d’ogni mito, l’intima essenza della
santità, negazione di sé, morte dell’istinto vitale, ascesi, è formulata rigorosamente come negazione
della volontà di vivere; la quale subentra dopo che la compiuta e perfetta conoscenza del proprio
essere-nel-mondo è divenuta quietivo di ogni volere. Dal punto di vista pratico, però, un santo può
esser ricolmo della più assurda superstizione, o esser viceversa, come nel caso di Thomas More, un
filosofo: i due si equivalgono. Soltanto il suo modo d’agire prova ch’egli è santo: perché la sua
condotta di vita, sotto il riguardo morale, non proviene dalla conoscenza astratta, bensì
dall’intuitiva, immediata conoscenza del mondo e della sua essenza; e da quegli sol per
appagamento della sua ragione viene spiegata con un dogma purchessia.
Ma appunto, esclusivamente astratto e generico e quindi freddo è il mondo, ragion per cui io ho
descritto in abstracto la negazione della volontà di vivere, ossia la condotta di una bell’anima, di un
santo rassegnato, che faccia volontaria penitenza.
«Solo allora furono messe le mani addosso a Gesù». Si può talvolta incominciare dalla fine, e
queste sono in effetti le ultime parole dell’ultima opera che Tommaso Moro scrisse dalla Torre di
Londra in attesa dell’esecuzione, e che è convenzionalmente intitolata De Tristitia Christi. In effetti
il titolo che appare nel manoscritto autografo è più lungo e descrive meglio il contenuto dell’opera:
Sulla tristezza, lo sconforto, la paura e l’orazione di Cristo prima della sua cattura. Si tratta infatti
di una meditazione che percorre tutta l’agonìa di Gesù nell’Orto degli Ulivi, e la brùsca durezza
della frase finale acquista ancóra maggiore drammaticità se si pensa che, come recita l’appendice
apposta all’opera, giunto a quel punto della stesura Moro fu privato di carta, penna e inchiostro, gli
fu tolta cioè ogni possibilità di scrivere: come a Gesù, anche a lui furono messe le mani addosso,
uccidendo per così dire la sua voce prima di mettere fine con la decapitazione alla sua vita.
Interruzione improvvida, allora, o degna conclusione?
A giudicare dall’ultimo titolo lasciato da Moro sembra di poter dire che l’opera aveva come
punto d’arrivo proprio l’arresto di Gesù, e dunque si può anche credere che, se proprio non si è
trattato di una felice invenzione retorica (come pare perlomeno possibile), si è almeno davanti a una
fortunata coincidenza. Ma già costituisce un aspetto interessante – e forse si dovrebbe dire
commuovente – di quest’opera moreana il fatto che Moro abbia deciso di scrivere e di meditare
sull’agonìa di Gesù mentre viveva la propria lunghissima agonìa, dato che su quale sarebbe stato lo
sbocco della sua prigionia da molto tempo non c’era più dubbio alcuno. È lui stesso ad affermarlo,
in una lettera alla figlia Margaret scritta il 2 o 3 maggio 1535, quando la condanna a morte di tre
priori certosini e del monaco brigidino di Syon Abbey, Richard Reynolds, era un chiaro preludio di
10
quella che sarebbe stata la sua fine. Commentando gli inutili tentativi di una commissione reale di
farlo recedere dalla sua posizione, Moro scrive: «Risposi che ero entrato nella piena determinazione
di non occuparmi né di immischiarmi più in alcuna faccenda di questo mondo, ma che tutta la mia
riflessione sarebbe stata sulla passione di Cristo e sulla mia uscita da questo mondo»2.
Con questo in mente, nonostante il distacco dello scrittore che evita accuratamente ogni rischio
di autobiografismo, oggettivando al massimo la meteria del suo trattato, il lettore non può fare a
meno di pensare ad ogni istante chi è e in quale situazione si trova l’autore delle pagine che sta
leggendo, fino a vedere e a vivere, nel fluire della meditazione, una sorta di identificazione tra More
e Gesù in un naturale e incessante passare dall’uno all’altro.
A questo si aggiunga il fatto che dell’opera possediamo il manoscritto autografo, conservato a
Valencia come una preziosa orliquia, ove è dato d’osservare l’autore nell’atto stesso dello scrivere.
È difficile, insomma, sottrarsi alla commozione trasmessa da un libro quando, a brevissima distanza
dal diaframma delle parole, è dato d’incontrare dal vivo il suo autore, e questo nel momento più
altamente drammatico della sua esistenza.
Opera ultima, e insieme opera di sintesi di una vita, come è stato osservato, compreso il fatto che
qui si raccordano nello stesso stile le varie figure di Moro scrittore: l’umanista e il fine latinista
dell’Utopia, il polemista dei varî ed estesi scritti contro l’eresia (luterana, giacché fin dall’inizio
Thomas More contrastò la Riforma), l’attento scrutatore di uomini, e soprattutto il laico devoto e
pieno di fede che nell’ultimo scorcio della sua vita ritorna a quell’esperienza di reclusione, anche se
non volontaria questa volta, che già aveva vissuto come ricerca di Dio e di se medesimo quando,
poco più che ventenne, aveva passato quattro anni nella Certosa di Londra. Non è un caso che le
cosiddette “opere della Torre” (Tower works), o opere della prigionia, abbiano tutte un soggetto
religioso, e riflettano tutte non solo la situazione di Moro in quel momento, ma anche i filoni più
diffusi e più praticati della letteratura del tardo medioevo in Inghilterra. Queste opere sono il
Trattato sulla passione, il Dialogo del conforto contro la tribolazione, scritti in Inglese, e il De
Tristitia, appunto, opera per la quale Thomas More tornò al Latino. Se pure la condizione di
prigionia ha avuto un peso non piccolo nella scelta dei soggetti, è anche chiaro che Moro non vi
arrivava impreparato, perché quelli erano stati temi di meditazione frequentati, si può dire
quotidianamente, insieme alle più fini anime religiose del suo tempo.
Sarebbe d’altronde singolare pretendere da un moralista, ch’egli non debba raccomandare se non
le virtù da lui stesso possedute. La storia del mondo tacerà invero sempre, e deve tacere, degli
uomini la cui condotta è migliore, l’unica soddisfacente illustrazione di questo punto della nostra
indagine. Giacché la materia della storia del mondo è tutt’altra, anzi è l’opposto: non è il negare, il
rinunciare alla volontà di vivere, ma è per l’appunto l’affermarla, la manifestazione di essa in
individui innumerevoli. Ma noi ci siamo proposti d’investigare il valore etico delle azioni, e di
questo il criterio unico per misurare quanto è per noi significativo e importante, noi non tratterrà
nessun timore della volgarità e della scipitaggine raccolte in perpetua maggioranza, dal proclamare
che il più alto, il più importante, il più significativo fenomeno che il mondo possa mostrare, non è
chi il mondo conquista, ma chi il mondo supera. Per chi si occupa di filosofia sono dunque sotto
questo riguardo incomparabilmente più istruttive e importanti, quanto riguardo al significato del
contenuto, le biografie di santi uomini (agiografìe), per male che sian scritte di solito, e presentate
con un misto di superstizione e di stoltezza, che non siano Plutarco e Livio.
Da dove viene un tal senso di vanità nella vita dei cristiani che godono della verità evangelica?
Di quali tumulti si riempie la nostra vita, in ogni occasione! Pratichiamo il commercio, solchiamo i
mari e il cielo, ci buttiamo nella guerra, stipuliamo trattati e li infrangiamo, generiamo figli,
nominiamo eredi, compriamo campi e li vendiamo, cementiamo amicizie, erigiamo edifici e li
abbattiamo. Ci esercitiamo in molteplici arti; sudiamo e diventiamo dottori in legge, in fisica, in
scienze, in lettere, in filosofia o in teologia. Fra queste tensioni ci torturiamo, ci facciamo vecchi e
lasciamo scivolare via gli anni e perdiamo il tesoro prezioso che solo ha valore. Ci accorgeremo in
2
Cfr. Lettera n. 214.
11
ritardo che tutte queste verità non erano che ombre e che abbiamo buttato le nostre vite
nell’illusione di un sogno. Qualcuno dirà a questo punto: «Così, un cristiano non deve aver nulla a
che fare con queste vanità?». Non si tratta di questo. Si deve partecipare, ma solo con distacco,
pronti a lasciare tutto per la sola cosa che importa, come dice Paolo, «avendo moglie come se non la
si avesse», piangendo come se non si piangesse, rallegrandosi come se non ci si rallegrasse,
vendendo come se non si fosse proprietarî di nulla, usando il mondo come se non lo si usasse,
perché la figura di questo mondo si dissolve. Fruire quindi del mondo, ma non riporre la propria
gioia in esso.
Alla migliore e più compiuta conoscenza di quel che noi, nell’astrazione e nell’universalità del
nostro modo d’esporre, chimiamo negazione della volontà di vivere, molto contribuirà, inoltre, lo
studio delle massime etiche le quali in questo senso furon date da uomini pieni di cotale spirito.
Esse ci mostreranno anche come antica sia la nostra concezione, per quanto nuova possa essere la
sua formulazione filosofica. Più dappresso a noi sta il cristianesimo, la cui etica è tutta permeata da
quello spirito, e non solo conduce al più alto grado d’amore verso il prossimo, ma anche alla
rinuncia. Quest’ultima è già ben visibile in germe negli scritti degli Apostoli, ma tuttavia solo più
tardi si sviluppa appieno e viene explicite enunciata. Troviamo che gli Apostoli prescrivono: amor
del prossimo eguale all’amor di sé; carità, amore e benevolenza in cambio di odio; pazienza,
mitezza, sopportazione d’ogni possibile offesa senza opporvisi; sobrietà nel cibo per mortificare il
piacere; resistenza all’istinto sessuale, ove sia possibile, completa. Vediamo già qui i primi gradi
dell’ascesi, o propriamente negazione della volontà di vivere, dell’istinto di conservazione e di
sopraffazione (ch’è tutt’uno). E questa nostra espressione indica proprio ciò che nei Vangeli si
chiama rinnegar se stesso e prender su di sé la croce (Matth. 16, 24-25; Marc. 8, 34-35; Luc. 9, 2324; 14, 26-27 e 33). Quest’indirizzo si sviluppò presto sempre più, e diede origine ai penitenti, agli
anacoreti, al monachesimo; il quale era in sé puro e santo, ma appunto perciò per nulla adatto alla
maggioranza degli uomini, per modo che soltanto finzione e turpitudine poté venirne: perché abusus
optimi pessimus. Col cristianesimo meglio sviluppato possiamo poi vedere quel germe ascetico
aprirsi nel suo pieno fiore, negli scritti dei santi mistici cristiani. Costoro predicano, oltre il puro
amore, anche rassegnazione intera, volontaria, assoluta povertà, verace calma, completa
indifferenza riguardo a ogni cosa terrena, morte della volontà individuale e rinascita in Dio, perfetto
oblìo della propria persona e assorbimento nella contemplazione divina. Ma forse mai lo spirito del
cristianesimo in questo suo sviluppo fu espresso con tanta perfezione e vigore come negli scritti dei
mistici tedeschi, e in particolare di Meister Eckhard, nel libro non a torto celebrato Die deutsche
Theologie (la teologia tedesca), di cui Lutero, nella prefazione che vi fece, disse di non aver da
nessun altro libro, eccettuati la Bibbia e sant’Agostino, imparato meglio che da questo, che cosa
siano Dio, Cristo e l’uomo. I precetti e ammaestramenti quivi impartiti sono la più completa
illustrazione, ispirata dalla più intima e profonda certezza, di ciò che abbiamo presentato come
negazione della volontà di vivere. Colà bisogna quindi imparare a meglio conoscerla; colà Bach si
ispirò a rappresentare in note la passione di Cristo. Scritta nel medesimo, altissimo spirito, sebbene
non tale da mettersi proprio a paro di quell’opera, è l’Imitazione della povera vita di Cristo
(Nachfolgung des armen Leben Christi) di Tauler, e anche, dello stesso autore, Medulla animae. Gli
insegnamenti di questi genuini spiriti cristiani sono rispetto a quelli del Nuovo Testamento ciò che è
l’alcool rispetto al vino. Ovvero: ciò che nel Nuovo Testamento ci appare come attraverso velo e
nebbia, ci si fa incontro nelle opere dei Mistici come la seconda iniziazione ai piccoli e grandi
misteri.
Venendo all’etica degli Induisti, quale noi già ora, per incompiuta che sia la nostra cognizione di
quella vastissima letteratura, la troviamo espressa nel modo più vario e vivace nei Vedas, nei
Puranas, nelle opere poetiche, nei racconti mitici, nelle leggende dei santi indiani, nelle massime e
regole di vita, vediamo che vi si prescrive: amore del prossimo con piena rinunzia a ogni egoismo;
amore non limitato al genere umano, ma estendentesi a ogni cosa viva; carità spinta fino a dare lo
stentato guadagno quotidiano; illimitata pazienza verso tutti gli offensori; bontà e amore in cambio
di ogni male, per duro che sia; volontaria e gioiosa tolleranza di ogni umiliazione; astinenza da ogni
12
nutrizione animale; completa castità e rinuncia a tutti i piaceri da parte di chi aspira alla vera santità;
donazione di ogni patrimonio, abbandono di ogni domicilio, di tutti i parenti; profonda, assoluta
solitudine, trascorsa in silenziosa contemplazione, con volontaria penitenza e terribile, lenta
macerazione, per pervenire alla completa mortificazione della volontà di vivere, mortificazione che
giunge fino alla morte volontaria per fame, o con l’esporsi ai coccodrilli, o col precipitarsi da una
sacra vetta dell’Himalaja, o col farsi seppellire vivi, ecc. Non ci si meraviglierà mai abbastanza
della somiglianza uniforme che si trova quando si legge la vita di un penitente o santo cristiano e
quella di un indiano. Ormai ho indicata la fonte, dalla quale si posson direttamente conoscere,
attingendo alla vita stessa, i procedimenti in cui si palesa la negazione della volontà di vivere.
In certo modo, è questo il punto più importante di tutto il nostro studio: nondimeno io l’ho
esposto tenendomi sempre sulle generali, meglio essendo rimandare a quelli i quali ne parlano per
diretta esperienza, che non ingrossare senza bisogno questo saggio con l’affievolita ripetizione di
ciò che essi hanno detto. Ma poco altro voglio aggiungere per definire genericamente il loro stato.
Vedemmo più indietro il malvagio, per vivacità del suo istinto, soffrire sempre divorante intimo
affanno, e da ultimo, quando tutti gli oggetti del volere sono esauriti, placare la rabbiosa sete
dell’egoismo con la vista della pena altrui; quegli viceversa, in cui si è affermata la negazione della
volontà di vivere, per quanto povero, scevro d’allegrezza mondana, pieno di privazioni sia il suo
stato visto dal di fuori, è pieno d’intima gioia e di vera calma celeste. Non sono più l’irrequieto
impulso vitale, l’esuberante gioia, che ha per condizione precedente o successiva un vivo dolore,
quali costituiscono la vita di un uomo amante dell’esistenza; ma è invéce un’incrollabile pace, una
profonda quiete ed intima letizia, uno stato che noi, se ci vien posto davanti agli occhi o alla
fantasia, non possiamo guardare senza altissimo desiderio, perché presto lo riconosciamo come
l’unico che ci si convenga, di gran lunga superiore a ogni altra cosa, e verso di esso il nostro spirito
migliore si spinge con il suo grande sapere aude. Sentiamo allora come ogni appagamento dei
nostri desiderî, delle nostre velleità, delle nostre bramosìe strappato al mondo è appena simile
all’elemosina, che oggi tiene in vita il mendicante perché domani ancóra soffra la fame. La
rassegnazione somiglia invece alla proprietà ereditaria, che libera per sempre il possessore da tutte
le angustie.
Ci sovviene l’esordio del presente saggio, che la gioia estetica del bello consiste in gran parte nel
fatto che noi, entrando nello stato della pura contemplazione, siamo per il momento liberati da ogni
volere, ossia da tutti i desiderî e gli affanni, quasi fossimo sciolti da noi medesimi; non più un
individuo dotato di una conoscenza al servizio del proprio perenne volere; bensì eterno soggetto del
conoscere, liberato dalla volontà. Così la gioia estetica del bello è descritta nel Piacere di
D’Annunzio. E sappiamo come gli istanti, in cui, sciolti dal feroce impulso della volontà, veniamo
quasi a tenerci sollevati sulla greve aria terrestre, siano i più beati che conosciamo. Da ciò possiamo
dedurre come debba esser felice la vita di un uomo la cui volontà sia domata non per fugaci istanti,
come accade nella fruizione del bello, ma per sempre, e sia anzi spenta del tutto, eccettuata
solamente l’ultima scintilla in estinzione, che regge il corpo e con questo si estinguerà. Sereno e
sorridente egli si volge ora a guardare le sbiadite immagini del mondo, che un tempo sapevano
scuotere e affliggere anche il suo animo, ma ora gli stanno innanzi indifferenti come i pezzi di una
scacchiera a gioco finito, o come al mattino i vestiti da maschera smessi e dispersi, le cui parvenze
finte ci avevano stuzzicati ed eccitati nella notte di carnevale. La vita e le sue forme ondeggiano
oramai davanti a lui come una fuggitiva visione, o come appare nel dormiveglia un lieve sogno
mattutino, attraverso il quale già traluce la realtà, e che più non riesce ad illuderci: e appunto come
questo sogno svaniscono, senza brusco passaggio.
Non ci è lecito tuttavia ritenere che una volta subentrata attarverso la conoscenza, la negazione
della volontà di vivere non tentenni mai più, e ci si possa su di essa posare come su di una proprietà
guadagnata. Con la parola ascesi, già spesso da me usata, io intendo, nel senso più stretto, il
deliberato infrangimento della volontà, mediante l’astensione dal piacevole e la ricerca dello
spiacevole, l’espiazione e la macerazione spontaneamente scelta, per la continuata mortificazione
della volontà. Ora, se noi vediamo questa mortificazione praticata da chi già è giunto alla negazione
13
della volontà, per rimanervi, è però il dolore in genere, quale viene inflitto dal destino, una seconda
via per arrivare a quella medesima negazione. Possiamo anzi ritenere, che i più solo da questa vi
arrivano, e che è il dolore direttamente provato, non quello semplicemente conosciuto, a produrre la
piena rassegnazione, spesso solamente in prossimità della morte.
Il più delle volte la volontà deve quindi venire spezzata da un fortissimo dolore personale, prima
che giunga a negarsi. Vediamo allora l’uomo, quando per tutti i gradi dell’angoscia è giunto,
resistendo con violenza, all’orlo della disperazione, improvvisamente tornare in sé, sé e il mondo
conoscere, mutare tutto il proprio essere, elevarsi sopra se stesso e sopra il dolore, e, come fosse da
questo dolore purificato e santificato, rinunciare in non attaccabile calma, in beatitudine e sublimità
di spirito a tutto quello che prima egli bramava con la massima violenza, e attendere gioioso la
morte. «Il mio cuore è fermo, e attende il giorno estremo», dice D’Annunzio nel Notturno.
Di questa negazione della volontà di vivere prodotta da una grande sventura e da nessuna
speranza di salvezza, ci ha dato una limpida e intuitiva rappresentazione, tale ch’io non ne conosco
pari nella poesia, Goethe, nel Faust, nella storia del dolore di Margherita. Essa è un esempio
perfetto della seconda via, la quale conduce alla negazione della volontà mediante un personale,
terribile dolore da noi stessi provato; e non, come prima, mediante la semplice cognizione del
dolore di un mondo intero, che volontariamente si fa dolore proprio. È vero che molte tragedie
conducono da ultimo il loro eroe pieno d’impetuosa volontà a questo punto di completa
rassegnazione: ma nessuna rappresentazione, ch’io conosca, ci mette innanzi agli occhi ciò ch’è
essenziale in quel rovesciamento di prospettiva con tanta limpidezza e così puro da ogni accessorio,
come la storia citata del Faust. Leggiamo ora la similitudine lucreziana (De rerum natura I, 936949) ripresa da Tasso:
Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi
di soavi licor gli orli del vaso:
succhi amari ingannato intanto ei beve,
e da l’inganno suo vita riceve3.
Prossimità della morte e perdita della speranza non sono d’altronde punto necessarie per codesta
purificazione prodotta dal dolore. Anche senza di quelle può, mediante malattia, grande sventura o
grande dolore, prodursi vigorosamente, e fare comprendere il nulla di ogni aspirazione, che viene
così a cadere dall’animo del sofferente, e viene, in definitiva, eliminata. Per questo si son visti
spesso degli uomini, che avevano menato una vita assai travagliata nel tumulto delle passioni,
improvvisamente mutare, darsi alla rassegnazione e alla penitenza, farsi eremiti e monaci. Qui
vanno comprese tutte le storie genuine di conversione, ad esempio quella di Raimondo Lullo, il
quale da una bella, a cui aveva lungamente fatto la corte, invitato finalmente a raggiungerla in
camera sua, si vedeva presso al compimento di tutti i desiderî, quand’ella, slacciandosi il corpetto,
gli mostrò il seno orribilmente divorato da un cancro. Da quell’istante, come avesse spinto l’occhio
nell’inferno, si convertì; abbandonò la corte del re di Majorca e andò nel deserto, a far penitenza.
A questa conversione somiglia molto quella dell’abate Rancé. Se consideriamo come in entrambi
il passaggio avvenisse dal piacere agli orrori della vita, abbiamo in ciò una spiegazione del fatto
sorprendente che la nazione più mondana d’Europa, quella francese, sia pur quella in cui è sorto
l’ordine monastico di gran lunga più rigido, la Trappa, poi restaurato dopo la sua decadenza da
Rancé, e malgrado rivoluzioni, evoluzioni ecclesiastiche e sbandierata incredulità, fino al giorno
d’oggi sopravvivente nella sua purezza e terribile severità.
Quanto più è vivace lo slancio vitale, quanto più stridente il fenomeno del suo contrasto, tanto
più forte è il dolore. Così Johann Sebastian Bach, come ogni genio, la cui volontà d’affermazione è
molto forte, con grande dolore e immenso contrasto si liberò dall’esuberanza delle Cantate giovanili
(si pensi a Gott ist mein König) e giunse al decantato stile delle opere sue più mature, distillate e
3
T. Tasso, Gerusalemme liberata I, 3, vv. 5-8.
14
purificate da ogni ambizione terrena, e dirette alla posterità più remota. Un mondo, il quale fosse
espressione di una volontà di vivere molto più vigorosa della presente, ci mosterrebbe dolore
d’altrettanto più grande: sarebbe dunque un inferno.
Poiché ogni sofferenza, essendo una mortificazione e un richiamo alla rassegnazione, ha la
possibilità di essere una forza purificatrice, si spiega con questo che una grande sventura e profondi
dolori già di per sé ispirino un certo rispetto. Ma del tutto degno di venerazione ci appare colui che
soffre, solo quando egli, guardando al corso della sua vita come a una catena di mali, o soffrendo
per un grande, insanabile dolore, non si soffermi a considerare attentamente la concatenazione di
circostanze, da cui fu precipitata in dolore la sua vita; e non s’arresti a quel singolo dolore che l’ha
colpito: entro questi limiti egli vorrebbe ancóra e sempre la vita, purché in condizioni diverse dalle
sue; ma invece, dico, degno di venerazione egli appare veramente solo quando il suo sguardo si è
elevato dal particolare all’universale, quando egli considera il suo dolore personale come esempio
del Tutto (esempio lampante di simili considerazioni è Leopardi), e per lui, diventato ormai geniale
sotto il rispetto etico, un caso vale quanto mille; così che il complesso della vita, visto come
essenziale dolore, lo conduce alla rassegnazione. In questo senso è degna di venerazione, nel
Torquato Tasso di Goethe, la Principessa, quando si effonde a narrare come sempre mesta e senza
gioia fosse la sua vita e quella dei suoi, e ciò facendo guarda al dolore universale.
Un carattere molto nobile ce lo immaginiamo sempre con una certa apparenza di muta tristezza;
la quale è tutt’altro che un permanente cattivo umore per le contrarietà quotidiane (ché questo non
sarebbe un tratto nobile, e darebbe a temere malvagità d’animo); bensì è coscienza, nata da
cognizione, della vanità di tutti i beni e del dolore d’ogni vita, non della propria soltanto.
Nondimeno questa cognizione può esser dapprima destata da mali personalmente sofferti,
soprattutto da un unico, grande dolore. Così un unico, inappagabile desiderio ha condotto Petrarca a
quella rassegnata mestizia nel considerar la vita intera, che tanto ci commuove nelle sue opere, e
particolarmente nei Rerum vulgarium fragmenta: perché la Dafne ch’egli inseguiva doveva sfuggire
dalle sue mani, per lasciare a lui, in luogo di se stessa, l’alloro immortale. Quando la volontà, per
una tale grande e irreparabile percossa del destino, è rotta in una certa misura, non viene quasi più
desiderato nient’altro che la morte, e il carattere si mostra dolce, triste, nobile, rassegnato. Quando
infine il dolore non ha più un luogo determinato, ma si estende e dilaga su tutta la vita nel suo
complesso, allora esso è in un certo modo un rientrare in sé, un ritirarsi, un graduale svanire
dell’impulso vitale, della cosiddetta “gioia di vivere”. E il corpo stesso finisce con l’essere a poco a
poco, ma nel profondo, minato dal dolore; in ciò l’uomo sente una certa liberazione dai suoi ceppi,
un dolce presentimento della morte che si annuncia insieme col dissolvimento del corpo e
dell’istinto vitale. Perciò tale dolore è affiancato da una segreta gioia, quella, a nostro parere, che il
più malinconico di tutti i popoli ha chiamato the joy of grief. Tuttavia si trova proprio qui lo scoglio
della sensibilità, sia nella vita, sia nella rappresentazione poetica di questa; se cioè si soffre sempre,
e sempre ci si lamenta, senza elevarsi alla rassegnazione e fortificarsi, ci si trova ad aver perduto
insieme e terra e cielo, conservando solo una dolente sensibilità, incline ad insulse lacrime e a vuoti
sospiri. Il soffrire è via di liberazione dalla volontà di vivere, ed è degno quindi di alto rispetto solo
in quanto perviene alla semplice, pura conoscenza della completa insignificanza della vita e della
santità della morte; e questa conoscenza indispensabile, fattasi lenitivo della volontà, produce vera
rassegnazione. Sotto tale riguardo proviamo alla vista di ciascun grande infelice un certo rispetto,
affine a quello che virtù e nobiltà c’ispirano; innanzi a lui ci sembrerebbe un rimprovero la nostra
condizione felice, se non ci soccorresse la consapevolezza dell’assoluta inconsistenza e mancanza
di valore di ogni persona umana, la nostra compresa, «inutile peso della terra» (Omero), e
dell’«infinita vanità del tutto» (Leopardi). Non possiamo però trattenerci dal considerare ogni
dolore, sia nostro che altrui, come un ravvicinamento, per lo meno possibile, alla virtù e alla santità,
in quanto ogni negazione della vita è di per se stessa positiva, e volge alla liberazione dal male, che
altro non è che la vita stessa; poiché chi non è esistito non ha conosciuto il male, la sola sostanza
della vita, tanto da potersi identificare pienamente con essa – il solo oggetto della conoscenza è
infatti la vita, cioè il male e l’inferno della continua, insostenibile, acre ed acuta sofferenza; e non ci
15
è possibile non considerare invéce i cosiddetti “beni”, cioè i piaceri e le soddisfazioni della vita, se
non come un allontanamento dalla virtù e della santità, ch’è azzeramento della voglia di vivere. Ciò
arriva al punto, che ogni uomo il quale patisca una grande sofferenza corporea, o una grave
sofferenza morale; o anche addirittura ogni uomo, che compia col sudore nel volto e con visibile
sfinimento un semplice lavoro fisico richiedente il massimo sforzo; e tutto ciò sopporti
pazientemente e senza mormorare; quest’uomo, dico, quando lo guardiamo con profonda
attenzione, ci appare come un malato: il quale faccia una cura dolorosa, ma sopportando di buon
animo e addirittura con piacere il dolore, che da quella terapia gli viene, perché sa che quanto più
soffre, tanto più sarà estirpata la causa del male.
Così all’egro fanciul porgiamo aspersi
di soavi licor gli orli del vaso:
succhi amari ingannato intanto ei beve,
e da l’inganno suo vita riceve4.
Il dolore presente è la misura della sua guarigione. Da quanto abbiam detto finora appare che la
negazione della volontà di vivere, che è quel che si chiama rassegnazione completa o santità,
proviene sempre da un’attenuazione della volontà di vivere, ovvero dalla conoscenza dell’intimo
dissidio a questa inerente, e della sua essenziale vanità (giusta le notissime parole dell’Ecclesiaste),
dissidio e vanità che si manifestano nei continui, ininterrotti dolori di ogni essere vivente:
Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perì l’inganno estremo,
ch’eterno io mi credei. Perì. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna
la terra. Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta omai. Dispera
l’ultima volta. Al gener nostro il fato
non donò che il morire. Omai disprezza
te, la natura, il brutto
poter che, ascoso, a comun danno impera,
e l’infinita vanità del Tutto5.
La differenza, da noi indicata con l’immagine delle due vie, è questa: se quella cognizione è
generata dal dolore semplicemente conosciuto, in abstracto considerato, con spontanea
comprensione e accettazione di esso, mediante il superamento della propria soggettività e
individualità; oppure dal dolore direttamente, personalmente provato. Vera salvezza, redenzione
dalla vita e dal dolore non può essere immaginata senza la completa negazione della volontà di
vivere. Prima di giungere a quel punto, noi non siamo altro che quella volontà stessa, la cui
manifestazione è un’esistenza evanescente («amaro e noia / la vita, altro mai nulla»6), è un sempre
nullo, vano aspirare, è l’intero, doloroso mondo dell’esperienza, al quale tutti in egual modo
irrevocabilmente appartengono. Per questo motivo abbiamo visto più sopra, che alla volontà di
vivere la vita è sempre sicura, e unica sua dimensione reale è il presente: a cui gli esseri, per quanto
4
T. Tasso, Gerusalemme liberata, I, 3, vv. 5-8 (vd. supra).
G. Leopardi, Canti, XXVIII (A se stesso), 1835.
6
Ibidem.
5
16
nascita e morte abbiano sì gran parte nell’esperienza, mai si sottraggono. Questo esprime il mito
indiano della reincarnazione, dicendo: «essi tornano a nascere». La grande differenza morale che
esiste tra i caratteri delle persone ha il significato seguente. Il malvagio, l’anima crudele è
infinitamente lontana dal raggiungere la conoscenza, da cui trae origine e si genera la negazione
della volontà (di vivere, di farsi spazio, strada, di opprimere: perché homo homini lupus), e quindi è
effettivamente e concretamente in balìa di tutti gli affanni che nella vita appaiono possibili: «Sorge
non lunge a le cristiane tende / tra solitarie valli alta foresta, / foltissima di piante antiche, orrende, /
che spargon d’ogni intorno ombra funesta. / Qui, nell’ora che il sol più chiaro splende, / è luce
incerta e scolorita e mesta, / quale in nùbilo ciel dubbia si vede / se ’l dì alla notte o s’ella a lui
succede. // Ma quando parte il sol, qui tosto adombra / notte, nube, caligine ed orrore / che
rassembra infernal, che gli occhi ingombra / di cecità, ch’empie di tema il core; / né qui gregge od
armenti a’ paschi, a l’ombra / guida bifolco mai, guida pastore, / né v’entra peregrin, se non
smarrito, / ma lunge passa e la dimostra a dito»7.
I dolori, che il malvagio infligge altrui, nella violenza e nella rabbia della sua sete di vendetta,
sono la misura dei dolori da lui personalmente provati, che non pervengono a infrangere la sua
volontà di vivere e a guidarlo verso la finale negazione e rassegnazione. Ogni vero e puro amore,
invece, e anche ogni libero senso di giustizia, provengono sempre dal superamento
dell’individualismo e del soggettivismo; il quale superamento, quando avvenga in pieno vigore, ha
per effetto la piena santità e redenzione. Il processo di questa è lo stato di rassegnazione sopra
descritto, l’incrollabile amore, che tale rassegnazione accompagna, e la suprema letizia nella morte.
7
T. Tasso, Ger. lib. XIII, 2-3.