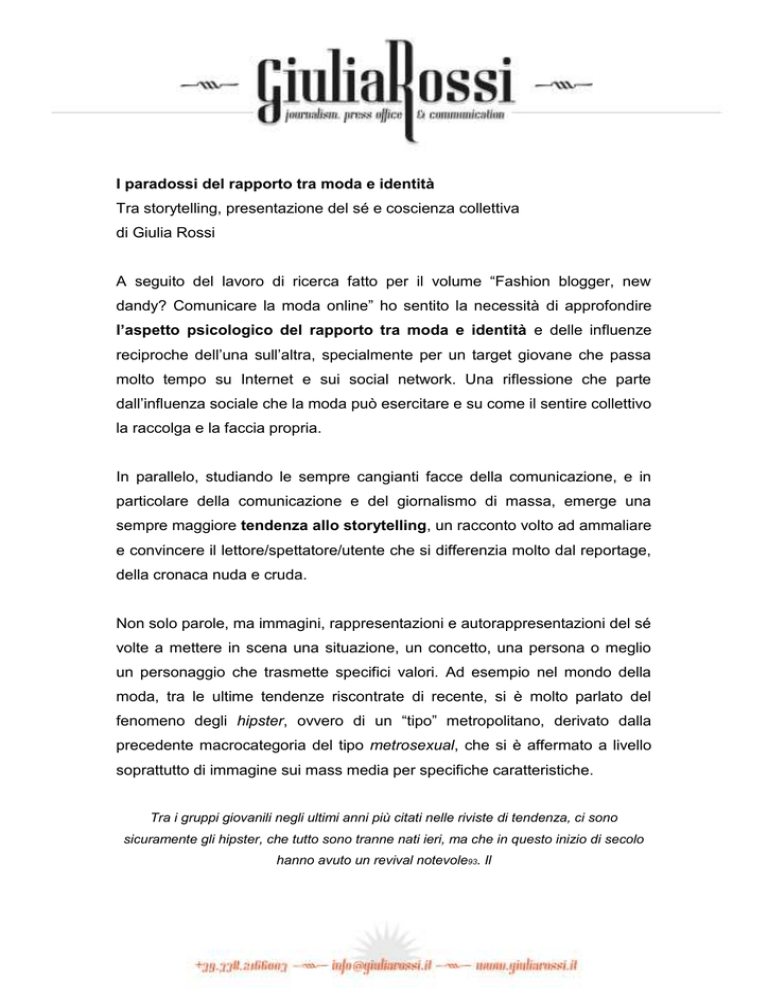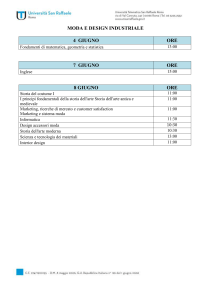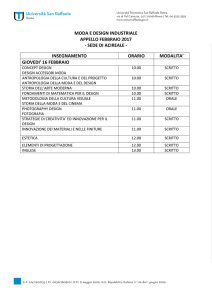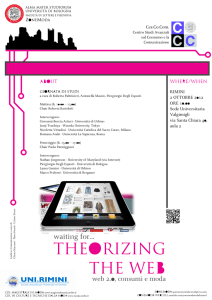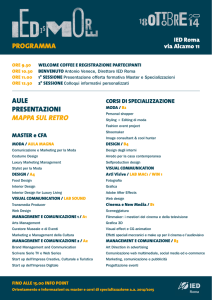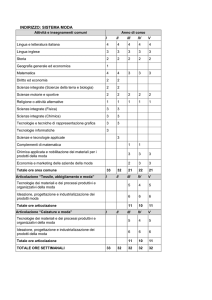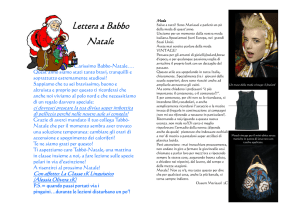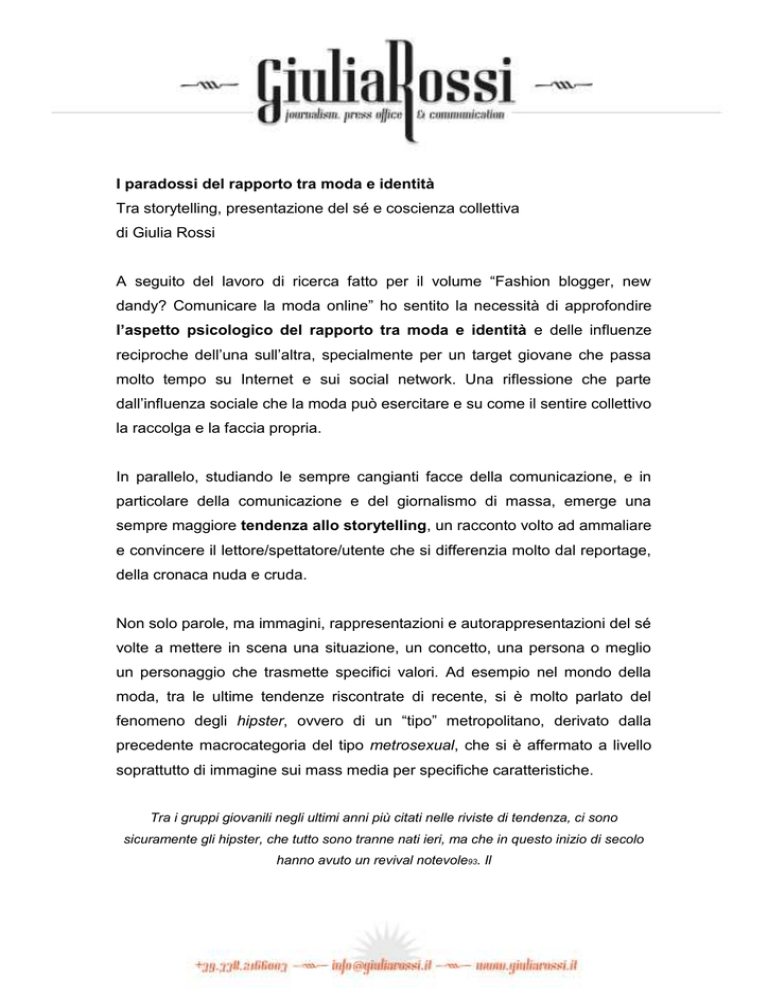
I paradossi del rapporto tra moda e identità
Tra storytelling, presentazione del sé e coscienza collettiva
di Giulia Rossi
A seguito del lavoro di ricerca fatto per il volume “Fashion blogger, new
dandy? Comunicare la moda online” ho sentito la necessità di approfondire
l’aspetto psicologico del rapporto tra moda e identità e delle influenze
reciproche dell’una sull’altra, specialmente per un target giovane che passa
molto tempo su Internet e sui social network. Una riflessione che parte
dall’influenza sociale che la moda può esercitare e su come il sentire collettivo
la raccolga e la faccia propria.
In parallelo, studiando le sempre cangianti facce della comunicazione, e in
particolare della comunicazione e del giornalismo di massa, emerge una
sempre maggiore tendenza allo storytelling, un racconto volto ad ammaliare
e convincere il lettore/spettatore/utente che si differenzia molto dal reportage,
della cronaca nuda e cruda.
Non solo parole, ma immagini, rappresentazioni e autorappresentazioni del sé
volte a mettere in scena una situazione, un concetto, una persona o meglio
un personaggio che trasmette specifici valori. Ad esempio nel mondo della
moda, tra le ultime tendenze riscontrate di recente, si è molto parlato del
fenomeno degli hipster, ovvero di un “tipo” metropolitano, derivato dalla
precedente macrocategoria del tipo metrosexual, che si è affermato a livello
soprattutto di immagine sui mass media per specifiche caratteristiche.
Tra i gruppi giovanili negli ultimi anni più citati nelle riviste di tendenza, ci sono
sicuramente gli hipster, che tutto sono tranne nati ieri, ma che in questo inizio di secolo
hanno avuto un revival notevole93. Il
termine infatti ha origine negli Stati Uniti negli anni Trenta e Quaranta e nasce nel mondo
del jazz a indicare i bianchi del ceto medio che si facevano contagiare dalla cultura
musicale nera e non solo, ritenuta cool e fuori dagli schemi. L’immagine viene ripresa e
la parola resa nota dai poeti “beat”, anche se poi cambiano i tempi e a prevalere è la
cultura hippy. Cosa li riporta agli onori delle cronache? Chi sono gli hipster e come si
riconoscono? Prevalentemente nei tempi recenti quando si parla di hipster si intende
soprattutto un modello maschile, metropolitano, occhialoni dalla montatura marcata,
barba lunga e camicia a scacchi, sneakers falso trasandato (ma un paio di stringate fatte
su misura nell’armadio), niente sport, solo bicicletta e un atteggiamento consapevole,
informato, ecologico. Per lei look androgino, leggins molto stretti, bigiotteria rétro e capelli
artificiosamente spettinati. Non ci sono codici precisi, basta allontanarsi dal mainstream.
(Che cosa è un hipster di F. Pacifico, in ilsole24ore.it, 30 luglio 2014)
Hipster, a Londra come a Portland, a Milano come a New York, ormai identifica un ventitrentenne estetizzante, dalla sessualità esteriormente incerta, al quale si rimprovera più o
meno consapevolmente il lusso di poter buttare via il proprio tempo alla ricerca di
un’autenticità che crede esistere solo in oggetti fatti e pensati nel passato..
L. Clausi, Generazione hipster 2.0. Quando la rivolta è estetica, in espresso.it, 26 marzo 2014)
(
Si tratta di un racconto che non vuole informare, ma suscitare emozioni, o
meglio spesso esso è volto a innescare il desiderio. Le cosiddette soft news di
“attualità” sono quindi volte a questo scopo, diffondere nella società alcune
abitudini o costumi con il pretesto di informare su di esse o la tendenza reality
in televisione che con la scusa di portare dietro lo schermo persone vere,
induce le stesse a snaturarsi e a diventare personaggi ad uso e consumo
degli spettatori. Oramai la maschera è caduta da tempo e la “verità” di queste
produzioni televisive, già denunciate dagli esperti come pura fiction, è palese
anche ai più. Un processo di coscienza avvenuto nel corso degli ultimi dieci
anni senza troppi scandali o censure, ma per semplice assuefazione passiva
di questo tipo di contenuti video. Pensiamo al primo dei reality show Il Grande
Fratello e a come dalle prime edizioni ad oggi sia sempre più palese una
scrittura delle puntate e dei personaggi che entrano a far parte della “Casa”.
Niente è lasciato al caso, niente è reale, ma tutto artificiosamente costruito a
beneficio degli spettatori e di ciò che gli strumenti di rilevazione dell’audience
e di popolarità attraverso i canali social svelano in tempo reale. Il pubblico ha
apprezzato un momento particolare di romanticismo o si è verificata
un’impennata di ascolti in corrispondenza di una scena di sesso o di un
litigio? ecco che queste saranno le leve su cui agire per le prossime puntate.
Il progetto editoriale a monte, forte di alcuni punti fermi, dovrà essere
sviluppato lungo il percorso necessariamente in maniera molto elastica e
flessibile. Lo stesso vale per tutto ciò che si muove sul web e che può essere
misurato in tempo reale in termini di gradimento, notizie comprese.
Abbiamo parlato di gradimento, ma in base a cosa una notizia o una tendenza
funziona o meno? cosa muove verso o contro qualcosa il pubblico? Il motore
di tutto è il desiderio. Difficile fornire una definizione di desiderio. Per sua
natura sfuggente, dalla forte carica
di alterità, potenzialmente infinito,
naturalmente mancanza, il desiderio sfugge a un inquadramento preciso,
tanto che in molti tra filosofi e studiosi si sono avvicinati ad esso, senza mai
coglierlo completamente, ma solo in parte. “Ciò che rimane impensato al
cuore stesso del pensiero” (Foucault, 1966, p-386)
Come sostiene Ugo Volli nel testo “Figure del desiderio - Corpo, testo,
mancanza” (Raffaello Cortina, Milano, 2002), Il desiderio nasce, nella sua
forma più pura e istintiva, come istanza sovversiva e rivoluzionaria, volta
a modificare e destabilizzare lo status quo, a innescare cambiamento a partire
da una non accettazione, un rifiuto e una volontà di cambiamento rispetto alla
realtà esistente. Per potersi definire con queste caratteristiche tuttavia, il
desiderio dovrebbe essere lasciato libero di scorrere senza argini che ne
delimitino troppo le forme, al contrario di quel che accade oggi. Nella società
capitalistiche moderne infatti il desiderio nasce e cresce come
anestetizzato, pronto a essere incasellato in un catalogo prodotti sempre più
dettagliato e pronto a rispondere a ogni più diversa esigenza. La “grande
varietà dei prodotti disponibili” rende l’utente più propenso a non ribellarsi e a
convincersi che, dopotutto, la scelta è talmente ampia che perché porsi il
problema di andare a cercare altre soluzioni, quando, già pronte, ce ne
vengono offerte così tante? Il desiderio come spinta alla realizzazione di sé
contrasta con il capriccio o il bisogno immediato che vuole essere soddisfatto
subito.
Anche nel sistema che riguarda la comunicazione della moda questa
tendenza risulta dominante. Si sente spesso dire, di fronte al cattivo gusto o
alla pochezza dei contenuti divulgati dalla stampa (o di una certa moda fast
fashion, low cost), che è quello che la gente vuole, che gli editori altro non
possono fare se non accontentare il loro target di riferimento, come se la
ricezione fosse esclusivamente un’operazione passiva. Non sempre è così,
anche se in molti casi, per le ragioni enunciate sopra, spesso lo diviene e a
chi produce o deve vendere contenuti o prodotti, è molto comodo farlo
credere.
I mass media, in ogni campo, moda compresa, non sono solo produttori di
contenuti che veicolano la realtà sociale, ma possono essere anche
considerati essi stessi come “potenti generatori di realtà sociali” (Tropea
F., Mode aggressive e aggressioni di moda, saggio all’interno del volume a
cura di Grandi R. e Ceriani G., Moda: regole e rappresentazioni,
FrancoAngeli, Milano, 1995). L’autore in questo caso contestualizza la
definizione parlando del concetto di street styles e di quello di tribù urbane.
Nonostante scientificamente ai gruppi giovanili che popolano le metropoli
contemporanee manchino molte delle caratteristiche proprie delle tribù in
senso classico e quindi sia erroneo accostare questi due termini in senso
etnologico, i mass media ne sono rimasti totalmente soggiogati - dal fascino
del termine - e parlano con scioltezza di “tribù urbane”, creando una nebulosa
semantica non facile da sciogliere. In pratica a forza di disquisire sulle tribù
urbane, sulle loro caratteristiche e idiosincrasie, hanno modellato l’esistenza e
lo sviluppo di alcuni gruppi e certe tendenze. Sul tema citiamo anche uno
degli studiosi che più ha indagato le tendenze sociali contemporanee,
Maffesoli (Maffesoli M., Le Temps de Tribus, 1989) che ha sottolineato a
livello trasversale la tendenza a conferire da parte dei soggetti un senso
più forte alla propria esistenza, colpendo il campo delle rappresentazioni
pubbliche dell’identità, regolate dal complesso sistema della Moda.
Ci sono stati creativi, in ogni campo, credo si possano definire i veri geni, che
hanno prodotto a prescindere dalle regole del mercato o da ciò che in un dato
momento veniva richiesto, ma perché sentivano dentro un moto dell’anima
che li ha portati in una determinata direzione. Certo seguivano, per
concordanza o per opposizione, lo spirito del proprio tempo, ma non ne erano
schiavi. Pensiamo a Samuel Beckett (1906-1989), autore fino a pochi anni fa
non particolarmente noto, autore di Aspettando Godot. Cosa rendeva così
ostica la sua ricezione? Il fatto che nelle sue opere si avvertisse sempre un
movimento a spirale di un’intelligenza sempre in vantaggio sul lettore e si
sa quanto il pubblico si inalberi non appena dubita che l’autore non abbia
bisogno di lui, che non smani per il suo consenso. Beckett non lo rincorre, i
suoi personaggi non strizzano l’occhio allo spettatore, non lo cercano, sono
creature dalla consistenza di larve che non solo non riescono a trovare se
stesse, ma nemmeno ci provano (Carlo Fruttero, introduzione a Aspettando
Godot, Einaudi, Torino, 1956). Pensando a un parallelo in ambito moda si
potrebbe citare una stilista, o meglio un’artista, Elsa Schiaparelli (18901973), che pur dando vita ad abiti e accessori dalle forme più assurde e
insolite seppe conquistarsi un suo pubblico, certo non un pubblico di massa,
ma gli intellettuali del suo tempo, un ambiente vicino ai surrealisti, tanto che
collaborò con Salvador Dalì, Alberto Giacometti e Leonor Fini. Accanto a
questa visione sofisticata del fare moda, “Schiap” (come lei stessa si definisce
nella sua autobiografia del 1954 Shocking life) fu una delle prime, insieme a
Coco Chanel, a capire che il vero business nella moda sarebbe venuto non
dall’alta moda, ma dal pret-a porter.
“Dalì era un habitué. Ideammo insieme il cappotto con i cassetti ispirato ai suoi
famosi quadri. Un’altra novità nata dalla nostra collaborazione fu il cappello nero con
il tacco di velluto Shocking che svettava con una piccola colonna...Jean Cocteau
disegnò per me delle teste. Io ne riprodussi alcune alcune dietro a un cappotto da
sera e una, con capelli gialli lunghi fino al petto, su un abito di lino grigio”.
(Schiaparelli, cit., p. 124, Alet, Padova)
Viviamo in una “società del desiderio” (Volli, cit.), desiderio del tipo enunciato
sopra, l’unico possibile in una società capitalistica che per il suo
mantenimento, non si accontenta di un mantenimento del livello presente, ma
necessita di un continuo aumento del desiderio del bisogno, di una costante
crescita quantitativa. Ma dove sono collocati i desideri possibili che
alimentano questo meccanismo? Nella pubblicità, nei centri commerciali, nelle
vie dello shopping, nelle riviste, nei continui messaggi spot che oramai
popolano qualsiasi territorio di conoscenza, rete compresa. La rete non è
libera e non è gratis, richiede solamente forme di pedaggio diverse
rispetto ad altri canali. Ormai la maschera è caduta e la falsa
disintermediazione è venuta a galla.
Dalla cupidigia di uno deriva l’arricchimento collettivo, come sosteneva Adam
Smith, ma anche prima la nota Favola delle api scritta nel 1600 da Bernard de
Mandeville. L’alveare (metafora della società descritta dall’autore) funziona
perché c’è qualcuno che decide e tutti gli altri che operosamente mettono in
pratica quelle decisioni, desiderano il desiderabile secondo le regole
costituite. Il movimento nella società odierna, anche in quella virtuale digitale,
è solo apparente, a regnare sono cambiamenti vorticosi, ma solo di superficie.
Ma come, dopo oltre un secolo di disillusione anticipata, mostrata, vissuta non
abbiamo imparato proprio niente? Esatto, la situazione odierna denuncia
proprio questo stato delle cose. Le “novità” sono tali non in quanto ricercate
da soggetti off e intercettate dal mainstream, ma è lo stesso mainstream a
imporle come tali a partire un “Così fan tutte” o almeno tutte/tutti quelli che
contano.
La moda è linguaggio, ovvero un’azione che parte da un corpo materiale,
finalizzata a esprimere qualcosa, un’azione in cui intervengono un emittente e
un ricevente/destinatario. Il linguaggio può essere di vari tipi, verbale se
prevede l’emissione di suoni, scritto o non verbale in relazione ad esempio
alla gestualità e alla prossemica. Per linguaggio/comunicazione si intende
quindi il passaggio da una sfera mentale individuale alla sfera comune e
questa messa in comune del pensiero avviene attraverso dei segni
capaci di instaurare una relazione. La moda può essere intesa in questo
modo, come un mettersi in relazione da parte di ciascuno di noi con l’esterno,
al pari di quando si parla, si scrive o si disegna. Georg Simmel, in un saggio
specifico sulla moda ha analizzato da vicino il fenomeno mettendo l’accento
sul duplice aspetto del conformismo e del separatismo, dell’imitazione e della
differenziazione. Da un lato la coesione attraverso l’imitazione di quanti si
trovano allo stesso livello sociale, dall’altro l’esclusione e la differenziazione di
un gruppo nei confronti degli altri, si può considerare quindi la moda come
una forma di chiusura nei confronti dei gruppi esterni attraverso una selezione
dei segni di riconoscimento. Questa segmentazione sociale evidenzia da un
lato una necessaria coesione interna al gruppo, ma dall’altro anche un
elemento di rivendicazione contro un altro gruppo o classe.
La moda è un fenomeno pervasivo, tutto è moda nella nostra società, non
solo l’abbigliamento, ma più in generale il modo di vivere, anche le idee
possono essere o meno di moda e proprio per questo la moda diventa un
fatto sociale, che riguarda principalmente il corpo, ma non solo. Ha un
carattere fluido, poroso, capace di adattarsi e come non esiste una società
senza linguaggio e comunicazione, così non esiste una società che non
faccia uso di una moda. La moda diventa strumento espressivo
dell’identità sociale, e questo vale soprattutto per gli adolescenti dove la
ricerca di identità è fenomeno essenziale e essere come gli altri diventa una
strategia per superare le incertezze individuali, utilizzando espressioni non
verbali e la sua valenza comunicativa è evidente anche nelle sue negazioni.
Celebre l’espressione “l’abito non fa il monaco”, ma certamente lo comunica,
potremmo aggiungere e con il sociologo William Thomas precisare che in
ogni caso di fronte a una persona vestita da monaco, noi ci comporteremo
“come se” fosse realmente un monaco. Nessuno si può dire estraneo alla
moda, è un elemento con cui ognuno di noi deve imparare a fare i conti, un
“gioco obbligatorio” a cui tutti siamo chiamati a partecipare, come sostiene
Ugo Volli.
Per quanto riguarda la prospettiva con cui la sociologia osserva il fenomeno
moda, è stato sottolineato che essa “studia la moda come tipo di
comportamento collettivo, come tratto saliente della cultura di massa e
della società di massa; come espressione peculiare della stratificazione
sociale; come fenomeno che anticipa e riflette forme più o meno importanti di
mutamento sociale e culturale; come processo economico attorno al
quale si condensano interessi, organizzazioni, professioni, aziende, modelli di
divisione del lavoro e attività dei mezzi di comunicazione di massa” (Gallino
L., Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1978, pp.437-438). Quel che ha
sempre attirato la sociologia nei confronti della moda è la sua grande forza di
penetrazione, un fascino quasi magico e inspiegabile che per certi versi si può
avvicinare a una devozione di tipo religioso. Lo stesso Carl Flugel, autore del
testo Psicologia dell’abbigliamento (Franco Angeli, Milano, 1974, p.166)
sottolinea la vicinanza del fenomeno moda a quello dei grandi culti nei quali
accanto ai credenti si individuano gli officianti, in questo caso i redattori dei
giornali di moda, gli stilisti, gli influencer. Di fronte ad essi gli studiosi che se
ne pongono erroneamente all’esterno e giudicano il fenomeno come una
ridicola e insensata professione di fede. Oltre a questa componente magica
che svicola da ogni analisi analitica il fenomeno moda si differenzia dagli altri
soprattutto per due elementi, il basso livello di interiorizzazione e l’alto tasso
di mutamento (Curcio AM, Franco Angeli, Milano, La moda, identità negata,
2012, p. 23). Grazie a questo elemento del nuovo continuo, la moda sembra
adatta a rispondere all’incessante mutamento del sistema dei bisogni, mentre
i modelli culturali sono più lenti nel mutare. Nei periodi di crisi, di passaggio da
una forma culturale ad un’altra, sorgono una pluralità di mode che
costituiscono una forma di compensazione alla quale ricorrono gli individui di
fronte agli ostacoli che si frappongono a un reale mutamento.
Se moda uguale comunicare, quindi dialogo, la prima regola per aprirsi agli
altri è conoscere se stessi e qui si marca uno dei paradossi del rapporto moda
identità,
come
risulta
evidente
dalle
pervasive
rappresentazioni
e
autorappresentazioni a cui siamo sottoposti ormai in ogni momento della
nostra vita. Piacere agli altri per piacere a se stessi o piacere a se stessi per
piacere agli altri? Certamente un’analisi più approfondita dovrebbe sposare la
seconda ipotesi, ma oggi è la prima a prevalere, nel momento in cui si nota la
moda di una continua costruzione di rappresentazioni dei momenti che
caratterizzano la nostra vita. Questo è stato possibile grazie a internet e ai
social network al continuo bisogno di sentirsi apprezzati, di condividere con
un potenziale infinito l’attimo finito che stiamo vivendo. Se ci pensiamo
storicamente è sempre stato così anche per quei gruppi che si sono sempre
dichiarati ai margini della società, in opposizione ad essa, destinati a
distruggere il mainstream. A prevalere è sempre stata e continua ad essere
una cultura della visibilità che mette in atto i già citati paradossi: persino
coloro che rifiutano radicalmente la cultura dominante (per esempio i punk o
gli skinhead) si preoccupano di dare a tale rifiuto la forma più visibile possibile
attraverso teste rapate, creste scolpite e modellate ad arte, scarponi chiodati,
catene, piercing e accessori non comuni ai più. E’ sempre presente, in
maniera più o meno evidente, una dialettica tra l’esibire e il nascondere,
tra dentro e fuori, ben espressa dall’espressione maschera pubblica, e
inscrivibile nella tradizione delle maschere della Commedia dell’Arte (sul tema
della maschera e i suoi significati Strauss L, Voies du masque). La maschera
nasconde il soggetto reale e lo incarna in un soggetto ideale, come un guscio
protettivo, così come l’uniforme del gruppo evita o attenua lo smarrimento
dell’individuo e gli permette di uscire dall’anonimato di una maggioranza
silenziosa, inerme e passiva. Il gioco obbligatorio della moda, come riportato,
è anche un gioco incessante tra l’individuo e il suo aspetto, tra il reale e
l’ideale, tra l’essere e il non essere. In alcuni casi, come in quello degli
Skinhead, sotto la maschera non c’è nulla o forse come in certe nature morte
del 1700, un teschio simbolo di morte, del soggetto che indossa la maschera
o della maschera stessa.
Come ci vestiamo la mattina, cosa mangiamo a colazione, l’insegna del
nuovo locale aperto sotto casa, il cane della vicina, la nuova vetrina della
nostra boutique preferita, l’ultimo libro letto, il colore dello smalto all’ultimo
grido con applicazioni e strass e così via frammentando in micro immagini
statiche e dinamiche le 24 ore della nostra giornata. Questa attività per alcuni,
da passione e svago, è diventata professione, forse non per la maggior parte
in esclusiva, ma per alcuni sì. Ecco che alla ribalta della società sono saliti i
fashion blogger, o fashion influencer, persone capaci di far tendenza
attraverso la rete con la propria immagine ad uso e consumo dei brand che la
“affittano” come testimonial. La declinazione può essere diversa, da un sito
proprietario a un blog condiviso a un canale Istagram, tra le ultime tendenze
nel settore moda e lusso. Se non hai un canale Istagram che funziona oggi
come brand sei tagliato fuori e quindi la corsa all’arrembaggio del nuovo
social è da tempo iniziata, con il risultato di vedere accanto ad esperimenti
molto ben riusciti, molti pessimi risultati, scopiazzamenti mal fatti dei canali
più noti, senza conoscenza della comunicazione digitale e delle sue regole.
Gli esperti di social media content dicono che per funzionare un qualsiasi
medium sulla rete deve essere vero e tempestivo, in aggiornamento continuo,
e quindi deve partire da un conosci te stesso approfondito, mentre spesso il
meccanismo in opera è inverso: l’osservazione di quello che funziona, degli
idoli a cui rifarsi, e tuttalpiù una personalizzazione. Se si osservano le
interazioni che avvengono sui canali più di successo in Istagram ad esempio
si può notare spesso non uno scambio di commenti sul contenuto dei post,
ma un semplice mercanteggiare di like, come dire attaccarsi al carro del
vincitore e farsi trascinare. Tentativo illusorio di crearsi una strada, che nella
migliore delle ipotesi dopo una breve ascesa sarà destinata a precipitare, e al
contempo meccanismo diabolico di perdita delle proprie coordinate
identitarie, ad inseguire quelle di altri potenzialmente vincenti.
La moda come desiderio di apparire, sembrare, voler essere quello che non si
è o come espressione più vera del sé? Impossibile trovare delle leggi nella
moda, piuttosto qualche vaga linea di tendenza che collega il mutare delle
mode al mutare dei valori di una società. L’irrazionalità della moda consiste
nell’impossibilità di certificare che la moda successiva sia migliore della
precedente e per questo la scalzi dal podio. “Se non esistono verità e
certezze definitive l’unico valore che rimane è la capacità di imporsi sugli
antagonisti. E la moda è appunto dare il proprio consenso a ciò che è via via
capace di imporsi. Un legame profondo unisce moda e potenza” (Perazzi M,
E’ l’abito che fa il potente, intervista a Emanuele Severino, in “Moda”
supplemento al Corriere della Sera, 21.08.87, citato in Volli, Black Modes,
Lupetti, Milano, 1998, p. 137).
L’aspetto interessante da indagare quindi è l’efficacia normativa della moda
nei confronti degli atteggiamenti e comportamenti dei singoli individui. Molti
gli studiosi che ne hanno parlato tra cui Simmel (1895), Veblen (1899), Flugel
(1930), Konig (1971), Descamps (1979), Lipovetsky (1987), Davis (1992),
affrontando il discorso da due prospettive quella del ruolo svolto dalle elite e
quella delle motivazioni individuali. Da entrambe comunque, quel che emerge
è una messa in discussione della definizione di Moda data dagli studiosi
classici, dato il modificarsi, in certi casi fino al venir meno, di alcune forme di
attuazione del fenomeno, in particolare della sua efficacia normativa. Da una
parte la necessità dell’industria della moda di definire segmenti sociali
omogenei per atteggiamenti, opinioni, comportamenti e valori, dall’altra
l’emergere
nella
post
modernità
di
individualità
sempre
più
fluide,
frammentate, ambivalenti. Per quanto riguarda le logiche di consumo che si
sono succedute in Italia negli ultimi decenni si individuano due macro fasi: gli
anni Settanta in cui gli oggetti erano connotati come simboli di status che
facevano riferimento a precisi bisogni, percepiti come tali dagli individui, e gli
anni Ottanta in cui si è allargato il processo di connotazione da oggetti di
status a stili di vita, in cui il senso di un bene è dato dalla sua relazione con gli
altri. Sono gli anni in cui trionfano le griffe e gli stilisti e le case di moda non
solo producono moda, ma diventano essi stessi moda. Costretti da se stessi
in una spirale vorticosa di continua novità, minano la loro stessa
sopravvivenza se non al prezzo di trasgredire sempre e sempre di più, per
colpire, per rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Ma mantenere alto il
livello di trasgressione e pretendere che questo faccia presa sui consumatori
diventando moda è sempre più difficile e crea sempre maggior disequilibrio e
frammentazione tra gli stili dei consumatori.
Per concludere, il paradosso della moda consiste in questo: si tratta di un
gioco obbligatorio in cui il soggetto crede di esprimere la sua libertà, ma si
muove obbligatoriamente attraverso maglie definite da cui non può liberarsi.
Si tratta quindi di un’illusione di libertà che placa l’inquietudine del singolo di
sostituire all’ansia di cambiamento la pacatezza di una forma di vestire le idee
o le fantasie con il manto di una fittizia identità.
Bibliografia
Ceriani G. e Grandi R., Moda: regole e rappresentazioni, FrancoAngeli,
Milano, 1995
Clausi L., Generazione hipster 2.0. Quando la rivolta è estetica, in espresso.it,
26 marzo 2014
Curcio AM, La moda, identità negata, Franco Angeli, Milano, 2012
“Moda” supplemento al Corriere della Sera, 21.08.87, citato in Volli, Black
Modes, Lupetti, Milano, 1998
Flugel C., Psicologia dell’abbigliamento, Franco Angeli, Milano, 1974
Gallino L., Dizionario di sociologia, Utet, Torino, 1978
Maffesoli M., Le Temps de Tribus, La table ronde, Paris, 1988, trad. it., Il
tempo delle tribù, il declino dell’individuo, Armando, Armando, Roma, 1988
Pacifico F., Che cosa è un hipster, in ilsole24ore.it, 30 luglio 2014
Perazzi M., E’ l’abito che fa il potente, intervista a Emanuele Severino, in
“Moda” supplemento al Corriere della Sera, 21.08.87, citato in Volli, Black
Modes, Lupetti, Milano, 1998
Rossi G., Fashion blogger, new dandy?, Pendragon, Bologna, 2015
Rossi G., Denim, una storia di cotone e di arte, Fashion Illustrated, Milano,
2010
Schiaparelli E., Shocking Life, Alet, Padova, 2008
Strauss L, Voies du masque, Skira, Geneve, 1975
Volli U., “Figure del desiderio - Corpo, testo, mancanza”, Raffaello Cortina,
Milano, 2002