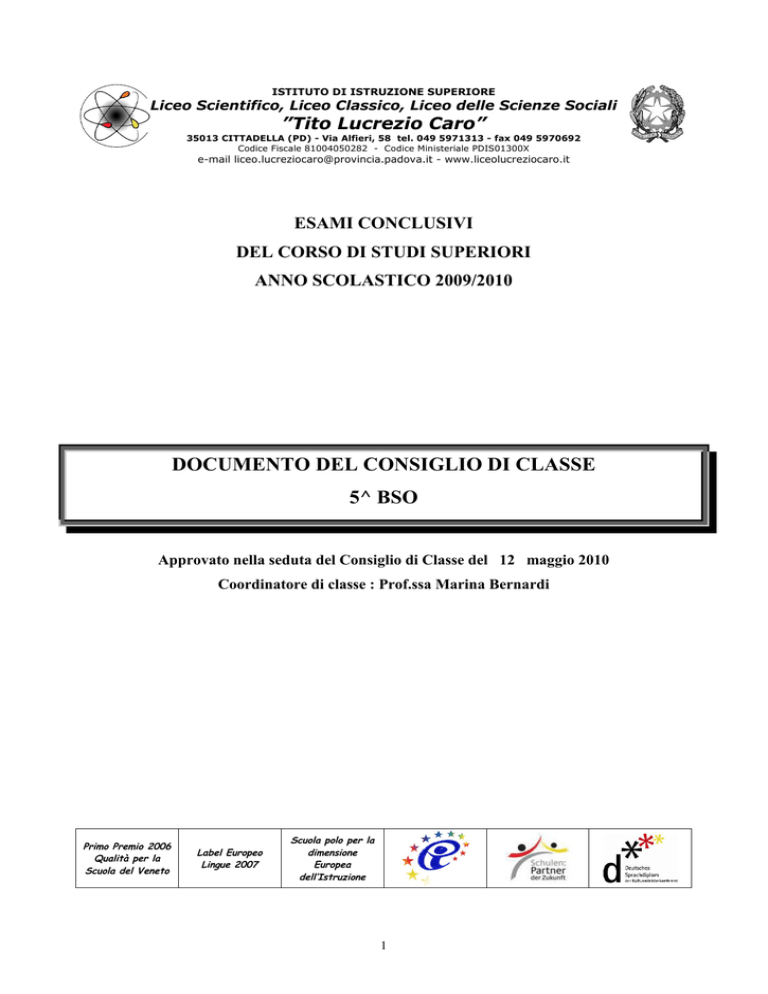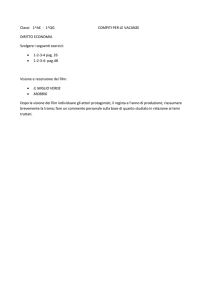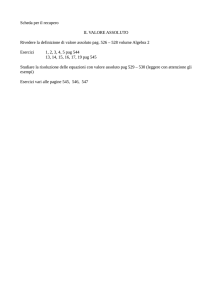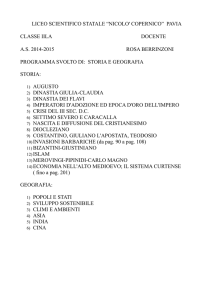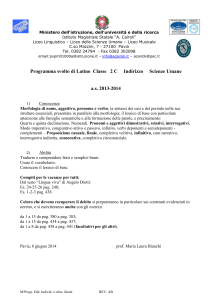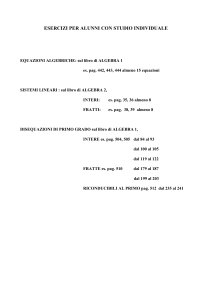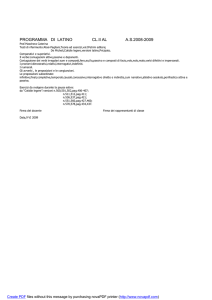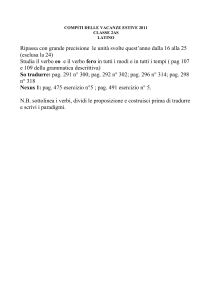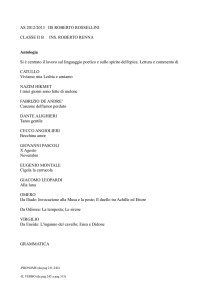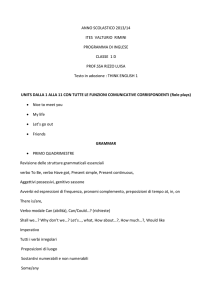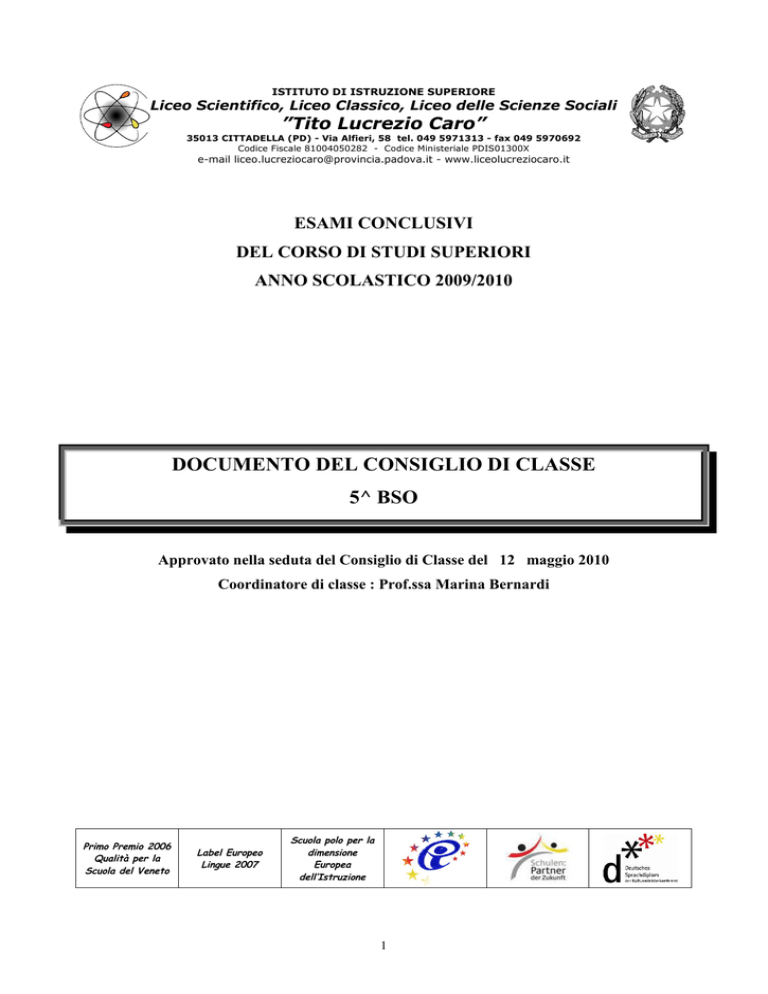
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Sociali
”Tito Lucrezio Caro”
35013 CITTADELLA (PD) - Via Alfieri, 58 tel. 049 5971313 - fax 049 5970692
Codice Fiscale 81004050282 - Codice Ministeriale PDIS01300X
e-mail [email protected] - www.liceolucreziocaro.it
ESAMI CONCLUSIVI
DEL CORSO DI STUDI SUPERIORI
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5^ BSO
Approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 12 maggio 2010
Coordinatore di classe : Prof.ssa Marina Bernardi
Primo Premio 2006
Qualità per la
Scuola del Veneto
Label Europeo
Lingue 2007
Scuola polo per la
dimensione
Europea
dell’Istruzione
1
INDICE GENERALE
1. INTRODUZIONE
pag. 3
2. PROFILO DELLA CLASSE
pag. 3
2.1 ELENCO MATERIE E DOCENTI
pag. 3
2.2 ELENCO ALUNNI
pag. 3
2.3 REPPRESENTANTI DI CLASSE
pag. 4
2.4 STORIA DELLA CLASSE
pag. 4
2.5 COMMENTO RIASSUNTIVO
pag. 5
3. SITUAZIONE IN INGRESSO
pag. 5
4. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
pag. 6
5. OBIETTIVI PROGRAMMI VALUTAZIONE
pag. 6
6.
pag. 8
INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE
7. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
pag. 8
8.SIMULAZIONI TERZA PROVA D’ESAME
pag. 8
9.ELENCO ALLEGATI
pag. 9
ALLEGATO 1: TESTI DI SIMULAZIONI DI TERZA PROVA
pag. 10
ALLEGATO 2: GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE PER LA
TERZA PROVA
pag. 13
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA
pag. 17
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA
pag. 21
ALLEGATO 3: PROGRAMMI SVOLTI
pag. 22
ITALIANO
pag. 22
INGLESE
pag. 26
FRANCESE
pag. 30
STORIA
pag. 34
FILOSOFIA
pag. 36
DIRITTO ED ECONOMIA
pag. 39
SCIENZE SOCIALI
pag. 42
MATEMATICA
pag. 50
FISICA
pag. 52
SCIENZE INTEGRATE
pag. 56
LATINO
pag. 59
STORIA DELL’ARTE
pag. 62
EDUCAZIONE FISICA
pag. 65
RELIGIONE
pag. 71
2
INTRODUZIONE
1.1Specificità dell’indirizzo delle Scienze sociali
L’indirizzo di studio del Liceo delle Scienze sociali è centrato sulla conoscenza della
pluriculturalità, delle strutture e stratificazioni sociali, delle articolazioni normative ed economiche,
delle dinamiche formative e della dimensione psicologica propria dei comportamenti individuali e
collettivi.
L’obiettivo formativo di tale indirizzo mira all’acquisizione di competenze finalizzate alla lettura
della società contemporanea colta nella sua complessità e alla gestione del rapporto io-altri.
Strumento operativo fondamentale dell’indirizzo è lo stage curricolare, che si svolge in ambiti
lavorativi e realtà sociali del territorio e che è legato allo sviluppo di argomenti affrontati in classe.
Per quanto riguarda il piano degli studi, le materie opzionali nel corso del triennio sono: Latino,
Storia dell’arte, Musica, Scienze integrate. Sono inoltre previste ore di compresenza, che riguardano
in particolar modo Filosofia e Scienze sociali, Storia e Diritto ed economia.
1. PROFILO DELLA CLASSE
2.1 Elenco materie e docenti della classe 5ˆ
MATERIA
DOCENTE
ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED ECONOMIA
PSICO-SC. EDUCAZIONE
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE INTEGRATE
STRORIA DELL’ARTE
FIOR FIORELLA
MARCON NICOLETTA
BERNARDI MARINA
SEMINARA LAURETTA
SEMINARA LAURETTA
MASTROMARINO ANTONIO
TOMBOLATO GRAZIELLA
FERRANTE DOMENICO
FERRANTE DOMENICO
MENDO DANIELA
DONADIO ALESSANDRO (supplente di Casarotto
Valentina)
LOVISETTO ALESSANDRA
TAFFARA ROBERTO
STECCANELLA ASSUNTA
LATINO
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE
2.2 Elenco alunni
N°
Cognome e Nome
Data di
nascita
Residenza
1 BAGAROLO EVA
27.07.1991 FONTANIVA - PD
2 BAGOLAN NICHOLAS
14.10.1991 PIAZZOLA SUL BRENTA - PD
3 BIROLLO ALBERTO
24.12.1991 FONTANIVA - PD
4 BONALDO DANIELA
20.04.1991 CITTADELLA - PD
5 CARLESSO ANNA
04.02.1991 CARMIGNANO DI BRENTA-PD
6 CECCHIN PATRIZIA
17.08.1991 GALLIERA VENETA - PD
7 CERATO GIULIA
23.06.1991 CITTADELLA - PD
3
8 DOLZAN ERIKA
05.09.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI
9 FERRONATO ALESSANDRA
27.11.1991 GALLIERA VENETA - PD
10 GIOPP SILVIA
28.11.1991 CITTADELLA - PD
11 GRIGOLETTO SELENE
25.02.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI
12 GUARISE EMANUELA
10.03.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI
13 LASCARACHE DANUTA AIDA
12.12.1989 TOMBOLO - PD
14 MARCONATO IRENE
03.05.1991 SAN MARTINO DI LUPARI – PD
15 MORETTI CHIARA
26.07.1991 SAN PIETRO IN GU - PD
16 PELLANDA FRANCESCA
04.09.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI
17 PICCOLI CRISTINA
13.02.1991 SAN PIETRO IN GU - PD
18 PILOTTO SARA
15.03.1991 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
19 PIRAN VERONICA
30.06.1991 LOREGGIA - PD
20 SUPPINI SARA
28.10.1991 GALLIERA VENETA - PD
21 TALIN FEDERICA
19.12.1991 FONTANIVA - PD
22 TONIATO MARTINA
04.04.1991 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
23 ZONTA NICOLE
22.10.1991 TEZZE SUL BRENTA - VI
2.3 Rappresentanti di classe studenti: Carlesso Anna, Pilotto Sara
Rappresentanti di classe genitori: Signora Alessandra Ferronato
2.4
Storia della classe
CONTINUITÀ DIDATTICA
MATERIA
ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO
ECONOMIA
PSICO-SC.
EDUCAZIONE
MATEMATICA
3ˆ
FIOR FIORELLA
4ˆ
FIOR FIORELLA
SETTIMO
SAMUELA
BERNARDI
MARINA
GALLATO
ROBERTA
GALLATO
ROBERTA
ED DI GIORGIO
PAOLO
GATTI SONIA
TUCCI CATERINA
5ˆ
FIOR FIORELLA
MARCON
NICOLETTA
BERNARDI
BERNARDI
MARINA
MARINA
SEMINARA
SEMINARA
LAURETTA
LAURETTA
SEMINARA
SEMINARA
LAURETTA
LAURETTA
MASTROMARINO
MASTROMARINO
ANTONIO
ANTONIO
GATTI SONIA
TOMBOLATO
GRAZIELLA
D’AMICO
MARIA FERRANTE
LAURA
DOMENICO
FERRANTE
-------DOMENICO
MENDO DANIELA
SBRISSA MATTEO
FISICA
---------SCIENZE CHIMICA MENDO DANIELA
4
GEOGRAFIA
SCIENZE
INTEGRATE
LATINO
STORIA
DELL’ARTE
EDUCAZIONE
FISICA
RELIGIONE
MENDO DANIELA
MENDO DANIELA
-------MENDO DANIELA
CHECCHINI
FLORISANA
CASAROTTO
VALENTINA
BUSÀ ELISABETTA
LOVISETTO
ALESSANDRA
CASAROTTO
VALENTINA
TAFFARA
ROBERTO
STECCANELLA
ASSUNTA
LOVISETTO
ALESSANDRA
CASAROTTO
DONADIO
TAFFARA
ROBERTO
STECCANELLA
ASSUNTA
STECCANELLA
ASSUNTA
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
Alunni
Iscritti da Promossi Non
Sospensione Promossi
iscritti
altra
a giugno
promossi di giudizio
nella
scuola
a giugno
sessione
differita
Terza
Quarta
Quinta
2.5
24
23
23
1
/
/
13
17
--
/
/
--
11
6
--
10
6
--
Non
promossi
nella
sessione
differita
1
/
--
Commento riassuntivo
La discontinuità didattica nelle discipline di inglese e di matematica ha caratterizzato l’intero
quinquennio della classe, che ne ha indubbiamente risentito.
Per quanto riguarda i risultati di fine anno, la classe più critica è stata la terza, dove si è avuto un
numero cospicuo di sospensioni di giudizio e anche l’unica non ammissione alla classe successiva.
Per quanto riguarda la scelta delle materie opzionali, nel triennio si sono avuto i seguenti gruppi:
Latino 6 alunni, Scienze integrate 11 alunni, Storia dell’arte 6 alunni.
3.SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe 4^ (alunni promossi)
MATERIA
Italiano
Inglese
Francese
Storia
Filosofia
Diritto ed
economia
Psico-sc.educaz.
Matematica
Scienze chimica
geografia
Latino
Scienze integrate
Alunni promossi
con 6
6
11
12
4
10
6
Alunni promossi
con 7
11
7
5
10
5
11
Alunni promossi
con 8
4
4
6
8
7
3
Alunni promossi
con 9/10
2
1
/
1
1
3
1
13
13
7
6
5
11
4
3
4
/
2
/
5
2
5
3
1
1
/
5
Storia dell’arte
Ed. fisica
Religione
/
/
/
2
5
2
15
Buono : 12
/
2
3
Ottimo: 11
4.RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
4.1 Situazione della classe, profitto e obiettivi
La classe è composta di 23 alunni, 21 femmine e 3 maschi. Ha sempre mantenuto un
comportamento sostanzialmente educato e corretto, partecipando attivamente alle lezioni e al
dialogo educativo.
Il profitto globale degli allievi è mediamente sufficiente / discreto nell’area umanistica e nelle
materie d’indirizzo. Una situazione di maggiore fragilità si evidenzia invece nell’area scientifica
della matematica e fisica, e nell’area linguistica dell’inglese, discipline caratterizzate dalla
discontinuità didattica nel corso dell’intero quinquennio.
Nella classe si possono riconoscere tre fasce di merito. La prima è costituita da un gruppo che per
capacità, impegno, assiduità nella frequenza e nello studio ha raggiunto un profitto decisamente
buono, possiede conoscenze precise, capacità di analizzare criticamente, di effettuare collegamenti e
di esprimersi in modo scorrevole e appropriato. La seconda, più ampia, presenta alunni che hanno
acquisito, grazie a uno studio abbastanza regolare e costante, conoscenze e competenze abbastanza
ampie per un profitto pienamente discreto, sia alunni che raggiungono un livello più che
sufficiente. La terza fascia raggruppa alcuni alunni che presentano qualche incertezza, fragilità o
lacuna, in certi casi nonostante l’impegno nello studio, in altri casi a causa di un impegno e una
frequenza discontinui.
Lo svolgimento dello stage curricolare (effettuato dal 9 al 13 novembre 2009, a cui ha fatto seguito
una mattinata dedicata alla restituzione) ha mostrato in modo più che soddisfacente la capacità da
parte degli alunni di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo e la
loro presa di coscienza delle responsabilità sociali (per un approfondimento sullo stage si rimanda
alla relazione del docente di Scienze sociali).
4.2 Casi particolari
All’inizio della classe 3ˆ (A.S. 2007-2008) è stata inserita nel gruppo classe una alunna proveniente
dalla Romania, arrivata in Italia nell’estate del 2007, in possesso di un Certificato di studi che
attesta la conclusione del Ciclo inferiore del Liceo nell’anno 2006, presso il Collegio Economico
(filiera tecnologica, profilo servizi, specializzazione turismo e alimentazione pubblica). La
scarsissima conoscenza della lingua italiana da parte dell’alunna ha reso necessaria la messa a
punto, nella classe 3ˆ e 4ˆ del triennio, di un Piano di lavoro individualizzato per le discipline di
Italiano, Storia e filosofia, Scienze sociali (solo in terza), Diritto ed economia, Francese e Inglese (si
veda il registro dei verbali del Consiglio di Classe: in allegato nei verbali del 4/10/2007 e del
3/11/2008), volto a una semplificazione dei contenuti e degli obiettivi.
Nel corso del secondo quadrimestre di quest’ultimo anno scolastico un’alunna è stata costretta, per
ragioni di salute, a una frequenza discontinua, che le ha comunque permesso di effettuare un
congruo numero di verifiche al fine della sua valutazione e che non ha compromesso il profitto.
5. OBIETTIVI, PROGRAMMI, VALUTAZIONE
DEGLI APPRENDIMENTI
5.1 Obiettivi trasversali
Il C.d.C. ha riconosciuto come prioritari nel corso dell’ultimo anno del triennio i seguenti obiettivi:
Educativi:
· Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti
· Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di
Stato
6
·
·
·
Presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza
Capacità di instaurare efficaci rapporti interpersonali in ambito sociale e lavorativo
Consapevolezza delle proprie aspirazioni e attitudini al fine dell’inserimento nel mondo del
lavoro o per il proseguimento degli studi
· Puntualità nelle consegne.
Didattici:
· Affinare le capacità di autovalutazione e della riflessione critica autonoma
· Capacità di individuare e arricchire autonomamente i nuclei proposti anche nei percorsi
pluridisciplinari
· Fare propria una flessibilità mentale da tradurre sia nella capacità di affrontare problemi che
nella capacità di sapersi rapportare alla realtà in cui si opera
· Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso
compiuto usando una terminologia appropriata
5.2 Programmi
Ogni docente nel proporre, affrontare e sviluppare gli argomenti ha avuto come riferimento i
programmi e le linnee guida inerenti all’indirizzo specificati nel POF dell’Istituto. Si è cercato di
puntare su una didattica per progetti e su una didattica modulare, per consentire anche percorsi
multidisciplinari.
Si rinvia alle relazioni e ai programmi svolti dei singoli docenti posti in allegato.
STRUMENTI DIDATTICI
1. Lezione frontale
2. Lezione partecipata e dialogata
3. Discussione in classe
4. Lavori di gruppo
5. Progetti
6. Visite guidate
7. Film, teatro, conferenze
STRUMENTI TECNICI
1. Libri di testo
2. Materiale integrativo:
riviste, siti internet
3. Biblioteca
4. Laboratori
5. Sussidi multimediali
giornali,
5.3 Valutazione degli apprendimenti
Criteri adottati
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al POF e per quelli specifici relativi ad ogni disciplina si
rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti.
Numero di verifiche effettuate nell'anno scolastico e tipologie di prove
Interrogazioni /
Compiti scritti
Compiti scritti
Prova strutturata
Materia
Italiano
Inglese
Francese
Storia
Filosofia
Diritto ed ec.
Psicosc.educazione
Matematica
Fisica
Scienze
integrate
prove pratiche
(n. medio per
studente)
(tema, analisi del
testo, saggio breve
ecc)
(problemi, casi
esercizi)
3
4
3
4
4
4
4
5
4
3
5
4
1
2
1
2
o semistrutturata
3
4
/
3
/
2
1
1
/
2
1
4
7
Simulazione terza
prova
Latino
Storia
dell’arte
Ed. fisica
Religione
3
3
1
1
4
2
2
6.INIZIATIVE COMPLEMENTARI E / O
INTEGRATIVE
5.1 Attività a cui ha partecipato tutta la classe:
· Viaggio d’istruzione: Berlino (dal 23 al 27 febbraio 2010)
· Visite guidate: Vittoriale di Gardone Riviera e MART di Rovereto: visita della mostra La
magia del teatro nella pittura dell’Ottocento (9 febbraio 2010)
· Progetti: Educazione alla salute: Centro trasfusionale (AVIS) (26 gennaio 2010).
Orientamento in uscita: Giornata dell’orientamento (20 aprile 2010); Scegli con noi il tuo
futuro, giornata di orientamento Università di PD ( 24 febbraio 2010). La fabbrica dei
lampi: Recitando la storia (6 maggio 2010).
· Iniziative culturali: Seminario a Venezia su Dante (30 ottobre 2009). Rappresentazione
teatrale: Toni e volumi. Poesia e musica intorno alla Libertà (21 aprile 2010).
6.2 Attività a cui ha partecipato parte della classe
· Nell’ambito del progetto di Orientamento in uscita incontri facoltativi con l’Università di
PD, TN, VE (IUAV e Cafoscari) (mese di febbraio)
· Certificazione linguistica DELF livello B1 di francese
6. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI
Argomento: La Multiculturalità
Materie interessate (per informazioni più dettagliate sui contenuti si rinvia ai programmi dei
singoli docenti in allegato):
· Italiano: lettura di articoli di giornale sulla tematica e discussione in classe
· Francese: la francofonia
· Scienze sociali: modelli e pratiche dell’educazione interculturale
· Religione: dalla multiculturalità all’interculturalità
7.
8.1
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA D’ESAME
La struttura della prova
Sono qui di seguito riportati i criteri generali per lo svolgimento delle simulazioni di terza prova
scritta :
•
Numero di simulazioni per l'intero anno scolastico : 3
•
Periodi di effettuazione: metà dicembre, metà marzo, fine aprile
•
Durata della prova: 3 ore
•
Numero di materie: 4 materie
•
Tipologia dei quesiti: tipologia B (tre domande per materia)
•
Modalità: 8-10 righe per domanda
•
Strumenti utilizzabili: un dizionario d’italiano a disposizione della classe, dizionario bilingue
e monolingue delle lingue straniere, calcolatrice numerica.
8
8.2
Prove effettuate
Data di
Tipologia
Materie coinvolte
Ore assegnate
effettuazione
per la prova
14.12.2009
B
Filosofia-Inglese-Matematica-Diritto ed
3
economia
30.3.2010
B
Storia-Fisica-Inglese-Educazione fisica
3
28.4.2010
B
Inglese-Ed. fisica-Storia-Matematica
3
8.3 Valutazione delle prove
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie allegate.
8.4
Risultati delle simulazioni
(Medie in quindicesimi)
<10
13
Prima
simulazione
9
Seconda
simulazione
8
Terza
simulazione
10-11
6
12-13
2
14-15
/
7
5
1
7
7
/
Prima simulazione:
Media in quindicesimi
Filosofia
8.8
Inglese
10.7
Matematica
7.8
Diritto ed ec.
9.4
Seconda simulazione:
Media in quindicesimi
Storia
10.7
Fisica
7.95
Inglese
9.6
Ed. fisica
12.72
Terza simulazione
Media in quindicesimi
Inglese
10.18
Ed. fisica
10.86
Storia
10.64
Matematica
8.81
Alunni assenti: prima simulazione1assente; seconda simulazione 1assente; terza simulazione1 assente.
8. ELENCO ALLEGATI
1
2
3
Testo delle simulazioni di terza prova d'esame somministrate
Griglie di valutazione
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline
9
ALLEGATO 1:TESTI TERZE PROVE
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:
Si allega il testo delle simulazioni effettuate.
Data di
Materia
effettuazione
14.12.2009
Filosofia
Inglese
Matematica
Quesito
1. “I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza
concetti sono cieche. E’ quindi necessario tanto rendersi i
concetti sensibili (cioè aggiungervi l’oggetto dell’intuizione),
quanto rendersi intelligibili le intuizioni (cioè ridurle sotto
concetti). ... La conoscenza non può scaturire se non dalla
loro unione.” (I. Kant, Critica della Ragion Pura, 77).
Commentando in modo perspicuo il passo citato, spiega
perché secondo Kant non è possibile la metafisica come
scienza. (8 righe)
2. Qual è la differenza tra etica eudaimonistica ed etica
deontologica? (8 righe)
3. Che cosa è il bello per Kant? (8-10 righe)
1. Write a paragraph about the changes brought about by the
Industrial Revolution in England.
2. Write a paragraph about the meaning of the word
“Romantic”.
3. Write a paragraph about the poem “The Lamb” by W.Blake;
mention: subject of the poem, kind of language, symbols and
their meanings.
1- x2
1. Traccia il probabile grafico della funzione
y=
x2
utilizzando gli strumenti che conosci (intersezioni, studio del
segno, asintoti, simmetrie,…).
x 2 - 6x + 9
2. Determina gli asintoti della funzione y =
.
3x - 9
3. Data la funzione f ( x) =
x2 + x - 2 - x
calcola:
4 - 2x
lim f ( x) ;
b) lim f ( x) .
a)
x® 2
x ®¥
Diritto ed
economia
1. Spiega perché in condizioni di libero mercato, per qualsiasi
bene, il punto in cui la domanda è uguale all’offerta è un
punto di equilibrio stabile.
2. Spiega qual è lo scopo della politica monetaria secondo
Keynes, ed in che modo si attua.
3. Hobson, nella sua analisi dell’imperialismo, mette in
relazione “l’eccesso di risparmio” con il “sottoconsumo” e
con la”distribuzione del reddito”. Spiega in quale maniera
l’Autore lega questi tre concetti per interpretare la politica
imperialistica Inglese di fine ‘900.
10
SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA:
Data di
effettuazione
12.3.2010
Materia
Ed. Fisica
Storia
Quesito
1. In relazione agli aspetti biologici dell’esercizio fisico, definisci
brevemente i concetti di “Energia di lavoro” e di “Energia di
ripristino”.
2. Quali sono i tre meccanismi di liberazione dell’energia e quali
gli enzimi principali implicati in ogni meccanismo?
3. Cosa si intende per “Modello di Prestazione” e perché è utile
conoscerlo?
1. Qual è l’atteggiamento degli U.S.A. nei confronti della
Grande Guerra? (8-10 righe)
2. Quali errori si compiono nella stipulazione dei trattati di pace
alla fine della Prima Guerra Mondiale? (8-10 righe)
3. Perché il 1924 è un anno decisivo nella storia del Regno
d’Italia? (8-10 righe)
Problema 1
Nei primi 3 s di moto, la velocità di un modellino radiocomandato cambia
come illustrato nel grafico.
Calcola:
n l'accelerazione media nei primi 3 s.
n lo spazio percorso nei primi 2 s.
n la velocità media nei primi 2 s.
Fisica
Problema 2
Una monoposto di Formula 1 si muove inizialmente a 100
km/h. Accelerando in modo costante per 7,1 s, raggiunge i 200
km/h.
n Qual è stata la sua accelerazione?
n Quanti metri ha percorso durante la fase di accelerazione?
Problema 3
Inglese
Un sasso viene lanciato da un ponte con una velocità di 15
m/s diretta verso l’alto. Il sasso cade nel fiume dopo 5 s. Poni
l’accelerazione di gravità g = 10 m/s2.
n Calcola quanto è alto il ponte rispetto al fiume.
1.Write a paragraph about the poem “The Tyger”; also mention
the subject of the poem, the use of images and symbols and their
meanings
2. Describe, in your own words, the so-called “Victorian
compromise”
3. Write a paragraph on the character of Dorian Gray.
11
TERZA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA
Data di
effettuazione
28.4.2010
Materia
Inglese
Ed. fisica
Storia
Matematica
Quesito
1. Referring to Joyce’s novel “Dubliners”, focus on the short
story “Eveline” and write a paragraph about it.
Mention:
- where is the story set
- Eveline’s life so far
- her relationship with Frank
- Eveline’s conflict
- what happens when she’s on the quayside
- how the story ends
2. Referring to Wilde’s novel “The picture of Dorian Gray”,
concentrate on the character of Dorian Gray and write a
paragraph about it, also mentioning his philosophy of life
3. Write a paragraph about “Hard Times”.
Mention :
- where is the story set
- who are the protagonists
- what difference/s it highlights ( and what it denounces)
-Dickens’s primary aim in this novel
1. In relazione ai meccanismi di liberazione dell’energia, cosa
stimola l’allenamento e come utilizzo questa informazione nella
programmazione dell’allenamento?
2. Nell’esecuzione di una gara di corsa sui 400 m quali
meccanismi di liberazione dell’energia vengono utilizzati e
quali principali enzimi intervengono nel processo?
3. Puoi definire i concetti di “ripetizione”, “serie” e “recupero”?
1. Quali sono le cause profonde della Prima Guerra Mondiale?
(8-10 righe)
2. Quali tratti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori
Tedeschi lo resero popolare nella Germania degli anni ‘30?
(8-10 righe).
3. Che cosa sono i piani quinquennali, da chi, quando, perché
vennero pensati e quali furono le condizioni della loro
attuazione? (8-10 righe)
1. Studia e rappresenta graficamente la seguente funzione
x2 -1
f ( x) = 2
x -4
2. Utilizzando i rapporti incrementali, calcola la derivata delle
seguenti funzioni nei punti indicati:
1
a.
y = x 3 in c = 2 ;
b) y = 3 x in c =
3
3. Utilizzando le formule, calcola le derivate delle seguenti
funzioni:
x3 -1
1 - 2x 2
a. a) y = x 5 - 2 + 3 x ;
b) y =
x
1- x2
12
ALLEGATO 2:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE
1.GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA
1.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA E FILOSOFIA
Criteri di misurazione (descrittori)
10-9: conoscenze approfondite ed organiche; argomentazione rigorosa, fluida e con lessico
appropriato e ampio.
8: conoscenze complete ed articolate; argomentazione efficace con lessico ampio.
7: conoscenze presenti e sicure; argomentazione corretta, ordinata e con lessico appropriato.
6: conoscenze essenziali; argomentazione essenziale nel lessico, accettabile nella forma.
5: conoscenze scarse ed incomplete; argomentazione con forma impropria e lessico impreciso.
4: conoscenze frammentarie ed apparentemente casuali esposte in modo altrettanto casuale.
3: conoscenze nulle; argomentazione assente.
2-1: compito in bianco, a domanda tace.
Per la valutazione delle terze prove sono stati usati i criteri di cui sopra con la seguente
corrispondenza in quindicesimi.
DECIMI
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
QUINDICESIMI 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6.5- 76/7 7.5
11
12
8
8.5
13
14
910
15
1.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DIRITTO – ECONOMIA
INDICATORI
DESCRITTORI
1
2
3
Pertinenza,
4
5
Conoscenze
Conoscenze
Conoscenze
completezza e
Conoscenze Conoscenze
non
lacunose o
essenziali e
correttezza delle
esaurienti approfondite e
pertinenti o frammentarie e sostanzialmente
conoscenze:
e corrette.
corrette.
e scorrette.
imprecise.
corrette.
1,5
1
Individua i
2,5
0,5
Capacità di
Disorganica o concetti chiave,
2
Completa,
Non individua
elaborazione e di
coglie solo
dandone una
Articolata e
organica e
alcun concetto
sintesi:
alcuni concetti
esposizione
coerente.
puntuale.
chiave.
chiave.
molto
schematica.
2
2,5
Competenze
1
1,5
Esposizione Esposizione
espositive e
0,5
Linguaggio
Linguaggio
chiara e
fluida e
padronanza del Linguaggio
impreciso e
corretto con
corretta,
precisa, con
lessico specifico. scorretto. lessico carente.
lessico
svolta con
padronanza
.
essenziale.
lessico
del lessico
specifico.
specifico.
IL VOTO COMPLESSIVO E’ ESPRESSO IN DECIMI.
Se la trattazione non è svolta il voto è l.
13
Tabella di corrispondenza decimi quindicesimi:
DECIMI
1
2
2,5
3
3,5
QUINDICESIM
I
1
2
3
4
5
4 4,5
5
5,5
6
6,47,2
7,37,9
8-8,8
8,99,6
10
6
8
9
10
11
12
13
14
15
7
1.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER MATEMATICA E FISICA
INDICATORI
Conoscenza
dell’argomento
Capacità logico
argomentative
Possesso del
linguaggio tecnico
DESCRITTORI
Padronanza di principi,
formule e regole
Applicazione in
situazioni note o nuove
Formalizzazione e/o
decodificazione del
linguaggio matematico
Totale
LIVELLI
PUNTI
Inesistente
1
Scadente
2
Limitata
3
Adeguata
4
Completa
5
Inesistente
1
Inadeguata
2
Accettabile
3
Buona
4
Ottima
5
Inesistente
1
Impropria
2
Adeguata
3
Corretta
4
Eccellente
5
PUNTI DATI
/15
14
1.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER INGLESE
descrittori
voto
Non è stata fornita alcuna risposta
La risposta è un frammento praticamente incomprensibile
Risposta quasi del tutto incomprensibile o non pertinente
Risposta confusa, scarsamente pertinente e fortemente difettosa nel linguaggio
Risposta parzialmente accettabile, ma confusa nei contenuti e linguisticamente difettosa
Risposta comprensibile e sostanzialmente pertinente, sebbene incompleta o con qualche
grave errore grammaticale
Risposta soddisfacente per quanto riguarda l’essenza del contenuto e comprensibile
anche se non totalmente corretta nel linguaggio
Risposta pertinente nei vari aspetti del contenuto e sostanzialmente corretta nel
linguaggio
RIsposta caratterizzata da pertinenza e completezza contenutistica e da una buona
qualità di espressione linguistica
Risposta eccellente nel linguaggio e nel contenuto o, pur se contenente qualche
imprecisione linguistica, notevole per originalità di contenuto e/o efficacia testuale
1
2
3
4
5
Tabella di trasposizione dei decimi in quindicesimi:
punteggio totale Voto in quindicesimi
10
1
11-15
2
16-20
3
21-25
4
26-30
5
31-35
6
36-42
7
43-49
8
50-56
9
57-62
10
63-68
11
69-74
12
75-80
13
81-90
14
91-100
15
15
6
7
8
9
10
15 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE FISICA
VOTO
DESCRITTORE
2
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
3
Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o
incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e
confusione nella comunicazione scritta e orale.
4
Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di
esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli
argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale.
5
Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti
fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia
nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.
6
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.
Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali
7
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta.
Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione
corretta degli argomenti richiesti.
8
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati.
Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli argomenti richiesti.
9
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e
personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di
organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari.
10
Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.
16
2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
Comprensione complessiva del
testo
ITALIANO TRIENNIO
Pertinenza rispetto alla
richiesta (analisi)
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”
CITTADELLA (PD)
TIPOLOGIA “A” - ANALISI TESTUALE
Correttezza linguistica e
coerenza testuale
Contestualizzazione
Approfondimento
Giudizio
Voto in
decimi
Voto in
quindicesimi
1-3
1-5
Confusa, priva di senso compiuto
Mancata comprensione della
richiesta
Gravi e numerosi errori, gravi
errori lessicali e mancanza di
progressione
Mancante
Negativi
Contraddittoria
Corrispondenza sporadica,
fraintendimenti, omissioni
Presenza di errori, punteggiatura
e lessico incerti, progressione
confusa
Collegamenti intra-intertestuali stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Parziale o molto approssimativa,
non ricostruisce il senso essenziale
Corrispondenza limitata e
disorganica
Errori sporadici, linguaggio
generico, progressione poco
chiara
Collegamenti sporadici e
superficiali
Insufficiente
5
9
Limitata al senso centrale
Corrispondenza limitata, ma
coerente
Progressione chiara, anche se
semplice, errori occasionali
Esposizione schematica, ma
corretta nei collegamenti
Sufficiente
6
10
Essenziale, ma con elementi di
specificazione correlati
Adesione precisa, omissioni e
fraintendimenti poco rilevanti
Progressione chiara, sintassi
corretta
Esposizione schematica con
un ampliamento significativo
Discreto
6,5-7
11
Inferenze denotano autonomia nel
metodo d’analisi
Adesione precisa
Morfosintassi sicura
Esposizione autonoma
Più che
7-7,5
12
Frequenti inferenze denotano
autonomia nel metodo d’analisi
Adesione precisa e, in parte,
approfondita
Morfosintassi sicura, articolazione
e lessico precisi
Esposizione autonoma,
elaborata criticamente
Buono
8
13
Ampia, precisa, svela il senso
profondo con inferenze interessanti
Adesione precisa e
approfondita di tutte le
richieste
Discorso articolato e strutturato,
lessico specifico e stile personale
Contestualizzazione ampia
che giustifica le
interpretazioni personali
ottimo
9/10
14-15
discreto
17
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
Aderenza al problema
ITALIANO TRIENNIO
TIPOLOGIA “B” – SAGGIO BREVE
Comprensione dei
documenti dati, utilizzo dei
documenti integrativi
Correttezza linguistica e coerenza
alla forma testuale prescelta:
destinatario, contesto comunicativo,
registro linguistico, scopo
Mancata focalizzazione del
problema
Assente
Gravi e numerosi errori, scelte lessicali
incongruenti, mancata progressione
Corrispondenza sporadica /
tesi non chiara
Approssimativa con
fraintendimenti e omissioni
Corrispondenza limitata e
disorganica / tesi esplicitata in
modo confuso
Giudizio
Voto
in
decimi
Voto in
quindicesimi
Mancanza di elementi
significativi
Negativo
1-3
1-5
Errori, uso della forma contraddittorio,
progressione confusa
Idee superficiali,
collegamenti stentati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Parziale, manca la
ricostruzione del quadro
essenziale
Errori sporadici; lessico, destinatario e
scopo generici; progressione non chiara
Collegamenti sporadici, idee
non significative
Insufficiente
5
9
Corrispondenza limitata ma
coerente / tesi chiara
Approssimazioni e omissioni n
on toccano i temi essenziali
Tipologia e progressione chiare, errori
occasionali
Esposizione schematica di
almeno un elemento
significativo
Sufficiente
6
10
Adesione coerente alle
principali articolazioni / tesi e
argomentazioni chiaramente
esplicitate
Limitata all’essenziale, ma con
conoscenze e documenti
integrativi
Tipologia e progressione articolate,
sintassi corretta
Esposizione schematica con
qualche ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Adesione sicura alla traccia e
alle sue articolazioni
Sicura, ben integrata con un
quadro di riferimento
Morfosintassi corretta, tipologia e
progressioni fluide
Esposizione problematica
con sviluppo di idee ed
elementi significativi
Più che
discreto
7-7,5
12
Adesione sicura e, in parte,
approfondita
Precisa, articolata, giustificata
dalle conoscenze personali
Morfosintassi sicura, tipologia adatta
all’articolazione
Scelta autonoma degli
elementi significativi,
problematizzazione
Buono
8
13
Adesione sicura e, in gran
parte, approfondita
Precisa, acuta, integrata in
un’organizzazione concettuale
Realizzazione efficace, padronanza di
lessico e sintassi
Ricerca di significati nello
sviluppo critico-problematico
Più che buono
9
14
Adesione precisa e
approfondita a tutte le
richieste della traccia
Accompagnata da sicuri quadri
di riferimento
Testo piacevole ed efficace, stile creativo
Integra problematicamente;
documentazione e
conoscenze personali
Ottimo
10
15
18
Rielaborazione
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”
CITTADELLA (PD)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
Pertinenza alla traccia
ITALIANO TRIENNIO
Conoscenza dei contenuti
TIPOLOGIA “C” – TEMA STORICO
Correttezza linguistica e coerenza
testuale
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”
CITTADELLA (PD)
Rielaborazione
Giudizio
Voto in
decimi
Voto in
quindicesimi
Negativo
1-3
1-5
Mancata comprensione della
richiesta
Scarsa o assente
Gravi e numerosi errori morfologici,
lessicali e di progressione
Mancano i collegamenti
Corrispondenza sporadica alla
traccia
Approssimativa, confusa su
date, avvenimenti e concetti
chiave
Errori morfologici, lessico incerto,
progressione confusa
Collegamenti stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza limitata e
disorganica
Parziale, confusa; quadro
cronologico e culturale
incompleto
Alcuni errori, lessico generico,
progressione non chiara
Collegamenti sporadici e
superficiali
Insufficiente
5
9
Corrispondenza limitata ma
coerente
Approssimazioni e omissioni
non toccano i temi essenziali
Tipologia e progressione chiare, errori
occasionali
Esposizione schematica di
almeno un elemento
significativo
Sufficiente
6
10
Adesione coerente alle
principali articolazioni
Limitata all’essenziale, con
alcuni elementi correlati
esattamente
Articolazione essenziale, sintassi
semplice ma corretta
Esposizione schematica con
qualche ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Adesione sicura alla traccia e
alle sue articolazioni
Essenziale, avvenimenti inseriti
in un chiaro quadro di
riferimento
Morfosintassi corretta, lessico specifico,
articolazione fluida
Esposizione con spunti
argomentativi, inferenze e
collegamenti
Più che
discreto
7-7,5
12
Adesione sicura e, in alcune
articolazioni, approfondita
Con riferimenti precisi,
articolati e giustificati
Morfosintassi corretta, lessico specifico,
articolazione fluida
Esposizione autonoma,
elaborata criticamente
Buono
8
13
Adesione sicura e approfondita
alla maggioranza delle
articolazioni
Con date, nomi e teorie in
un’organizzazione che sa
valorizzarle
Articolazione fluida, sintassi e lessico
specifico precisi
Sviluppo critico
argomentativo della
contestualizzazione
Più che buono
9
14
Adesione precisa e
approfondita a tutte le
richieste della traccia
Ampia, personale,e precisa di
nozioni, fonti e interpretazioni
Discorso articolato e strutturato, lessico
specifico e stile personale
Contestualizzazione ampia
che giustifica le
interpretazioni personali
Ottimo
10
15
19
GRIGLIA DI VALUTAZIONE –
Pertinenza alla traccia
ITALIANO TRIENNIO
Conoscenza dei contenuti
TIPOLOGIA “D” – TEMA DI ATTUALITÀ
Correttezza linguistica e coerenza
testuale
I.I.S. “TITO LUCREZIO CARO”
CITTADELLA (PD)
Rielaborazione
Giudizio
Voto in
decimi
Voto in
quindicesimi
Negativo
1-3
1-5
Mancata comprensione della
richiesta
Scarsa o assente
Gravi e numerosi errori morfologici,
lessicali e di progressione
Mancano i collegamenti
Corrispondenza sporadica alla
traccia
Approssimativa, confusa su
concetti chiave
Errori morfologici, lessico incerto,
progressione confusa
Collegamenti stentati e non
giustificati
Gravemente
insufficiente
4
6-8
Corrispondenza limitata e
disorganica
Parziale, confusa; quadro
culturale incompleto
Alcuni errori, uso di un lessico generico,
progressione non chiara
Collegamenti sporadici e
superficiali
Insufficiente
5
9
Corrispondenza limitata, ma
coerente
Con lacune che non toccano i
temi essenziali
Progressione chiara, anche se semplice,
errori occasionali
Esposizione schematica ma
corretta nei collegamenti
Sufficiente
6
10
Adesione coerente con la
traccia e le sue articolazioni
Limitata all’essenziale,con
alcuni elementi correlati
esattamente
Articolazione essenziale, sintassi
semplice ma corretta
Esposizione schematica con
qualche ampliamento
significativo
Discreto
6,5-7
11
Adesione sicura alla traccia e
alle sue articolazioni
Essenziale, avvenimenti inseriti
in un chiaro quadro di
riferimento
Morfosintassi corretta, lessico specifico,
articolazione fluida
Esposizione con spunti
argomentativi, inferenze e
collegamenti
Più che
discreto
7-7,5
12
Adesione precisa e, in alcune
articolazioni, approfondita
Riferimenti precisi, articolati e
giustificati
Morfosintassi corretta, lessico specifico,
articolazione fluida
Esposizione autonoma,
elaborata criticamente
Buono
8
13
Adesione sicura e approfondita
alla maggioranza delle
articolazioni
Teorie in un’organizzazione
efficace
Articolazione fluida, sintassi e lessico
specifico precisi
Sviluppo critico
argomentativo della
contestualizzazione
Più che buono
9
14
Adesione precisa e
approfondita a tutte le
richieste della traccia
Ampia, personale e precisa di
nozioni, fonti e interpretazioni
Discorso articolato e strutturato, lessico
specifico e stile personale
Contestualizzazione ampia
che giustifica le
interpretazioni personali
Ottimo
10
15
20
3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA
Materia
Punteggio
(in quindicesimi)
Conoscenza e pertinenza
degli argomenti
Conoscenza completa ,
approfondita e corretta
6
Conoscenza adeguata e
abbastanza approfondita
5
Conoscenza essenziale e corretta
Conoscenze superficiale e
generica
Conoscenze frammentarie e
lacunose
4
3
Conoscenze inadeguate e
incomplete
Sostanzialmente preciso,
appropriato e corretto
Linguaggio pressoché corretto
anche se talvolta generico e con
qualche imprecisione
Linguaggio inadeguato e con
errori
Sa effettuare analisi e sintesi
corrette e autonome
Sa effettuare analisi e sintesi,
anche se talvolta parziali e
imprecise
Non sa effettuare analisi e sintesi
corrette
Sviluppo organico
nell’argomentazione anche in
modo personale
Elaborazione coerente e
abbastanza organica, anche se
talvolta imprecisa
Elaborazione e organizzazione
incoerente
1
(max punti 6)
Uso del linguaggio specifico
(max punti 3)
Capacità di analisi e di sintesi
(max punti 3)
Competenze
(max punti 3)
DECIMI
1
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.56/7
11
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
77.5
12
88.5
13
9
10
QUINDICESI 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14 15
MI
N.B. : Produzione nulla: 1/15.
Per produzione non pertinente al quesito si valutano soltanto competenza linguistica e
linguaggio specifico.
21
ALLEGATO 3:
RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE VARIE DISCIPLINE
PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE
DOCENTE: FIORELLA FIOR
anno scol. 2009-2010
Materia: ITALIANO
Classe: V B sociale
Nel primo consiglio di classe sono stati definiti gli obiettivi educativi-cognitivi generali che sono stati
riportati nella programmazione comune del consiglio di classe e ai quali il presente programma
svolto fa riferimento.
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, nella quale ho insegnato nel triennio, è composta di 23 studenti dei quali due sono maschi e il
restante numero (21) femmine; nel complesso tutti hanno cercato di impegnarsi, in base alle loro
possibilità, nel seguire in modo costante il percorso proposto per questa disciplina.
Dal punto di vista delle conoscenze, la situazione di partenza era discreta e si è mantenuto un livello di
discreta collaborazione e partecipazione alle attività disciplinari proposte durante l’anno.
La classe si è mostrata sufficientemente motivata nell’apprendimento della disciplina e ha cercato di
rispondere alle sollecitazioni che l’insegnante ha proposto durante lo svolgimento del programma.
Le maggiori difficoltà sono state riscontrate nello svolgimento dei compiti scritti, soprattutto nella
trattazione approfondita dei contenuti proposti dalle tracce. Il livello di preparazione può essere distinto in
tre fasce: un gruppo di studenti preparato e interessato alle tematiche proposte, un secondo gruppo di
allievi con conoscenze e competenze che si attestano su un giudizio discreto e un terzo gruppo che ha
conseguito risultati appena sufficienti, sia nella produzione scritta che orale.
CONOSCENZE
a) conoscere le linee essenziali della letteratura italiana dalla fine del 1700 al 1900, relativamente ai
principali autori e generi affrontati;
b) conoscere le opere letterarie e i testi più significativi dei periodi letterari presi in esame nel corso
dell'anno;
c) conoscere caratteristiche tipologiche e strutture formali delle opere letterarie considerate;
d) conoscere le principali vicende biografiche degli autori trattati, le linee evolutive del pensiero e della
produzione;
e) conoscere il contesto storico e culturale degli autori trattati;
f) conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.
COMPETENZE
LETTERARIE
LINGUISTICHE
a) saper contestualizzare i testi letterari affrontati nel corso dell’anno;
b) saper riconoscere le caratteristiche strutturali e linguistiche di un testo;
c) saper analizzare gli elementi metrici e stilistici, riconoscere le principali figure
retoriche, individuare le parole chiave, le tematiche;
d) acquisire il senso storico dell'evolversi della lingua e della cultura.
a) saper utilizzare progressivamente un linguaggio adeguato ad esprimere i
diversi contenuti appresi;
b) saper produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che siano
completi, coerenti e coesi;
c) saper rielaborare in modo autonomo e personale i contenuti appresi
utilizzando un lessico appropriato.
CAPACITA'
22
a) saper esprimere i contenuti utilizzando un lessico appropriato e specifico;
b) saper produrre testi di diversa tipologia, facendo in modo che siano corretti e completi;
c) saper collocare il singolo autore o movimento in rapporto con quanto lo ha preceduto e individuare gli
aspetti che lo legano con gli sviluppi successivi;
d) saper analizzare, sintetizzare e confrontare i testi, gli autori e i movimenti trattati nel corso dell’anno;
e) saper rielaborare in modo critico e autonomo i testi, stabilendo collegamenti in senso interdisciplinare.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO (ripasso generale)
1
2
3
Le idee e la visione del mondo di UGO FOSCOLO: la vita e le
opere; (pag. 477 e seg.) vol.2
studio di brani tratti dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis: il tema
politico e la figura dell’eroe, l’amore e le illusioni,
l’incontro con Parini; la lettera da Ventimiglia;
I Sonetti: Alla sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni; Dei
Sepolcri,
le Grazie: il velo delle Grazie.
Il ROMANTICISMO in Europa e in Italia: caratteri fondamentali della
società e della cultura del periodo; (pag.546 e seg.) vol.2
lettura e analisi di Madame de Stael: sulla maniera e l’utilità delle
traduzioni; Giovanni Berchet: la lettera semiseria di Grisostomo al
suo figliolo.
ALESSANDRO MANZONI: vita e opere; (pag.747 e seg.) vol.2
dalle Lettere: storia e invenzione poetica- lettera a Chauvet; l’utile,
l’interessante, il vero- lettera a M.D’Azeglio;
dalle Odi: il 5 maggio; Marzo 1821
dagli Inni Sacri: la Pentecoste;
dalle Tragedie: Dagli atrij muscosi, dai fori cadenti (coro atto III),
Sparsa le trecce morbide (coro atto IV); la morte di Adelchi (atto V
scene VIII-X);
I Promessi Sposi
La visione poetica di GIACOMO LEOPARDI: vita e opere;
(pag.853 e seg.) vol.2
studio di passi tratti dallo Zibaldone: alle origini della prima grande
stagione poetica (143-144), la teoria del piacere (646-648)
dai Canti: Ultimo canto di Saffo, L’infinito, La sera del di’ di festa, Alla
luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La
quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero solitario; A
se stesso ( confronto con la poesia di Foscolo, Autoritratto)
dalle Operette morali: Dialogo di un folletto e uno gnomo, Dialogo
della natura e di un islandese, Dialogo di Torquato Tasso e del suo
Genio familiare.
23
PERIODO
Settembre
1 ora
Settembre
Ottobre
9 ore
Ottobre
5 ore
Ottobre
Novembre
11 ore
Dicembre
10 ore
Gennaio
2 ore
4
POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO: (pag.71 e seg.)
vol.3A
C: Darwin, Da L’origine delle specie, (estratto dalla III parte intitolata
La lotta per l’esistenza, pag.20 e seg.);
Prefazione a I Malavoglia (pag.33 e seg.)
GIOVANNI VERGA: vita e opere; (pag.283 e seg.) vol.3A
da Vita dei campi: Rosso Malpelo,
dalle Novelle rusticane: la roba, libertà;
da I Malavoglia: : la famiglia Toscano, la morte di Luca, Tre addii;
da Mastro Don Gesualdo: Gesualdo tra i notabili, la morte di
Gesualdo.
TRA CLASSICISMO E SPERIMENTALISMO (pag.179 e seg.
Vol.3A
Cenni al movimento della Scapigliatura
GIOSUE’ CARDUCCI: vita e opere; ( pag.186 e seg.)
dalle Rime nuove: Traversando la Maremma toscana, Pianto antico,
San Martino;
dalle Odi Barbare: Nevicata, Nella Piazza di San Petronio;
da Rime e ritmi: Mezzogiorno alpino.
5
L’ETA’ DEL DECADENTISMO: contesto storico e linee generali
della cultura europea e italiana del periodo (pag.105 e seg.)
GIOVANNI PASCOLI: vita e opere; (pag.417 e seg.)
dal Fanciullino: la poetica;
da Myricae: Rio Salto, Arano, Temporale, Lavandare, L’assiuolo,
Novembre, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo,
da I canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno
GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere; (pag.363 e seg.)
da Terra vergine: Dalfino (fotocopia)
da Il Piacere: Ritratto di andrea Sperelli;
dalle Laudi, sezione Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel
pineto;
Da Notturno: Il bisogno di scrivere.
6
ITALO SVEVO: vita e opere; (pag.465 e seg.)
da Una vita: L’inetto e il suo rivale;
da Senilità: Un’avventura facile e breve, Angiolina scacciata e
trasfigurata;
lettura del romanzo ”La coscienza di Zeno”.
LUIGI PIRANDELLO: vita e opere; (pag.531 e seg.)
lettura e analisi delle novelle tratte da Novelle per un anno: Ciàula
scopre la luna, La patente;
Il fu Mattia Pascal, lettura e analisi dei brani: Morte di Mattia Pascal e
nascita di Adriano Meis, Adriano Meis e la sua ombra, La
resurrezione di Mattia Pascal.
7
Gennaio
4 ore
Febbraio
8 ore
Marzo
5 ore
Marzo
3 ore
Aprile
5 ore
Aprile
5 ore
AprileMaggio
5 ore
Maggio
6 ore
IL PRIMO NOVECENTO: caratteristiche del periodo, ideologie, e
forme letterarie (cenni di carattere generale)
Da
concludere
LA POESIA TRA LE DUE GUERRE (pag.89 e seg.) vol. 3B
cenni generali
L’ERMETISMO E LA NUOVA POESIA: concetti fondamentali del
nuovo modo di far poesia.
Maggio
2 ore
GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere; (pag.205 e seg.) vol.3B
analisi delle poesie: da L’Allegria, I Fiumi, Veglia, Soldati.
Maggio
4 ore
24
EUGENIO MONTALE: la sua visione poetica e le nuove tecniche
poetiche; (pag.243 e seg.) vol. 3B
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato;
da Le Occasioni: non recidere forbice quel volto;
da Satura: Ho sceso dandoti il braccio…..
8
Divina Commedia di Dante Alighieri
Lettura, parafrasi e commento dei canti I-III-VI-XI-XII-XV-XVIIXXXIII del Paradiso
maggio
4 ore
Giugno
ripasso
durante
l’anno per 16
ore
Sono state dedicate 15 ore allo svolgimento dei compiti di produzione scritta.
Totale: 120 ore
CRITERI METODOLOGICI
Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da un’introduzione generale sul contesto storicoculturale caratterizzante ogni movimento letterario, per arrivare poi ad una conoscenza più ravvicinata
delle tematiche e degli autori attraverso la lettura commentata di testi significativi.
Il contributo degli alunni è stato importante nella strutturazione della lezione in classe, soprattutto per
l’acquisizione della capacità di riflettere sulle tematiche proposte e l’avviamento ad uno studio sempre più
autonomo.
Gli studenti sono stati stimolati alla riflessione in classe, in modo da poter acquisire la capacità di
confrontarsi su tematiche letterarie e culturali, soprattutto per comprenderne la modernità e l’attualità. Si è
cercato di creare rapporti interdisciplinari con le materie che hanno maggiore collegamento con la
letteratura italiana, in modo che le allieve potessero acquisire una mentalità aperta e flessibile. Lo
svolgimento del programma ha tenuto conto delle difficoltà delle alunne nel padroneggiare appieno tutte le
competenze previste per questa disciplina e per questo motivo le spiegazioni sono state precise e
puntuali, rispettando anche dei tempi adeguati per l’assimilazione dei contenuti e delle conoscenze. Come
rinforzo del lavoro scritto sono stati proposti temi di svolgimento a casa. Per quanto concerne la tematica
interdisciplinare sulla MULTICULTURALITA’ sono stati letti e commentati articoli di giornale.
MATERIALI DIDATTICI
S.Silveravalle Giusti Casati Saetti, Vaghe stelle dell’orsa, Einaudi scuola, (voll. 2, 3A,3B)
Il testo della Divina Commedia in adozione alla letteratura con canti scelti
Fotocopie, giornali e riviste.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate due prove scritte, due verifiche scritte valide per l’orale e una interrogazione orale
per il 1° quadrimestre; tre prove scritte, due prove scritte valide per l’orale e e due interrogazioni orali nel
secondo quadrimestre.
Le verifiche proposte sono state a risposta sintetica e/o commento ai testi. Tali prove hanno permesso di
valutare le conoscenze acquisite e/o le abilità.
Per quanto riguarda i compiti scritti, gli studenti hanno avuto a disposizione tre e talvolta anche 4 ore; sono
state proposte le prove previste dai nuovi esami di stato con le varie tipologie richieste (testo
argomentativo, articolo di giornale, saggio breve, analisi del testo).
Le verifiche orali hanno permesso di sondare l'acquisizione dei contenuti e il grado di rielaborazione
critica; la capacità di espressione e di commento autonomo ai testi.
I criteri per lo scritto sono stati i seguenti: la correttezza formale e l’uso di un lessico adeguato al contesto;
l’ adeguatezza rispetto alla traccia assegnata, la coesione e l’ ordine di svolgimento; l’originalità
dell'impostazione e la capacità critica.
Per l'orale: la correttezza nell’uso lessicale, la completezza nell’esposizione dei contenuti, la fluidità
d’esposizione, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di far collegamenti.
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della disciplina, i contenuti essenziali e le griglie di valutazione si
rinvia alla programmazione di dipartimento e al P.O.F.
Cittadella,lì 11.05.2010
La docente
Fiorella Fior
25
RELAZIONE FINALE
PER IL DOCUMENTO FINALE CLASSE QUINTA BSO
MAGGIO 2010
docente: Prof.ssa MARCON NICOLETTA
materia: INGLESE
classe: V BSO
1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE
La classe, composta da 23 alunni, di cui 21 femmine e 2 maschi, dal punto di vista scolastico poteva essere divisa in
due gruppi: un gruppo era composto da studenti con un livello di conoscenza dell’inglese più che sufficiente; l’altro
gruppo presentava difficoltà sia nella produzione che nella comprensione;alcuni studenti del secondo gruppo
presentavano forti lacune nella conoscenza e quindi nell’uso delle strutture linguistiche di base ed avevano notevoli
difficoltà sia nella comprensione che nella produzione della lingua scritta e orale.
L’interesse della classe per la disciplina era inizialmente sufficiente; si è cercato di stimolare e controllare
continuamente gli studenti con maggiori difficoltà per aiutarli a raggiungere un apprendimento e delle competenze
della lingua inglese sufficienti, soprattutto in vista dell’Esame di Stato.
Il comportamento degli studenti in classe era complessivamente rispettoso, anche se richiedeva un controllo
costante da parte dell’insegnante. Il rapporto tra loro si presentava amichevole e tollerante, anche se il gruppo-classe
non risultava ben coeso.
È importante rilevare che la classe aveva cambiato docente di inglese in ogni anno scolastico: la mancanza di
continuità didattica non aveva certo contribuito a dare agli studenti un ritmo di lavoro stabile ed un riferimento
costante per il metodo di studio.
2. SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE (AL 12 MAGGIO 2010)
Il gruppo classe ha dimostrato un disceto impegno e desiderio di migliorare le proprie prestazioni linguistiche, sia
nello scritto che nell’orale, ottenendo miglioramenti nelle proprie competenze e capacità. L’interesse per la disciplina
si è via via intensificato, e la partecipazione alle attività proposte – anche con qualche spunto di approfondimento
individuale – è stata costante.
Dal punto di vista del comportamento, il rapporto tra studenti e docente è sempre stato improntato al rispetto e alla
collaborazione reciproca e la necessità di richiami e controllo è divenuta episodica. I rapporti con le famiglie sono stati
abbastanza frequenti, positivi e improntati al dialogo.
Dal punto di vista del profitto si può quindi tracciare il seguente quadro finale diviso per livelli:
livello 1 – non sufficiente:20% della classe
livello 2 –sufficiente: 40 % della classe
livello 3 – discreto: 30% della classe
livello 4 – buono:10% della classe
3. MATERIALI DIDATTICI
Testi adottati:
- Keystage English,follow up (Student’s Book + Workbook), Andreolli – Linwood, ed. Petrini.
- New Literary Landscapes, Thomson, Maglioni, ed.Black Cat
Altri materiali utilizzati:
- estratti di testi di letteratura forniti dalla docente in fotocopia ( Eveline, from Dubliners, Joyce;
- schede grammaticali approntate dalla docente e tratte dal testo Grammar files,
Durante le lezioni si è usufruito spesso di schemi preparati dalla docente, al fine di migliorare la comprensione del
lessico specifico e di conseguenza la correttezza grammaticale ed ortografica.
4. PROGRAMMAZIONE
Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e didattici generali, le metodologie e gli strumenti di verifica, si rimanda alla
programmazione trasversale delineata dal Consiglio di Classe (30 settembre 2009). Si passa qui di seguito ad illustrare
nel dettaglio la programmazione curricolare svolta, distinguendo tra obiettivi cognitivi, competenze e capacità:
a. OBIETTIVI COGNITIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI E SCANSIONE DEI TEMPI:
MODULI DI LINGUA E GRAMMATICA
TEMPI E DURATA
26
MODULO 1: Ripasso e rinforzo di alcune aree della grammatica inglese con
7 ore tra settembre e ottobre
l’ausilio del testo Keystage English, follow up e di schede tratte da Grammar
files
[uso dei tempi al passato, futuro, condizionale,frasi relative, verbi
modali.discorso indiretto, forma passiva]
MODULO 2 : produzione scritta guidata.
6 ore tra settembre e gennaio
Sono stati affrontati i passi fondamentali di una produzione scritta su
argomenti personali e con l’ausilio di linee guida e quindi la riflessione su
errori tipici dei madrelingua italiani. Sono stati prodotti autonomamente
alcuni lavori di produzione scritta come esercizio di rinforzo.
NOTA: Per quanto riguarda le attività di grammatica e di rinforzo linguistico, il piano annuale è stato rispettato.Dato
che l’orario curricolare è di 2 ore settimanali,per buona parte dell’anno gli alunni hanno frequentato lezioni di
“sportello”, tenute dalla docente di classe, per rinforzare ed esercitare le strutture linguistiche di base e migliorare la
produzione orale. In occasione della correzione dei compiti si è sempre curata la correzione degli errori di lingua.
MODULI DI LETTERATURA
TEMPI E DURATA
Nel precedente anno scolastico lo studio della letteratura era stato solo accennato; si era svolto solo la parte
riguardante W.Shakespeare. Si è pertanto deciso di affrontare in quinta lo studio degli argomenti inerenti l’esame di
stato e di partire con l’epoca Romantica.
MODULO 1
TOTALE ORE 13 TRA OTTOBRE E
The Romantic Age
NOVEMBRE
(i)
The Romantic Age: Historical Context:
ore 3
The age of revolutions , the industrial revolution, from French
revolution to the Napoleonic wars,Radicalism in Britain, the road to
reform pag.141,142,143,144,attività pag147
(ii)
The Romantic Age : Literary Context:
ore 5
Literature in the Romantic age, Isn’t it Romantic?, Romantic poetry,
the sublime, the first generation of Romantic poets, characteristics of
Roamnticism, the second generation of Romantic poets,
pag.150,151,152,153,154
The Preface to Lyrical Ballads, pag.168
(iii)
William Blake: life and works, pag.158, 159
ore 5
Lettura, traduzione, analisi di “The Lamb”, “ The Tyger”, pag.160, 161,
162
MODULO 2
The Victorian Age
TOTALE ORE
15 TRA DICEMBRE E
FEBBRAIO
(i)
The Victorian Age: Historical Context :
The age of the empire, economy and society,the pressure for reform,
the cost of living, poverty and the Poor Laws,managing the empire,
the Victorian compromise, pag.211,212,213,215, 216, 220
(ii)
The Victorian Age: literary context:
The Victorian novel, early Victorian novelists,women’s voices, late
Victorian novelists, colonialist fiction, pag.223,224,225,226,227 attività
pag.228
(iii)
Charles Dickens : life and works, pag.239
Hard Times: the plot, features pag.239, 240
Lettura, comprensione analisi di un brano tratto da “Hard Times”pag.
240,241,242
(iv)
Oscar Wilde: life & works; pag.266,267
“The picture of Dorian Gray”: the Preface, the plot, features and
themes,pag.267,268
lettura, comprensione analisi di un brano tratto da “The picture of
Dorian Gray” pag.269, 270
27
ore 3
ore 3
ore 5
ore 4
MODULO 3
The Modern Age
(i) The Modern Age: Historical Context :
A time of war,the last days of Victorian optimism, World War I,
consequences of the war, the inter-years war, World War II, The Holocaust,
th
Hiroshima and Nagasaki,cultural transformation in the early 20 century,
pag. 299,300,301,302,304
(ii)
The Modern Age : Literary Context :
Modernism in Europe, Modernism and the novel, Freud, Bergson,
James, Stream of consciousness fiction, the continuity of the realist
tradition, pag. 308,312,314,315
(iii)James Joyce : life and works, pag. 337
Dubliners, pag. 337, 338
Lettura, comprensione, analisi del racconto “Eveline” da “Dubliners”,
J.Joyce ( fotocopie )
(iii)
George Orwell: life & works, pag.362
“Nineteen eighty-four” : the plot, features and themes, pag.362,363
Lettura, comprensione, analisi di un brano tratto da “Nineteen eightyfour” pag. 364,365,366
TOTALE ORE
16 TRA MARZO E MAGGIO
ore 3
ore 3
ore 5
ore 5
attività previste dopo il 15 maggio:
a) ripasso del programma svolto: gli studenti lavoreranno a gruppi o a coppie sugli schemi precedentemente
preparati; ogni gruppo presenterà poi alla classe in lingua il lavoro svolto (tale lavoro sarà funzionale alla
preparazione dell’esame scritto e orale) (4 ore)
b) allenamento per la terza prova (2 ore)
b. COMPETENZE E CAPACITÀ RAGGIUNTE:
Alla fine dell’a.s. la maggior parte della classe – tenendo conto delle capacità personali e delle conoscenze pregresse
di ciascun studente– è in grado di:
i) applicare correttamente in diverse situazioni comunicative forme grammaticali di livello base e alcuni studenti
anche di livello intermedio;
ii) saper leggere, trovare, organizzare in uno schema, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di
diversa tipologia (narrativa, poesia);
iii) sapersi esprimere in lingua (allo scritto e all’orale), utilizzando un lessico sufficientemente appropriato e strutture
grammaticali di complessità base e in alcuni casi intermedia (in particolare per gli argomenti di letteratura);
iv) saper riconoscere testi appartenenti a diversi generi letterari ;
v) saper collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali delineati nella storia della letteratura
inglese.
5. METODOLOGIA
Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate. L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo
formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo.
Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di ascolto.
6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
E’ stata attuata una verifica costante in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti e tramite la correzione e
valutazione dei compiti assegnati a casa.
28
a. Produzione scritta: per le verifiche scritte sono state effettuate 3 verifiche (1 di grammatica, 2 di letteratura) per il
primo quadrimestre e 3 (di letteratura) per il secondo quadrimestre. Tre di queste verifiche (1 nel primo quadrimestre,
2 nel secondo quadrimestre) facevano parte delle simulazioni della terza prova dell’esame di stato.
La verifica di grammatica presentava tipologie varie di esercizi (simili a quelli del libro di testo e proposti in classe), di
diversa complessità, in relazione al livello raggiunto dagli studenti. Per le verifiche di letteratura si è utilizzata
prevalentemente la tipologia B (quesiti a risposta aperta breve, 8-10 righe).
Le verifiche di grammatica erano sufficienti se corrette per il 50%.
Le verifiche di letteratura – anche delle simulazioni di terza prova – sono state valutate adottando la griglia di
valutazione (elaborata e condivisa dal Dipartimento di Lingue Straniere) in allegato nel documento tra le griglie di
terza prova.
Verifiche svolte:
numero
Data
primo quadrimestre
1
10 ottobre 2009
2
5 dicembre
2
12 dicembre 2009 (simulazione terza prova, 3
domande)
secondo quadrimestre
1
6 febbraio 2010
2
12 marzo 2010(simulazione terza prova, 3
domande)
3
28 aprile 2010 (simulazione terza prova, 3 domande)
Tipologia
grammatica
Letteratura( Romantic Age)
letteratura (Romanticismo, Blake)
letteratura (Victorian Age, Dickens)
letteratura (Blake, Wilde, Victorian Age)
letteratura (Dickens, Wilde, Joyce)
L
b. Produzione orale: nelle prove orali si è valutata la comprensione della lingua, la conoscenza degli argomenti, la
pronuncia, la capacità di elaborazione personale. Sono state svolte 3 verifiche orali – 1 nel primo e 2 nel secondo
quadrimestre - suddivise in interrogazioni di grammatica, brevi interazioni in lingua e presentazioni guidate di
argomenti di letteratura.
Sia per la produzione orale che per quella scritta sono state valutate la correttezza grammaticale e sintattica, quella
lessicale e il contenuto (scritto o orale) prodotto.
La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, delle verifiche (scritte e orali) effettuate durante
l’anno, dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della costanza dell’impegno, della partecipazione alle
attività didattiche e al dialogo educativo, dei condizionamenti socio-culturali, anche in relazione ad eventuali
progressi o regressi nel profitto.
7. ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO
Per rafforzare le competenze individuali (scritte e orali) si è assegnato del lavoro individuale (domande brevi sul
modello della tipologia B, tracce da svolgere) ; i lavoro svolti e consegnati sono stati corretti individualmente.
La docente ha tenuto un corso di recupero pomeridiano rivolto agli alunni con maggiori difficoltà e specificatamente
indirizzato al recupero delle conoscenze di base.
Dato che l’orario settimanale è di 2 ore e che la classe risultava particolarmente carente nell’espressione orale, la
docente si è resa disponibile da novembre a maggio per un’ora la settimana da dedicare alle abilità orali.
8. ORE DI LEZIONE SVOLTE
I quadrimestre :23 ore ore; II quadrimestre: (al 12 maggio 2010): 28 ore.
Cittadella, 12 maggio 2010
La docente
Prof.ssa Nicoletta Marcon
29
Relazione e Programma svolto
CLASSE 5 BSO
Materia: FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
DOcente: MARINA BERNARDI
1. RELAZIONE
Ho seguito la classe nell’intero triennio. Gli alunni si sono sempre dimostrati interessanti alla
materia, hanno mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto e hanno partecipato in modo
attivo al lavoro proposto in classe. Il livello di apprendimento è mediamente più che sufficiente.
Alcuni alunni, grazie anche a un impegno costante e attento, hanno raggiunto un livello decisamente
buono sia nella produzione orale che nella produzione scritta. Un gruppo più ampio presenta un
livello discreto, mostrando una maggiore competenza nella produzione orale che nella produzione
scritta. Un ultimo gruppo, nel complesso pienamente sufficiente, presenta ancora qualche incertezza
nel padroneggiare nello scritto le strutture morfosintattiche.
2. PROGRAMMA SVOLTO
1. In relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi
disciplinari in termini di:
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
s Ulteriori strutture linguistiche di livello B2
s Il linguaggio letterario e alcuni strumenti di analisi dei testi letterari
s Alcune tematiche e contenuti relativi alla geografia, alla civiltà, alla storia e alla letteratura
francese.
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno:
s Comprendere globalmente e analizzare testi autentici anche di tipo letterario di L2
s Relazionare oralmente in modo sufficientemente corretto su testi autentici in L2
s Esprimersi in L2 anche su argomenti di tipo letterario
s Usare alcuni strumenti di base di analisi testuale
s produrre testi sufficientemente corretti anche di tipo argomentativo
s prendere appunti in L2
s riassumere in modo sufficientemente coeso e coerente un testo
CAPACITÀ:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
s riorganizzare i contenuti sintetizzati e le conoscenze acquisite
s esprimere in modo sufficientemente corretto alcuni giudizi e valutazioni personali
s operare collegamenti con altre discipline
4. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe
Modulo / U.D.
MODULO 1. LE ROMAN RÉALISTE ET NATURALISTE
Libro di testo: Bonini, Jamet, Kaléidoscope, mod. C, Valmartina
U. 1
30
99
Ore
impiegate
·
·
BALZAC. Notices sur la vie. L’œuvre : le peintre de l’homme, le
peintre réaliste de la société, le style ; La Comédie humaine : l’époque
historique représentée, le projet et le but de l’œuvre expliqués dans la
Lettre à Mme Hanska (libro di testo p. 70,71, 78-80).
Analyse de texte. Passage tiré du Père Goriot : la pension Vauquer et
Mme Vauquer (materiale integrativo); la description réaliste : lexique et
effet de réel, la construction de la description ; le point de vue ;
l’omniscience du narrateur ; la description subjective ; le rapport entre
personnage et espace (appunti).
U. 2
· FLAUBERT. Notices sur la vie. L’œuvre : la tentation e la crise du
romantisme, la représentation de la médiocrité et du quotidien, le thème
de l’échec, l’anti-héros, réalisme et technique narrative , le travail de
l’écriture et le souci du style, époque historique représentée dans l’œuvre
de Flaubert ; quelques notices sur Mme Bovary ; le bovarysme (libro di
testo p. 127, 131, 140, 141)
· Analyse de texte. Passage tiré de Madame Bovary (libro di testo p.128130) : la séduction amoureuse de Rodolphe ; l’amour pour Emma ; le
rapport entre dialogue, narration et description ; la description de la
nature et la focalisation ; le style indirect libre ; le bovarysme d’Emma
(appunti).
ore: 7
ore: 7
ore: 7
U. 3
· ZOLA. Notices sur la vie. L’œuvre : le roman expérimental, Zola
théoricien du naturalisme, le style ; Les Rougon-Macquart : structure et
thèmes de l’œuvre, époque historique représentée (libro di testo p. 142,
146,147, 151, 152) .
· Analyse de texte. Passage tiré de L’Assommoir (p. 143-144): la
déchéance d’une famille due à l’alcool ; les détails crus et choquants ; la
langue de Zola : argot et langage populaire. Passage tiré de
Germinal (p.162-163): la grève des mineurs affamés ; les personnages
(les bourgeois patrons des mines, la foule des mineurs), la vision de la
révolution, la violence, la pitié.
MODULO 2. L’HISTOIRE DE FRANCE
(semplici e schematiche nozioni ricavate dal libro di testo Kaléidoscope)
U. 1
· DE LA RESTAURATION AU COUP D’ÉTAT DE LOUIS
NAPOLÉON . La Restauration et la monarchie de juillet (le règne de
Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe d’Orléans ; les idées
républicaines et libérales; la Révolution de ’48 : les journées de février,
le gouvernement provisoire de la république, la deuxième République et
le coup d’état de Louis Napoléon (p.18, 19, 22, 23).
U. 2
· DE NAPOLÉON III À LA III RÉPUBLIQUE. Le Second Empire (la
dictature, la libéralisation, la politique extérieur et la guerre francoprussienne) ; la Commune de Paris ; la Troisième République (le régime
parlementaire, la phase modérée : les libertés, les lois sociales, les
reformes de l’enseignement ; le boulangisme et l’affaire Dreyfus ; la
phase radicale ) (p.114, 115, 117, 119, 120).
31
ore : 2
ore : 2
ore : 7
U. 3
· LES DEUX GUERRES MONDIALES.
·
La Grande Guerre de 14-18 : l’entrée en guerre de la
France, la guerre des tranchées, la crise de 1917, la victoire, profits et
pertes, les conséquences (p. 212, 213, 215). Analyse de texte : passage
tiré de Maurice Genevoix, La mort de près : l’horreur de la guerre des
tranchées.
·
L’entre deux guerres : état de crise (les problèmes
financiers, le problème socialiste, la reprise sous la présidence de
Poincaré, la crise mondiale en France, la crise du régime, le Front
Populaire (succès et échecs) (p. 216 – 217).
·
La Seconde Guerre mondiale : le drôle de guerre, la
débâcle et l’armistice ; l’occupation allemande et la République de
Vichy ; l’organisation de la résistance ; occupation et libération ; la fin de
la guerre et son bilan (p. 218-220). Analyse de texte : passage tiré de
Vercors, Le silence de la mer : l’occupation allemande : dimension
historique et dimension individuelle (p. 220).
U. 4
· LA QUATRIÈME ET LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE. Le
gouvernement provisoire de de Gaulle, l’instabilité ministérielle, le
redressement économique, le problème colonial (p. 304, 305). De Gaulle
et la constitution de 1958, les Présidents de la Cinquième République ;
mai 68 ; la bipolarisation entre la droite et la gauche, la cohabitation (p.
309, 310, 312).
MODULO 3. LA GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE
Libro di testo: E. De Gennaro, Forum, Il Capitello
U. 1
· LA FRANCE PHYSIQUE. L’espace français; plaines et plateaux;
montagnes ; côtes ; fleuves ; climat (p.216-220).
U. 2
· LA VIE ÉCONOMIQUE. L’agriculture, l’élevage, la pêche.
L’industrie: caractères généraux, les secteurs de pointe, les secteurs
traditionnels, le secteur tertiaire, le tourisme (p.220-227).
U. 3
· L’ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE. La
République sémi-présidentielle; le Président et le gouvernement ; le
Parlement ; l’organisation administrative (p. 228-231)
MODULO
4.
PERCORSO
PLURIDISCIPLINARE
SULLA
MULTICULTURALITÀ: LA FRANCOPHONIE
Libri di testo e materiale integrativo
U. 1
· LA FRANCE D’OUTRE-MER. Les D.O.M., les T.O.M. et le
Collectivités territoriales (Forum, p. 240-242).
U. 2
· L’EMPIRE COLONIAL ET LA DÉCOLONISATION. L’empire
français en 1914 ; les débuts de la décolonisation ; la guerre d’Algérie ; la
fin de la décolonisation (Kaléidoscope, p. 306-307).
· Visione del film La Bataille d’Alger di Gillo Pontecorvo. Analisi e
discussione
·
U. 3
32
ore : 2
ore : 2
ore : 3
ore: 3
ore : 2
ore : 3
ore: 4
ore: 8
·
LA FRANCOPHONIE. Francophonie et pays francophones (materiale
integrativo); la France et le français dans le monde (Kaléidoscope, p.
313-314). Littérature du Maghreb (materiale integrativo) ; analyse de
texte : passage tiré des Amandiers sont morts de leur blessure de Tahar
Ben Jelloun : la condition de l’immigré. Du côté de l’Afrique et des
Caraïbes : la négritude, Afrique noire, Senghor et Césaire (materiale
integrativo) ; analyse de texte : poème tiré de Chants d’ombre de
Senghor (materiale integrativo e appunti). Du côté du Québec : une
littérature en langue française, la Révolution tranquille, la question de la
langue (materiale integrativo); analyse de texte : passage tiré des Belles
Sœurs de Michel Tremblay : la condition féminine ; le québécois
(materiale integrativo, appunti).
Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico fino al 15
maggio (che comprendono, oltre allo svolgimento dei contenuti
sopraelencati, anche lo svolgimento di contenuti morfosintattici, di
attività linguistiche di produzione scritta e orale, le verifiche scritte, le
correzione delle verifiche scritte, le verifiche orali)
ore : 83
5. METODI
Lezioni frontali, lezioni dialogate e partecipate; attività individuali, a coppie, per stimolare la
partecipazione degli studenti e l’attività autonoma di apprendimento e approfondimento. Costante
attività di revisione
6. MEZZI
Libri di testo: G. F. BONINI, M:-C. JAMET, Kaléidoscope, Valmartina; E. DE GENNARO,
Nouveau Forum, Il Capitello; materiale integrativo, appunti.
8. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alle griglie di dipartimento inserite nel POF. Sono state
svolte 5 prove scritte e 3 prove orali nell’arco dell’anno scolastico.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE SCRITTE E ORALI
Prove scritte: verifiche scritte di vario tipo come esercizi strutturali e di completamento,
comprensione e analisi del testo, riassunto, domande a risposta aperta.
Prove orali: riferire contenuto di un testo analizzato, esporre argomenti di civiltà e letterari,
riassumere testi scritti.
Cittadella, 12 maggio 2010
Firma del Docente
Marina Bernardi
33
MATERIA: STORIA
DOCENTE: LAURETTA SEMINARA
MONTE ORE PREVISTO: 99
ORE FINO AL 12 MAGGIO: 77
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
In classe, il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e un gruppo di quattro o cinque alunni ha
dimostrato, con domande e interventi, di avere un certo interesse per i problemi affrontati. Il rendimento
risulta diversificato nel modo seguente: il gruppo degli alunni sopra citato ha realizzato un profitto di livello
sicuramente buono e ha messo a frutto discrete capacità di analisi e sintesi; un secondo gruppo, più
numeroso, lavorando con impegno ha superato alcune delle difficoltà iniziali e ha meritatamente raggiunto
un livello di sufficienza; un terzo gruppo, il più ristretto, in alcuni casi per una certa discontinuità
nell’impegno, in altri a causa di numerose assenze, ha con difficoltà raggiunto gli obiettivi minimi.
OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze: relativamente agli argomenti trattati (si veda tabella dei contenuti disciplinari, che segue), gli
obiettivi minimi assumono la conoscenza degli eventi storici almeno nei loro tratti fondamentali e nelle loro
conseguenze principali.
Competenze: gli obiettivi minimi assumono la capacità di distinguere le cause profonde da quelle immediate
degli eventi e quella di correlare tra loro gli eventi storici; ancora, l’utilizzo di un lessico adeguato e quello di
argomentazioni semplici e lineari.
Capacità: gli obiettivi minimi auspicano la capacità di analizzare un fenomeno nei suoi elementi costitutivi, e
di saper tuttavia proporre una sintesi efficace dello stesso. Ancora, la capacità di cogliere analogie
sincroniche e diacroniche.
METODO
La trattazione degli argomenti è stata affrontata con lezioni frontali svolte per lo più sulla base di schemi
sintetici ma tuttavia esaustivi per quel che concerne i punti fondamentali (obiettivi minimi).
Compresenza
Le ore in compresenza con il collega di Diritto ed Economia sono state utilizzate per approfondire alcuni
nuclei tematici comuni alle due aree e particolarmente significativi anche in relazione ad una trattazione
pluridisciplinare delle due materie. Quando necessario sono utilizzate per ripassi e recuperi integrati. Nella
seconda parte dell’anno sono state dedicate per lo più allo svolgimento e all’approfondimento della parte
storica, viste le materie dell’Esame di Stato. Per contenuti svolti si veda la tabella di Diritto ed Economia.
MEZZI
Lezioni frontali, schemi (vedi “Metodo”), lettura di fonti. Il sussidio del testo in adozione (A. Giardina, G.
Sabbatucci, V. Vidotto, Nuovi profili storici, Laterza 2008) è stato costantemente raccomandato per
l’integrazione del lavoro svolto in classe.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Strumenti
Verifiche orali e scritte. Si è inoltre tenuto conto, nella valutazione finale, dell’interesse dimostrato, della
partecipazione, degli interventi.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomento sintetico
Completamento
programma anno
precedente
Sviluppo analitico
Tempi
Lo Stato liberale dell’ ‘800. Unità d’Italia, di Germania, e la
nascita della Terza Repubblica francese: le guerre del 1866 e del
1870La Francia della Terza Repubblica: La Comune di Parigi e
la Prima Internazionale, il caso Dreyfuss (1 h). Il Regno d’Italia:
la Destra Storica (2 h); la Sinistra Storica: la politica di Depretis e
il trasformismo, il decollo industriale e il protezionismo, la
politica estera. Il periodo crispino: autoritarismo e riformismo, i
Fasci siciliani, la politica estera (3 h). L’età giolittiana: la nuova
12 ore
SettembreNovembre
34
L’Imperialismo e la
Seconda Rivoluzione
Industriale
La Prima Guerra
Mondiale
La Russia
La Repubblica di
Weimar
politica nei confronti della questione sociale, il rapporto con i
cattolici e con i socialisti; lo sviluppo industriale; la politica
estera e la guerra di Libia (2 h). La Germania di Guglielmo I e di
Bismarck: politica interna ed estera. Il Nuovo Corso di
Guglielmo II (2 h)
L’Imperialismo: definizione del fenomeno, differenze rispetto al
colonialismo e le sue cause. La conferenza di Berlino (1 h); la
Seconda Rivoluzione Industriale: caratteristiche del fenomeno, i
mutamenti nel sistema economico e finanziario, fordismo e
taylorismo;i riflessi del fenomeno sulla questione sociale: i
socialisti (il revisionismo di Bernstein) e i cattolici (la Rerum
Novarum) (1 h)
Cause immediate e cause profonde (2 h, con schema); caratteri e
differenze rispetto ai conflitti precedenti (1 h); le fasi più
importanti del conflitto con particolare riguardo al 1917 (1h);
l’entrata in guerra dell’Italia (1 h); le conferenze di pace: i limiti,
i 14 punti di Wilson e il nuovo assetto politico dell’Europa (2 h,
con schema). L’eredità della Grande Guerra (1 h, con schema)
La Russia di fine secolo, le diverse forme di dissenso e la
Domenica di sangue (1 h); la guerra come scintilla di una già
grave situazione politica e sociale; la rivoluzione di febbraio; la
Duma e i Soviet; il ritorno di Lenin e le tesi di aprile; la
rivoluzione Bolscevica (1 h); lo scioglimento dell’Assemblea
Costituente e la guerra civile; il comunismo di guerra e la NEP
Le deboli basi sociali e politiche della Repubblica di Weimar (1
h)
2 ore
Novembre
8 ore
Dicembre-Gennaio
3 ore
Gennaio
1 ora
Febbraio
Il Fascismo
La crisi post -bellica in Italia: il biennio rosso, le elezioni del
1919 e del 1921, l’atteggiamento giolittiano (1 h); il fascismo e
l’ascesa al potere (1h); la fase di transizione e la costruzione del
regime (1 h); la fascistizzazione della società e lo Stato totalitario
(1 h); la politica economica e i Patti lateranensi (1 h); la politica
estera e la guerra d’Etiopia (1 h).
La crisi del 1929 e il
New Deal
Gli anni ruggenti e il crollo della Borsa di Wall Street (1 h); le
conseguenze, le prime reazioni, il New Deal (1 h)
2 ore
Marzo
Il Nazismo
La crisi economica e il malcontento sociale, il lieve
miglioramento degli anni ’20 e il tracollo con la crisi del 1929;
l’ascesa del nazismo (1 h). Il regime: la sua rapida costruzione; la
politica razziale e la repressione delle opposizioni (1 h); la
politica economica e la bellicosa politica estera (1 h)
La morte di Lenin e la “crisi di successione” (1 h); la
pianificazione economica (1 h); l’industrializzazione a tappe
forzate: i suoi mezzi e le sue conseguenze; il regime totalitario, le
epurazioni e i gulag , la ricerca del consenso (1 h). La politica
estera, dagli anni ’20 al Patto Molotov-Ribbentrop (1 h)
3 ore
Aprile
La guerra di Spagna e le cause della Seconda Guerra Mondiale
(2 h); cronologia essenziale (2 h); l’Italia dal 25 Luglio all’8
Settembre (1 h); il CLN, la Resistenza, gli Alleati e la guerra di
liberazione. La fine della guerra in Europa e nel Pacifico (1 h)
6 ore
AprileMaggio
L’URSS
La Seconda Guerra
Mondiale
35
6 ore
Febbraio
4 ore
Aprile
La Guerra Fredda
Definizione del fenomeno; caratteristiche.
2,5 ore
Maggio
La Decolonizzazione
Condizioni di possibilità del fenomeno; problemi postindipendenza
0,5 ore
Maggio
Dopo il 15 Maggio
Il Secondo Dopoguerra in Italia
Dalla Costituente alla vittoria
democristiana del 1948; gli anni
del centrismo
2 ore
Maggio
Cittadella,
L’INSEGNANTE
_________________________________
MATERIA: FILOSOFIA
DOCENTE: LAURETTA SEMINARA
MONTE ORE PREVISTO: 99
ORE FINO AL 12 MAGGIO: 68
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
In classe, il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso e un gruppo di quattro o cinque alunni ha
dimostrato, con domande e interventi, di avere una certa sensibilità per le questioni affrontate. Il rendimento
risulta diversificato nel modo seguente: il gruppo degli alunni sopra citato ha realizzato un profitto di livello
sicuramente buono e ha messo a frutto discrete capacità di analisi e sintesi; un secondo gruppo, più
numeroso, lavorando con impegno ha superato alcune delle difficoltà iniziali e ha meritatamente raggiunto
un livello di sufficienza; un terzo gruppo, il più ristretto, in alcuni casi per una certa discontinuità
nell’impegno, in altri a causa di numerose assenze, ha con difficoltà raggiunto gli obiettivi minimi.
OBIETTIVI DIDATTICI
Conoscenze: relativamente agli argomenti trattati (si veda tabella dei contenuti disciplinari, che segue), gli
obiettivi minimi assumono la conoscenza del pensiero degli autori almeno nei loro tratti fondamentali.
Competenze: gli obiettivi minimi assumono la capacità di individuare il nucleo problematico degli autori e
quella di confrontare tra loro risposte diverse ad analoghe domande; ancora, l’utilizzo di un lessico adeguato
e quello di argomentazioni semplici e lineari.
Capacità: gli obiettivi minimi consistono nella capacità di analizzare le problematiche filosofiche nei loro
elementi costitutivi, e di saper proporre una sintesi delle diverse visioni del mondo.
METODO
La trattazione degli argomenti è stata affrontata con lezioni frontali svolte per lo più sulla base di schemi
sintetici e strutturati in funzione della esplicitazione dei punti fondamentali degli obiettivi minimi.
Compresenza
L’ora in compresenza con la collega di Scienze Sociali è stata utilizzata con lo scopo di supportare le due
materie. In virtù dell’indirizzo del Liceo, si sono affrontati studiosi particolarmente rilevanti per il loro
contributo alle scienze sociali. Nella tabella dei contenuti disciplinari che afferendo in modo più specifico
all’ambito filosofico sono stati trattati dalla docente di filosofia in queste ore di compresenza con schemi e
letture di passi (anch’essi allegati ai programmi svolti insieme con i testi di filosofia) sono contrassegnati da
un asterisco (*). Per i restanti contenuti svolti si veda la tabella di Scienze Sociali.
MEZZI
Lezioni frontali, schemi (vedi “Metodo”), lettura di fonti. Rispetto all’uso del testo in adozione (Brandolini,
Debernardi, Leggero, Simposio, Laterza, Bari 2005 ) mi sono trovata di fronte ad un problema piuttosto
36
spinoso. Ho rilevato, infatti, delle carenze nell’impostazione generale della trattazione degli autori e svariate
affermazioni che si possono configurare come letture e interpretazioni fortemente anomale (per non dire
errate) rispetto a quei concetti di base che costituiscono gli obiettivi minimi della materia. Ho preferito,
quindi, come spiegato nel punto precedente (Metodo) svolgere sempre in classe il lavoro di spiegazione dei
contenuti, definizioni lessicali, costruzione di mappe concettuali, in modo da ridurre al minimo il lavoro a
casa; nelle spiegazioni ho sempre avuto cura di richiamare e ripetere (a volte anche rispiegando) i concetti e i
contenuti fondamentali delle lezioni precedenti in modo che anche eventuali assenze degli studenti non
pregiudicassero la comprensione delle lezioni. Questa strategia è stata adottata dopo averne esplicitate le
ragioni agli studenti e avendo verificato, insieme a loro, dopo il primo mese di scuola, che era effettivamente
possibile e per loro non di danno ma anzi di aiuto, procedere in questo modo.
Al programma svolto verranno allegati in copia i testi antologici letti durante l’anno.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Strumenti
Verifiche orali e scritte. Si è inoltre tenuto conto, nella valutazione finale, dell’interesse dimostrato, della
partecipazione, degli interventi.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomento sintetico
Kant
Sviluppo analitico
Critica della Ragion pura: la struttura e le finalità dell’opera, le
forme a priori di sensibilità ed intelletto, la rivoluzione
copernicana e l’attività trascendentale, il fenomenismo, il
significato dell’Io penso, le idee della ragione e il destino della
metafisica (13 h) Critica della Ragion pratica: il postulato della
libertà come condizione di possibilità, imperativi categorici e
ipotetici, il formalismo e l’autonomia (3 h); Critica del Giudizio:
il giudizio estetico e il giudizio teleologico (2 h)
Tempi
18 ore
Settembre-OttobreNovembre
Dal Kantismo
all’Idealismo
Il periodo storico; il Romanticismo; il fenomeno come
rappresentazione
2 ore
Dicembre
* Comte e il
Positivismo
Il Positivismo: caratteristiche generali. Comte: la legge dei tre
stadi; la fisica sociale
2 ore
Dicembre
Hegel
I presupposti hegeliani: l’Assoluto è la totalità, il vero è l’intero
(2 h); la dialettica, la ragione e l’intelletto; le parti del sistema (3
h); lo Spirito Soggettivo e lo Spirito Oggettivo: l’eticità, lo Stato
e la filosofia della storia. Lo Spirito Assoluto (5 h)
11 ore
Gennaio-Febbraio
*Freud
La scoperta dell’inconscio e la nascita della psicoanalisi (1 h); la
rimozione e la struttura della psiche – le due topiche (2 h); i
meccanismi del lavoro onirico (1 h)
Il dopo Hegel
L’inevitabile confronto con Hegel e le principali reazioni
1 ora
Marzo
Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione (1 h); il mondo come volontà e i
caratteri della Volontà (1 h); Le vie di liberazione dalla volontà:
l’arte, la compassione e l’ascesi (4 h)
6 ore
Marzo
Destra e Sinistra
hegeliana
L’interpretazione della religione e della politica
1 ora
Aprile
37
4 ore
Febbraio-Marzo
Feuerbach
Le critiche a Hegel; la religione come alienazione
1 ora
Aprile
Durkheim*
La sociologia di Durkheim: i fatti sociali come cose; società
semplici e società complesse: l’anomìa
2 ore
Marx
Marx e i pensatori precedenti (1 h); struttura e sovrastruttura,
ideologia (1 h); il materialismo storico e dialettico (2 h). L’analisi
del capitalismo: merce e valore (1 h); l’alienazione dell’operaio
e la mistificazione della merce (1 h); le contraddizioni del
capitalismo; la società socialista e quella comunista (1 h)
6 ore
Aprile-Maggio
Dopo il 15 Maggio
Nietzsche
Apollineo e dionisiaco
la critica della morale e della
religione
la morte di Dio, l’oltreuomo e
l’eterno ritorno
Cittadella,
L’INSEGNANTE
_____________________________
38
4
ore
Maggio
Materia: Diritto-Economia
Docente: Mastromarino Antonio
classe: 5^ Bso
Libro di testo adottato:
E. Malinverni – B. Tornari “Diritto economia e società.” Ed. Scuola e Azienda
Monte ore di lezione curricolare per l’intero anno scolastico: 66
1. Presentazione della classe
Il giudizio complessivo sulla classe è sufficiente. Il comportamento è stato buono e discreto l’interesse generalmente
dimostrato dagli allievi durante le lezioni; modeste le capacità complessive dimostrate nello studio e nella comprensione
in questa materia. All’interno del giudizio generale si evidenzia un gruppo di 3-4 studenti che ha seguito e studiato con
continuità, ottenendo esiti mediamente buoni, e un secondo gruppo di 6-7 studenti che ha seguito con molta difficoltà.
La maggior parte degli allievi si colloca tra questi due “estremi”, con un rendimento mediamente sufficiente. Per gli
allievi che hanno reso in misura poco soddisfacente, la causa principale è stato un impegno inadeguato.
L’ora in compresenza con l’insegnante di storia ha ovviamente supportato le due materie, in quanto ha trattato la
formazione dell’economia globale con il connesso fenomeno dell’imperialismo, la crisi di Wall Street, aspetti della
teoria e pratica negli stati totalitari, Costituzione Repubblicana e Stato Sociale, che si integrano bene nel programma
disciplinare delle due materie.
Avuto riguardo alle necessità specifiche durante lo svolgimento del programma di diritto ed economia e storia, si è
scelto di impegnare alcune ore di compresenza per attività di recupero in ambedue le materie e di ripasso verso la fine
dell’anno scolastico.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini
di:
CONOSCENZE:
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:
o la nozione di stato e i suoi elementi costitutivi;
o la funzione legislativa;
o la funzione esecutiva;
o la funzione giurisdizionale;
o il ruolo del Presidente della Repubblica;
o la funzione della Corte Costituzionale;
o la contabilizzazione della ricchezza nazionale: il PNL, il RNL, il PIL e i loro caratteri distintivi;
o l’equazione del reddito globale nell’ipotesi di una economia chiusa agli scambi internazionali;
o la funzione del consumo, dell’investimento e del tasso di interesse nell’equilibrio macroeconomico;
o gli aspetti essenziali dell’imperialismo;
o le cause e conseguenze economiche e sociali del crollo della borsa di New York del 1929;
o alcuni elementi essenziali della teoria e della pratica nei regimi totalitari tra le due guerre mondiali;
o i tratti essenziali dello Stato Sociale.
COMPETENZE:
Alla fine dell’ anno scolastico gli alunni sanno spiegare:
ü la centralità del Parlamento nell’Ordinamento Costituzionale;
ü la funzione propulsiva del Governo nell’Ordinamento dello Stato;
ü l’esigenza di indipendenza della Magistratura ai fini dell’imparzialità della sua azione;
ü la funzione di garanzia e di equilibrio costituzionale svolta dal Presidente della Repubblica;
ü le funzioni di salvaguardia della Costituzione e di equilibrio tra i Poteri dello Stato svolta dalla Corte
Costituzionale;
ü la funzione programmatica della Costituzione italiana;
ü i punti essenziali della teoria Keynesiana;
ü gli effetti sul reddito globale di una variazione nelle singole componenti della domanda;
ü la connessione tra distribuzione sperequata del reddito, struttura sociale e imperialismo;
ü la connessione tra teoria economica keynesiana e stato sociale.
CAPACITA’:
v Svolgere semplici processi di analisi e sintesi dei contenuti studiati utilizzando il lessico specifico;
v collocare gli istituti giuridici e i modelli economici studiati nel contesto storico in cui sono si sono affermati;
v applicare le conoscenze acquisite per interpretare aspetti di politica economica reale;
v applicare le conoscenze acquisite in un contesto pluridisciplinare.
PROGRAMMAZIONE SVOLTA
39
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Argomento sintetico
Sviluppo analitico
Tempi
Richiamo alle leggi di domanda e di offerta e all’equilibrio di mercato.
1 ora
Nozioni di teoria
monetaria Keynesiana.
Richiamo dei principali aspetti monetari evidenziati dall’equazione di
Fisher.
Analisi della funzione della domanda di moneta secondo Keynes:
correlazione inversa tra domanda di moneta e tasso di interesse.
La moneta bancaria: il moltiplicatore dei depositi.
Determinazione del tasso di interesse di equilibrio sul mercato monetario.
Politica monetaria: regolazione della quantità di moneta in circolazione e
fissazione del tasso di interesse di equilibrio.
8 ore
La contabilità nazionale.
il PNL, il RNL, il PIL.
l’equazione del reddito globale.
l’analisi del reddito globale.
L’equazione semplificata del reddito nel modello keynesiano.
La funzione di consumo.
La domanda aggregata.
Il moltiplicatore keynesiano.
L’equilibrio tra risparmi e investimenti: un modo alternativo per
rappresentare l’equilibrio sul mercato dei beni.
Investimenti e tasso di interesse.
Correlazione tra mercati del lavoro, delle merci, dei capitali e della moneta
nella teoria keynesiana.
2 ore
o
o
o
o
o
o
o
Nozione di Stato;
Elementi costitutivi dello Stato;
Costituzione italiana;
Le forme di governo repubblicane
La composizione del Parlamento;
L’iter legislativo;
I sistemi elettorali proporzionale e maggioritario.
2 ore
La funzione esecutiva
o
o
La composizione del Governo;
Le funzioni del Governo.
2 ore
La funzione
giurisdizionale
o
o
o
La giurisdizione e i suoi principi.
L’organizzazione della Magistratura.
La sentenza.
2 ore
Il Presidente della
Repubblica nel nostro
ordinamento
o
o
o
Modalità di elezione.
Funzioni.
Responsabilità del Presidente della Repubblica.
2 ore
o
o
o
o
o
Il valore della
produzione nazionale
L’equilibrio
macroeconomico nella
teoria keynesiana.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Stato e forme di
governo
La funzione legislativa
6 ore
3 ore
Totale ore 28
Moduli interdisciplinari con storia (compresenza).
Argomento sintetico
La formazione del
mercato mondiale.
Sviluppo analitico
o
o
o
2^ rivoluzione industriale: innovazione tecnica e sviluppo economico.
1870-1914 formazione di un mercato mondiale e rapporti tra mercato,
industria e finanza.
J. Shumpeter: innovazione e funzione dell’imprenditore nello sviluppo
economico.
40
Tempi
3 ore
Sviluppo economico,
nazionalismo e
imperialismo.
Il crollo della Borsa di
Wall Street: cause ed
effetti.
Lo Stato Autoritario
La Costituzione
Repubblicana.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Teorie sull’imperialismo all’inizio del XX secolo.
Hobson. Nazionalismo e imperialismo: sovrapproduzione, sottoconsumo
e distribuzione del reddito.
La situazione economica europea e mondiale dopo la 1^ G.M.
Keynes: Le conseguenze economiche della pace.
La crisi di Wall Street.
Berle: L’economia sociale del New Deal.
Mussolini: “Il discorso del bivacco”.
La denuncia di G. Matteotti alla Camera.
Il manifesto dei fasci di combattimento.
L’autarchia come politica economica.
Le leggi naziste di Norimberga.
La pianificazione nell’URSS di Stalin: aspetti economici, costi umani.
La costituzione repubblicana e la nascita del nuovo stato sociale.
5 ore
7 ore
5 ore
2 ore
Totale ore 22
Ore effettivamente svolte fino al 13 maggio: 55
Le ore ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla somma di quelle indicate nel prospetto sono state dedicate alla
partecipazione ad attività culturali interdisciplinari di istituto.
Riguardo alle ore di lezioni rimanenti fino alla fine dell’anno scolastico è mio proposito completare il programma con il
seguente argomento:
La Corte
o Composizione e garanzie dei suoi membri.
1 ore
Costituzionale
o Competenze.
o I procedimenti di sindacato di costituzionalità in via principale ed in via
incidentale.
e ripassare gli argomenti già spiegati.
2. Metodi:
La trattazione degli argomenti è stata svolta mediante lezioni frontali, uso di presentazioni in power point, discussioni in
classe e schematizzazioni alla lavagna.
I moduli interdisciplinari con storia sono stati sviluppati mediante analisi di documenti inerenti gli argomenti elencati.
Si è cercato costantemente di evidenziare il legame tra quegli eventi storici e la realtà odierna, e si sono sollecitati gli
allievi ad elaborare ed esporre valutazioni personali.
3. Mezzi:
Oltre al libro di testo, per le parti “Presidente della Repubblica” e “Corte Costituzionale” è stato necessario fare uso di
fotocopie, perche non sono trattate nel testo in adozione. Per tutta la parte economica del programma, allo scopo di
accorpare, dare unitarietà, sintetizzare e semplificare il materiale, è stato necessario ricorrere a testi rielaborati dal
sottoscritto e forniti in fotocopia. Il materiale usato è allegato in fotocopia.
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Data la esiguità del tempo attribuito alla mia materia, la valutazione è consistita principalmente in interrogazioni scritte,
ma si è valutato anche impegno, partecipazione, attenzione, progressi, disposizione al dialogo educativo. Le verifiche
scritte sono state impostate sul modello della tipologia B, prevista dalla normativa riguardante la 3^ prova dell’esame di
stato.
Cittadella, 12/05/2010
prof. Antonio Mastromarino
41
RELAZIONE FINALE
Materia: SCIENZE SOCIALI
DOCENTE: TOMBOLATO GRAZIELLA
anno scolastico 2009/10
classe 5 ASO
Finalità e Apprendimenti
Fin dal primo anno di corso l'indirizzo ha mirato al raggiungimento delle seguenti finalità:
- favorire una maturazione della personalità attraverso una migliore conoscenza di sé ed una
progressiva consapevolezza rispetto alla propria formazione;
- indurre una presa di coscienza della diversità e della disuguaglianza e sviluppare
atteggiamenti di rispetto e d'interesse ed, eventualmente, di intervento;
-
sviluppare una gamma di interessi legati alle discipline;
-
valorizzare il senso del lavoro comune salvaguardando le peculiarità e le differenze;
-
addestrare ad una impostazione multidisciplinare dei problemi e al trasferimento delle
conoscenze teoriche nell'esperienza sociale quotidiana e nello stage.
Lo scopo ultimo è rappresentato, oltre che dal raggiungimento di una reale autonomia da parte degli
studenti, da un autentico interesse per i temi culturali e dell'indirizzo e da una effettiva capacità
d'essere protagonisti.
Obiettivi trasversali e abilità di studio
Fin dal primo anno di corso l'Indirizzo ha curato le abilità di studio legate all'uso e alla produzione
di testi, inoltre ha puntato l'attenzione sia sugli aspetti socio-affettivi sia su quelli cognitivi che sono
fortemente intrecciati nell'atto del conoscere.
Anche durante quest’ultimo anno della scuola secondaria superiore è stato curato l'aspetto della
motivazione, della corretta comunicazione e del coinvolgimento degli studenti sulla base di una
esplicitazione dei criteri di scelta e di metodo da parte dell'insegnante. Inoltre si è cercato di
sviluppare l'aspetto costruttivo e produttivo del pensiero potenziando capacità riorganizzativee
valutative allo scopo di favorire chiarezza e precisione nei confronti del sapere, ma anche elasticità
e prudenza di giudizio. A questo scopo si è rivelata particolarmente utile l'esperienza di stage (e la
rielaborazione delle due esperienze precedenti alla Scuola dell’Infanzia e Primaria) che ha richiesto
una forte capacità osservativa, comunicativa, organizzativa e di iniziativa nel risolvere i problemi.
Obiettivi specifici della disciplina quest’anno sono stati:
- Completare il controllo sul proprio protagonismo per favorire una più ampia apertura verso
l’esterno – autonomia e responsabilità - così da potersi relazionare in modo positivo sia
nell’istituzione scolastica (compagni, professori ecc. ) sia all’esterno ( stage e in tutte le
situazioni che lo hanno richiedono ).
- Consolidare l’atteggiamento riflessivo rispetto al lavoro che si sta svolgendo sapendo che
ogni analisi e rielaborazione personale è da confrontare, accostare ad altre in modo da
possedere mappe di saperi sempre più complesse e articolate.
Il contesto di sfondo
La progettazione delle scienze sociali nell’ultimo anno di corso ha portato a conclusione un
percorso quinquennale che, in modo graduale e ricorsivo, si è proposto di condurre la classe verso
una conoscenza più approfondita del Sé, delle dinamiche relazionali e del ‘mondo’. La gradualità è
stata scandita da un biennio, che aveva come obiettivo principale la costruzione di un abito mentale
aperto e sensibile ai temi del soggetto e della società, e un triennio,che avviava uno studio più
sistematico e attento all’analisi dei processi e dei problemi con il supporto più esplicito dei saperi
disciplinari. Parallelamente la didattica creava occasioni diverse e plurime di crescita autonoma di
42
ogni allievo/a, processi di autonomizzazione dall’insegnante, di responsabilizzazione, ma anche di
ricerca e valorizzazione delle qualità personali, allo scopo di dare ad ognuno/a più occasioni per
esprimere i personali talenti. Per quest’ultimo aspetto lo stage formativo ha rappresentato una
chance strategica.
STAGE CURRICOLARE
Nel corso sperimentale del Liceo di Scienze Sociali, il curriculum di studi prevede nelle classi
terze, quarte e quinte l’attuazione di un periodo di stage obbligatorio.
Le attività svolte durante lo stage hanno permesso agli alunni di confrontarsi con le diverse realtà
ed emergenze sociali del territorio, di affinare le abilità tecnico-pratiche relative alle discipline di
indirizzo, anche in termini di fattiva collaborazione con le agenzie presenti nel Comune e nel
territorio (Asl, ospedale, associazioni di volontariato, terzo settore).
Gli obiettivi specifici hanno riguardato la capacità di interpretare le relazioni sociali avendo
consapevolezza della complessità della persona umana e la capacità di inserirsi in modo attivo con
istituzioni, persone o gruppi, oltre che lo sviluppo e l’incremento di capacità di socializzazione,
progettuali e di orientamento in itinere.
1.
Nella progettazione dello stage formativo si è tenuto conto:
dell’importanza di questa esperienza, così come viene evidenziato nel Piano dell’Offerta
Formativa del nostro Istituto, in cui si afferma che essa “rappresenta il richiamo alla dimensione
pratico-operativa, coniuga il sapere e il fare ovvero le conoscenze e la loro messa in gioco in
settori della realtà sociale, consente all’allievo/a una riflessione su se stesso ovvero sulle proprie
capacità relazionali e lo orienta rispetto alle future scelte di studio e di lavoro”;
della convinzione, espressa dai docenti del Dipartimento di Scienze Sociali, che questa
esperienza debba, ove possibile, differenziarsi durante l’ultimo anno di studio, per offrire agli
alunni/e la possibilità di misurarsi con ambiti diversi della realtà sociale, in base agli studi
compiuti, agli approfondimenti e alle predilezioni personali;
delle possibilità/opportunità offerte dal territorio.
Durante il terzo anno scolastico, gli studenti si sono occupati dell’infanzia attraverso
l’osservazione dei bambini in un setting educativo quale quello delle scuole dell’infanzia ponendo
particolare attenzione agli aspetti relazionali e relativi allo sviluppo socio-affettivo rintracciandovi
le conoscenze di tipo psicopedagogico acquisite.
Nel quarto anno il percorso ha riguardato l’osservazione dei bambini nelle scuole primarie
ponendo particolare attenzione alle metodologie d’insegnamento e alle conoscenze relative allo
sviluppo cognitivo, emotivo, morale, motorio
Nel quinto anno lo sguardo è stato ampliato a situazioni di più vasta portata dell’ambito sociale
nell’ottica dello sviluppo della capacità di lettura della complessità.
Gli studenti hanno potuto così completare, nel corso del triennio, l’esperienza diretta dei vari
livelli di ricerca e dei vari ambiti conoscitivi delle scienze sociali mantenendo una coerenza con le
tematiche affrontate nello studio teorico.
Organizzazione e selezione dei contenuti
I contenuti disciplinari del quinto anno hanno proseguito l’ analisi sistematica su temi e scuole di
pensiero che aiutano a decifrare la contemporaneità. Gli argomenti e gli autori sono stati scelti o
come risposta a problemi emergenti della contemporaneità o come esponenti di soluzioni
contrastive o come produttori di nuove domande.
43
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
MODULO / U. D.
Ore
PSICOLOGIA
INDIVIDUO GRUPPO E SOCIETA’
Il contesto sociale
Che cosa studia la psicologia sociale
L’organizzazione sociale inizia dagli spazi
Le teorie della psicologia sociale
Interazione sociale:comprensione e malintesi
La percezione sociale
Perché facciamo uso di stereotipi
I pregiudizi
Stereotipi e pregiudizi possono alterare i ricordi
Interazione e comunicazione
L’influenza degli altri
L’anomia e i suoi effetti
Gruppo e pressione sociale
Tratti di personalità del conformista
la teoria della dissonanza cognitiva
“sottomissione distruttiva” e indipendenza
I comportamenti collettivi
Comunicazione interpersonale e di massa
Comunicazione verbale e non verbale
La pragmatica della comunicazione: gli assiomi
La comunicazione persuasiva
Comunicazione e mass media
20 ore
Disturbi psichici e devianza
RITARDO MENTALE E PROBLEMI DI ADATTAMENTO
Cause del ritardo mentale
Problemi di adattamento nel bambino con ritardo mentale
Educazione del bambino con ritardo mentale
DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELLA SCRITTURA
Mutismo e disturbi del linguaggio
Dislessia
Il bambino balbuziente
Problemi del mancinismo
DISAGIO PSICHICO NELL’INFANZIA
La depressione nel bambino
Psicosi nell’infanzia
Comportamenti dei bambini affetti da autismo
Le fobie
DISTURBI MENTALI: TEORIE A CONFRONTO
La società e la follia
Organicismo e ambientalismo
I disturbi del comportamento
Scuole di pensiero psicologiche:
Comportamentismo
44
La scuola culturale (Vygotskij)
L’epistemologia genetica (Piaget)
La scuola sistemico-relazionale (Watzlawick)
La teoria freudiana
Visione del film su FREUD “Passioni segrete”
Il Cognitivismo (Bruner)
EDUCAZIONE
30 ore
LE NUOVE FORME DELL’EDUCAZIONE
L’educazione oltre la scuola
La società della conoscenza
La centralità del soggetto nel lifelong learning
L’educazione degli adulti:teoria e metodo
L’educazione tra formazione e terapia
Il ruolo dell’educazione contro il disagio
La malattia mentale
Le regole della società e le scelte dell’individuo
La devianza
La tossicodipendenza
Una popolazione che invecchia
Le nuove terapie educative
Il teatro come forma terapeutica: lo psicodramma
L’EDUCAZIONE NELLA SOCIETA’ MULTICULTURALE
Le società multiculturali: aspetti e problemi
Alle radici della multiculturalità
Il riconoscimento delle culture: dall’uguaglianza alla differenza
La ricchezza della diversità nella società di oggi
Modelli e pratiche dell’educazione interculturale
L’esigenza di una nuova cultura pedagogica
La pedagogia interculturale
Il lessico della pedagogia interculturale
buone pratiche di educazione interculturale
ANTROPOLOGIA
LO SGUARDO ANTROPOLOGICO SUL MONDO CONTEMPORANEO
Il gesto e la parola: l’uomo come essere culturale
Le origini del concetto antropologico di cultura
L’antropologia come scienza della cultura
La cultura in movimento:trasmissione,innovazione, diffusione
Lingua e cultura
Il concetto di cultura nella società globale
Un nuovo concetto di cultura,un nuovo ruolo dell’antropologia
45
20 ore
Etnografia del mondo contemporaneo
Antropologia del quotidiano: dimmi come mangi
L’antropologo e il turista
Metodi e orientamenti dell’antropologia contemporanea
Due orientamenti scientifici. Positivismo e interpretativismo
Il lavoro sul campo: l’osservazione partecipante
Da vicino e da lontano:i popoli studiati oggi dagli antropologi
L’antropologia e le altre scienze sociali
Antropologia e psicologia
Antropologia e sociologia
SOCIOLOGIA
La sociologia di fronte al lavoro
Il lavoro: storia e concetti fondamentali
Una definizione di base
Le parole del lavoro
Teoria e pratica del lavoro nella storia occidentale
Il lavoro nella cultura classica
Il lavoro nel Medioevo cristiano
Umanesimo e calvinismo:la rivalutazione del lavoro
La rivoluzione industriale
Il lavoro salariato
La classe lavoratrice e i suoi problemi
Le trasformazioni del lavoro dipendente
L’organizzazione del lavoro
Adam Smith:la divisione del lavoro
Il Taylorismo
Ford e la catena di montaggio
I limiti del lavoro a basso margine di autonomia
La gestione del fattore umano:il counseling aziendale
Tecnologia e organizzazione del lavoro
Il Toyotismo
Il mondo del lavoro:aspetti e problemi
La merce lavoro e il suo mercato
La ricerca del lavoro: un problema tipico della società industriale
Il mercato del lavoro: lalegge della domanda e dell’offerta
L’atipicità del mercato del lavoro
Come si misura il mercato del lavoro
Il problematico incontro tra domanda e offerta: la disoccupazione
Interpretazioni della disoccupazione: colpa individuale o problema sociale
Le conseguenze della disoccupazione
Il mercato del lavoro in Italia
Il libro bianco di Biagi
Verso un lavoro più flessibile
La sicurezza sul lavoro
Gli infortuni sul lavoro e le “morti bianche”
Le malattie professionali
La normativa più recente
Letture
La funzione dello schiavo secondo Aristotele Aristotele,Politica
46
20 ore
L’alienazione del proletariato industriale Marx,Manoscritti economico-politici
Tra capitale e lavoro: l’organizzazione scientifica del lavoro Taylor
Visione del film In questo mondo libero
Dal dieci maggio le ore settimanali di scienze sociali sono state utilizzate per il
ripasso degli argomenti svolti.
Compresenza con Filosofia:
Durante le ore di compresenza Scienze Sociali- 21 ore
Filosofia, è stato attuato un lavoro di
approfondimento, in particolare si sono
effettuate letture riguardanti i seguenti argomenti
e autori:
Il positivismo e Comte: caratteri generali del
positivismo; la fisica sociale di Comte
Durkheim: la sociologia di Durkheim; i fatti
sociali come cose
Freud: la scoperta dell’inconscio; la nascita della
psicoanalisi; la rimozione e la struttura della
psiche; l’interpretazione del sogno
M.Montessori: Dalla psicologia misuratrice alla
pedagogia modificatrice della personalità. La
concezione educativa: sviluppo psicologico e
autodeterminazione
dell’uomo.
Il
metodo:normalizzazione psichica e sviluppo
sensoriale
Piaget: Biologia e psicologia: nascita e sviluppo
dell’intelligenza. La funzione simbolica:gioco
simbolico, imitazione differita,linguaggio. Lo
sviluppo stadiale. Psicologia e pedagogia: la
costruzione
dell’intelligenza
come
fine
educativo. La presenza
di Piaget nella
pedagogia contemporanea.
J. Bruner:Lo studio delle strategie della mente.
Incontri di Approfondimento
Ruolo
dell’antropologia
nella
contemporanea
società
6 ore
47
Multiculturalità, interculturalità, persona:
modelli a confronto
METODI
Alternanza di lezioni frontali e lezioni interattive, discussioni in classe, ricerche in
biblioteca,ricerche in rete. Analisi di comunicazioni individuali e sociali ; analisi di giornali, riviste,
pubblicità; realizzazione di mappe concettuali.
MEZZI e SPAZI
Libro di testo, articoli di giornali o riviste, registrazioni audio e video, Film, Computer.
A disposizione della commissione una cartellina con documenti e letture non riportate nei manuali
adottati
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
La valutazione si è effettuata in itinere e in conclusione di ogni modulo attraverso colloquiinterrogazione in forma orale e scritta.
In preparazione all’esame di Stato si sono effettuate prove conformi alle tracce degli anni precedenti
e una simulazione di seconda prova.
Per le valutazioni orali e della seconda prova, si sono adottate le seguenti griglie:
vo
to
CONOSCENZA
- dei contenuti
- dei principali
concetti
- della terminologia
specifica di leggi e
principi della
disciplina
COMPETENZA
- applicazione
- espressione
- competenza comunicativa
CAPACITÁ
- comprensione
- analisi
- sintesi
- elaborazione logico-critica -
Conoscenza scarsa rifiuta la prova o
dimostra di ignorare
completamente gli
argomenti.
Applicazione errata - manifesta notevoli difficoltà nell'applicare
le scarse conoscenze.
Espressione scorretta - utilizza un lessico scarno e inadeguato, o
non riesce a esporre gli argomenti, neanche nella forma scritta.
Difficoltà nella relazione - dimostra notevoli difficoltà nel
rapporto con compagni e insegnanti durante le diverse attività
didattiche, e nel cogliere e interpretare adeguatamente i diversi
codici comunicativi; si estranea e si dimostra passivo nei lavori
di gruppo.
Comprensione marginale - non
capisce né a livello lessicale né a
quello contenutistico, la richiesta sul
da farsi.
Analisi confusa - non è in grado,
neppure se guidato di orientarsi e
individuare gli elementi essenziali di
un testo.
Sintesi inconsistente - non sa
cogliere gli elementi fondamentali di
un messaggio orale o scritto.
Elaborazione assente - non ha
autonomia di giudizio.
Conoscenza limitata
- dimostra di
possedere una
conoscenza
lacunosa,
frammentaria e/o
superficiale degli
argomenti.
Applicazione incerta - applica solo in modo incerto, nelle
diverse attività, le conoscenze, le metodologie e i principi logici
della disciplina.
Espressione approssimativa - non utilizza il lessico appropriato
ed espone gli argomenti in modo disorganico, solo se guidato.
Insicurezza - dimostra difficoltà nell'esprimere pienamente e nel
comprendere le istanze proprie e altrui durante le diverse
attività; si attiva solo se guidato e incoraggiato per raggiungere
gli scopi prefissati, anche nelle attività di gruppo.
Comprensione approssimativa capisce in modo parziale ciò che
viene richiesto e non è in grado di
attivarsi correttamente.
Analisi superficiale - sa individuare e
collegare pochi elementi, solo se
guidato.
Sintesi frammentaria - coglie solo
alcuni degli elementi significativi,
ma non sa organizzarli secondo uno
scopo, se non guidato.
Elaborazione confusa - non valuta in
modo adeguato.
1-3
4-5
48
6
7-8
910
Conoscenza
sufficiente dimostra di
possedere una
conoscenza minima
ma adeguata ed
essenziale degli
argomenti.
Applicazione appropriata - dimostra di saper applicare, anche se
in modo semplice e se guidato, i contenuti, i metodi e i
procedimenti appresi.
Espressione chiara - è in grado di esporre, nelle forme orale e
scritta, anche se in modo semplice e lineare, i contenuti appresi
con una certa autonomia e un lessico appropriato.
Comunicazione adeguata - sa come usare e interpretare
sufficientemente i diversi codici comunicativi, anche se in
modo automatico e non sempre consapevole; è in grado di
inserirsi adeguatamente, rispetto alle richieste, nelle attività di
gruppo, manifestando atteggiamenti empatici.
Comprensione corretta - comprende
in modo adeguato la richiesta e sa
valutare come operare, anche se in
modo meccanico.
Analisi essenziale - sa individuare gli
elementi essenziali dei diversi
argomenti, e le loro relazioni.
Sintesi coerente - sa cogliere gli
elementi più significativi di un
argomento semplice e sa collegarli,
anche se in modo elementare,
secondo le indicazioni fornite.
Elaborazione sufficiente - effettua
valutazioni personali se orientato.
Conoscenza
approfondita possiede una
conoscenza
completa e articolata
dei diversi
argomenti.
Applicazione sicura - è in grado di applicare le conoscenze, in
modo corretto e ordinato, nei diversi contesti delle attività
svolte.
Espressione precisa - espone in modo articolato, sia nella forma
orale che in quella scritta, utilizzando una terminologia
appropriata.
Comunicazione efficace - sa come attivarsi per comunicare
efficacemente nei diversi contesti, e per raggiungere gli scopi
prefissati, interpretando in modo corretto i messaggi; è in grado
di interpretare adeguatamente le dinamiche comunicative anche
nelle attività di gruppo, partecipando attivamente e con
interesse.
Comprensione aderente - comprende
in modo corretto e rapidamente una
richiesta complessa ed è in grado di
valutare autonomamente come
operare.
Analisi articolata - sa distinguere, e
cogliere le rispettive relazioni, tra gli
elementi principali e secondari di un
argomento.
Sintesi significativa - sa individuare i
livelli di articolazione di un
argomento anche complesso,
organizzandoli in nuclei significativi
secondo le indicazioni fornite.
Elaborazione aderente - valuta in
modo personale.
Conoscenza rigorosa
- possiede una
conoscenza
completa, coordinata
e approfondita degli
argomenti.
Applicazione autonoma - sa come fare per applicare, anche in
nuove situazioni, contenuti, metodi e procedimenti appresi, con
competenza, precisione e autonomia.
Espressione articolata - sa come esporre in modo sicuro,
organico e articolato, utilizzando un lessico appropriato e
complesso.
Comunicazione sicura - sa come padroneggiare,
consapevolmente, una gamma di intenzioni espressive e di
situazioni interazionali, adeguandole ai diversi contesti, per il
conseguimento delle mete programmate; sa come fare per
interpretare, gestire ed orientare in modo originale le dinamiche
e le attività di gruppo.
Comprensione puntuale - intuisce
rapidamente una richiesta anche
complessa ed è in grado di valutare
in modo autonomo, preciso e
creativo come operare.
Analisi penetrante - è in grado di
distinguere tutti gli elementi di un
argomento complesso, nelle loro
relazioni e articolazioni.
Sintesi originale - sa cogliere i
diversi nuclei più significativi di un
argomento, organizzandoli secondo
uno o più scopi.
Elaborazione sicura - interpreta in
modo critico.
Cittadella 13 maggio 2009
Firma del docente
49
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Matematica Classe 5^ BSo a.s. 2009-2010
Non conoscendo la classe, ho iniziato l’anno col ripasso delle funzioni goniometriche per potermi
rendere conto del livello di preparazione. Resomi conto delle gravi difficoltà e carenze ho deciso di
impostare la programmazione trascurando il formalismo matematico, limitandomi ai concetti
fondamentali e agli aspetti intuitivi. Durante l’anno ho cercato di rivedere alcuni argomenti degli
anni passati, ma essendo il tempo limitato, non sono riuscito a recuperare le conoscenze e
competenze mancanti: solo pochi alunni hanno colmato parte delle lacune e hanno raggiunto una
preparazione soddisfacente.
Indipendentemente dai risultati raggiunti, l’impegno degli studenti è stato disomogeneo: c’e’ chi si è
impegnato durante tutto l’anno sia in classe che nel lavoro a casa, chi ha studiato poco e male solo
in vicinanza delle verifiche non dimostrando effettiva volontà di apprendere e/o recuperare; c’è chi
ha mostrato interesse per gli argomenti svolti e ha acquisito delle competenze, chi si è limitato a una
conoscenza mnemonica superficiale.
Per questi motivi ho cercato di lavorare in classe con molte esercitazioni e discussioni dei problemi
riducendo al minimo i contenuti e il formalismo, trascurando i casi particolari o difficili nella
speranza di fare poco e bene piuttosto che un programma approfondito ma non compreso dalla
classe.
Di seguito sono elencate le conoscenze, competenze e capacità che si è cercato di perseguire ad
inizio anno con un breve commento sui risultati effettivamente raggiunti.
CONOSCENZE
Gli alunni conoscono:
· il concetto di funzione reale di variabile reale e di dominio e codominio della stessa;
· il segno di una funzione e le simmetrie rispetto all’asse y e all’origine;
· il concetto di limite e il suo significato intuitivo;
· il concetto di continuità di una funzione;
· il significato di derivata e della sua interpretazione geometrica.
· il significato di massimo e minimo di una funzione.
· i passi necessari per ottenere il grafico di una funzione.
In realtà le conoscenze non sono sufficienti per la maggior parte della classe e alcuni sono in
difficoltà con i concetti e con le definizioni studiate.
COMPETENZE
Gli alunni sanno:
· calcolare semplici limiti anche nelle forme indeterminate;
· calcolare l’asintoto orizzontale, verticale ed obliquo di una funzione;
· calcolare la derivata di una funzione anche composta;
· calcolare i massimi e minimi di una funzione;
· individuare la concavità o convessità di una funzione;
· calcolare gli integrali immediati;
· calcolare semplici aree con gli integrali.
Parte degli alunni deve essere guidata per portare a termine correttamente gli esercizi proposti
usando consapevolmente le tecniche di calcolo richieste.
50
CAPACITA’
Gli alunni sono in grado di:
· disegnare il grafico di una funzione;
· riconoscere le proprietà di una funzione dal suo grafico;
· individuare le strategie risolutive più opportune;
· utilizzare il linguaggio appropriato della materia;
· rielaborare gli argomenti trattati e fare collegamenti.
Pochi alunni riescono a svolgere i problemi più impegnativi scegliendo strategie efficaci: molti
hanno difficoltà nell'analizzare autonomamente situazioni problematiche e anche il linguaggio
specifico della materia è carente per la maggior parte della classe.
PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA
Modulo / Ore
Periodo
Ripasso di goniometria: angoli e misura, la circonferenza goniometrica, i
radianti; funzioni seno, coseno, tangente e cotangente: grafici e angoli
particolari, formula fondamentale; gli angoli associati, le formule
goniometriche di addizione, sottrazione e duplicazione; le identità e le
equazioni. (Fatti esempi ed esercizi).
Tempo: 9 ore
Funzioni: relazioni e funzioni, dominio e codominio; funzioni reali e loro
classificazione, significato del grafico di una funzione; campo di esistenza
e segno di una funzione; funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti;
funzioni composte. (Esempi ed esercizi con funzioni razionali).
Tempo: 9 ore
Limiti e continuità: intervalli e intorni, concetto intuitivo di limite e
definizione (semplici esercizi); operazioni sui limiti e teorema di
Weierstrass; forme indeterminate; le funzioni continue, i punti di
discontinuità e gli asintoti di una funzione; grafico probabile di una
funzione.
Tempo: 20 ore
Derivate: definizione di derivata e suo significato geometrico, derivata di
una funzione in un punto, retta tangente al grafico di una funzione;
continuità e derivabilità; le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo
delle derivate e regole di derivazione; teoremi sulle funzioni derivabili:
Lagrange e de L’Hospital (con esempi ed esercizi), Rolle e Cauchy (solo
esempi).
Tempo: 15 ore
Settembre – Ottobre
Novembre
Dicembre – Gennaio
Febbraio – Marzo
Studio di funzioni: funzioni reali di variabile reale, massimi e minimi,
concavità e convessità di una curva, flessi a tangente orizzontale e
obliqua; studio completo di una funzione.
Tempo: 15 ore
Aprile
Integrali: integrali indefiniti, proprietà dell’integrale indefinito, integrali
immediati; integrale definito e suo significato geometrico, proprietà
dell’integrale definito, calcolo di un’area nel piano con gli integrali (casi
semplici).
Tempo: 12 ore
Ripasso: le ore rimanenti dopo la stesura del documento.
Maggio – Giugno
N.B. Ho lavorato quasi esclusivamente con funzioni razionali fratte; solo raramente ho mostrato
funzioni irrazionali o con valore assoluto.
51
METODOLOGIE:
·
·
·
·
·
lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare
attenzione alla ricerca e alla scoperta;
esercizi applicativi guidati e individuali;
correzione degli esercizi assegnati che presentano difficoltà;
individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione;
attività di recupero in itinere e/o sportello didattico.
MATERIALI DIDATTICI:
·
testi in adozione :M. Bergamini, A. Trifone : “ I limiti “ e “Le derivate e lo studio di
funzioni” , Casa Editrice Zanichelli.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:
·
·
·
·
interrogazioni scritte relative ad un singolo argomento con esercizi di difficoltà crescente
mirate ad individuare principalmente le conoscenze e le competenze;
verifiche scritte con problemi riguardanti più argomenti mirate ad individuare
principalmente competenze e capacità;
interrogazioni alla lavagna mirate ad individuare le difficoltà degli alunni per poter poi
intervenire con attività di recupero;
verifiche di simulazione “terza prova” esame di stato.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
·
·
·
·
·
verifiche scritte e orali;
formalismo e qualità espositiva;
attenzione e partecipazione in classe;
svolgimento dei compiti a casa;
confronto tra il livello iniziale e il livello finale raggiunto.
Data, 12 maggio 2010
Firma del Docente
Ferrante Domenico
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Fisica Classe 5^ BSo a.s. 2009-2010
La classe ha introdotto la disciplina solo all’ultimo anno di corso e, anche se negli anni precedenti
ha seguito lezioni di scienze naturali, chimica e biologia, l’approccio alla fisica è stato
metodologicamente diverso. Ho cercato di rendere le lezioni il più possibile vicine alle esperienze
di vita quotidiana, ma le scarse conoscenze e competenze matematiche hanno reso difficoltoso lo
svolgimento del programma. Solo pochi alunni hanno dimostrato un reale interesse ed effettiva
volontà di apprendere, discutendo in classe le situazioni problematiche proposte e lavorando con
continuità anche a casa, riportando peraltro buoni risultati. Inoltre lo scarso lavoro domestico e la
sua non continuità per gran parte degli alunni mi ha convinto a far lavorare il più possibile gli alunni
in classe con ampi spazi dedicati alle esercitazioni e discussioni, rendendo comunque l’azione
didattica limitata al minimo indispensabile. Pertanto, in molti casi, gli argomenti trattati hanno
lasciato una conoscenza mnemonica superficiale e solo alcuni studenti hanno acquisito la capacità
di impostare e discutere le situazioni problematiche proposte con un linguaggio appropriato.
52
Di seguito sono elencate le conoscenze, competenze e capacità che si è cercato di perseguire ad
inizio anno con un breve commento finale sui risultati effettivamente raggiunti.
CONOSCENZE
Gli alunni conoscono:
· le unità di misura del sistema internazionale;
· la densità di una sostanza;
· le tipologie di errore;
· le relazioni tra grandezze;
· la notazione scientifica e l’arrotondamento;
· i vettori;
· la legge degli allungamenti elastici;
· i componenti di una forza;
· il dinamometro;
· le definizioni di velocità e accelerazione;
· il moto rettilineo uniforme e il moto uniformemente accelerato;
· il moto di caduta libera dei corpi;
· i tre principi della dinamica;
· il concetto di massa inerziale;
· la forza peso;
· le leggi di Keplero;
· la legge di gravitazione universale;
· la definizione di pressione;
· le leggi di Stevino e Pascal;
· il principio di Archimede.
La maggior parte della classe ha acquisito i concetti più importanti e le definizioni studiate.
COMPETENZE
Gli alunni sanno:
· misurare grandezze fisiche e associare l’errore;
· utilizzare la notazione scientifica;
· distinguere la massa dal peso;
· distinguere le grandezze scalari da quelle vettoriali;
· disegnare e calcolare la risultante di più forze;
· applicare la legge degli allungamenti elastici;
· scomporre una forza;
· calcolare la velocità media e l’accelerazione media;
· ricavare la legge oraria del moto da un grafico;
· applicare i tre principi della dinamica;
· calcolare la pressione di un fluido;
· applicare la legge di Stevino.
Parte degli alunni deve essere guidata per portare a termine correttamente gli esercizi proposti.
CAPACITA’
Gli alunni sono in grado di:
· rappresentare un fenomeno fisico;
· tradurre una relazione tra due grandezze in una tabella;
· risolvere semplici problemi di fisica;
53
·
·
·
individuare le strategie risolutive più opportune;
utilizzare il linguaggio appropriato della materia;
rielaborare gli argomenti trattati e fare collegamenti.
Pochi alunni riescono a svolgere i problemi più impegnativi scegliendo strategie efficaci: molti
hanno difficoltà nell'analizzare autonomamente le situazioni proposte e anche la padronanza del
linguaggio specifico è limitata per la maggior parte della classe.
PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA
Modulo / Ore
Periodo
La misura e le grandezze: le grandezze fisiche, il sistema internazionale,
la misura delle lunghezze, la misura della massa, la densità di una
sostanza, la misura del tempo, la notazione scientifica e
l’arrotondamento; l’incertezza di una misura: il valore medio, l’errore
assoluto, l’errore relativo; le caratteristiche degli strumenti di misura.
Tempo: 8 ore
Settembre – Ottobre
La rappresentazione dei dati: la rappresentazione di un fenomeno, le
tabelle le formule e i grafici, le grandezze direttamente e inversamente
proporzionali, la proporzionalità quadratica.
Tempo: 3 ore
I vettori e le forze: i vettori e gli scalari, la direzione e il verso di uno
spostamento, le operazioni con i vettori (somma, prodotto tra un vettore
e uno scalare), la scomposizione di un vettore, i componenti di un
vettore; le caratteristiche delle forze e la misura, gli effetti delle forze; la
costante elastica della molla, il dinamometro, la forza elastica; le
operazioni sulle forze, la scomposizione di una forza, le componenti di
una forza.
Tempo: 8 ore
La cinematica: il sistema di riferimento, la velocità media e istantanea, il
moto rettilineo uniforme e rappresentazione grafica del moto;
l’accelerazione media e istantanea, il moto uniformemente accelerato e
rappresentazione grafica.
Tempo: 12 ore
Novembre – Dicembre
Gennaio – Febbraio
La dinamica: il primo principio della dinamica, i sistemi inerziali; il
secondo principio della dinamica e la massa inerziale; azione e reazione e
il terzo principio della dinamica; la forza peso e la caduta libera; le leggi
di Keplero, la legge di gravitazione universale, forza esercitata da un
corpo sferico, l’accelerazione di gravità.
Tempo: 12 ore
Marzo – Aprile
I fluidi: la pressione, la legge di Stevino, i vasi comunicanti, il principio di
Pascal, il principio di Archimede.
Tempo: 7 ore
Ripasso: le ore rimanenti dopo la stesura del documento.
Maggio – Giugno
METODOLOGIE:
·
·
·
·
lezione partecipata, mediante dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni con particolare
attenzione alla ricerca e alla scoperta;
semplici esercizi applicativi guidati e individuali;
lavoro di gruppo;
correzione degli esercizi assegnati che presentano difficoltà;
54
·
·
individuazione dei nodi concettuali dell’argomento oggetto di studio e schematizzazione;
attività di recupero in itinere e/o sportello didattico.
MATERIALI DIDATTICI:
·
testi in adozione: G. Ruffo : “ Lezioni di fisica 1“ Casa Editrice Zanichelli.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:
·
·
·
verifiche scritte comprensive di una prima parte con domande a risposta multipla (per
valutare conoscenze e competenze) e di una seconda parte con semplici problemi per
valutare le capacità;
interrogazioni alla lavagna mirate ad individuare le difficoltà degli alunni per poter poi
intervenire con attività di recupero;
verifica di simulazione “terza prova” esame di stato.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
·
·
·
·
verifiche scritte e orali;
formalismo e qualità espositiva;
attenzione e partecipazione in classe;
svolgimento dei compiti a casa.
Data, 12 maggio 2010
Firma del Docente
Ferrante Domenico
55
Presentazione della classe
RELAZIONE FINALE
2009/2010
ANNO SCOLASTICO
Docente: Mendo Daniela
Materia: scienze opzione
Classe:__5 A B sociale
Sono stata la docente di Scienze per l’intero quinquennio e nel triennio ho integrato l’attività curricolare, con una parte
della classe che l’aveva scelto,con altre due ore di scienze opzionale. La classe, mista tra le due dell’indirizzo delle
scienze sociali, ha sempre risposto adeguatamente alle diverse proposte presentate nei vari anni. In quest’ultimo anno
l’insegnamento è stato quello legato al rapporto scienze e società e alle neuroscienze, scelta personale considerato
l’indirizzo. La classe ha seguito sempre con interesse, dimostrato anche dai continui interventi e domande. Il
programma è stato svolto abbastanza fedelmente rispetto a quanto programmato all’inizio dell’anno. La modalità di
lavoro ha, pure, seguito la programmazione. I risultati sono decisamente soddisfacenti, presentando alcune valutazioni
ottime e un certo numero di studenti che si collocano su un livello discreto. Pur non essendo mancate nel corso
dell’anno alcune insufficienze, queste sono state superate con un maggior impegno e con un lavoro domestico più
adeguato.
In relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti i seguenti aspetti formativi:
Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti,
trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando
linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale
In relazione alla programmazione curricolare, si sono conseguiti i seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini
di:
CONOSCENZE
Rapporto bioetica e società
Rapporto scienza e società
Cultura della ricerca
Etica e libertà della scienza
Neurobiologia cellulare
Neuroscienze
Processi di apprendimento
Memoria
Memoria e apprendimento
Emozioni
Mente e cervello
Sonno
COMPETENZE :Comunicare, concettualizzare, problematizzare,
Per comunicare:
codificare
decodificare
per problematizzare:
individuare il problema
prospettare possibili soluzioni
scegliere sulla pluralità di elementi di analisi
per concettualizzare:
riconoscere ( in un fenomeno, problema, modello..) i concetti implicati
distinguere tra fenomeno e concetto
saper generalizzare
CAPACITÀ
Saper comunicare, concettualizzare, problematizzare
CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI
Monte-ore annuale previsto dal curricolo nella classe
Monte ore realizzato al quindici di maggio
Ore
Monte ore preventivato fino alla fine della scuola Ore
Ore 66
47
52
56
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Modulo
organizzato
in
unità
di Competenze disciplinari
apprendimento
(elencate
in
ordine
cronologico)
Rapporto bioetica e società
Sa ripercorrere la storia della bioetica
( h. 5 primo quadrimestre)
Sviluppa la consapevolezza del rapporto problematico che
lega le scoperte scientifiche alle loro applicazioni, da un lato, e
ai risvolti etico-sociali dall'altro
Cultura delle scienze
( h. 5 primo quadrimestre)
Sa analizzare testi scientifici individuandone le tesi, il
percorso argomentativo, il contesto di riferimento
Etica e libertà delle scienze
( h.7 primo quadrimestre)
Sa ricostruire il percorso compiuto e le diverse procedure
adottate
Sa analizzare il problema nella sua complessità
Sa descrivere le differenze tra il neurone e una qualsiasi altra
cellula
Sa descrivere come i neuroni producono stimoli e li
trasmettono
Descriver i campi di ricerca e i livelli di conoscenza indagati
dalla disciplina
Ripercorre le tappe di sviluppo della disciplina
Sa analizzare come l’informazione sensoriale deve essere
ricombinata in modo idoneo con l’attività motoria per
produrre un comportamento adeguato
Sa analizzare testi scientifici individuandone le tesi, il
percorso argomentativo, il contesto di riferimento
Sa descrivere gli studi degli ultimi anni
Riconosce le varie implicazioni di tali studi
Sa descrivere i processi di apprendimento come forma
continua di differenziazione e come mutamento di
comportamento adattativi condizionato dall’informazione
Sa differenziare l’apprendimento associativo da quello non
associativo
Classifica i vari esempi di l’apprendimento associativo
Sa descrivere questa funzione cerebrale complessa come la
capacità di immagazzinare le informazioni scaturite
dall’esperienza e di recuperare gran parte di esse
Descriver la biologia dei ricordi
Sa riportare le fasi principali dello studio delle basi
molecolari della memoria
Sa descrivere come i sentimenti soggettivi e gli stati
fisiologici a essi associati sono aspetti essenziali della normale
esperienza umana
Sa analizzare testi tratti dalla rivista “Mente e cervello “
individuandone le tesi, il percorso argomentativo, il contesto
di riferimento
Sa individuare le differenze a livello di attività cerebrale tra il
sonno e la veglia
Sa spiegare perché gli animali dormono
Neurobiologia cellulare
( h. 7 primo e secondo quadrimestre)
Neuroscienze
( h.8 secondo quadrimestre)
Mente artificiale
( h. 4 secondo quadrimestre)
Processi di apprendimento
( h. 2 secondo quadrimestre)
Memoria ( h. 4 secondo quadrimestre)
Emozioni ( h. 2
secondo quadrimestre)
Attività di ricerca
( h. 5 secondo quadrimestre)
Sonno ( h. 3
secondo quadrimestre)
METODI
Articolazione dell'attività
Fase introduttiva Presentazione dell’argomento
Sistematizzazione
conoscenze
Verifica sommativa
modulo ( 1h)
Strategie e organizzazione sociale del lavoro
Problem posing / brain-storming\ Lavoro individuale
Problematizzazione dell’argomento / lezione frontale\ lezione circolare\
Studio individuale
delle Lavoro individuale / domande individuali
di fine Verifica finale scritta relativa alle unità didattiche che concorrono a completare il
modulo è stata costituita costituita da diverse tipologie di item ( a risposta multipla, a
completamento, esercizi, vero/falso, accoppiamento di termini a definizioni) per una
valutazione veloce dell'apprendimento. Una seconda parte è stata utilizzata per saggi
57
brevi, trattazioni sintetiche anche in vista della terza prova all’esame di stato
È stato riservato uno spazio anche al colloquio orale sotto forma di discussione
guidata dal docente o di riflessione orale su problemi sperimentali e teorici
Sono state attivate strategie diverse, durante la lezione, di recupero per gli studenti
che nel modulo non hanno ottenuto la sufficienza. Sono stati valutati anche e lavori
domestici e/o approfondimenti personali o di gruppo.
Recupero approfondimento
MATERIALI DIDATTICI:
Appunti di lezione
Prodotti multimediali
Articoli e testi scientifici vari
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione finalesi è tenuto conto dei risultati conseguiti dall’alunno, con particolare riguardo:
Ø
Ø
Ø
Ø
agli obiettivi minimi di carattere formativo e contenutistico
alla diligenza e all’impegno, ai progressi conseguiti nel corso dell’anno scolastico
ai prodotti desunti da verifiche scritte, lavori individuali e domestici, produzioni di vario genere
alla capacità di recupero individuale
Griglia di valutazione per le domande aperte
Conoscenza,
completezza
e scorretta, lacunosa e non parziale e
pertinenza delle informazioni
pertinente
approssimativa
35%
0.5
1
Capacità di analisi e sintesi
totalmente carente
poco efficace
25%
0.5
1
Essenziale
2
chiara e abbastanza
approfondita
2.5
Corretta
2
precisa, completa e
pertinente
3.5
puntuale ed efficace
2.5
Coerenza argomentativa
20%
contraddittoria e disorganica
0.5
Corretta
1
approfondita ed organica
2
Correttezza formale ed uso di un
linguaggio specifico
20%
impreciso e non appropriato
0.5
globalmente corretto e
appropriato
1
scorrevole ed appropriato
2
Griglia di valutazione domande chiuse
Conoscenza contenuti(30%)
Punteggio totale complessivo
Comprensione (40%)
70
Cittadella, …………………..
Rielaborazione (30%)
Totale
Punteggio minimo per la sufficienza 40
Firma del Docente
58
/70
RELAZIONE FINALE
DOCENTE: ALESSANDRA LOVISETTO
Materia LATINO (opzionale) Classe 5e Aso e Bso
A.S. 2009 / 2010
Presentazione della classe
Le sei alunne che hanno scelto latino come materia opzionale, nel corso dei due anni in cui ho
insegnato in questo gruppo, hanno sempre dimostrato disponibilità ed interesse nei confronti della
materia.
La partecipazione è stata positiva sia durante le lezioni frontali e dialogiche, sia durante le attività di
ricerca e presentazione di percorsi tematici, approfonditi in piccoli gruppi.
Il profitto complessivo è buono, per alcune più che buono.
Programma svolto
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Le alunne conoscono:
·
le principali nozioni di morfosintassi, con particolare attenzione alla sintassi del periodo
·
alcuni temi, generi, autori, aspetti di civiltà in particolare del periodo dell’Impero
·
il pensiero di alcuni autori latini relativamente ad argomenti svolti in altre discipline e/o collegati al
presente
·
l’uso e l’evoluzione della lingua latina nei secoli in alcuni ambiti specifici
COMPETENZE
Le alunne sanno:
·
con la guida del docente, riconoscere ed analizzare in un testo le principali strutture morfosintattiche
·
individuare e comprendere in un testo parole e frasi-chiave
·
comprendere, con l’ausilio della traduzione svolta assieme all’insegnante, il contenuto di un brano
·
riconoscere in un testo elementi significativi relativi ad aspetti della civiltà latina
·
individuare in un testo caratteristiche tematiche e linguistiche del genere o dell’autore
·
tradurre testi adeguati alle conoscenze linguistiche acquisite rendendoli in lingua italiana corretta
CAPACITÁ
Le alunne sono in grado di:
·
operare semplici confronti tra testi in senso sincronico e diacronico
·
cogliere alcuni dei rapporti esistenti tra aspetti linguistici, letterari e di civiltà latini e italiani
·
esporre oralmente in modo chiaro ed efficace, con corretto impiego del lessico specifico
·
ritrovare linee di continuità e alterità nel rapporto tra presente e passato
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONTENUTI
QUINTILIANO E LA SCUOLA A ROMA
Contestualizzazione: la vita e l’opera di Quintiliano; la scuola a Roma; la crisi
dell’oratoria in età imperiale.
Dall’Institutio oratoria:
· I, 1, 1-8 (in trad.): Come vanno insegnati i primi elementi (fotocopia)
· I, 2, 1-2; I, 2, 3 (in trad.); I, 2, 4-5: È meglio inviare i propri figli in
una scuola pubblica o chiamare un maestro privato a casa?
· I, 2, 18-22: Quintiliano si schiera a favore dell’insegnamento
pubblico: la scuola aiuta a stare “inter multos”
· I, 2, 6-8: I genitori, spesso pessimi esempi per i loro figli, dovrebbero
temere le conseguenze di un’educazione troppo indulgente
· I, 2, 27-28: Le menti dei nostri alunni sono come dei piccoli vasi dal
59
TEMPI
Settembre – Gennaio
24 ore
collo ristretto
· I, 3, 8-9: La ricreazione (in fotocopia)
· II, 4, 10 e 12-14: Anche le correzioni devono adeguarsi alle capacità
del discente
· I, 3, 14-17 (in trad.): Le punizioni (in fotocopia)
· II, 2, 4-8: Le doti di un bravo maestro: l’integrità morale, l’equilibrio,
lo zelo
· II, 3, 7-12, passim: Altre caratteristiche del bravo maestro: la
chiarezza e la preparazione culturale
Approfondimenti lessicali: studente, alunno, scolaro, opus, caligine, opulento,
ambizione, maestro e ministro.
Ricerche di gruppo su percorsi tematici
L’ALTRO, LO STRANIERO
Il lessico; l’antisemitismo nell’antichità; l’evoluzione in epoca crtistiana
Lettura di testi tratti da Cesare, Tacito, Cicerone, Plinio il Giovane
Gennaio – Maggio
28 ore
LE PAURE DELL’INCONSCIO
Horror, magia nera, licantropia e vampirismo nella letteratura e nel folklore
latini; il lessico; lettura di testi di Seneca, Lucano, Orazio, Ovidio, Petronio,
Apuleio, Plinio il Vecchio, Tacito
Le tabellae defixionum
LA SOCIETÀ ROMANA
Aspetti della società romana nei testi di Giovenale, Marziale, Persio
IL LATINO ALLE ELEMENTARI
Ipotesi di presentazione della lingua latina a partire da un percorso lessicale
sugli animali
PERCORSO CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE DOPO IL 15
MAGGIO
IL LATINO NEI SECOLI: percorso storico-lessicale sul permanere del latino
in alcuni ambiti:
Il latino della Chiesa
Il latino lingua della scienza
Il latino nell’italiano
Consolidamento ed ampliamento delle conoscenze della grammatica latina e
delle competenze di:
- riconoscimento delle strutture morfosintattiche
- traduzione
- riconoscimento del lessico chiave e confronto con gli esiti italiani
l’intero a.s.
METODOLOGIE
·
·
·
·
·
·
Lezioni frontali di impostazione e inquadramento dei fenomeni letterari
Lezioni frontali e dialogiche per la lettura e traduzione dei testi in lingua latina, con trattazione
essenziale degli aspetti morfosintattici via via incontrati
Attività guidata di analisi testuale e di confronto e contestualizzazione di autori e testi
Rilevazione a partire dai testi delle caratteristiche tematiche e stilistiche di un autore, di una corrente
o di un movimento letterario
Lettura di pagine di critica letteraria e di articoli di giornale relativi agli argomenti proposti
Elaborazione ed esposizione da parte degli studenti di percorsi tematici
60
MATERIALI DIDATTICI
Manuali in adozione, integrati da fotocopie
Internet
Lavagna
Lavagna luminosa
Computer e videoproiettore (presentazioni ppt)
Dizionari
TIPOLOGIA E NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA
Tipologia
Verifiche orali
Verifiche scritte (semplici traduzioni guidate, commento ed approfondimento dei temi trattati)
Lavori di gruppo
Verifiche
I quadr.: due verifiche orali
II quadr.: una verifica scritta, un lavoro di gruppo
VALUTAZIONE
I criteri per la valutazione si riferiscono a: comprensione e contestualizzazione globale del testo; capacità di
analisi di aspetti specifici (grammaticali, lessicali, tematici…) e di resa in italiano; autonomia e proprietà
nell’esporre.
Per il lavoro di gruppo, oltre ai criteri sopra esposti, si è valutata anche la qualità del materiale reperito e
della rielaborazione della bibliografia e della sitografia utilizzate.
Cittadella,
Prof.ssa Alessandra Lovisetto
61
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia opzionale: Storia dell’Arte Classe 5 BSO a.s. 2009/2010
Prof. Alessandro Donadio
La parte della classe che ha scelto come materia opzionale Storia dell’arte si è dimostra motivata ed
interessata verso la disciplina, disponibile all’ascolto ed al dialogo. Il comportamento è in genere
corretto ed educato. Nel mese di settembre, attraverso le prime lezioni dialogiche, sono state
accertate e implementate le nozioni fondamentali relative alla metodologia specifica con cui
affrontare lo studio della materia. Il programma svolto l’anno precedente permetteva di affrontare
con agilità la prima parete del programma (il Rococò e il Neoclassisicmo), per dare maggior spazio
alla trattazione dell’Ottocento e delle Avanguardie, che risvegliano l’interesse degli studenti.
La partecipazione degli studenti è sempre stata improntata a uno scambio proficuo, cosa che ha reso
le lezioni più dinamiche e interattive, il tutto sostenuto da un buon grado di studio e di critica.
Nella programmazione della disciplina ho inserito approfondimenti anche esterni al libro di testo
quali:
- La cultura giapponese nell’arte dell’Ottocento
- Tamara de Lempicka, una donna fuori dagli schemi
Questi temi e argomenti hanno dato un contributo trasversale alla lettura critica delle opere e, grazie
al continuo esercizio di riconoscimenti, gli studenti hanno migliorato alcune competenze quali
l’individuazione delle tecniche artistiche, dei riferimenti culturali e storici interni ed esterni
all’opera, e delle caratteristiche stilistiche proprie dei diversi movimenti artistici, italiani e stranieri,
pregressi e coesistenti nel medesimo secolo.
Le lezioni sono sempre state tenute con materiale multimediale, con massiccia proiezione di
immagini delle opere e di tutto il materiale iconografico ad esso collegate.
A integrazione ho proposto di visionare a casa dei documentati o della filmografia sia a carattere
biografico che a carattere storico, per rendere più piacevole l’acquisizione del senso storico artistico
dei periodi trattati.
Le prove di verifica, interrogazioni e test, sono state programmate e concordate con gli studenti con
sufficiente anticipo, con chiara definizione degli obiettivi da conseguire, e nella valutazione è stata
rispettata la griglia della disciplina contenuta nel POF.
La classe ha raggiunto un livello buono di conoscenze e competenze, con alcune punte di
eccellenza.
Il vivo interesse per la disciplina è perdurato per tutto l’anno, anche se la materia non è stata inserita
tra quelle inerenti la prova d’esame. Alcuni studenti hanno richiesto la mia partecipazione per
dotare gli approfondimenti per l’esame di maturità di una adeguata parte iconografica inerente
l’argomento prescelto.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZA:
-
Conoscenza specifica di stili, correnti e singole personalità del campo artistico, dal Settecento alla metà del
Novecento.
Conoscenza dei termini essenziali del lessico specifico inerente le espressioni artistiche studiate (pittura, scultura,
architettura), la storia dell’arte e la critica d’arte.
Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione dell’opera d’arte
COMPETENZE:
Esposizione analitica, sintetica e complessiva delle conoscenze inerenti le espressioni artistiche studiate, la storia dell’arte e
la critica d’arte .
- Superamento dell’approccio superficialmente valutativo dell’opera d’arte, dipendente solo:
a) dal livello di apprezzamento estetico personale;
b) da criteri inerenti la verosimiglianza dell’immagine
62
CAPACITA’:
-
Capacità di lettura dell'opera d'arte a più livelli:
descrittivo (saper fornire una descrizione strutturata secondo possibili schemi di lettura con un utilizzo appropriato della
terminologia specifica),
stilistico (saper collocare l’opera in un ambito stilistico, evidenziandone le peculiarità),
contenutistico (saper individuare i significati principali di un'opera d'arte o di un evento artistico),
storico e sociale (saper storicizzare l'opera d'arte analizzata e inserirla nell'appropriato ambito sociale di produzione e di
fruizione),
iconologico (saper riconoscere significati non evidenti dell’opera d’arte sulla base dell’individuazione di una struttura
simbolica o allegorica)
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
Modulo / U.D.
Ore
Il primo Settecento: inquadramento storico generale
F. Juvarra, L. Vanvitelli, G. Tiepolo
Il vedutismo veneto: A. Canaletto, B. Bellotto
La scena di vita: P. Longhi.; il ritratto settecentesco: Rosalba
Carriera
Il Neoclassicismo:
inquadramento storico generale, la vita e le opere di
La riscoperta del mondo classico. G. B. Piranesi, A. Canova
La pittura : J. L. David, F. Goya, D. Ingres
Il Romanticismo: inquadramento storico generale, cenni sulla vita e
sulle opere di
T. Géricault, E. Delacroix, F. Hayez
Approfondimento: I pittori visionari del nord: W. Blake, J.H. Fussli,
C. D. Friedrich
Il Realismo: inquadramento storico generale, cenni sulla vita e sulle
opere di
La nascita della fotografia: Nadar
G. Courbet, F. Millet
Approfondimento: Il giapponismo nell’arte dell’Ottocento
L’Impressionismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere
di
E. Manet,
C. Monet
P. A. Renoir
E. Degas
Il Neoimpressionismo: G. Seurat
Il Postimpressionismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle
opere di
P. Gauguin
V. Van Gogh
P. Cezanne
H. de Toulouse Lautrec
I fenomeni artistici del secondo Ottocento:cenni sui movimenti, sulla
vita e sulle opere dei Macchiaioli: S. Lega, G. Fattori
G. Boldini a Parigi
La Scultura: A. Rodin;
Art Nouveau: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
63
Periodo /ore
2h
1h
1h
Settembre/
Ottobre
2h
2h
3h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
2h
Novembre
Dicembre
1h
2h
2h
1h
Gennaio
1h
1h
1h
1h
1h
Febbraio- Marzo
G. Klimt
Approfondimento: Una donna fuori dagli schemi: Tamara De
Lempicka
Le avanguardie artistiche del Novecento: inquadramento storico
generale
L’Espressionismo: i Fauves e Die Brucke, H. Matisse
Caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
E. Munch, O. Kokoschka, E. Schiele, O. Dix, G. Grosz
Il Cubismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
L’esperienza artistica di Picasso
Il Futurismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
U. Boccioni, A. Sant’Elia, E. Prampolini, G. Dottori:
Approfondimento: La fotografia futurista dei fratelli Bragaglia
Il Dadaismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
M. Duchamp, Man Rey, F. Picabia, La fotografia americana: Alfred
Stieglitz
Il Surrealismo:caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere d i
M. Ernst; J. Mirò; R. Magritte, S. Dalì
L’astrattismo: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
V. Kandinskij; P. Klee
De Stijl: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
P. Mondrian. L’esperienza del Bauhaus
La “Scuola di Parigi”:
M. Chagall, A. Modigliani
La Metafisica: caratteri generali, cenni sulla vita e sulle opere di
G. De Chirico, G. Morandi
L’architettura del Novecento: cenni sulla vita e sulle opere di
Le Corbusier, F. L. Wright
L’arte dopo la Seconda guerra mondiale, cenni sulla vita e sulle
opere di
L’Informale: J. Pollock
La Pop art: A. Warhol
Ultime tendenze nell’arte del XX secolo
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico,
comprese le interrogazioni
Cittadella, ……………
1h
1h
2h
2h
2h
Aprile
1h
2h
1h
2h
Entro il 15
Maggio
1h
1h
2h
1h
Dopo il 15
Maggio
1h
1h
57
Firma del Docente
Alessandro Donadio
Firma dei rappresentanti __________________________________
___________________________________
64
ore
RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2009/20010
DOcente: Roberto Taffara
Materia: Educazione fisica
Classe: 5aBSO
Facendo riferimento alla Parte Pratica del programma svolto, si sono tenuti in
considerazione soprattutto gli aspetti relativi alla formazione sia fisica
(capacità condizionali) che tecnica (didattica delle discipline sportive). Nel
primo caso si è puntato soprattutto allo sviluppo muscolare attraverso lo
svolgimento di esercizi di potenziamento a carico soprattutto del settore
posturale ma anche degli arti inferiori e superiori. Di difficile attuazione (dato
il tempo a disposizione) l’incremento della resistenza organica per la quale si
sono date solo delle indicazioni sulle modalità di allenamento.
Aspetti formativi
Per la Parte Teorica legata alle discipline sportive, si è cercato di approfondire,
per ogni attività, gli aspetti relativi ai regolamenti e al loro rispetto, sia dal
punto di vista strettamente sportivo che paragonandoli alle problematiche
della vita sociale e di dare indicazioni anche sulla didattica dell’insegnamento
delle varie discipline.
La formazione umana atta a cogliere la complessità e le problematiche della
realtà è stata una presenza costante durante tutte le lezioni.
La Parte Teorica non direttamente legata alle discipline sportive e svolta in
funzione dell’Esame di Stato, si è sviluppata in due diversi ambiti:
il primo più strettamente attinente all’attività motoria (meccanismi
bioenergetici, metodologia dell’allenamento, capacità motorie) e allo sport
(storia e organizzazione del CONI);
nel secondo, in cui si è tenuto conto dell’indirizzo scolastico specifico, si sono
trattati temi coerenti con la sociologia dello sport prendendo come filo
conduttore la storia delle Olimpiadi moderne estive con le sue problematiche
e i suoi personaggi.
Di seguito alla Relazione sono elencati più nel dettaglio gli argomenti
affrontati.
Obiettivi di
apprendimento
Gli obiettivi sono stati quelli di far apprendere agli studenti con quali mezzi
potenziare le capacità condizionali e coordinative, come eseguire i gesti tecnici
dei fondamentali individuali degli sport di squadra trattati, come eseguire i
gesti tecnici delle discipline individuali trattate, come eseguire i principali
movimenti sul campo degli sport di squadra trattati.
Nei limiti imposti dal tempo a disposizione, si può dire che gli obiettivi previsti
sono stati raggiunti in maniera abbastanza completa, anche se sarebbe stata
Obiettivi raggiunti
necessaria qualche ora in più per il consolidamento degli apprendimenti
stessi.
65
Contenuti
disciplinari e
scansioni
I contenuti disciplinari elencati nel Programma Consuntivo della materia, sono
stati sviluppati nel corso dell’anno scolastico senza dare a ogni argomento un
periodo di svolgimento particolare. Ogni disciplina e ogni attività sono state
proposte secondo uno schema a rotazione per cui le singole unità didattiche
delle discipline si alternavano di settimana in settimana con lo scopo di
arrivare verso la fine dell’anno senza avere dimenticato le attività svolte
all’inizio.
Il monte ore totale dell’a.s. è stato di 62 ore, quello relativo relativo a ogni
argomento è dettagliato nella parte della relazione che riguarda i contenuto
disciplinari.
Criterio
metodologico
È stato utilizzato sia il metodo d’insegnamento globale che quello analitico con
sistema di correzione sia individuale che collettivo. Talvolta si sono utilizzati
sistemi di osservazione e correzione degli esercizi affidati agli studenti stessi.
Le lezioni sono state svolte, per lo più, in forma dialogica e interattiva con gli
studenti, in modo da stimolare maggiormente la loro attenzione e per un più
attivo coinvolgimento alle lezioni.
Sussidi didattici
Le lezioni si sono svolte prevalentemente in palestra, al coperto. Si sono
utilizzati anche spazi all’aperto in particolare per le lezioni di atletica leggera. I
sussidi didattici utilizzati sono stati quelli tradizionali delle varie discipline,
anche se, talvolta sono stati introdotti attrezzi alternativi.
Durante le lezioni di teoria si sono utilizzati sussidi didattici informatici
(presentazioni in power-point, internet)
Strumenti e
criteri per la
valutazione
La valutazione dello studente è avvenuta attraverso l’osservazione diretta
dei risultati raggiunti e sempre in relazione alla situazione di partenza. In
particolare si è cercato di attuare una valutazione diagnostica per definire la
situazione di partenza di ogni processo di apprendimento. La valutazione
formativa ha accertato i livelli di apprendimento raggiunti in ogni unità di
lavoro ed è stata importante per programmare eventuali modifiche degli
obiettivi preventivati e delle strategie utilizzate.
Di seguito è riportata la griglia di valutazione relativa all’Educazione Fisica
che è stata utilizzata anche per la valutazione delle due simulazioni di terza
prova.
66
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE FISICA
VOTO /10
DESCRITTORE
2
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio
3
Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di
comprensione o incapacità di applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e
numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale.
4
Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di
esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli
argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e orale.
5
Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli argomenti
fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia
nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.
6
Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche
inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati.
Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali
7
Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta.
Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed
applicazione corretta degli argomenti richiesti.
8
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta,
appropriata e personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i
contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli
argomenti richiesti.
9
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta,
appropriata e personale. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche
complesse e di organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni
collegamenti interdisciplinari.
10
Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.
67
CONTENUTI DISCIPLINARI
PARTE PRATICA
1 - Potenziamento fisiologico (8 ore)
miglioramento delle capacità condizionali sia attraverso l’utilizzo di esercitazioni specifiche delle
singole qualità, sia attraverso la pratica sportiva.
2 - Schemi motori (in parti di varie lezioni)
miglioramento delle capacità coordinative attraverso lo sviluppo di schemi motori complessi, di
coordinazioni particolari e di gesti motori propedeutici e collegati all’apprendimento degli
elementi fondamentali individuali delle varie discipline sportive. Giochi e squadre sulla
destrezza ed esercitazioni di ritmo con la funicella individuali, a coppie e di gruppo.
3 - Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico (in parti di
varie lezioni)
organizzazione di giochi di squadra che implichino il rispetto di regole e l'assunzione di ruoli
(“palla-quadrato”, “palla-muro”); l'affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio;
l'organizzazione di giochi tradizionali o popolari e di gruppo.
4 - Conoscenza e pratica delle attività sportive
a - Rugby (6 ore)
perfezionamento dei fondamentali appresi negli anni precedenti: la filosofia del
gioco, il passaggio, la ricezione, il placcaggio, la posizione in campo, i ruoli, l’attacco
e la difesa, la mischia, esercitazioni per il gioco dei “tre quarti”.
b - Pallacanestro (4 ore)
perfezionamento dei fondamentali appresi negli anni precedenti: il palleggio, il “ballhandling”, il passaggio, il tiro piazzato e in corsa (“terzo tempo”), gli arresti, la
posizione in campo, i ruoli, i movimenti principali in fase di gioco, il rimbalzo e il
taglia fuori; il concetto di “transizione”.
c - Softball (3 ore)
passaggio dal gioco propedeutico della “palla-base” al softball; regolamento di
gioco, il lancio e la battuta, le tattiche elementari di difesa
d - Pallavolo (6 ore)
perfezionamento dei fondamentali appresi negli anni precedenti: il palleggio, il
bagher, il servizio, la posizione in campo, i ruoli, i movimenti di prima e seconda
linea, la ricezione, l’attacco e la difesa.
e - Atletica Leggera (8 ore)
descrizione generale del programma gare olimpico: le corse e i concorsi, corse piane
e a ostacoli, di velocità e di mezzofondo, i salti e i lanci;
la corsa: andature tecniche e analisi del gesto (calciata, skip, skip doppio e passo
saltellato)
il salto in alto: ripresa della didattica e salti completi con 7 passi di rincorsa
la corsa a ostacoli: il passaggio dell’ostacolo ed esercizi di ritmo gara
PARTE TEORICA
1 - Aspetti bioenergetici dell’esercizio fisico (3 ore)
a - il meccanismo anaerobico alattacido
b - il meccanismo anaerobico lattacido
68
c - il meccanismo aerobico
d - il modello di prestazione: definizione e utilità
2 - Aspetti generali della Metodologia dell’allenamento (1 ora)
a - il concetto di serie
b - il concetto di ripetuta
c - il concetto di recupero
3 - Le Capacità Motorie (2 ora)
a - capacità coordinative
b - capacità condizionali
4 - Organizzazione dello sport in Italia (1 ora)
a - storia e funzionamento del CONI e delle Federazioni Sportive
5 - Aspetti della Sociologia dello Sport analizzati attraverso la storia dei Giochi Olimpici
Moderni
a - definizione di Sport
b - aspetti generali della storia dello Sport
(4 ore)
c - la nascita dei Giochi Olimpici Moderni
d - effetti dello sport sul comportamento e personaggi particolari (1 ora)
Paavo Nurmi (1920 - 1928)
Johnny Weissmuller (1924)
Emil Zatopek - CEC (1948)
Don Schollander - USA (1964)
e - lo sport come spettacolo (2 ore)
le edizioni dei Parigi 1900 e St. Louis 1904
le gestioni di Montreal 1976, Barcellona 1992 e di Atene 2004
rapporti con gli sponsor
Yao Ming e Liu Xiang - CIN (2008)
f - lo sport e il professionismo e personaggi particolari (3 ore)
il professionismo sportivo
Carlo Airoldi - ITA (1986)
Jim Thorpe - USA (1912)
il “dilettantismo di stato” in Italia (1932)
Jesse Owens - USA (1936)
Laszlo Papp - UNG (1948 - 1956)
Teofilo Stevenson - CUB (1972 - 1980)
il nulla osta del basket (1992)
g - lo sport e il doping e casi particolari (3 ore)
le problematiche legate al doping
Dorando Pietri - ITA (1908)
Francisco Lazaro - POR (1912)
Knud Jensen - DAN (1960)
l’antidoping (1968)
il “doping di stato” nella DDR
Ben Johnson - CAN (1988)
Marion Jones - USA (2000)
Kostantinos Kenteris ed Ekaterini Thanou - GRE (2004)
h - lo sport e i mass media (1 ora)
69
la prima Olimpiade in mondovisione: Tokyo 1964
la regola 5 dello statuto CIO modificata
i - lo sport e la politica (6 ore)
Francia e Germania (1986)
le rivendicazioni di Boemia e Ungheria, Finlandia, Scozia, Galles e Irlanda (1908)
le olimpiadi e le guerre (1916, 1940, 1944)
la torcia olimpica
la Cina e Taiwan
il Sudafrica
l’Olimpiade del Terzo Reich (1936)
Avery Brundage dal 1936 al 1972
la “Guerra Fredda” alle Olimpiadi
il 1948 e la rinuncia dell’URSS
la prima volta dell’URSS (1952)
la storia di Olga Fikotova - UNG e Harold O’Connolly - USA (1956)
le due Germanie (1968)
la Corea del Nord e la Corea del Sud (1988)
la primavera di Praga (1968)
la rivalità tra Ungheria e URSS dopo la repressone a Budapest (1956)
Cassius Clay (Mohamed Alì) - USA (1960)
la strage in Piazza delle Tre Culture e il “Black Power” (1968)
il massacro di Monaco (1972)
i grandi boicottaggi
Montreal 1976
Mosca 1980
Los Angeles 1984
la questione tibetana (2008)
Cittadella, 15 maggio 2010
70
Programma svolto
ANNO SCOLASTICO 2009/2010
Classe: V Bso
DOcente: Steccanella Assunta
Materia: Insegnamento Religione Cattolica
1. Situazione della classe:
La classe è collaborativa e globalmente presenta una discreta propensione all'ascolto e al
dialogo educativo; le lezioni si svolgono in un clima sereno, anche se a volte segnato da una
certa vivacità; la maggior parte degli studenti partecipa attivamente.
2. Obiettivi di apprendimento:
Almeno nelle sue linee maggiori, gli alunni conoscono lo sviluppo del messaggio cristiano nella
storia: fedeltà e contraddizioni della Chiesa e delle Chiese; i valori culturali elaborati dal
cattolicesimo e che fanno parte della tradizione storica del popolo italiano; la proposta cattolica
in merito a temi di particolare rilevanza sociale e i principali aspetti della sua proposta etica.
3. Obiettivi raggiunti:
Gli alunni mostrano di cogliere il valore formativo per la propria persona del confronto
consapevole con la dimensione religiosa; sono in grado, almeno in modo iniziale, di operare una
riflessione critica autonoma in merito al ruolo della religione nella cultura e nella società, in
particolare europea.
4. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:
Monte-ore svolto al 12/05/2010
27/32
Modulo / U.D.
Modulo 1: l’incontro tra le culture
1. Dalla cronaca locale e nazionale: accoglienza o
respingimento?
2. La multiculturalità: difficile e inevitabile. Confronto sulla
situazione socioeconomica dei paesi del primo e del quarto
mondo.
3. L’immigrato in Europa, oggi: alcune situazioni
problematiche.
4. Il discorso del presidente Obama al Cairo.
5. Dalla
multiculturalità
spontanea
all'interculturalità
progettata.
Modulo 2: L'elaborazione del lutto
Modulo 3: Chiesa e società
1. La dottrina sociale della Chiesa: dalla Rerum novarum a
Sollicitudo rei socialis e Caritas in veritate.
2. I principi della dottrina sociale della chiesa: solidarietà,
sussidiarietà, non-violenza.
3. Diritti umani e convenzione dei diritti del bambino.
4. L'enciclica di Benedetto XVI Deus caritas est. Struttura e
contenuti.
5. A partire dalla lettura dei quotidiani: lo scandalo pedofilia
nella Chiesa.
Modulo 4: Il disagio adolescenziale
71
Periodo /ore
Settembre – dicembre
Undici ore
Dicembre
Un'ora
Gennaio-marzo
Sei ore
Aprile
Un'ora
Marzo
Un'ora
Modulo 4: “Venga il Tuo regno”
1. La pace come sogno e come progetto, affidata a ciascuno di
noi.
2. Premi Nobel per la pace: approccio ad alcune figure
significative: Albert Schweitzer, Dag Hammarskjold, Martin
Luther King, Andrej Sacharov, Sadat e Begin, M. Teresa di
Calcutta, Adolfo Pérez Esquivel, Lech Walesa, Desmond
Tutu, Dalai Lama, Michail Gorbacev, Aung San Suu Kyi,
Rigoberta Menchu, Nelson Mandela e F. W. De Klerk,
Shirin Ebadi.
3. Le figure di Benedetto XV e Giovanni XXIII come pontefici
impegnati per la pace nelle vicende storiche del loro tempo.
Ore occupate da Simulazioni prove d'esame
Marzo – maggio
Cinque ore
22/03 un'ora
26/04 un'ora
5. Metodi
Avendo come orizzonte operativo la centralità dello studente, la scelta metodologica privilegiata è
stata quella di intrecciare alle lezioni frontali proposte di tipo esperienziale induttivo, nel tentativo
di provocare gli studenti ad un apprendimento attivo e significativo.
Le tecniche utilizzate consistono in:
1. ricerche di approfondimento svolte in gruppo, esposte e discusse in classe;
2. risposte personali o di gruppo a domande poste dal docente.
3. rilievo conferito all’analisi autonoma dei problemi, attraverso lo stimolo a ricercare letture
ulteriori rispetto all’immediatezza delle percezioni spontanee.
6. Sussidi
Testo adottato: Marinoni G. – Cassinotti C. – Airoldi G., La domanda dell’uomo, Triennio, Marietti
Scuola.
Nel triennio, oltre ai tradizionali strumenti didattici, è stato fatto uso di dispense preparate dal
docente stesso ad integrazione del testo.
Sono stati utilizzati anche degli audiovisivi, sia di carattere didattico sia giornalistico, come
introduzione ai temi di attualità inseriti nella programmazione.
8. Criteri e strumenti di valutazione
La verifica dell'apprendimento di ogni studente è stata fatta attraverso:
1. interventi spontanei di chiarimento degli studenti;
2. domande individuali di ripasso ad inizio lezione;
3. ricerche scritte interdisciplinari ;
I criteri di valutazione si basano:
· sull'attenzione e interesse dimostrati in classe e sugli apporti critici personali;
· sulla partecipazione attiva e creativa al dialogo educativo e alle attività in generale svolte in classe
· sull'impegno e la costanza nel portare avanti gli impegni richiesti per una sufficiente assimilazione
della materia, nonchè il rispetto di valori quali: l'ascolto di chi parla, il rispetto delle idee e delle
opinioni altrui, capacità di collaborare in classe a creare un clima solidale e sereno fra i compagni.
Griglia di valutazione e descrittori:
Non sufficiente: Conoscenze frammentarie, assenza e disturbo nella partecipazione al dialogo
educativo, interesse assente rispetto alla globalità dei contenuti proposti, non ha conseguito le
abilità richieste.
Sufficiente: Conoscenze essenziali, interesse selettivo, alterna partecipazione al dialogo educativo,
impegno discontinuo, insicurezza nell’utilizzo delle abilità richieste.
72
Discreto: Conoscenze globalmente acquisite, interesse costante, partecipazione al dialogo educativo
nella dimensione dell’ascolto, impegno continuo, possiede le abilità richieste in modo
soddisfacente.
Buono: Conoscenze complete, interesse e impegno costanti, partecipazione costruttiva al
dialogo educativo, utilizzo appropriato del linguaggio specifico.
Ottimo: Conoscenze ampie e complete con approfondimenti personali, interesse e impegno
costanti, capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari, partecipazione creativa e propositiva al
dialogo educativo, ottima padronanza del linguaggio specifico.
Cittadella, 30 aprile 2010
Firma del Docente
Assunta Steccanella
73
IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 74 E' STATO
PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE
5^ BSO NELLA SEDUTA DEL 12 maggio 2010
COORDINATORE DI CLASSE PROF. Marina Bernardi
CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA
DOCENTE
FIRME
ITALIANO
INGLESE
FRANCESE
STORIA – FILOSOFIA
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE SOCIALI
MATEMATICA – FISICA
SCIENZE INTEGRATE
LATINO
STORIA DELL’ARTE
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE
FIOR FIORELLA
MARCON NICOLETTA
BERNARDI MARINA
SEMINARA LAURETTA
MASTROMARINO ANTONIO
TOMBOLATO GRAZIELLA
FERRANTE DOMENICO
MENDO DANIELA
LOVISETTO ALESSANDRA
DONADIO ALESSANDRO
TAFFARA ROBERTO
STECCANELLA ASSUNTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALBERTO BORTOLASO
PER PRESA VISIONE DEI PROGRAMMI SVOLTI
I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
CARLESSO ANNA
_______________________________
PILOTTO SARA
_______________________________
74