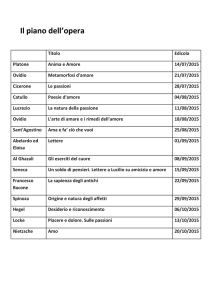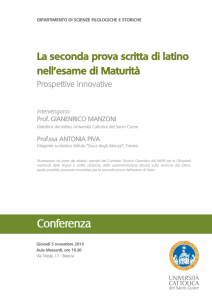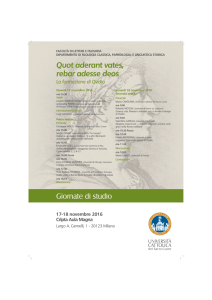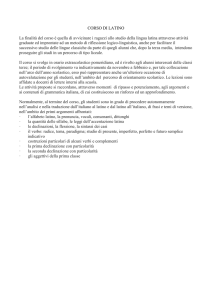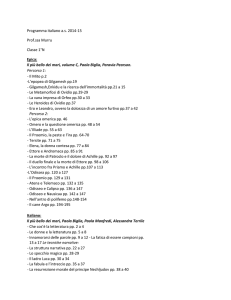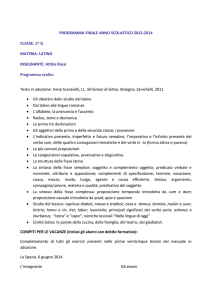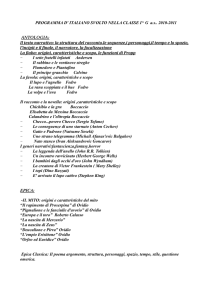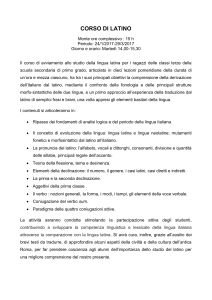METAMORFOSI
Storie sull’origine del mondo
secondo Publio Ovidio Nasone
Locarno, 10 settembre 2015
METAMORFOSI
Storie sull’origine del mondo secondo Publio Ovidio Nasone
perque omnia saecula (...) vivam,
«e per tutti i secoli (...) vivrò»
Publio Ovidio Nasone,
Metamorfosi, (XV, 878-879)
Dobbiamo ammettere che, circa un anno fa, quando abbiamo cominciato a ipotizzare Ovidio e le sue Metamorfosi come protagonisti dell’edizione 2015 di «Piazzaparola», eravamo un po’ scettici. Ovidio,
c’eravamo detti, è stato un grandissimo poeta, ma la sua parabola
umana e sociale (per come è giunta a noi) rende difficile presentarlo a
ragazze e ragazzi di nove o dieci anni. Poco più che cinquantenne, l’imperatore romano Augusto lo mandò via da Roma, la capitale
dell’Impero, a trascorrere gli ultimi anni della sua vita in esilio a Tomi,
una piccola cittadina in riva al Mar Nero, lontano tanti e tanti chilometri dal centro della romanità (oggi si chiama Costanza e si trova in
Romania). Difficile stabilire se la ragione stia dalla parte della corte e
dei suoi intrighi, o da quella dell’uomo. In più Le Metamorfosi, che
sono il suo capolavoro, sono un testo difficile. Pensate: è un poema
epico-mitologico scritto duemila anni fa in latino, quindici libri in versi
che partono dalla descrizione del Chaos e dell’origine del Mondo per
arrivare fino al trionfo di Gaio Giulio Cesare, militare, console, dittatore, oratore e scrittore romano, considerato uno dei personaggi più
importanti e influenti della storia. Non a caso Italo Calvino ha scritto
che «le Metamorfosi vogliono rappresentare l’insieme del raccontabile
tramandato dalla letteratura con tutta la forza d’immagini e di significati che esso convoglia».
Poi, però, col passare delle settimane, abbiamo cominciato ad amare
quest’uomo di 2’000 anni fa, la sua esistenza controversa e avventurosa, e, ciò che più conta, ad appassionarci alle sue Metamorfosi.
Allora, come succede a tutti quando incontrano qualcosa di meraviglioso e avvincente, ci è venuto il desiderio di suscitare anche l’interesse
altrui e di far conoscere ad altre persone la nostra scoperta, affinché
possano emozionarsi come ci siamo emozionati noi, preparando quest’edizione 2015 di «Piazzaparola», dedicata a Publio Ovidio Nasone,
detto Ovidio, e a una delle sue opere più importanti, Le Metamorfosi:
un capolavoro talmente capolavoro, che a venti secoli di distanza lo
leggiamo ancora con interesse e passione.
Questo fascicolo, destinato per lo più alle maestre e ai maestri, intende creare il miglior presupposto affinché l’incontro con lo splendore
delle Metamorfosi ovidiane — un’interpretazione del mondo che ha la
bella età di duemila anni — possa entusiasmare anche le ragazzine e i
ragazzini che frequentano le ultime classi della scuola elementare. Ma
l’incontro con queste storie sull’origine del mondo, scritte con gli occhi
di un antichissimo poeta, può essere l’occasione, volendo, per avvicinarsi più in generale alla storia di Roma antica — dalla sua fondazione
all’espansione di un impero smisurato, fino alla sua decadenza, più di
mill’anni dopo. Naturalmente, in queste pagine incontreremo anche
Ovidio, il nostro protagonista, il sommo poeta, e le sue opere.
Ci sarà un’altra avventura straordinaria da conoscere e avvicinare: la
nascita dell’italiano, la nostra bella lingua, ch’è figlia diretta e legittima
del latino, la lingua di Ovidio e di tanti re, condottieri, imperatori, donne
e uomini potenti o umili, che hanno fatto la storia di Roma e dell’Europa. L’italiano, si dice, è lingua neo-latina, cioè che deriva dal latino (o,
meglio, continua il latino), ch’era la lingua dei romani, la lingua parlata
e scritta di Ovidio e di tanti altri scrittori del suo tempo. Nel mondo vi
sono altre lingue neo-latine, dette anche lingue romanze, quali lo spagnolo, il rumeno, il portoghese e il francese.
Il 10 settembre sarà l’occasione per ascoltare la «voce» di Ovidio,
magari per la prima volta. E, ve lo garantiamo, sarà una incontro del
tutto inatteso, pieno di sorprese che, ne siamo sicuri, vi emozioneranno e vi lasceranno a bocca aperta. Questo quaderno dà a ognuno la
possibilità di prepararsi per bene all’appuntamento — un appuntamento con una persona importante — e, per chi vorrà, di saperne un po’ di
più.
Agosto 2015
Silvia Demartini e Adolfo Tomasini
Un pensiero di gratitudine a Stephanie Grosslercher e all’intero servizio Risorse didattiche, eventi e comunicazione del DFA per la preziosa
e qualificata collaborazione.
2
Nota per gli insegnanti
Come è sempre giusto e doveroso fare, è utile preparare i propri allievi ad affrontare un’attività «speciale», uno di quei momenti che si
potranno riprendere in seguito, ma che non sarà possibile riprodurre
dopo che saranno accaduti. Il discorso vale per un’uscita di studio, per
la visita a una mostra o per assistere a uno spettacolo teatrale. Salvo
poche eccezioni — e, a volte, scelte pedagogiche consapevoli, che ipotizzano i passi successivi — conviene che gli allievi sappiano a cosa
vanno incontro e cosa li aspetta: il che non significa azzerare la possibilità che nascano delle emozioni e delle curiosità. Insomma, non è
necessario rivelare come andrà a finire la storia.
Come preparare gli allievi all’incontro con Ovidio e le sue Metamorfosi,
affinché ne traggano beneficio e possano seguire con profitto le diverse proposte della mattinata? Questo fascicolo propone alcune piste
che saranno utili soprattutto nelle settimane e nei mesi successivi,
qualora l’insegnante volesse partire dagli stimoli di «Piazzaparola» per
scavare sotto la superficie di un mondo che si sarà appena disvelato.
Ma potrà essere utile all’insegnante anche se intende limitare l’incontro con Ovidio a ciò che si ascolterà e si vedrà quel giovedì mattina. In
altre parole, la preparazione all’incontro con Publio Ovidio Nasone
dipenderà almeno in parte dal percorso pedagogico e didattico che si
è scelto.
«Piazzaparola» 2015 si svolgerà in tre momenti distinti. La prima parte,
con tutti gli allievi, proporrà, al Teatro di Locarno, il racconto della
Creazione del mondo, con un accompagnamento musicale composto
espressamente per noi. Seguirà una prima metamorfosi, il racconto di
un mito in un adattamento proposto sul palco da due lettrici.
In seguito le classi si sposteranno, a rotazione, in due luoghi suggestivi: ai giardini «Rusca», davanti alla statua del toro bronzeo donato alla
città di Locarno dallo scultore Remo Rossi (1909-1982), dove Cristina
Zamboni racconterà due miti, che saranno illustrati dall’artista Simona
Meisser; e in Piazza Grande, nel cuore del mercato del giovedì, dove
Sara Giulivi racconterà due altre storie, con l’accompagnamento musicale di Daniele Dell’Agnola.
Le metamorfosi di Ovidio sono una grande raccolta di narrazioni derivanti dalla mitologia greca, che a sua volta le aveva recuperate da storie precedenti. Il poema contiene, legate fra loro in un’unica macro-storia, circa 250 narrazioni mitologiche. Noi ne presenteremo cinque,
oltre alla Creazione, che nell’originale è composta di per sé da almeno
tre o quattro trasformazioni.
Tenuto conto di quanto precede, e tornando all’imperativo iniziale, vi
sono alcuni spunti di partenza che conviene proporre agli allievi, affinché possano avere qualche indizio relativo al contesto che li accoglierà. Publio Ovidio Nasone, per cominciare, è un poeta: dunque, non scri-
3
veva in prosa, mentre i nostri
adattamenti sono in prosa. E
nemmeno scriveva in italiano,
bensì in latino. E cosa c’entra,
allora? Beh, c’è il discorso sull’italiano lingua romanza, e un
accenno, seppur minimo, lo si
può fare. Eppoi siamo in un’epoca lontana: Ovidio nasce nel 43
a. C. e muore nel 18 d. C. È quindi un uomo e un poeta della
prima età imperiale, dominata
da Ottaviano e poi da Tiberio.
Infine, le storie delle Metamorfosi si rifanno alla mitologia greca e romana, coi suoi dei, le sue
dee e le loro regge, le loro vicende appassionanti con animali,
appunto, «mitologici», gli amori,
le guerre, le competizioni. C’è la
dea che, per punizione, vien trasformata in un ragno e quell’altra in una pianta di alloro; e poi
Icaro che s’avvicina troppo al
sole e re Mida che muta in oro
tutto ciò che tocca.
Non è insomma il caso di anticipare dei possibili contenuti di
«Piazzaparola» raccontando storie e descrivendo dei e dee. Ma
sarà certamente utile sapere
che si ascolteranno storie di
migliaia d’anni fa, con personaggi un po’ particolari, quali dei e
dee e ninfe; e luoghi lontanissimi
e un po’ celesti, accanto ad altri
ancor oggi segnati sulle carte
geografiche.
Per tutto il resto, volendo, ci sarà
tempo dopo il 10 settembre.
Breve cronologia della storia romana
DI
LA ROMA DEI RE
Verso la fine dell’ottavo secolo
avanti Cristo le città del Lazio,
come Tarquinia e Veio, cominciarono a provare interesse per una
piccola città che si stava sviluppando sulla riva sinistra del
Tevere, a pochi chilometri dal
mare. Questa città si chiamava
Roma. Era circondata da mura
difensive, che racchiudevano
povere capanne e alcuni ripidi
sentieri che si inerpicavano su
sette colli fitti di boschi, e si
affacciava su una valle paludosa
e infestata dalla malaria.
Gli abitanti di questa città narravano alcune leggende che spiegavano la nascita di Roma.
Queste leggende avevano come
protagonisti i gemelli Romolo e
Remo, discendenti addirittura da
Enea, eroe troiano figlio della
dea Venere, sbarcato nel Lazio
dopo la caduta della sua città.
I gemelli, abbandonati da un loro
zio crudele, erano scampati
miracolosamente alla morte grazie a una lupa che li aveva allattati e a una coppia di pastori che
li aveva allevati. Romolo, diventato un giovane guerriero, aveva
fondato Roma nell’anno 753 a.
C. ed era diventato il suo primo
re. Per i romani quella data era
l’anno Uno della loro storia.
La leggenda narra che a Roma i
re furono sette. In realtà durante
tutto questo periodo furono più
di sette i re che governarono
Roma. L’ultimo di essi, che si
chiamava Tarquinio, fu sopran-
LISA FORNARA
nominato il Superbo perché
governò male. Secondo le leggende, suo figlio Sesto giunse ad
insediare una signora romana di
nome Lucrezia, che, non potendo tollerare la vergogna, si uccise. I romani, che oramai si consideravano capaci di governare da
soli, presero le armi e cacciarono
Tarquinio dalla città.
LA REPUBBLICA ROMANA
Era l’anno 509 a. C., in quella
data i romani abolirono la monarchia e fondarono la Repubblica. Così essi definivano uno
Stato che ha a cuore «la cosa
(res) pubblica», cioè che non ha
a capo un sovrano a vita di cui ci
si può liberare solo attraverso
una rivoluzione, ma è uno Stato i
cui governanti, eletti periodicamente dai cittadini, devono per
legge rendere conto agli elettori
del loro operato. A capo della
4
Repubblica stavano due consoli
che, eletti ogni anno, convocavano le assemblee e comandavano
gli eserciti. L’assemblea romana
più importante era il Senato, che
aveva molti poteri di decisione e
poteva emanare le leggi. Quando
la città di Roma era considerata
in pericolo e quando c’era un’emergenza grave veniva nominato
un dittatore, dotato di poteri
assoluti su tutti i cittadini ma che
poteva governare solo per sei
mesi al massimo.
Sotto la Repubblica, Roma si
espanse notevolmente. L’avversario più importante fu la città
africana di Cartagine, che fu
sconfitta durante le due guerre
puniche. La prima durò più di
vent’anni, tra il 264-241 a.C, e si
combatté quasi esclusivamente
sul mare.
Le navi di Cartagine erano dotate di rostri per speronare le
imbarcazioni nemiche.
I romani inventarono invece uno
strumento che si rivelò straordinariamente efficace: i corvi, cioè
passerelle uncinate che venivano agganciate alla nave nemica
permettendo l’abbordaggio. Grazie a questo sistema Roma riuscì
a battere Cartagine a Milazzo
nella più grande battaglia navale
dell’epoca, combattuta da
150’000 uomini e 480 navi.
Nella seconda guerra punica
(218-202 a. C.), il cartaginese
Annibale attraversò le Alpi per
raggiungere l’Italia e Roma con
degli elefanti. Egli fu però sconfitto e con questa vittoria, Roma
divenne padrona di tutto il
Mediterraneo.
Durante il periodo repubblicano,
numerose altre conquiste furono
fatte da Roma. Le continue guerre e l’occupazione di nuovi territori fecero vivere periodi tumultuosi per la repubblica. Numerose volte essa chiamò i più famosi generali a diventare dittatori
per superare le situazioni più difficili. Questi generali diventavano
cana, che i congiurati avevano
ritenuto l’unica in grado di garantire la libertà dei cittadini. Con
l’uccisione di Cesare, essi speravano di ripristinare la Repubblica. Al contrario, la morte di
Cesare diede avvio ad un altro
grande periodo di guerra civile.
Contro i congiurati si batterono i
generali Marco Antonio e Ottaviano, figlio adottivo di Cesare.
Sconfitti i congiurati, Marco Antonio, amante di Cleopatra, faraone d’Egitto, si pose in conflitto
anche con Ottaviano. Nel 31 a.C
Ottaviano sconfisse Marco Antonio ad Azio. Cleopatra, alla notizia, si suicidò facendosi mordere
da un serpente velenoso.
sempre più potenti, perché potevano avere l’appoggio totale
delle loro grandi armate che essi
pagavano con il bottino delle loro
conquiste. Per questo motivo ci
furono molte guerre civili tra
generali romani. Il più famoso di
questi generali fu Giulio Cesare
che conquistò l’odierna Francia,
chiamata allora Gallia (dal 58
a.C al 50 a.C).
Diventato estremamente potente, Cesare fu proclamato dittatore e imperatore a vita. Con questi
atti, la Repubblica aveva cessato
di esistere. Per questa ragione,
un gruppo di senatori uccise
Cesare in Senato il 15 marzo del
44 a. C. Tra i congiurati vi erano
il figlio adottivo Marco Bruto e
l’amico Crasso.
Proclamandosi dittatore a vita,
Cesare aveva inferto il colpo definitivo alla Costituzione repubbli-
L’IMPERO ROMANO
Nel 27 a. C. Ottaviano chiese dei
poteri eccezionali e assunse il
titolo di Imperatore. Con l’appellativo di Cesare Augusto, Ottaviano divenne capo del territorio
conquistato dai romani. Nel 15
d. C., alla morte di Augusto, gli
successe il figlio Tiberio, dando
inizio alla dinastia imperiale.
L’impero romano, organizzato da
Augusto raggiunse la sua massima espansione nel II secolo d.C
durante i regni di Traiano, Adriano e di Marco Aurelio (morto nel
180 d. C.). Nel secolo successivo
una serie di problemi tra cui la
crisi economica e la pressione
militare dei barbari alle frontiere
indussero l’imperatore Diocleziano a una riforma istituzionale
che divise l’impero in due parti.
Nel 313 l’Imperatore Costantino
concedette ai cristiani la libertà
5
di culto con l’editto di Milano.
Costantino nel 330 trasportò la
capitale dell’impero da Roma a
Bisanzio, che da lui prese allora
il nome di Costantinopoli. La crescente divisione tra le due parti occidentale e orientale - dell’impero ne minò infine l’unità fino
alla scissione del 395: iniziava la
storia
dell’impero
romano
d’Oriente, dal VI secolo chiamato
«bizantino», mentre quello d’Ocdente divenne preda dei barbari.
Nel 476 l’ultimo imperatore,
Romolo Augustolo, fu deposto
dal germanico Odoacre.
L’Impero romano d’Oriente sopravvisse ancora per ben 1000
anni fino al 1453, quando Costantinopoli fu conquistata dai
turchi e assunse il nome di
Istanbul.
L’espansione di Roma sull’arco di 1’200 anni
La città di Roma nel 500 a. C.,
quando governava Lucio
Tarquinio, detto Tarquinio il
Superbo, ultimo re di Roma.
Le conquiste romane dopo la
seconda guerra punica: siamo
più o meno nel 200 a. C., vale a
dire nel III secolo a. C.
Il territorio romano dopo la conquista della Gallia, attorno al
50 a. C.
6
Ecco l’Impero Romano alla morte
di Marco Aurelio e all’ascesa al
trono dell’imperatore
Commodoro (circa nel 180 d. C.).
Nel 313 d. C. gli imperatori
Costantino il Grande e Giovio
Licinio sottoscrivono l’editto di
Milano.
Il 4 settembre 476 venne destituito quello che è considerato
l’ultimo imperatore romano,
Romolo Augusto, conosciuto con
il diminutivo Augustolo, cioè piccolo Augusto.
È l’anno che, per tradizione,
segna l’inizio della seconda
grande epoca della storia europea: il Medioevo.
7
Vivere a Roma: le abitazioni, gli abiti, gli alimenti, il tempo libero
DI
LISA FORNARA
Un’insula, cioè un isolato, a Roma, nei pressi dei
mercati di Traiano.
Non tutti i quartieri di Roma luccicavano di marmi. La popolazione della città e gli alloggi scarseggiavano. Nei quartieri popolari imprenditori di pochi scrupoli
costruivano case di quattro o cinque piani, chiamate insulae
(cioè isole, da cui isolato), destinate ad ospitare molte famiglie
in piccoli appartamenti.
I materiali da costruzione erano
scadenti e i crolli frequentissimi.
Le strutture di legno e l’uso dei
bracieri per il riscaldamento favorivano gli incendi, che la man-
8
canza di acqua corrente, soprattutto nei piani alti, rendeva ancor
più pericolosi. Le case erano
addossate l’una all’altra e il
fuoco si propagava con rapidità
divorando interi quartieri.
Augusto istituì un corpo speciale
di vigili contro il pericolo di incendi e vietò che gli edifici superassero una certa altezza, ma non
sempre la legge è rispettata. Per
di più gli affitti erano altissimi e
le sottili pareti non proteggevano
da rumori molesti.
LE STRADE E I QUARTIERI
Poche strade principali avevano
un nome (la via Sacra, la via
Trionfale, la via Lata), le altre ne
erano prive; le case mancavano
di numeri civici. Perciò non era
facile orientarsi fra vicoli e viuzze. Per trovare un indirizzo bisognava basarsi su punti di riferimento come templi, portici,
negozi…
Nei quartieri stagnava spesso un
odore nauseabondo, prodotto
soprattutto da lavorazioni artigianali (del cuoio, della porpora, dei
detersivi…), e i passanti più delicati si proteggevano con un fiore
o una boccetta di balsami odorosi.
Di giorno la legge vietava il passaggio dei carri, ma per le strade
c’era lo stesso un rumore assordante. Una folla vociante e variopinta di gente indaffarata, di
sfaccendati, stranieri, ciarlatani,
mendicanti ingombrava a tutte le
ore le vie centrali dei fori. Poche
lettighe di ricchi, sorrette da
robusti schiavi, si facevano largo
a stento. I più si spostavano a
piedi.
GLI ABITI
Dall’abbigliamento era possibile
capire chiaramente la posizione sociale
di ciascuno.
L’abito dei cittadini romani
adulti, quando dovevano
mostrarsi in
pubblico, era
la toga, una
grande pezza
di stoffa, tagliata a semicerchio, che
copriva tutto il
corpo fino ai
piedi. Indossare la toga era un’operazione
complessa.
La stoffa poteva raggiungere anche i sei
metri di diametro e, per
accomodarsela addosso,
bisognava ricorrere all’aiuto di uno
schiavo.
La toga di un
cittadino adulto era priva di
decorazioni
ed aveva il colore giallastro della
lana. Quelli che intendevano
farsi eleggere dalle magistrature
facevano sbiancare la stoffa,
forse per essere meglio riconosciuti fra la folla, e dal colore
candido della toga deriva il loro
nome: candidati. I magistrati e i
bambini portavano la toga pretesa orlata di porpora, e i generali
trionfatori ne indossavano una
orlata d’oro.
9
LA TUNICA, LA STOLA,
LE CALZATURE
Sotto la toga i Romani si infilavano la tunica, una sorta di camicia
che lasciava scoperte le gambe
e parte delle cosce ed era stretta
in vita da una cintura. La tunica
era l’abito della plebe e degli
schiavi. Le donne indossavano la
stola, una tunica lunga fino alla
caviglia e su di essa portavano
un mantello simile alla toga ma
con assai meno pieghe, chiamato palla.
Insieme con la toga era d’obbligo
calzare calze chiuse e molto scomode che nascondevano completamente i piedi e stringevano
i polpacci. Naturalmente esistevano anche sandali, ma erano
calzature inadatte per le cerimonie e un cittadino distinto non le
avrebbe mai indossate in pubblico, a meno che non partecipasse ad un banchetto.
I BANCHETTI E I CIBI
Durante i pranzi era ammessa la
più grande libertà di vestiario. Gli
invitati ad un banchetto potevano indossare una comoda tunica
e si portavano da casa i sandali
per calzarli prima di entrare nella
sala da pranzo, il triclinio.
Secondo un’usanza orientale già
nota agli Etruschi e dalla quale
all’inizio le donne erano escluse,
si pranzava sdraiati sui letti.
I cibi si prendevano con le dita e si considerava educato usare
solo le punte per non ungersi
troppo - o un cucchiaio.
Ai Romani piaceva mescolare
gusti contrastanti: si univano ad
esempio pepe e miele o si usava
miele (lo zucchero era sconosciuto) misto ad aceto per condire gli arrosti. Un condimento
molto apprezzato, già noto ai
Cartaginesi, era il gaum, una
sorta di salsa che si otteneva
con carne di pesce mescolata a
sale e ad erbe aromatiche.
Nei banchetti di lusso si faceva
grande consumo di cibi rari e
costosi, manipolati in modo da
renderli irriconoscibili e da stupire in convitati. Ma il banchetto
era un mezzo per conversare e
discutere piacevolmente, per
ascoltare la musica (c’erano i
suonatori di flauto e cetra), per
assistere a mimi e a recite e per
rafforzare i legami tra amici.
Al di fuori dei banchetti la cucina
romana era molto meno elaborata. Del resto essa cambiò più
volte nei secoli. Nella severa età
repubblicana l’alimentazione si
basava sui cereali, le verdure, i
legumi. Per i poveri questi cibi
costituirono sempre la normalità.
LE CASE DEI RICCHI
Esistevano naturalmente anche
case signorili, bellissime e abitate da una sola famiglia. A Roma
se le potevano permettere solo i
cittadini molto ricchi.
Queste case erano costruite con
mattoni o calcestruzzo (impasto
di sabbia, ghiaia, acqua e
cemento), e si componevano di
due parti. La parte anteriore
aveva al suo centro un grande
vano (atrio)n con un’ampia apertura sul soffitto: di qui scendeva
l’acqua piovana, che veniva raccolta in una vasca e sistemata
nello spazio sottostante. Sul
fondo dell’atrio, proprio di fronte
all’entrata, si trovava una grande
sala di soggiorno (tablino), sepa-
rata dall’atrio soltanto da tendaggi. In questa parte della sala
erano esposte le immagini degli
antenati, le opere d’arte, gli oggetti di lusso e altri segni di nobiltà e ricchezza; qui il padrone di
casa riceveva visitatori e clienti,
soci e alleati politici.
La vita privata della famiglia si
svolgeva di solito nella parte
posteriore della casa, raccolta intorno ad un giardino ben curato,
che nelle case più belle era circondato da un portico a colonne
(peristilio) e ornato da statue,
marmi e fontane. La sala da
pranzo o triclinio, si trovava nell’una o nell’altra parte della
casa, spesso in tutte e due.
Come tutti gli ambienti destinati
al ricevimento, i triclini erano lussuosi, con affreschi alle pareti e
mosaici ai pavimenti.
Ricostruzione dello Stadio di Domiziano (oggi Piazza Navona).Vi si svolgevano per lo più gare tra atleti.
10
IL TEMPO LIBERO
Tutti i romani, ricchi e poveri, si
prendevano cura dell’igiene e
del loro corpo. Solo chi era in
lutto poteva vestire abiti stracciati e portare la barba lunga e
mostrare capelli ispidi per
mostrare il suo dolore.
In tutti gli altri casi un romano
doveva essere ben pulito e vestito decorosamente.
Il bagno in casa era un lusso
riservato alle persone ricche, ma
fin dall’età repubblicana esistevano numerosi bagni pubblici.
Più tardi gli imperatori li trasformarono in edifici sfarzosi e monumentali, chiamati terme , e li
adornarono di marmi, specchi,
statue e mosaici.
Il bagno si svolgeva in quattro
momenti. Prima si eseguivano
esercizi ginnici nella palestra
della terme, poi ci si immergeva
in acqua calda, in un ambiente
riscaldato con sistemi avanzatissimi, quindi si faceva un bagno
freddo seguito da una salutare
nuotata in piscina. Infine era la
volta delle frizioni con olio profumato, dei massaggi, della depilazione.
Tutti frequentavano le terme:
uomini e donne, ragazzi e adulti,
poveracci e ricchi magistrati che
sicuramente avevano il bagno in
casa, perfino imperatori con i
loro famigliari.
Non si trattava solo di un fatto
igienico. Oltre che per bagnarsi
alle terme di andava per altri
motivi, come incontrare amici e
clienti, prendere accordi politici,
fare scommesse e pettegolezzi.
All’interno degli stabilimenti era
possibile trascorrere piacevolmente il tempo, passeggiando in
giardini ombrosi, assistendo a
spettacoli, ascoltando musica e
poesia, mangiando e bevendo
alle numerose rivendite.
La visita quotidiana alle terme
era un fatto di costume, che presto si diffuse in tutto il mondo
romano. Dovunque nelle città
dell’impero sorsero stabilimenti
termali e, accanto ad essi, gli
edifici destinati ai giochi e agli
spettacoli, come i teatri e gli anfiteatri.
Gli anfiteatri erano grandi costruzioni a pianta quasi circolare con
al centro lo spazio per gli spettacoli, chiamato arena, e tutt’intorno le gradinate. Il teatro più
famoso era il Colosseo, inaugurato a Roma nel 80 d. C. e capace di contenere circa 45’000
posti a sedere. Vi si svolgevano
soprattutto giochi di gladiatori e
combattimenti di belve. Con speciali congegni era possibile inondare completamente l’arena trasformandola in un lago. Si rap-
Il Colosseo è ancor oggi il più imponente monumento di epoca romana e il più grande anfiteatro del
mondo. Era usato per gli spettacoli dei gladiatori e per e altre manifestazioni pubbliche, che si svolgevano
davanti a un pubblico stimato tra 50 e 75 mila.
tirati da due, quattro e più cavalli.
Generalmente le gare si svolgevano nel Circo Massimo, una
grande pista a forma di U allungata, divisa da un muro nel
senso della lunghezza.
Fina dalla notte precedente allo
spettacolo, gli spettatori si affollavano sulle gradinate, rinunciando al sonno pur di conquistare un buon posto. La passione
sportiva era accesa e le zuffe tra
Il Circo Massimo è un antico circo romano, dedicato in particolare alle corse dei cavalli. L’immagine è
una ricostruzione di come appariva ai tempi dell’imperatore Traiano, attorno all’anno 103.
presentavano allora vere e proprie battaglie navali con l’impiego di grandi imbarcazioni e di
migliaia di gladiatori che si
affrontavano fra l’entusiasmo
del pubblico.
Uno degli spettacoli preferiti dai
romani erano le corse dei carri,
tifosi erano frequenti. Il mestiere
di auriga, cioè di guidatore di
cavalli era rischioso, perché i
carri sbandavano facilmente e si
capovolgevano, soprattutto in
curva. Tuttavia gli aurighi più
bravi guadagnavano cifre favolose e godevano di larghissima
11
popolarità. Non meno famosi
erano i cavalli. Sappiamo di uno,
di nome Incitato, che viveva in
una stalla di marmo, aveva coperte di porpora e schiavi a sua
disposizione. Si racconta perfino
che l’imperatore allora in carica
volesse nominarlo console.
Il circo massimo era la più grande piste del mondo e poteva contenere fino a 300’000 spettatori.
I teatri invece raccoglievano un
pubblico molto meno numeroso.
Si rappresentavano commedie,
tragedie e mimi, ma dall’età
augustea in poi solo gli spettacoli mimici riuscivano a reggere alla concorrenza dei giochi del
circo. Il pubblico partecipava rumorosamente all’azione con
grida, schiamazzi, battute di spirito. Gli attori - tutti maschi fuorché negli spettacoli di mimo non godevano di buona reputazione ed erano privati di alcuni
diritti (ad esempio non potevano
occupare uffici pubblici). Col
tempo la loro condizione migliorò, gli attori di successo diventarono famosi quasi quanto gli
aurighi, e furono anch’essi ricchi
e ricercati.
Perché leggere Ovidio?
Perché affrontare, oggi, questo
autore latino? Qual è il senso di
proporre gli articolati racconti
delle Metamorfosi a ragazzi nati
a duemila anni di distanza? Sono domande legittime, per rispondere alle quali possono essere stimolanti alcune brevi riflessioni introduttive, che proviamo a sintetizzare in tre parole: curiosità, fascino, complessità. Sono tre parole che si possono immaginare collegate da
un filo invisibile: la curiosità dei
bambini, motore primario dell’intelligenza e del desiderio di scoprire, trova nelle storie di Ovidio
molti stimoli e molte risposte; il
fascino è la risposta letteraria
alla curiosità: le storie di Ovidio
piacciono perché sono belle,
perché conquistano e perché
sanno portare il lettore-ascoltatore in altri mondi di immagini
e parole; la complessità è la
chiave che ci permette di provare a decodificare la realtà in cui
siamo immersi: l’opera ovidiana
è complessa e varia, e per questo ci affascina; non è mai banale o monodimensionale, e permette numerosissimi riferimenti
letterari ed extra-letterari.
Per questo e per molto altro vale
la pena di chiudere gli occhi e
ascoltare l’eco della voce del
poeta, liberi da restrizioni di
spazio e di tempo.
Anzi: Eco – maiuscolo! – pensando alla storia della ninfa che
portava questo nome e di cui
Ovidio racconta come mai è rimasta solo la voce. Ci sono parole – letterarie – la cui eco è
talmente potente che nei secoli
si amplifica, arrivando a orecchie lontane, che popolano un
mondo nuovo, ma alle quali
hanno ancora molto da dire.
Quest’eco sarà, ce lo auguriamo, la risposta alle domande dei
bambini e dei ragazzi quando,
mossi dal gusto di risalire
all’indietro alla ricerca di origini
e cause, si chiederanno (ci chie-
deranno): ma questa cosa, questa storia, questa partizione geopolitica, questo modo di dire…
da dove arriva? Spesso arriva,
come intuizione o già definita,
dall’antichità. Le Metamorfosi, il
poema della trasformazione
continua, dall’inizio dei tempi, ci
permettono di intuire, in forma
narrativa, la potenza di questo
legame con l’antico. Un legame
che è, inoltre, profondamente
culturale, nel senso più ricco del
termine: è nell’antichità classica, infatti, e nelle lingue greca e
latina, che pone le sue basi più
solide il sostrato culturale e linguistico che ci appartiene, e che
condividiamo con un numero
troppo spesso dimenticato di
nazioni che si affacciano sul
Mediterraneo e non solo.
Una bella immagine greco-latina
colloca anche noi nella metafora
infinita della traditio lampadis,
la consegna della fiaccola dagli
anziani ai giovani, immagine secondo cui l’umanità progredisce
attraverso un incessante passaggio di testimone. In questo
senso, conoscere il nostro ieri
serve a non farsi trovare sprovvisti di strumenti (critici, culturali) oggi. Per la letteratura che
rende possibile questo passaggio, e per i prosatori e i poeti che
le hanno dato vita, rendendola
patrimonio collettivo, si prestano
alla perfezione le parole di un
grande scrittore da poco scomparso, Sebastiano Vassalli, che,
nel suo libro Amore lontano, ha
scritto:
La poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole.
Vita che vive al di fuori di un
corpo, e quindi anche al di fuori
del tempo. Vita che si paga con
la vita: le storie dei poeti […]
stanno a dimostrarlo.
Ovidio è stato proprio così: un
poeta vero, che ha trovato ispirazione nella sua vita e ha paga12
to la sua arte con la vita; non
perché abbia fatto un unico,
grandioso gesto eroico, ma perché la sua intera esistenza è
stata un mutuo scambio con la
letteratura, giorno dopo giorno.
Storia di un uomo
e di un poeta
Partiamo dal nome, o, meglio,
da una veloce analisi della sequenza dei tria nomina, che in
latino (come, del resto, in molte
lingue antiche e moderne) rappresentava una sintetica “carta
d’identità” della persona: Publio
Ovidio Nasone, in latino Publius
Ovidius Naso. Il praenomen, Publius, cioè il nome proprio, il
nomen (il nome per eccellenza),
che indicava la famiglia (o gens)
d’origine, Ovidius, e, infine, il
cognomen, Naso, che caratterizzava ogni individuo per una specifica caratteristica fisica o caratteriale. Ovidio aveva, dunque,
un naso importante e Naso (Nasone) era una sorta di soprannome, di quelli che ԟ a non voler
essere troppo teneri con le altrui
caratteristiche fisiche o morali ԟ
potremmo usare ancora oggi.
Certo oggi ne faremmo un uso
diverso, ludico e senz’altro non
giuridico, mentre, al contrario,
presso gli antichi romani, dall’e-
tà repubblicana in poi, il cognomen aveva un valore pari a quello del ben più illustre nomen; e
aveva un’utilità in più: serviva a
distinguere gli individui, almeno
quelli di censo superiore. Non a
caso, alcuni dei nostri cognomi
derivano proprio da lì: da qualche avo che si notava fra gli altri
per una caratteristica particolarmente spiccata e dalla sua
discendenza. Lo stesso cognome “Naso” è, tutt’oggi, vitale e
diffuso; non sarà difficile trovare
altri esempi analoghi.
Ma torniamo più precisamente
sulla vita del nostro autore. Noto, oggi, semplicemente come
Ovidio, il poeta nacque a Sulmona, nell’odierno Abruzzo, il
20 marzo del 43 a.C. e morì a
Tomi (oggi Costanza, nell’attuale
Romania) nel 18 d.C.. In realtà,
sulla sua vita si sa poco e
l’unico autentico resoconto che
abbiamo ci arriva dalle sue
stesse parole: quelle di una lunga elegia − cioè una poesia −
autobiografica rivolta ai posteri
(Tristia, IV, 10*, qui riportata in
traduzione nel capitolo che precede la presentazione delle Metamorfosi); accenneremo oltre a
che cosa sono i Tristia, anche se
il nome permette già di anticipare qualche suggestione).
Gli estremi cronologici ci permettono di ricavare una prima
informazione generale: Ovidio
nasce negli ultimi anni della
Roma repubblicana e nel pieno
delle guerre civili che seguirono
l’assassinio di Cesare (alle idi di
marzo del 44 a. C.). Se si considera che nel 27 a. C. viene assegnato a Ottaviano il titolo di
Cesare Augusto, possiamo dire
che Ovidio fu un uomo e un poeta della prima età imperiale. Gli
ultimi e turbolenti anni della sua
vita, dal 14 d. C. in poi, saranno
segnati dalla presenza dell’imperatore Tiberio. Queste brevissime notazioni storiche non
vanno considerate esterne ed
estranee alla sua biografia, perché, in particolare nel suo caso
e in generale per gli uomini di
cultura, il rapporto con il loro
tempo e con la società in cui vivono ha un’influenza determinante sul loro operato.
La famiglia di Ovidio era benestante, appartenente al rango
equestre1. A 12 anni, cioè nel 31
a. C., il padre mandò Ovidio a
Roma insieme al fratello per
completare gli studi di grammatica e retorica, studi che tutti i
giovani di famiglia agiata dovevano praticare: questi, infatti,
avrebbero permesso loro di intraprendere la prestigiosa carriera forense e politica. Ovidio
frequentò le lezioni dei più illustri maestri attivi nella capitale,
in particolare Marco Arellio Fusco e Porcio Latrone, e, più tardi, andò ad Atene, patria natale
dell’arte oratoria, per approfondire le sue conoscenze ed esercitare le sue capacità; durante il
viaggio di ritorno visitò numerose le città dell’Asia minore. Da
ormai un secolo circa, questo
viaggio formativo era un costume diffuso tra i ragazzi di buona
famiglia, un po’ come sarà il
grand tour e, in tempi assai recenti, le vacanze studio per imparare una lingua straniera,
l’anno scolastico all’estero o
l’Erasmus; insomma, a guardare
con attenzione ed evitando superficiali approssimazioni, ci sono analogie fra tutte le epoche.
Rientrato in patria, Ovidio capì
che la retorica, il foro e la politica non erano il suo mestiere: i
suoi interessi erano letterari,
così come le sue attitudini. Provò a intraprende la carriera
pubblica, ma non si distinse per
impegno o risultati particolari;
decise, dunque, di scontentare il
padre per provare a diventare
1
L’ordine equestre, nella Roma del tempo di Ovidio, si distingueva dai patrizi e
dalla plebe. Nella Roma antica, questa
classe sociale era formata dai cittadini
sufficientemente ricchi da possedere un
cavallo ed entrare, perciò, nella cavalleria; solo in seguito, questa divisione
dell’esercito diventò una classe di censo
e con caratteristiche specifiche (privilegi
e ricchezze che li distinguevano dalla
plebe, e l’accesso a specifiche professioni, una fra tutte gli esattori delle tasse).
13
ciò che davvero voleva: un poeta. Ai tempi era meno complicato di oggi fare di quest’arte una
professione, e viverne, ma era
comunque una carriera molto
più incerta e rischiosa del
cursus previsto per un giovane
di buona famiglia. Da ultimo,
un’informazione personale. Ovidio ebbe tre mogli: dopo due
matrimoni sfortunati (da uno dei
quali ebbe una figlia), sposò una
fanciulla della gens Fabia, che
amò profondamente sino alla
fine dei suoi giorni, lontano da
Roma.
Un poeta ribelle, cantore
dell’amore e del sogno
Destinato dalla famiglia alla carriera forense e politica, Ovidio
provò sin da giovanissimo una
spiccata inclinazione verso la
letteratura e la poesia: tutto ciò
che gli riusciva di esprimere bene era in versi (lo scrisse egli
stesso nell’elegia prima citata:
“quod temptabam dicere versus
erat”). Per seguire questa sua
inclinazione, contrariamente al
fratello e ribellandosi alla volontà di suo padre, si dedicò agli
studi letterari.
Le sue opere ebbero da subito
un notevole successo, cosa che
gli permise di entrare a far parte
dell’importante circolo letterario
romano di Messalla Corvino e di
conoscere molti illustri poeti, fra
i quali, ad esempio, Orazio e i
poeti elegiaci Properzio e Gallo,
che erano i principali autori di
poesie amorose del tempo (Virgilio, invece, lo conobbe appena). Anche Ovidio è stato, in
numerosi suoi testi, poeta galante, cantore di una Roma che,
dopo i difficili anni della guerra
civile, aveva voglia di vivere, di
gioire, di gustare la vita e la pace con leggerezza, cedendo al
lusso (in controtendenza coi
programmi di restaurazione dei
costumi morali promossi da Augusto). Ovidio ha saputo offrire a
questa società la letteratura che
cercava, una letteratura che ne
rifletteva i gusti e i comportamenti, e, perciò, ebbe un successo strepitoso. Tra le sue opere, molte sono di carattere giocoso-amoroso, come gli Amores
(tre libri di elegie in cui il poeta
canta il suo amore per Corinna e
per altre donne, e in cui sono
narrate le frivole avventure galanti dell’alta società romana), le
Heroides (ventuno lettere d’amore immaginarie, scritte da
donne della mitologia antica ai
loro amanti), l’Ars Amatoria (un
trattato che spiega che cosa fare per conquistare l’amore delle
donne: un autentico codice della
seduzione, gaudente, esplicito e
dettagliato, in netto contrasto
coi rigidi dettami morali promulgati da Augusto), i Remedia Amores (l’ “anti” Ars amatoria: un
libro che spiega come evitare
l’amore e in che modo liberarsene nel caso ci si innamori); da
ultimo, possiamo ricordare l’incompiuto Medicamina faciei:
circa 100 versi dedicati ai cosmetici femminili.
Apparentemente frivoli e superficiali, questi testi, scritti in metro elegante e impeccabile (distici elegiaci), ricchi di riferimenti storico-mitologici e astutamente ammiccanti, esprimono una
voce acuta, libera e moderna.
Non solo propagano leggerezza
e lodano il progresso, ma inneggiano con maestria al mondo
femminile e alla libertà in modo
non comune all’epoca delle severe disposizioni di Augusto, che
nel 18 a. C. aveva promulgato
leggi severe sui costumi (una in
particolare era de pudicitia, cioè
dettava le norme sugli adulteri e
sul comportamento sessuale in
generale). Altri poeti, quelli legati al circolo di Mecenate, avevano il compito di propagandare la
Roma augustea: Orazio, che faceva divertire con ironia, ma
sempre entro i limiti; Virgilio, che
celebrava la stirpe di Augusto
esaltandone le origini direttamente collegate a Enea. Ovidio
no: preferiva la libertà, e il prezzo che questa gli costò fu alto.
Una fine misteriosa:
l’allontanamento da Roma al
Mar Nero
Nell’8 d.C., con una procedura
eccezionale e istantanea, Ovidio
venne confinato da Augusto a
Tomi, sul Mar Nero, lontano dalla capitale e dai suoi cari, verso i
confini del mondo latino. A tutti
gli effetti si trattò di una relegatio, che, a differenza dell’exilium, non prevedeva la perdita
dei diritti di cittadino e la confisca dei beni; eppure, nonostante le suppliche sue, della moglie
e degli amici, rimase lì fino alla
morte, avvenuta nel 18 d.C. Sulle autentiche ragioni dell’esilio,
è calato, sin dall’antichità, un
silenzio inspiegabile e impenetrabile, e la parabola umana di
Ovidio è ancora oggi un mistero
sul quale si possono solo avanzare delle congetture a partire
dalle testimonianze pervenuteci:
la più probabile è che Ovidio sia
stato, in maniera più o meno volontaria, complice, partecipe o
magari testimone di qualche
scandalo che coinvolse la famiglia imperiale (forse l’adulterio
di Giulia Minore, nipote di Augusto, che fu esiliata nello stesso
anno). Secondo le vaghe parole
di Ovidio stesso nel secondo libro dei Tristia, “carmen et error”
furono le cause del suo allontanamento, cioè la pubblicazione
della troppo audace Ars amatoria e uno sbaglio (suo? Altrui?
Non possiamo dirlo).
In esilio il poeta scrive i cinque
libri dei Tristia, cioè una cinquantina di elegie redatte con
visibile disperazione tra l’8 e il
12 d.C.: dobbiamo immaginare
Ovidio, cantore e fruitore del
lusso, vivere solo, in un paese
sconosciuto, circondato da barbari che parlavano una lingua
incomprensibile. Erano i Geti,
che per i romani rappresentavano l’espressione estrema della
14
rozzezza e dell’incultura, relegati
con loro alla fine del mondo noto. Nei Tristia Ovidio racconta
l’ultima sera a Roma, con parole
drammatiche:
Quando mi torna in mente la visione tristissima di quella notte,
delle ultime ore che passai a
Roma, quando ripenso a quella
notte in cui lasciai i miei affetti,
ancora adesso mi si riga il viso
di lacrime. Si era quasi levato il
giorno in cui per ordine di Augusto dovevo allontanarmi dagli
estremi confini d’Italia. [...] Ero
attonito come quando una persona colpita dalla folgore resta
viva e non si rende conto d’esserlo.
A quell’epoca, un viaggio come
quello che Ovidio doveva compiere, solo, verso il mistero, era
un addio alla vita. Il poeta ricorda (e ci tramanda) anche le ultime parole che gli disse Fabia,
sua moglie, alla quale non cesserà mai di scrivere da Tomi:
“Non ti possono strappare a me.
Partiremo insieme, sì, insieme.
Ti seguirò, moglie in esilio di un
uomo in esilio. Anche per me c’è
un viaggio, anche per me c’è un
posto nella terra ai confini del
mondo: non sarò un gran carico
in più per la tua nave di fuggiasco”. Ma niente da fare: Ovidio
partì senza compagnia, per ordine imperiale, e morì da solo, in
esilio, dieci anni dopo, nonostante le ripetute suppliche a
Ottaviano Augusto e, poi, al suo
successore Tiberio. Del suo periodo sul Mar Nero ci restano
anche le Epistulae ex Ponto: un
epistolario che comprende lettere in forma di elegia ad amici e
parenti.
Ovidio secondo Ovidio
* TRISTIA, IV, 10.
In questa lunga poesia Ovidio
narra ai posteri l’intera storia
della sua vita, secondo il suo
punto di vista, dalla nascita al
sofferto esilio da Roma. Il testo è complesso e raffinato –
secondo lo stile ricercato e
curato tipico del poeta −, ricco
di riferimenti a personaggi, usi
e costumi del tempo, e a tutto
l’immaginario di divinità e
ambientazioni legate all’arte
della poesia (le Muse, il Monte Elicona); tuttavia, non occorre avere presenti con chiarezza tutti i riferimenti per gustare appieno un testo che
racconta la vita di un uomo
che ha vissuto con pienezza e
intensità, scegliendo e soffrendo con coraggio, caparbietà e un briciolo di sfrontatezza, sin dalla più giovane
età.
Chi io fossi, il noto cantore di teneri amori,
ascolta, per apprenderlo, posterità che mi leggi.
Mi è patria Sulmona ricchissima di gelide onde,
che dista nove volte dieci miglia da Roma.
Qui fui dato alla luce, e perché tu sappia la data,
fu quando con pari destino caddero i due consoli.
Se vale qualcosa, antico erede dell’ordine fin dai lontani
proavi, divenni cavaliere non per dono recente della fortuna.
Non fui il primogenito, ma fui generato dopo un fratello
che era nato quattro volte tre mesi prima di me.
La medesima stella vide la nascita di entrambi
e un unico giorno veniva celebrato con due focacce:
è quello, dei cinque giorni di festa dell’armigera Minerva,
che primo diviene cruento per le battaglie dell’arena.
Subito ancor teneri veniamo istruiti e per la premura del padre
frequentiamo i maestri celebri in Roma per la loro arte.
Il fratello fin dalla verde età tendeva all’eloquenza,
nato per le grandi schermaglie oratorie del foro.
Ma a me fin da ragazzo piaceva coltivare le cose celesti
e segretamente la Musa mi conduceva al suo ministero.
Spesso il padre mi diceva: «Perché tenti uno studio inutile?
Il Meonide stesso non ha lasciato alcuna fortuna.»
Ero scosso dalle sue parole e lasciato del tutto l’Elicona
provavo a scrivere parole libere dal ritmo.
Spontaneamente un carme si formava nei metri appropriati,
e ciò che tentavo di scrivere erano versi.
Intanto con tacito passo via scorrevano gli anni
e il fratello e io prendemmo la toga più libera,
e ci ricopre le spalle la porpora col laticlavio
ma la nostra inclinazione rimane quella di prima.
Già mio fratello aveva raddoppiato dieci anni di vita,
quando morì, e io cominciai a essere privo di una parte di me.
Ricoprii le prime cariche dell’età giovanile
e una volta fui uno dei triunviri.
Restava la curia: ma io restrinsi la striscia di porpora.
Quello era un fardello troppo grande per le mie forze;
né il corpo sopportava né la mente era adatta alla fatica
e io rifuggivo dagli affanni dei pubblici onori;
e le sorelle Aonie mi allettavano a cercare i tranquilli
ozi letterari, quelli che il mio intimo ha sempre amati.
Coltivai e adorai i poeti di quel tempo, e quanti vati
erano con me, tanti dèi ritenevo che mi fossero accanto.
Spesso mi lesse i suoi uccelli, più anziano di me, Macro,
e i serpenti che nuocciono e le erbe che giovano;
spesso era solito recitarmi i suoi amori Properzio
in virtù dell’amicizia che a me lo legava;
Pontico celebre per i versi eroici e Basso per i giambi
furono parte diletta della mia cerchia di amici,
e affascinò le mie orecchie Orazio ricco di ritmi,
mentre toccava sulla lira ausonia carmi di dotta fattura.
Virgilio lo vidi soltanto, né l'avaro destino
concesse tempo a Tibullo per la mia amicizia.
Egli successe a te, o Gallo, Properzio a lui,
quarto dopo questi fui io stesso in ordine di tempo.
E come io venerai i più anziani di me, così venerarono
15
me i più giovani, e non tardò a divenir nota la mia Talia.
Quando lessi per la prima volta al popolo i miei carmi
giovanili, la barba mi era stata tagliata una o due volte.
Aveva mosso il mio genio, da me cantata per tutta la città,
Corinna, così chiamata da me con nome non vero.
Ho scritto senza dubbio molto, ma le cose che ho giudicato
non buone le ho date io stesso da correggere alle fiamme.
E anche sul punto di fuggire bruciai certe cose che sarebbero
piaciute, adirato con la mia passione e con i miei carmi.
Tenero e non inespugnabile ai dardi di Cupido
era il mio cuore e un niente bastava a commuoverlo.
Tuttavia pur essendo io tale e accendendomi alla più piccola
fiamma, sotto il mio nome non corse nessuna diceria.
Quasi ragazzo mi fu data una moglie né degna
né utile, che per breve tempo rimase mia sposa;
a lei successe una sposa che, sebbene senza colpa,
non avrebbe diviso tuttavia per sempre il mio letto;
l’ultima, che è rimasta con me fino agli anni avanzati,
sopportò di essere la consorte di un marito esiliato.
Mia figlia, due volte madre nella prima giovinezza,
ma non da un solo marito, mi fece nonno.
E intanto mio padre aveva compiuto il suo destino
e a nove lustri aveva aggiunto altri nove lustri.
Lo piansi non diversamente da come avrebbe egli pianto
me stesso defunto. Resi poco dopo le dovute onoranze alla madre.
Felici ambedue e sepolti nel momento opportuno,
poiché morirono avanti il giorno della mia condanna!
Felice me pure, che sono esiliato quando essi
non sono più in vita e non hanno sofferto per me!
Se tuttavia agli estinti qualche cosa oltre il nome
rimane e una gracile ombra scampa al rogo eretto,
se notizia vi è giunta di me, o ombre dei miei genitori,
e nel foro stigio si parla della mia colpa,
sappiate, vi prego, − né potrei ingannarvi − che la causa
del mio esilio è un errore, non un delitto.
Questo basta per i Mani! A voi torno, o cuori
che desiderate sapere le vicende della mia vita.
Già la canizie, fuggiti via gli anni migliori,
era giunta a mescolarsi alle mie chiome di un tempo.
E dopo la mia nascita, il cavaliere vincitore, cinto
dell’olivo di Pisa, aveva strappato dieci volte il premio,
quando l'ira del principe offeso mi ordina di raggiungere
Tomi situata sulla riva sinistra del mare Eusino.
La causa della mia rovina a tutti troppo nota
non ha bisogno che sia attestata dalle mie parole.
Perché ricordare la slealtà degli amici e i servi malvagi?
Molte cose ho sopportato non più lievi dell’esilio stesso.
Ma l’animo ebbe a sdegno di dover soccombere ai mali
e si dimostrò invitto ricorrendo alle sole sue forze
dimenticando me stesso e una vita trascorsa negli ozi
impugnai con mano non avvezza le armi che il momento chiedeva
e affrontai per terra e per mare tanti pericoli quante
sono le stelle fra il polo nascosto e quello visibile.
Infine dopo essermi trascinato per lunghe peregrinazioni
toccai le rive di Samarzia contigue ai faretrati Geti.
Qui sebbene mi risuonino intorno le armi confinanti,
16
con la poesia, per quanto posso, allevio il triste destino,
e se essa non può giungere alle orecchie di nessuno,
trascorro tuttavia così la giornata e inganno il tempo.
Perciò se vivo, se resisto alle dure sofferenze
e non mi prende il tedio di una vita angosciata,
te ringrazio, o Musa! Infatti tu mi dai il conforto,
tu sei riposo agli affanni, tu vieni come medicina;
tu sei guida e compagna, tu mi porti via dall’Istro
e mi fai posto nel mezzo dell’Elicona.
Tu mi hai dato da vivo − e questo è raro – un nome
eccelso, che la fama suole dare dopo le esequie.
E l’invidia, che denigra le opere dei viventi, non ha morso
col suo dente malevolo nessuna delle mie opere.
Infatti, quantunque il nostro tempo abbia prodotto grandi
poeti, la fama non è stata maligna col mio genio,
e se io pongo molti davanti a me, sono stimato
non inferiore a loro e assai sono letto nel mondo intero.
Perciò se i presagi dei poeti hanno qualcosa di vero,
dovessi io anche subito morire, non sarò tuo, o terra.
Sia che io abbia raggiunto questa fama per il tuo favore,
o con la mia poesia, ti devo il mio grazie, benevolo lettore.
Le Metamorfosi: un canto dall’origine del mondo
Febo mi disse: “Esprimi un desiderio, vergine cumana:
sarà esaudito”. Io presi un pugno di sabbia e glielo mostrai,
chiedendo che mi fossero concessi tanti anni di vita
quanti granelli di sabbia c’erano in quel mucchietto.
Sciocca, mi scordai di chiedere che anni fossero di giovinezza.
(Met., XIV)
Le Metamorfosi (in originale alla greca Metamorphoseon libri, Libri
delle trasformazioni) sono solo un’opera tra le molte di Ovidio, ma di
certo sono la più lunga e la più complessa. Si tratta di un poema epico-mitologico dedicato alle “trasformazioni” (dal greco μεταμόρԄωσις,
che deriva dal verbo μεταμορԄόω, «trasformare»), che l’autore iniziò a
comporre intorno al 3 d. C. arrivando a realizzare (intorno all’8 d. C.
circa) quindici libri di esametri (unica delle sue opere scritta in questi
versi), contenenti circa 250 miti che condividono il tema del mutamento: in essi, esseri umani o creature mitologiche cambiano o vengono cambiati in parti della natura (animata e non).
Ovidio ci fa sapere che l’opera non ha potuto essere rivista da lui come avrebbe desiderato. Anzi, probabilmente sarebbe andata perduta
se non fosse stata pubblicata, su indicazione del poeta stesso da Tomi, a cura di un amico che ne possedeva una copia.
Per descrivere le Metamorfosi, seppur brevemente, partiamo col considerare due concetti generali, eterogenei fra loro, ma imprescindibili,
soprattutto quando si parla di opere antiche: la storia del testo (cioè
la sua tradizione filologica) e il dialogo con le opere precedenti. Il primo aspetto va tenuto presente ogni volta che ci si accosta, o si accompagnano bambini e ragazzi, all’incontro con un testo antico: il testo che oggi possiamo agevolmente sfogliare come sfogliamo un ro17
manzo moderno è un prodotto
totalmente diverso da un romanzo moderno, con una storia
del tutto particolare. Infatti, il
testo non ci è quasi mai arrivato
tale e quale in forma autografa
dell’autore, ma tramite numerosi manoscritti, ciascuno con somiglianze e differenze2 (basti
pensare che della ben più recente Commedia dantesca sono
pervenuti a noi oltre seicento
codici redatti da mani diverse!).
Solo l’accurato lavoro di confronto e scelta dei filologi ci
permette di fruire dell’opera in
una forma, se non originale, almeno coerente e plausibile; ciò
significa anche che possono
2
Nel caso delle Metamorfosi, i codici
pervenuti probabilmente continuano una
pluralità di edizioni antiche. Infatti, nonostante la grande popolarità che le
Metamorfosi ebbero quando vennero
composte nessun manoscritto di quel
tempo è giunto a noi; ciò non stupisce se
si considera che il poema fu tacciato di
essere “opera pericolosamente pagana”: probabilmente, molti manoscritti
vennero distrutti soprattutto durante il
periodo della cristianizzazione dell’Impero. Esistono frammenti dei secc. IX e
X, ma i primi manoscritti utilizzabili per la
ricostruzione testuale sono databili intorno all’XI secolo
sempre essere approntate nuove edizioni, che presentano nuove
scelte a livello di testo latino proposto (e, sicuramente, nuove traduzioni rispondenti a diversi criteri stilistici: più attuali, più poetiche, più
letterali…). Il secondo aspetto, quello del dialogo con le opere precedenti, è legato ai contenuti e ci porta a riflettere sul valore del bagaglio culturale, del sapere, delle informazioni che portiamo con noi e
sappiamo riutilizzare; oggi ԟ nella nostra società sintetica e veloce ԟ
molto meno, ma per gli antichi, e almeno fino al Rinascimento (con
esito estremo nel principio d’imitazione), riprendere le opere precedenti, giocare con l’intertestualità, fare tesoro e riproporre in forma
nuova i saperi precedenti erano segni del valore di un autore e di
un’opera. E al pubblico piaceva (i miti, ad esempio: sono storie di
sempre, e, a ben guardare, ritroviamo l’impronta di molti nelle novelle
e nelle fiabe di epoche successive).
In questo senso, le Metamorfosi sono una grande raccolta di narrazioni derivanti dalla mitologia greca ԟ che a sua volta le aveva recuperate da storie precedenti ԟ reinterpretate alla luce della storia e della
sensibilità latine, per mano di Ovidio: il poema contiene, infatti, legate
fra loro in un’unica macro-storia, circa 250 narrazioni mitologiche, più
o meno lunghe. Perché scegliere di scrivere un’opera del genere? Le
risposte che si potrebbero dare sono molte, e di diversa entità. Anzitutto, va detto che l’attenzione di Ovidio per i miti e le tradizioni si era
già, in parte, espressa nei Fasti: sei libri che descrivevano l’origine
delle feste del calendario romano, insieme a numerose altre leggende
e tradizioni (il progetto prevedeva dodici libri, uno per ogni mese
dell’anno). Inoltre, la mitologia rappresentava una materia apprezzata, vastissima e affascinante con cui cimentarsi, per la quale erano
disponibili numerosi modelli filosofici e letterari da rielaborare e personalizzare (uno per tutti, la raffinata poesia dei poeti alessandrini di
età ellenistica). Il fine più significativo dell’opera nel suo insieme, tuttavia, era ancora un altro: celebrare la storia della romanità inquadrandola nel percorso dell’intera creazione, romanità che, sotto il
principato di Augusto, aveva raggiunto il culmine.
Le Metamorfosi, lungi dall’essere una raccolta
disorganica, rivelano una profonda unità espressa attraverso la presenza pervasiva di una natura in dialogo con la leggenda e col mito, principio
instancabile del divenire del tutto: una natura
profondamente viva, in cui ogni albero e ogni fiore hanno una storia da raccontare. Nel fluire della storia universale, ogni mito si lega nella finzione letteraria al successivo, partendo dalla creazione dell’universo (la trasformazione più antica:
dal Chaos al Kosmos ordinato) fino alla storia più
recente (l’apoteosi di Cesare, trasformato in astro, e la glorificazione di Augusto). In questo
percorso trova posto l’intero bagaglio mitologico
e storico greco-latino, narrato in una sorta di
“carmen continuum” della nostra civiltà (da Medea a Teseo e Arianna, dalle fatiche di Ercole a
Orfeo ed Euridice, da Enea a Romolo), come se il
mito non fosse disgiungibile dalla storia reale,
nel fluire incessante e a volte angoscioso del
tempo che passa. La maestria del poeta è quella
di saper unire un episodio all’altro, di lunghezza
diversa, attraverso legami sottili, ma efficaci: a18
nalogie tra i miti, similitudini
contenutistiche, incastri, personaggi che diventano voci narranti e molto altro.
Sebbene il materiale sia in gran
parte tradizionale, il risultato
dell’operazione ovidiana è innovativo: nei suoi racconti ci sono
più fantasia, più sensibilità e più
attenzione alle sfumature psicologiche dell’individuo e alle sue
sofferenze; inoltre, lo stile, le
scelte lessicali accurate e il metro (un esametro di estrema musicalità) accompagnano con leggerezza l’incessante racconto
delle mutazioni e la percezione
della vanità delle forme solo apparentemente stabili. Della trasformazione, Ovidio mette in risalto talvolta la velocità, altre
volte la lentezza, il persistere
della natura precedente nella
nuova, con il dramma che questo comporta. Anche nei casi in
cui le narrazioni non comportino
una evidente trasformazione fisica, c’è comunque un sottile
gioco di trasformazione interiore. In tutti i casi, al di là della
superficie del racconto, si intravede una sensibilità inquieta
molto attuale, che trapela dal
tormento de
ei personaggii e che ha afffascinato arttisti di tutte le epoche: basti so
offermarsi a leggere i frem
miti che ancorra percorrono
o la ninfa Dafne tra
asformata in alloro per sfuggire
s
all’am
more imposssibile di
Apollo o l’ecco della voce della ninfa in
nnamorata dii Narciso, che
e a sua
volta, innam
morato di sé sttesso, si ridurrrà a un fiore.
Soffermiamo
oci, infine, brrevemente, su
s un aspetto
o formale della poesia, e cioè sull’esametro
s
. Non possiam
mo sapere co
ome i latini le
eggevano esattame
ente né questo né altri schemi metrici mutuati dalla tradizione greca, ma sappiam
mo che essi ra
appresentano
o delle seque
enze regolari di pied
di (gruppi di due
d o più silla
abe brevi o lu
unghe3) che costituic
vano la misu
ura del verso (piedi perché
é il ritmo si ba
atteva col piede).
Ogni forma poetica era realizzata se
econdo precisse e regolari scelte
metriche. L’e
esametro è la
a più antica tipologia di ve
erso in uso, im
mpiegato in partico
olar modo perr la poesia ep
pica (è il mettro dell’Eneid
de) o didascalica; esso
e
è formatto da una seq
quenza di se
ei piedi dattilici (prevalentementte di tipo
, lunga
a-breve-breve
e, ma con variante
frequente lu
unga-lunga: la
a sillaba lungga porta rego
olarmente l’acccento;
nel caso di due lunghe è sempre acccentata la prrima); l’ultimo
o piede
manca di un
na sillaba:
Proviamo a leggere
l
in me
etrica il primo
o distico delle Metamorfosi:
Ìn nova fèrt animùs
mutàtas dìce
ere fòrmas
còrpora dì co
oeptìs
nam vòs mu
utàstis et ìllass
3
Per una spieggazione sulle qu
uantità vocaliche
e si veda la sezione dedicata alla lingua
latina.
19
Solitamente, dopo il terzzo acS
c
cento
si rea
alizza una cesura,
d
detta
pentem
mimera (cioè
è una
p
pausa
brevisssima nella le
ettura,
c può colloccarsi anche altrove
che
a
n verso). Va ribadito, perrò, che
nel
q
queste
regola
arità di letturra, qui
s
solo
accennate, sono una
a conv
venzione
che non ci arriva
a diretta
amente dallla latinità: infatti,
n possiamo
non
o sapere con
n esatte
ezza come vveniva letta la
a poes nel mondo latino, e, probasia
b
bilmente,
la lettura era piiù timb
brica,
cromatiica e musicale della
a nostra (che si basa, in
nvece,
s
sull’aumento
dell’intensità
à della
v
voce
dove ccade un acccento).
P
Pertanto,
posssiamo anch
he god
derci
le opere
e poetiche dandone
u lettura in
una
n prosa espre
essiva;
tu
uttavia, è o
opportuno almeno
s
sapere
che, a livello formale, vi
e
erano
convenzioni metrich
he ben
p
precise
e che
e nulla, nem
mmeno
u singola p
una
parola, era la
asciata
a caso.
al
Dal latino alle lingue romanze: un parlare al modo dei romani
GIOCHI LINGUISTICI TRA PASSATO E PRESENTE
Noi parliamo latino? Perché
accostarsi a questa lingua.
La domanda potrebbe apparire
ingannevole. Troppo semplice
rispondere “No, parliamo italiano”, troppo vago – anche se più
vicino alla risposta esatta – rispondere “Sì, in un certo senso
sì”. Come fare, allora? Quali sono gli strumenti interpretativi
corretti per arrivare alla risposta
giusta? Come accompagnare i
bambini, gradualmente e in
forma ludica, a scoprire la grande trasformazione linguistica di
cui sono eredi e nella quale sono immersi ogni giorno? E, soprattutto, perché? Da più parti si
sente dire che il latino non serve
a nulla, perché è una lingua
morta e non insegna niente di
pratico. Limitiamoci a considerare l’aggettivo morta: se, in riferimento a una lingua, si intende
non più parlata, non più usata
come strumento di comunicazione, possiamo anche essere
d’accordo; tuttavia, se ci fermiamo a considerare la vitalità
del latino come base di derivazione dell’italiano e delle altre
lingue romanze di oggi, nonché
l’inesauribile possibilità che offre, insieme al greco, per la creazione di neologismi (in particolare scientifico-tecnologici) dobbiamo ricrederci.
È qui che l’argomento dell’inutilità dell’avvicinamento al latino
cade: non si tratta di diventare
traduttori esperti, ma, semplicemente, di stimolare la naturale curiosità dei ragazzi attraverso il materiale linguistico che li
circonda, in modo che ne diventino osservatori più consapevoli.
Perché si pensa sia possibile,
giusto e urgente incentivare nei
giovanissimi lo sguardo scientifico sulle diverse dimensioni della realtà, ma questo non si con-
sidera utile in campo linguistico? Il tentativo di risposta alla
domanda “Noi parliamo latino?”
parte proprio da qui, nella presa
di coscienza che l’italiano di oggi non è un prodotto stabile, nato, chissà come, qualche decina
d’anni fa, e non è nemmeno
sempre stato uguale, ma ha una
storia, in parte comune con altre
lingue, che si radica indissolubilmente a quella del latino, di
cui è la continuazione. Un simile
allargamento di prospettive, oltre a prestarsi come miniera di
possibilità didattiche, potrà contribuire, pian piano, a incentivare la sensibilità linguistica degli
allievi.
Cominciamo:
che cos’è il latino?
Intuitivamente, per formazione
scolastica o per cultura generale, grossomodo abbiamo tutti
un’idea più o meno esatta di
che cos’è il latino. Se dovessimo
rivolgere la domanda a un gruppo di persone (non classicisti o
filologi classici di professione),
dall’età dell’adolescenza in su,
otterremmo
presumibilmente
svariate risposte, ciascuna delle
quali contenenti una parte di
verità e ciascuna delle quali sarebbe una variante sui temi seguenti: “Era la lingua parlata
nell’antica Roma”, “Era la lingua
che si usava prima dell’italiano”.
Qualcosa di esatto c’è, ma mancano molti elementi.
Confrontiamo con queste risposte la definizione di un’illustre
enciclopedia (la voce “lingua latina” della Treccani, consultabile
online):
Lingua indoeuropea appartenente al gruppo italico o protolatino, lo stesso di cui fanno parte
quelle di altri popoli (Ausoni, Opici, Enotri e Siculi) che, insieme
20
ai Latini, si insediarono nella
parte centromeridionale dell’Italia fra il 3° e il 2° millennio a. C.
Vediamo, innanzitutto, che il
senso comune ci porta – con
alcune limitazioni e imprecisioni
− alla dimensione dell’uso (era
la lingua “parlata”, ma anche
“scritta”, a Roma), mentre l’enciclopedia ci offre per prima una
definizione della lingua dal punto di vista storico. Un manuale
universitario di glottologia andrebbe più a fondo nelle caratteristiche tipologiche ed evolutive della lingua, mentre un manuale specifico di grammatica
storica illustrerebbe i mutamenti
interni che hanno portato dal
latino al volgare italiano (per fare un esempio fra i più semplici,
mostrerebbe che, gradualmente, i dittonghi latini hanno subito
monottongamento: per intenderci, da AURUM sia derivato il
nostro oro).
Tutto ciò è “il latino” o, meglio,
tutto ciò è studio del latino.
Questi e altri approcci concorrono a descrivere una qualsiasi
lingua come entità caratterizzata da più livelli d’indagine e da
più dimensioni di variazione nel
tempo e nello spazio, a seconda
dei registri e del canale di trasmissione orale o scritto. Nella
realtà di individui parlanti e scriventi, siamo propensi a percepire una lingua nella sua dimensione concreta di strumento di
comunicazione immediatamente disponibile; eppure, dietro la
lingua dell’uso quotidiano odierno c’è una storia lunga e complessa, una storia che continua
ancora oggi. Infatti, nemmeno
l’italiano odierno è arrivato a
una conformazione grammaticale, sintattica e neppure ortografica definitiva: basti notare la
quantità di grafie concorrenti e
di abbreviazioni (più o meno accettate a seconda del mezzo di
comunicazione: ciò che è lecito
in un sms o in una chat può non
esserlo in una tesi di laurea),
per non parlare della libertà sintattica, dei neologismi, dei prestiti e delle rifunzionalizzazioni
di parole (un esempio per tutti,
tipo in luogo di come).
La data di nascita delle lingue: un compleanno impossibile
Da quel poco che abbiamo detto
finora, possiamo facilmente intuire che è estremamente complicato fissare una “data di nascita” per le lingue moderne; e il
risultato che si ottiene è inevitabilmente approssimativo e fittizio. L’evoluzione linguistica è,
infatti, più un flusso che una sequenza di tappe. Per l’italiano gli
storici della lingua hanno prova-
to a individuare nel 960 l’anno
natale del volgare e nel celebre
Placito Capuano (Sao ko kelle
terre... Con k per ch-: grafia, ai
tempi, perfettamente lecita) il
suo “atto di nascita” (si trattava
di un atto notarile vero e proprio, nel quale, in mezzo a frasi
tutte in latino, ne compariva una
chiaramente in volgare). Per il
latino, la questione è ancora più
complessa e, dato il difficile reperimento di testimonianze
scritte, è davvero difficile dire
quando questo idioma ha prevalso sugli altri diffusi tra le popolazioni dell’Italia preromana
(visibili nella cartina qui a fianco). Eppure, a un certo punto,
dopo una lenta competizione
con gli idiomi delle popolazioni
sottomesse (lingue di sostrato),
il latino è diventato protagonista
della storia della romanità e delle sue conquiste, della sua oratoria e della sua letteratura.
21
Dal latino alle lingue romanze:
l’italiano e le lingue sorelle
Insomma, anche le lingue hanno
una storia e non nascono come
prodotti pronti all’uso in un momento preciso della storia. Anzi,
la loro storia è, spesso, complessa e lunga, e procede su un
doppio binario: la storia interna
(come cambiano la grammatica
e le strutture delle lingue nel
tempo) e la storia esterna (Come cambia l’uso linguistico?
Come si trasforma la percezione
dei parlanti? Perché certe lingue, un tempo prestigiose, gradualmente perdono di vitalità?).
Le due “storie” sono indissolubilmente legate: infatti, sono
proprio i parlanti, che vivono in
un dato lasso di tempo, a cooperare lentamente e senza accorgersene al cambiamento linguistico interno. Dal latino parlato, più esposto ai mutamenti rispetto alla sua varietà scritta,
sono nate le diverse lingue romanze, che potete vedere qui
sotto; sono lingue sorelle in
quanto derivano da un unico
genitore: il latino, appunto. Ecco
perché in esse possiamo trovare
molte somiglianze (ad esempio
nel lessico). Le differenze nei
suoni, nelle parole e nelle strutture dipendono, invece, dalla
storia individuale delle singole
lingue, che si sono dovute confrontare con idiomi preesistenti
nei territori di diffusione. Il fenomeno di trasformazione del
latino nelle diverse lingue “figlie” è avvenuto lentamente.
Le lingue romanze o neolatine
sono, dunque, un gruppo di lingue geneticamente affini; esse
sono la continuazione del latino,
rispetto al quale non manifestano nessuna interruzione drastica. Il periodo intercorso fra
l’epoca dell’unità latina e quella
dell’attestazione dei diversi idiomi indipendenti non è troppo
grande; e comunque va detto
che anche lo stesso latino non
era una lingua davvero omogenea. L’espansione del Latino dal
suo primitivo centro sulla riva
sinistra del Tevere, prima in Italia e poi nell’intera Romània
(termine preso a prestito dalla
filologia romanza per indicare il
territorio di diffusione del latino),
e i conseguenti contatti con le
lingue dei popoli assoggettati
avevano senz’altro creato numerose differenziazioni nelle diverse aree di latinità. All’incirca
nel quinto secolo, quando
l’Impero Romano d’Occidente
cedette alla pressione dei barbari, le differenze regionali cominciarono a farsi più marcate e
lo divennero ancor di più quando i legami politici e amministrativi che riunivano le parti
dell’impero iniziarono ad allontanarsi, originando singole regioni man mano più autonome.
Insomma, fino a quando la forza
accentratrice della capitale
dell’Impero
permise
che
all’unità politica corrispondesse
anche una relativa unità linguistica, le varietà non uscirono
mai dagli argini delle differenze
regionali, almeno per quanto
risulta dalle testimonianze scritte superstiti. Man mano, però,
che l’unità imperiale si allentò,
anche l’unità linguistica, sebbene i legami culturali permanessero, ne risultò indebolita.
Per quanto riguarda il cambiamento linguistico, i glottologi
hanno individuato un elemento
importante e significativo nella
distinzione fra centro e periferia
dell’impero, che vale la pena di
ricordare. Partiamo da un caso,
quello della parola “plus”, più,
che nelle lingue moderne ha avuto gli esiti seguenti (provate a
pronunciarli, tenendo conto che
sardo e rumeno si pronunciano
come si scrivono, proprio come
il latino):
22
Plus (latino)
plus (rumeno)
pius (sardo)
plus (francese)
più (italiano)
mas (spagnolo)
mais (portoghese)
Consideriamo prima di tutto la
geografia: Spagna e Portogallo
sono laterali e più lontane rispetto al centro dell’impero, così
come la Romanìa (che oltre a
essere laterale è isolata fra lingue di ceppo slavo); isolata, nel
vero senso della parola, è la
Sardegna. Poi consideriamo che
mas e mais derivano da MAGIS,
forma comparativa arcaica precedente PLUS in latino. Mettendo assieme i pezzi possiamo notare che la forma più recente,
PLUS, si è affermata in Italia e in
Francia con vistose differenze di
pronuncia: questo vuol dire che
la lingua era più vitale; poi possiamo osservare che plus si è
affermato in sardo e in rumeno,
ma senza differenze di pronuncia rispetto al latino; infine, notiamo che nello spagnolo e nel
portoghese si è continuata la
forma arcaica, cioè l’innovazione linguistica latina più recente
(plus) non è arrivata. Che cosa
significa tutto ciò? Secondo la
linguistica areale, significa che
le zone lontane, laterali e isolate
conservano caratteristiche più
arcaiche in quanto il cambiamento linguistico si è manifestato di meno: l’innovazione, infatti,
procedeva dal centro alla periferia. Questo spiega perché in
spagna “bello” si dice hermoso
(dal lat. classico FORMONSUS,
bello; BELLUS è, invece, aggettivo del latino tardo).
Lettere e suoni della lingua latina
L’ALFABETO LATINO
Cominciamo con una riflessione sull’alfabeto (in particolare sui caratteri latini, e più in generale, sul concetto stesso di alfabeto) e facciamolo cimentandoci in un piccolo gioco, che si può proporre ad adulti e bambini:
(a)
木
Osservate qui a sinistra. Che cosa vedete? C’è scritto qualcosa? È
una scritta o un disegno?
(b)
ARBŎR
E qui? Che cosa vedete? Riuscite a leggere? Sapete dire che cosa
significa?
Certamente, nel secondo caso
(b) i problemi di decifrazione sono stati minori: siamo riusciti a
leggere (cioè a riconoscere le
lettere del nostro alfabeto e i
suoni corrispondenti) e a intuire
il significato della parola (albero). Anche nel primo caso c’è
scritto albero, ma si tratta di un
ideogramma cinese, cioè –
semplificando al massimo – di
un sistema di scrittura non alfabetico, bensì ideografico: per
provare a capire il significato del
significante (a), dobbiamo muoverci su un altro livello di interpretazione, cioè quello visivo,
del riconoscimento di un’immagine stilizzata (un albero rovesciato). Non si tratta più di simboli astratti come quelli alfabetici, a ciascuno dei quali corrisponde un suono, ma di riproduzioni della realtà.
I caratteri dell’alfabeto latino ci
sono familiari in quanto sono
quelli utilizzati per la trascrizione
di lingue a noi note: non solo di
quelle romanze, anche di lingue
come l’inglese o il tedesco, di
ceppo germanico. Tuttavia, leggere il latino non è proprio come
leggere l’italiano, per alcune dif-
ferenze che vedremo qui di seguito; per leggere, come per tradurre, ci
sono alcune regole precise, che possono essere presentate come regole di un gioco, rispettando le quali ci si può accostare in modo divertente a una lingua nuova e misteriosa.
Leggiamo il latino:
caratteristiche e differenze principali rispetto all’italiano
Poiché non è possibile ascoltare dei parlanti nativi, gli studiosi hanno
dovuto dedicare attenzione particolare e specifica per individuare delle norme di lettura del latino, ricavate da testimonianze di varia natura (prime fra tutti gli scritti dei grammatici del tempo). L’alfabeto latino è formato da 24 lettere (le 21 italiane più k, x, y). Conta in totale
dieci vocali: i segni, in realtà, sono cinque (a, i, e, o, u), ma tutti possono realizzarsi in forma breve o lunga, originando, così, sillabe brevi
e sillabe lunghe:
– una sillaba è breve se contiene una vocale breve, caratterizzata
dal segno caratteristico simile ad una piccola mezzaluna, tracciato
su di essa nei vocabolari e nelle grammatiche (ĕ);
– una sillaba è lunga se contiene una vocale lunga o un dittongo:
una vocale lunga si riconosce da quel segno caratteristico, simile a
un trattino, tracciato su di essa nei vocabolari e nelle grammatiche
(ē).
Non è semplice per noi, oggi, sapere esattamente a che cosa corrispondeva la differenza di lunghezza; forse aveva un valore timbrico,
cioè segnalava una differenza di pronuncia che non sappiamo riprodurre. Infatti, il sistema vocalico dell’italiano è composto di sette vocali (graficamente sono cinque, ma la e e la o possono essere aperte o
chiuse, anche se fra gli italofoni di oggi la sensibilità per questa di23
stinzione si va perdendo; una
maggiore sensibilità e capacità
di riprodurre le aperte e le chiuse è comune solo in Toscana).
Le regole di lettura del latino,
strettamente legate alla quantità vocalica, sono tre:
1. l’accento non cade mai
sull’ultima sillaba: non esistono quindi parole tronche,
tipo verità;
2. in latino l’accento non può
mai cadere oltre la terzultima sillaba: quindi può esserci al massimo una parola
sdrucciola come sìngolo (p.
es. ìncipit), ma non una parola come telèfonami;
3. infine, c’è la cosiddetta legge
della penultima, che riguarda
le parole di tre o più sillabe.
Nelle parole di tre o più sillabe, si possono verificare due
casi:
– la penultima sillaba è
lunga: l’accento cade su
di essa;
– la penultima sillaba è
breve: l’accento cade sulla sillaba precedente.
Vanno ricordati, poi, i dittonghi, cioè i gruppi formati da vocale più una
semivocale: in latino i dittonghi più frequenti sono tre
au = au (aurum, oro)
ae = e (Caesar, Cesare)
oe = e (poena, pena)
Le consonanti non presentano particolari difficoltà, ma occorre sapere che alcuni gruppi di lettere si pronunciano diversamente da come
sono scritti o comunque in modo diverso da come verrebbe spontaneo fare. Vediamo qualche caso, per curiosità:
ti + voc. = zi (es. vitium pr. vìzium); questa regola non vale se ti + voc.
è preceduto da s, x o t (es. quaestio pron. quèstio);
sc = le due lettere sono sempre pronunciate separate (il suono palatale di pesce è nato nel latino tardo, così come i suoni affricati del nostro cielo e del nostro gennaio);
gn = come nel caso precedente, la tendenza classica era probabilmente quella di realizzare due suoni separati.
Infine, una curiosità. Abbiamo parlato di vocali brevi e lunghe, che
l’italiano non ha. Tuttavia, l’italiano ha una caratteristica in un certo
senso simile a questa. Dove? Facciamo una prova. Affinate le orecchie e pronunciate (o fare pronunciare da qualcuno) la parola CARO,
poi la parola CARRO; oppure pronunciate la parola PALA, poi la parola
PALLA. Non solo sentirete la consonante doppia rafforzata, ma anche
la vocale che precede la geminata pronunciata in un’emissione vocale un pochino più lunga.
24
Gioco linguistico: il Memory delle parole latine e italiane
DI ROSANNA IAQUINTA
Il «Memory» è un noto gioco di carte che richiede attenzione, concentrazione e memoria. Le carte sono inizialmente mescolate e disposte,
coperte, sul tavolo. I giocatori scoprono, a turno, due carte. Se queste
formano una coppia (cioè hanno qualche elemento che le lega), vengono incassate dal giocatore di turno, che può scoprirne altre due,
altrimenti, vengono nuovamente coperte e rimesse in gioco sul tavolo,
e il turno passa al prossimo giocatore. Vince il giocatore che riesce a
scoprire più coppie. Ovviamente, molto sta nell’avere buona memoria
di dove si trovano le carte scoperte e poi rimesse in gioco.
Perché non provare a creare la coppia unendo la parola latina e quella italiana derivata da essa? L’obiettivo di questo gioco è, innanzitutto, quello di incuriosire e sensibilizzare spontaneamente alle somiglianze fra la lingua latina e l’italiano (ma si possono facilmente coinvolgere anche altre lingue!). Man mano che i bambini si appassioneranno all’affascinante processo di trasformazione dal latino
all’italiano, sarà possibile costruire altri «Memory», con nuove parole
più o meno complesse (all’occorrenza si può anche consultare un dizionario etimologico).
Buon divertimento!
Per il docente: per completezza, a lato di ogni abbinamento è accennata una breve spiegazione dei mutamenti fonetici avvenuti nel corso
del processo di trasformazione (cfr. G. Patota, Nuovi lineamenti di
grammatica storica dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2007).
Regola
Il dittongamento spontaneo
In sillaba aperta dalle vocali «e»
e «o» brevi si sono sviluppati i
due dittonghi ascendenti «ie» e
«uo».
Chiusura in protonia e postonia
In posizione protonica la /e/
tende a chiudersi in /i/ e la /o/
passa in /u/
Lo sviluppo della /j/ in posizione
iniziale o intervocalica
La spirantizzazione di /b/
La sonorizzazione delle sorde
intervocaliche
Le occlusive sorde latine /p/, /t/
e /k/ comprese tra vocali si sono spesso trasformate nelle corrispondenti sonore. Nel primo
caso, invece, la /p/ fricativizza
in /v/
Latino
Italiano
pedem
decem
levitum
bonum
focum
core
molinum
piede
dieci
lievito
buono
fuoco
cuore
mulino
secūrus
sicuro
iocum
peius
maiorem
hăbēre
ripam
stratam
patrem
cattum
macrum
gioco
peggio
maggiore
avere
riva
strada
padre
gatto
magro
25
Regola
Latino
Italiano
La semplificazione (assimilazione) dei nessi consonantici /gm/
e /mn/
fragmentum
somnum
mensem
sponsam
ipsum
scripsi
saxum
vixi
laxare
factum
frammento
sonno
mese
sposa
esso
scrissi
sasso
vissi
lasciare
fatto
lactem
latte
aqua
antiquum
acqua
antico
Il nesso /ns/
La nasale prima della sibilante
cade sistematicamente
Il nesso /ps/
Il nesso /ps/ ha avuto come esito /ss/
Il nesso /ks/
Il nesso /ks/ ha avuto in italiano
un duplice esito: /ss/ oppure
/sc/
Il nesso /ct/
Il nesso /ct/ ha avuto in italiano
come esito l’assimilazione regressiva
Il nesso /kw/
Il nesso /kw/ ha subito diversi
esiti.
26
Dal latino alle lingue romanze: un gioco
DI ROSSANA IAQUINTA
L’obiettivo di questo gioco è, innanzitutto, quello di mettere in evidenza il rapporto tra la lingua latina e le lingue romanze, in modo visivo e
comparativo, senza “insegnare” nulla a priori ai ragazzi. Prima di introdurlo potrebbe anche essere utile procurarsi una carta geografica
raffigurante la massima estensione dell’impero romano, e confrontare successivamente la stessa con una carta geografica moderna, per
avere un’idea di come sono cambiati i confini.
Partendo dall’idea di questo gioco, si possono naturalmente inventare
tutte le variazioni che si desiderano. La tabella sottostante vuol essere solo uno spunto di partenza.
Così, ad esempio, si può cominciare con un cartellone in cui, nella colonna di sinistra, compaiono le parole latine, mentre le altre colonne
restano vuote. Le «traduzioni» nelle cinque lingue considerate – italiano, francese, spagnolo, portoghese e rumeno – finiranno invece in
una specie di mazzo di carte: tirando a caso, si tratterà di incollare
ogni parola nel giusto riquadro.
Ovviamente la tabella può essere ampliata con nuove parole, consultando dizionari di lingua straniera o etimologici. Oppure, espandendo
il gioco all’infinito, potrà essere affascinante andare alla ricerca di altre contaminazioni linguistiche, che a volte percorrono e hanno percorso strade assai strane.
Latino
manus, -us
Italiano
Francese
Spagnolo
Portoghese
Rumeno
mano
main
mano
mão
mână
occhio
formaggio/cacio
capra
œil
ojo
olho
ochi
fromage
queso
queijo
caş
chèvre
cabra
cabra
caprǎ
clavis, -is
chiave
clé
llave
chave
cheie
oculus, -i
caseus, -i
(latino popolare: formaticus, -i)
capra, -ae
ecclesia, -ae
chiesa
iglesia
igreja
église
biserică
basium, -ii
bacio
baiser
beso
beijo
sărut
mater, -tris,
madre
mère
madre
mãe
mamă
pater, -patris
padre
père
padre
pai
tată
stella, -ae
stella
étoile
estrella
estrela
stea
lingua, -ae
lingua
langue
lengua
lingua
limbă
platea, -ae
piazza
place
plaza
praça
piaṭǎ
pons; -ntis
ponte
pont
puente
ponte
pod
nox, noctis
notte
nuit
noche
noite
noapte
rosa, -ae
rosa
rose
rosa
rosa
roz
flos, -oris
fiore
fleur
flor
flor
floare
unus, -a, -um
uno
un
uno
um
unu
duo, -duae,-duo
due
deux
dos
dois
doi
tres, -tres,-tria
tre
treus
tres
três
trei
viginti
venti
vingt
veinte
vinte
douăzeci
centum
cento
cent
cien
cem
sută
mille
mille
mille
mil
mil
mie
27
Latino
Italiano
Francese
Spagnolo
Portoghese
rapide (rapidamente)
rapidamente rapidement rápidamente rapidamente
lente
lentamente
lentement
despacio
lentamente
frigus, -oris
freddo
froid
frío
frio
calidus, -a, -um
caldo
chaud
caliente
quente
cantare
chanter
cantar
cantar
dire
dire
dicer
dixer
cantare
dicere
Rumeno
repede
frig
cânta
Osservazione: il latino usa normalmente due tipi di segni distintivi,
detti breve (ŭ, ĕ, …) e lunga (ā, ē, …). Ad esempio, la traduzione latina corretta di occhio è ocŭlus e quella di rapidamente è răpĭdē. Per
comodità e per non complicare il tutto, abbiamo scelto di riportare le
parole latine senza questi segni.
28
Piazzaparola a Locarno / Giovedì 10 settembre 2015
METAMORFOSI
Storie sull’origine del mondo secondo
Publio Ovidio Nasone
A cura di Silvia Demartini e Adolfo Tomasini
Alle 9 al Teatro di Locarno
Accoglienza e saluto ai partecipanti
da parte di Raffaella Castagnola, ideatrice e coordinatrice di
Piazzaparola, e della direzione del DFA
«Ascoltate, o Dei, il mio canto...»
Il racconto della creazione del mondo in un libero adattamento di
Silvia Demartini e Adolfo Tomasini da Le Metamorfosi di Ovidio,
con le voci di Marco Fasola e Beppe Vedani (per gentile concessione
della RSI), la musica di Giovanni Galfetti e le luci di Luca Bertolotti e
Werner Walther.
La storia di Eco e di Narciso
adattata da Silvia Demartini e Rosanna Iaquinta,
con le voci di Sara Giulivi e Cristina Zamboni.
E poi altre metamo
orfo
osi, scelte e adattate da
Silvia Demartini e Rosanna Iaquinta:
ai giardini Rusca
con la voce di Cristina Zamboni
e le illustrazioni di Simona Meisser
Enti e sponsor
in piazza Grande, al mercato del giovedì
con la voce di Sara Giulivi
e la fisarmonica di Daniele Dell’Agnola
SUPSI
Banque SYZ & CO
Città di Locarno
Teatro
di Locarno
Città
di Locarno
In caso di cattivo tempo la manifestazione si svolgerà interamente al
Teatro di Locarno.
Piazzaparola è una manifestazione che nasce dalla Dante Alighieri di Lugano.
www.dantealighieri.ch — [email protected] — Facebook: piazzaparola
Piazzaparola a Locarno / Lo staff
Daniele Dell’Agnola, narratore e musicista, insegna italiano e comunicazione nelle scuole superiori e attualmente è docente dei corsi bachelor alla SUPSI. Suona il pianoforte, la fisarmonica e adora i ritmi del carnevale.
Silvia Demartini, ricercatrice in didattica dell’italiano alla SUPSI (DFA).
Dopo la laurea in lingua e cultura italiane, ha conseguito il dottorato di
ricerca all’università del Piemonte Orientale. Collabora al progetto
«TiScrivo», sulla lingua scritta a scuola dai bambini ticinesi.
Marco Fasola e Beppe Vedani lavorano insieme da almeno vent’anni.
La coppia artistica, oltre ad occuparsi della realizzazione dei messaggi promozionali per le reti radio RSI, ha prodotto numerose serie radiofoniche sotto lo pseudonimo di «Circo Rilassa». Appassionati di musica,
si sono spesso lanciati nella composizione ed esecuzione di sigle
radiotelevisive, tra le quali le canzoncine delle rubriche radio del Cane
Peo e l’immortale hit «La Fregata Dell’Amore». Il primo è appassionato
di cartoni animati giapponesi che traduce a spanna. Il secondo di discipline mediche orientali.
Giovanni Galfetti ha studiato al Conservatorio di Zurigo e ora è insegnante di musica e di didattica della musica presso il dfa della SUPSI. È
organista della Collegiata di S. Antonio di Locarno. Suona in duo con
Carlo Bava (Laetimusici) e dirige l’Ensemble Controcanto.
Sara Giulivi ha conseguito nel 2007 il dottorato di ricerca in linguistica e linguistica italiana presso l’università di Firenze ed è attualmente ricercatrice presso il Dipartimento formazione e apprendimento
della SUPSI. Si è inoltre formata come attrice presso il Centro Teatro
Internazionale (CTI) di Firenze, dove ha frequentato il corso triennale di
Formazione Professionale per Attori di Prosa, sotto la guida di O.
Melnik, dell'Università Statale di Cultura e Arte di Mosca.
Rosanna Iaquinta si è iscritta al DFA della SUPSI dopo aver conseguito
nel 2012 la laurea in lettere moderne all’università Statale di Milano.
Attualmente frequenta il Bachelor of Arts SUPSI in Insegnamento per il
livello prescolastico. Come studentessa al DFA ha collaborato all’edizione 2015 di «Piazzaparola» nell’ambito di un credito libero proposto agli
studenti del II anno (Metamorfosi di una lingua: dal latino all’italiano…
e altro!).
Simona Meisser, illustratrice di libri per l’infanzia, lavora a Lugano. Ha
frequentato l’Istituto Europeo di Design a Milano, dove ha ottenuto il
diploma di illustratrice. Espone in mostre itineranti e svolge corsi di illustrazione nella scuole. Il suo sito: www.simonameisser.com.
Publius Ovidius Naso, (43 a. C. - 18 d. C.), poeta elegiaco romano tra i
più popolari. Malgrado diverse sollecitazioni, il poeta non ha ritenuto di
inviare una sua breve nota biografica. In tutti i casi è l’autore delle storie di «Piazzaparola» di quest’anno.
Adolfo Tomasini, pedagogista, è stato insegnante di scuola elementare per una decina d’anni. Nel 1987 ha conseguito la licenza in scienze
dell’educazione all’università di Ginevra e, nello stesso anno, è stato
nominato direttore delle scuole comunali di Locarno, funzione che ha
lasciato nel 2013. Cura dal 2001 la rubrica «Fuori dall’aula» del
Corriere del Ticino e, in collaborazione con la SUPSI, coordina le appendici locarnesi di «Piazzaparola».
Cristina Zamboni, attrice, si forma alla scuola di teatro «Quelli di Grock»
di Milano. Collabora con Cambusateatro, Teatro Agorà e come attrice
indipendente ha proposto il ciclo di narrazioni mitologiche «Raccontami
un mito». Dal 2006 è lettrice alla RSI e voce RSI Cult TV.