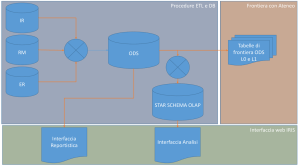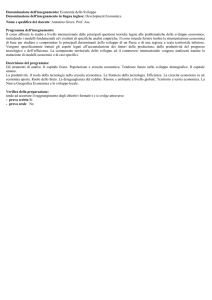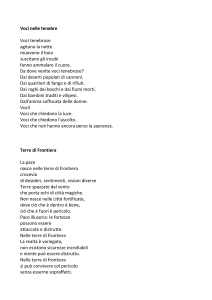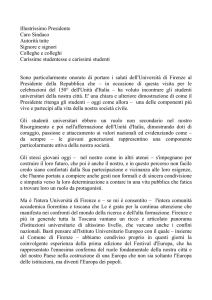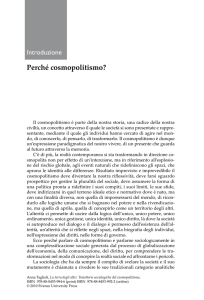Città, luoghi di frontiera
Ulf Hannerz
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna
Riesce ancora molto difficile trovare la metafora perfetta capace di cogliere l’essenza della
vita nelle città. Le città hanno configurazioni, strutture e ripartizioni di ogni tipo e varietà, e
altrettanto eterogenei sono i loro abitanti. C’è chi immagina la città come una giungla, altri
come un macchinario; poi, talvolta, all’interno delle città ci troviamo davanti a un villaggio
urbano. Oggi tuttavia vorrei affrontare il tema della vita cittadina, facendo ricorso a
un’immagine che a mio parere riesce a cogliere almeno in parte alcuni degli elementi della
vita urbana che mi hanno interessato e che ancora richiamano l’attenzione della pubblica
opinione e degli esperti. Prenderò quindi in esame la città come luogo di frontiera. Uno dei
motivi per i quali il concetto di frontiera è potenzialmente utile per esplorare la vita cittadina è
indubbiamente dettato dal fatto di essere di per se stesso sfaccettato e quindi di evocare
qualità diverse in contesti altrettanto diversi.
Una frontiera, di converso, tende ad assumere significati diversi sulle due sponde opposte
dell’Atlantico. Per gli europei, essa può significare principalmente un confine politico, la linea
di demarcazione tra due stati e per questo, forse, il luogo in cui gli insider di una nazione si
confrontano con gli outsider – in generale o in specifico. Per gli americani, la frontiera, nella
storia e nel mito nazionale, è stata principalmente una frontiera in movimento, il luogo in cui i
nuovi coloni incontrano l’inesplorato, su cui cercano di stabilire il controllo, continuando
quindi a spingere la frontiera sempre più in avanti. È tuttavia possibile che questa differenza
sia ora meno netta, visto che il potere soft dell’immaginario americano esercita il suo influsso
sul pensiero popolare europeo. In ogni caso, i concetti che ruotano attorno a questi temi
potrebbero anche assumere differenze di ordine linguistico. Infatti, in una lingua, termini quali
frontiera, confine, limes e margine possono condurre il nostro pensiero verso direzioni
leggermente diverse, oppure non trovare, in un’altra lingua, un pari numero di corrispondenti.
Intendo qui spaziare tra i diversi concetti di frontiera, dato che possono guidarci verso punti di
osservazione differenziati da cui esplorare la vita urbana contemporanea. Per iniziare, visiterò
la frontiera come spazio del futuro, un progetto, un’area di creatività e, forse, di
improvvisazione. Successivamente, passerò a esplorare le modalità attraverso le quali ogni
città contemporanea tende a diventare un luogo di confine, una zona di contatto, o almeno un
luogo in cui insider e outsider si fronteggiano. Passerò poi a riflettere sulla tendenza che vede
la città come luogo selvaggio, un territorio insicuro e pericoloso, dove talvolta il
comportamento umano diventa animalesco.
La frontiera come progetto
Naturalmente il mito della frontiera, nella cultura americana, è iniziato con la sua
identificazione con i territori selvaggi, in antitesi con la città. Se scegliamo di tralasciare le
fonti della cultura popolare, più scontate e vicine a noi, possiamo altresì ispirarci
all’autorevole analisi elaborata più di cent’anni fa dallo storico Frederick Jackson Turner
(1893/1961). Secondo quest’ultimo, la frontiera in movimento era un luogo di opportunità:
un’immensità selvaggia che si trasformava in territorio libero da sfruttare, dove i coloni erano
autosufficienti, ma potevano formare comunità senza i vicoli delle tradizioni e delle
disuguaglianze che si erano lasciati alle spalle, senza il peso del passato. Lo scenario delineato
2
da Turner non è scevro da critiche: alcuni commentatori l’hanno interpretato come uno
strumento simbolico all’interno del dibattito culturale americano che vedeva contrapposti
quelli che, all’inizio del secolo scorso, erano l’Est sviluppato e il West in trasformazione.
Inoltre, forse nemmeno la frontiera nordamericana fu mai davvero così come la descrive
Turner; con l’emergere di una storia socio-culturale comparata delle frontiere si sono delineati
scenari alquanto variegati. Queste complessità non devono però distoglierci dalla nostra
esplorazione; ciò che importa è che nel vocabolario americano, da Turner al Presidente John
F. Kennedy con la sua New Frontier degli anni 1960, l’idea della frontiera ha continuato a
mantenere connotazioni e significati positivi, per la sua capacità di puntare al futuro e di
evocare un habitat di opportunità che persone sufficientemente abili e disposte a impegnarsi
potevano plasmare a piacimento.
Ritengo che sia proprio questo l’ habitat che gran parte degli esseri umani vengono a cercare
nella città, più di quanto sia possibile trovare in un luogo selvaggio. Questo mi richiama alla
mente un saggio intitolato “Soft City” (1974) dello scrittore inglese Jonathan Raban, nel quale
l’autore afferma che le città, a differenza dei villaggi e dei paesi, sono per natura plastiche.
Potete decidere chi volete essere e tutt’attorno la città assumerà la forma fissa a voi più
consona. Nel decidere che cos’è la città, trasparirà la vostra identità umana. La città sembra
qui diventare uno spazio ludico, oppure, passando dallo storico Frederick Jackson Turner
all’antropologo Victor Turner (1974), un’area di liminalità.
In questi termini, tuttavia, potrebbe sembrare che la città soft di Raban, nel suo essere un
habitat malleabile per giochi d’identità, sia soprattutto un luogo adatto a persone
ragionevolmente benestanti, con un potere sufficiente a imporre la propria volontà
sull’ambiente materiale e sociale circostante, o in grado di scegliere in esso ciò che trovano
interessante: un lavoro, un luogo in cui vivere, una cerchia di amicizie, passatempi, o altre
amenità. Da un certo punto di vista potrebbe essere effettivamente così. Eppure mi rendo
conto, con una punta di sorpresa, che questa prospettiva della vita urbana viene evocata in
un’opera recente di AbdouMaliq Simone (2004) sulle città d’Africa; possiamo presumere che
le condizioni descritte da Simone nella sua vivida etnografia urbana e nella sua incisiva
analisi siano molto più tipiche di ciò che vivono le grandi masse urbanizzate di oggi di quanto
non lo fossero per i londinesi di Jonathan Raban. Per molti di questi africani urbanizzati, la
migrazione verso le città porta con sé un raggio di speranza, forse anche l’ultima, quella di
sfuggire alla povertà rurale, alla stagnazione o al degrado. Simone sottolinea anche che le città
africane contemporanee sono realtà in cui regnano incontrastate condizioni di emergenza
personale più o meno continue. Sono situazioni in cui il passato è diventato immateriale, le
risorse da esso offerte sono inadeguate, dove in un certo senso resta ben poco da ricordare. Il
concetto di emergenza evoca inoltre l’idea di qualcosa che sale in superficie, che si palesa,
nuovi pensieri e pratiche in divenire. Come nella frontiera di Frederick Jackson Turner,
seppure in condizioni di maggiore sovraffollamento, individui molto diversi tra di loro
possono stringere alleanze con spirito di collaborazione, per finalità specifiche, senza curarsi
troppo di quelle consuetudini sociali che, in circostanze più stabili, li avrebbero separati e
tenuti a debita distanza gli uni dagli altri .
Come nella città soft di Raban, la vita descritta da Simone nelle città dell’Africa sub-sahariana
sembra diventare un progetto e, di solito, un progetto individuale a scala ridotta. Se ogni stile
di vita umano richiede una misura di routine e un’altra di improvvisazione, qui
l’improvvisazione la fa da padrona. Simone ci mostra la presenza di un senso profondo della
forma e delle dinamiche delle reti sociali. Non ci sorprende quindi che i legami di parentela si
rivelino essere le relazioni più durature ed affidabili, pur richiedendo un’abile gestione per
3
non trasformarli in un peso; altrimenti, i legami sembrano costruirsi, spezzarsi, per poi di
nuovo ricomporsi. Se si riscontra anche in questo caso un interesse nei confronti delle
identità, sembra finalizzato principalmente ad affermarle, rafforzarle o celarle con l’obiettivo
tangibile di restare a galla. Questa attività si manifesta soprattutto nel settore informale
dell’economia, che tende a crescere sia in termini relativi che assoluti. Esistono certo
differenze tra le città che Simone conosce intimamente, connesse come sono a specifiche
storie politiche ed economiche, ma in generale sembrano avere in comune il fatto che, ancora
come la realtà della frontiera, i loro abitanti sono per così dire lasciati in balia di se stessi. Lo
stato sembra essere scarsamente presente, offre loro ben poco in materia di protezione o di
interesse per il loro benessere. Potrebbe essere visto come predatore, uno stato che interviene
nelle loro vite in maniera imprevedibile, ma dal quale è possibile spesso tenersi alla larga.
Mi colpisce che Simone faccia ripetutamente ricorso alla metafora del ”navigare”. Gli abitanti
delle città africane di cui parla devono compiere sforzi costanti per fissare la rotta della loro
vita. Come afferma l’autore in un’altra definizione degna di nota, essi “si preoccupano di
quali giochi, strumenti, linguaggi, linee d’orizzonte, costruzioni e oggetti possano attivare per
anticipare nuovi allineamenti di iniziative e risorse sociali, e quindi di capacità” (Simone
2004: 11). Ovviamente, ”navigare” potrebbe essere considerata una metafora troppo
marinaresca per accostarla all’idea di ”frontiera”. Eppure, ciò che questi due termini hanno in
comune potrebbe essere il senso di imprevedibilità, della necessità di dover restare sempre sul
chi vive, poiché segni importanti vanno e vengono, sempre in movimento, nelle terre
selvagge, in mare e nella città.
Esistono sicuramente città prive di quelle qualità che ne fanno uno scenario consono ai
progetti di vita variabili e in movimento a cui ho fatto cenno: città che sembrano macchine,
”città hard”, forse, che impongono le proprie strutture su esistenze ed identità, lasciando ben
poco spazio di manovra. Anche in questo caso dovremmo forse esplorare il ventre molle di
questa durezza, gli interstizi che gli abitanti intenzionati a perseguire i propri obiettivi
potrebbero tentare di scoprire e coltivare. Potremmo anche chiederci chi siano veramente i
soggetti più propensi e inclini a percepire la città nell’ottica della frontiera. Appare probabile
che si tratti in gran parte di giovani, con tanti progetti davanti a loro, con abitudini meno
radicate e reti più mobili, più preparati ad affrontare l’imprevisto.
Un posto sul confine
Passerei ora al mio secondo punto di osservazione, che esplora l’idea di città come luogo sul
confine, come punto di contatto. Ovviamente sono esistiti confini che non erano affatto zona
di contatto, ma piuttosto il suo esatto contrario. Berlino è stata costretta a vivere per quasi
trent’anni con un confine tracciato al suo interno, proprio allo scopo di demarcare una zona di
non contatto. Tralasciamo questo caso specifico e iniziamo con una prospettiva temporale a
lungo termine. Nella storia dell’urbanesimo mondiale, un tempo è stato possibile fare una
distinzione tra due principale tipologie di città, con ruoli culturali diversificati. Circa mezzo
secolo fa gli antropologi Robert Redfield e Milton Singer (1954) descrissero le città in base
alla loro trasformazione culturale di tipo ortogenico, o eterogenico. Le città ortogeniche, ben
rappresentate agli inizi dell’urbanesimo, erano creazioni interne, composte da centri simbolici,
che nascevano a partire da un affinamento della tradizione delle circostanti società contadine.
Le città eterogeniche erano popolate da abitanti di origini culturali diverse, solitamente
rimossi dai loci indigeni delle rispettive culture. Si trattava quindi di città dei territori di
4
confine, anche se non sempre in senso politico, ma culturale. Gli esempi riportati da Redfield
e Singer erano soprattutto grandi città portuali: Londra, New York, Bombay, Singapore,
Shanghai, Yokohama.
Potrebbero ancora esistere delle città con caratteristiche ortogeniche, in qualità di santuari
nazionali. Gerusalemme si trova nella condizione estremamente complessa di essere
contemporaneamente sia ortogenica che eterogenica. Ma attualmente, negli anni a cavallo tra
il XX e il XXI secolo, non riusciamo a identificare un centro urbano importante che non sia
una città eterogenica, nel senso di città di frontiera. Anzi, fu proprio in uno dei centri portuali
più importanti del mondo che sessant’anni fa accade qualcosa che potrebbe simboleggiare la
trasformazione che da quel momento hanno conosciuto quasi tutte le città d’Europa: l’arrivo
del piroscafo Empire Windrush a Tilbury, fuori Londra, il 21 giugno 1948, con il primo carico
di speranzosi emigranti giamaicani in Gran Bretagna. In parte questo cambiamento ha avuto
luogo nel periodo tardo-coloniale o post-coloniale, quando alcuni imperi si rifiutarono di
andarsene, o piuttosto di starsene alla larga. In particolare, mentre gli imperi britannici e
francesi venivano smantellati, gli abitanti di quei territori lontani arrivarono in massa a
bussare alle porte della loro presunta madrepatria, la Gran Bretagna e la Francia, in
particolare, ma certamente anche l’Olanda, il Belgio, l’Italia e il Portogallo. Anche altrove si
sono verificati flussi analoghi di nuovi arrivi, di emigranti in cerca di lavoro e di rifugiati,
venendo così a creare società e in particolare città che sono in un modo o nell’altro e
inevitabilmente “multi-“: multiculturali, multietniche e anche multirazziali. E chiaramente
oggi è poco rilevante sapere se le città che diventano eterogeniche, secondo l’analisi di
Redfield e Singer, siano collocate su una linea di confine politico, o sul mare. In ogni caso,
una città con un aeroporto internazionale è di frontiera: tutti i confini del mondo si
intersecano, per così dire, nel cielo sopra di essa. È inoltre probabile che questo si rifletta sulla
costellazione dei suoi abitanti; ma oltre a ciò, oggi la città è tipicamente un luogo sul/di
confine, dove si incontrano coloro che in una certo senso sono, o sono stati, insider e outsider.
Ed è così non soltanto in Europa, ma in tutto il mondo.
Non sono in grado di tracciare una mappa di tutte le situazioni, gli eventi, le esperienze e le
relazioni che si sviluppano sulle frontiere urbane che stiamo trattando qui. Mi limiterò a
indicare alcune di queste realtà e possibilità. Ovviamente, si sono sviluppati processi di
formazione e di riconfigurazione di gruppi diversi. Gruppi nazionali, regionali o etnici con
origini più o meno comuni si sono ritrovati insieme nel nuovo habitat, per costituire nuove reti
e nuove istituzioni interne e probabilmente per cercare un riconoscimento esterno. Questo
appare evidente se consideriamo il fatto che oggi le città vengono percepite come entità
“multiculturali”. Per quanto riguarda l’organizzazione più o meno informale della vita
quotidiana del gruppo, sospetto che questa tenda ad assumere significati analoghi e condivisi
quasi ovunque, con la messa in gioco di relazioni di parentela, di amicizia, di buon vicinato,
di piccola imprenditoria e con livelli di fiducia e di controllo sociale. È molto più probabile
invece che venga ad assumere significati molto differenziati su un piano pubblico e formale,
dato che le autorità e le agenzie cittadine devono decidere come agire in materia di
“multiculturalismo”, inteso qui come una problematica su ampia scala che tocca le politiche e
l’amministrazione. Non posso vantare una conoscenza dettagliata e comparativa di questo
fenomeno, ma sembra che siano stati adottati approcci differenziati per affrontare queste
tematiche di ordine politico, se prendiamo, ad esempio, quanto avviene in Gran Bretagna, in
Francia e in Germania. È possibile che la diversità di approcci per gestire il problema delle
nuove frontiere urbane alla fine del XX secolo si rifaccia in qualche modo alle diversità che
ancora permangono su come anche le società più allargate si percepiscono come nazioni. Mi
sembra che esistano dei parallelismi tra gli approcci adottati rispettivamente da Gran Bretagna
5
e Francia in materia di immigrazione e di minoranze e la loro politica di amministrazione
coloniale in un’epoca precedente: l’una privilegiava il governo indiretto, l’altra era piuttosto
incline a perseguire una missione civilizzatrice di stampo repubblicano e più assimilativo. Va
osservato comunque che, soprattutto nei paesi in cui mancano antecedenti storici per
affrontare la diversità di gruppo, si riscontra una maggiore apertura nei confronti di una
diffusione transnazionale di modelli di multiculturalismo. Mi colpisce come il mio paese, la
Svezia, con un passato di relativa omogeneità e con un apparato politico-amministrativo
centralizzato, a un certo punto abbia modificato molto rapidamente il proprio approccio nel
gestire una popolazione crescente di nuovi arrivati, in particolar modo nelle città, in
corrispondenza con la diffusione di nuove idee sul multiculturalismo e sul riconoscimento di
gruppo, attraverso i media e altri canali dal mondo esterno.
Potrei anche aggiungere di non essere molto convinto che le strutture di governo e
amministrative di grandi dimensioni, a livello statale o cittadino, dispongano di strumenti
sufficienti a gestire le problematiche della diversità umana alle quali fa riferimento un termine
come multiculturalismo. Abitudini, preferenze personali, relazioni e identità, che in larga
parte rientrano nel campo della cultura e della differenza culturale, nella vita reale si rivelano
spesso concetti alquanto fluidi e negoziabili, su un piano informale su scala ridotta, ma non
necessariamente si prestano a una logica amministrativa basata sui grandi numeri e che
richiede categorie stabili, socialmente amalgamate. e sistemi di regole formali. La diversità
culturale sulla frontiera urbana potrebbe talvolta funzionare meglio senza il multiculturalismo.
Non v’è dubbio che le politiche multiculturali sono state spesso animate dalle migliori
intenzioni, da sentimenti, ragionevolmente generosi, di estendere il riconoscimento sociale in
risposta a bisogni e richieste specifiche di gruppi di nuovi entrati e delle minoranze. Forse
anche per questo, politiche di questo genere hanno talvolta contribuito a generare un altro
fenomeno che a sua volta si è auto-riprodotto nelle realtà di frontiera sviluppatesi tra la fine
del XX secolo e gli inizi del XXI secolo. Le popolazioni locali non hanno sempre accolto
positivamente i nuovi entrati stranieri, né tanto meno hanno sostenuto le politiche di apertura
nei confronti degli emigranti o la concessione ad essi di una serie di diritti generalizzati. Alle
reazioni più negative sono stati affibbiati diversi appellativi: xenofobia, populismo di destra,
razzismo culturale, neonazionalismo. Le forme più visibili di reazione si sono manifestate in
movimenti organizzati e in partiti politici, ma anche in azioni estreme di violenza collettiva e
atti di terrorismo individuali.
Troviamo queste reazioni nelle città, ma non solo; in effetti sembra che i rappresentanti delle
minoranze si sentano molto più al sicuro nelle grandi città, che in quelle piccole e medie, e
che quindi esitino ad avventurarsi in queste comunità. Abbiamo assistito purtroppo
all’emergere di reazioni di questo genere non solo in Europa. Forse vengono alimentate dal
senso di minaccia che serpeggia tra gli autoctoni, i vecchi insider, che temono di essere
trasformati in outsider; che la loro casa diventi un territorio alieno, o direttamente confinante
con esso, e quindi di essere esposti a rischi. Negli ultimi anni ci siamo imbattuti in Europa in
nuovi slogan semi-geografici e distopici, che sembrano suggerire che all’interno delle nostre
città si stiano formando nuovi territori e paesi – “Londonistan”, “Eurabia”. L’origine precisa
di questi epiteti sembra oscura; devono necessariamente essere balenati nella mente di
qualcuno; spesso appaiono accostati a programmi politici e culturali specifici. Eppure, proprio
perché solleticano l’immaginazione, per il fatto di iniziare da ciò che è familiare e di
terminare con ciò che ci è alieno, potrebbero essere assunti in maniera più generalizzata ed
entrare a far parte di un vocabolario più esteso nel gergo della frontiera. L’estate scorsa
quando “Eurabia” è stata l’oggetto dell’articolo di copertina di The Economist (24 giugno
6
2006), il settimanale pubblicato in Inghilterra ma con un’ampia tiratura oltreoceano, si è
trattato forse dello sdoganamento pubblico di un termine che in precedenza era apparso
soltanto in oscuri blog e siti web.
Sia “Eurabia” che “Londonistan”, ovviamente, indicano una frontiera particolare, che traccia
una linea di demarcazione tra “l’Occidente”, l’Europa, sia cristiana che laica, da un lato, e i
mussulmani dall’altro. Si presume che l’Eurabia si sviluppi a seguito della rapida crescita
della popolazione in Nord Africa e Medio Oriente che finisce per tracimare nelle città
europee. “Londonistan” si ispira ovviamente al fatto che l’immigrazione extra-europea nel
Regno Unito ha interessato non soltanto gli abitanti dei Caraibi, il cui arrivo è legato
storicamente all’Empire Windrush, quel primo piroscafo carico di emigranti, ma soprattutto
gli individui provenienti dal sud-est asiatico e in particolare dal Pakistan, sebbene il termine
evochi un’immagine più generalizzata di lontane terre esotiche e selvagge.
Appare quindi chiaro come in Europa i crescenti sentimenti di ostilità nei confronti degli
immigranti tendano a concentrarsi in maniera più precisa e focalizzata sull’islamofobia. Gli
eventi dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti – “nine-eleven” – hanno sicuramente avuto dei
riflessi rilevanti anche sulle nostre sponde dell’Atlantico, ma hanno anche conosciuto una loro
controparte in Europa, forse non meno drammatica – a Madrid, a Londra. Più localmente, ma
in maniera ricorrente, sorgono controversie sull’integrazione dell’Islam nel tessuto della vita
quotidiana degli europei, su temi quali la costruzione di moschee e il velo. È alquanto difficile
determinare quale spazio occupino effettivamente queste controversie nella vita individuale e
privata di gran parte degli europei, siano essi autoctoni, migranti o discendenti di migranti.
Eppure non possiamo trascurare l’immagine pubblica del conflitto e del sospetto che ha
trovato una certa eco sulla carta stampata e sui media in generale, con “lo scontro di civiltà”
come concetto fondante, e con termini quali “Eurabia” e “Londonistan” ad ampliare il
repertorio.
Pur tuttavia è fin troppo semplicistico interpretare i territori di confine sociale e culturale tra
autoctoni e nuovi giunti, siano essi musulmani o no, come luoghi di un unico scontro tra
blocchi omogenei. Un’immagine leggermente più sfumata, fatta di frammenti e fazioni,
potrebbe rivelarsi più utile alla nostra comprensione. Gli incontri tra gruppi, e la risposta a
questi incontri, plasmano le linee di demarcazione interna ai gruppi, o gettano su di esse una
nuova luce, impedendo che altrimenti possano passare inosservate. Recentemente ho letto il
libro della giornalista inglese Melanie Phillips, intitolato proprio Londonistan (2006), e ho
scoperto che una parte consistente non è dedicata alla presenza musulmana e islamica nelle
città britanniche, ma alla descrizione, alquanto partigiana, di una guerra culturale interna tra
gli inglesi, nella quale, secondo l’autrice, è proprio l’etica laica, razionalista ed egalitaria delle
elite politiche, educative e persino religiose della Gran Bretagna ad aver reso la nazione
impotente e indifesa davanti a un’islamizzazione strisciante. Si tratta certamente di
un’argomentazione che trova una corrispondenza nel pensiero neonazionalista in molti paesi,
laddove esistono individui che ritengono che posizioni critiche nei confronti di ciò che un
tempo sembrava appartenere a una verità eterna e incontestabile rasenti il tradimento.
Si finisce altresì per riscontrare analoghe e corrispondenti separazioni interne, che assumono
talvolta manifestazioni tragiche, anche nelle realtà dei nuovi arrivati e delle minoranze.
Alcuni di essi, forse molto più di altri, sono in grado di percepire nuove opportunità, nuove
alternative, in presenza di un paesaggio sociale e culturale diverso. Non va dimenticato che gli
ordini culturali tendono a costituirsi sulle premesse di una distribuzione specifica di potere e
di beni materiali; quando tali distribuzioni mutano, possono emergere differenze di opinione e
7
di valutazione che prima erano rimaste più o meno celate. Possono pertanto evidenziarsi più
facilmente in ambiti che toccano le relazioni tra i sessi e gli aspetti intergenerazionali. Se
solitamente i giovani sono più propensi a vedere le città come entità soft, come spazi per
realizzare i propri progetti di vita e inventarsi come individui, forse non si può dire altrettanto
di coloro che, sulle frontiere urbane, intravedono percorsi diversi da quelli seguiti dei loro
padri e dalle loro madri, quelli che spesso etichettiamo come “seconda generazione”. Ecco
dunque che può nascere il conflitto, all’interno di contesti esistenziali più intimi e personali
che toccano gli stili di vita, le mode, le scelte professionali e dei partner e, più in generale, i
concetti di autorità e rispetto. E ciò che di solito appartiene alla sfera del privato, esplode,
talvolta drammaticamente, nell’arena pubblica, quando i giornali riportano a titolo cubitali di
un altro rapimento, di un altro delitto d’onore, perpetrati nei territori di confine culturale.
Non dobbiamo tuttavia interpretare in termini di scontro e conflitto tutto ciò che accade
all’interno e attraverso gli incontri culturali che avvengono lungo la frontiera urbana. Vorrei
introdurre ora il concetto di cosmopolitismo, un termine che porta con sé un pesante bagaglio
storico di significati differenti legati a luoghi e periodi diversi, ma certamente legato alla città
e alla vita urbana. In realtà appare evidente che per moltissimo tempo due significati hanno
coesistito insieme sotto quest’unica etichetta. Nel primo, con cosmopolitismo si fa riferimento
a questioni più politiche e civiche, che evocano uno spirito di responsabilità che travalica le
linee di demarcazione abbracciando l’umanità nella sua interezza. Negli ultimi tempi è questo
il significato di cosmopolitismo che si trova maggiormente al centro dell’attenzione. Ha
suscitato l’interesse di alcuni esponenti politici, ma anche di teorici politici e di filosofi. Non è
difficile evidenziare le ragioni di questo interesse, che richiamano a una realtà sempre più
connotata globalmente, accompagnata da una crescente presenza di problemi che sembrano
richiedere interventi e organizzazioni che superano i confini nazionali, tra cui ad esempio la
questione ambientale e i diritti umani. Eppure, mentre i concetti di cosmopolitica, per adottare
un termine sintetico, acquisiscono un crescente primato a partire dagli anni 90 del secolo
scorso, appare chiaro, a mio parere, quanto abbiano a che fare con la fine della guerra fredda.
Almeno per qualche tempo, è parso possibile organizzare il potere e la responsabilità in modo
nuovo, per trascendere i confini e considerare l’umanità come una comunità di cittadini del
mondo. Eppure tra i teorici politici e i filosofi che hanno dibattuto sulle potenzialità del
cosmopolitismo, è molto diffusa la sensazione che, rispetto al patriottismo o al nazionalismo,
esso sia simbolicamente debole e culturalmente superficiale. Inoltre è spesso ritenuto un tema
che riguarda soltanto le elite; il presupposto è che soltanto un gruppo molto ristretto e
privilegiato con a disposizione la sicurezza materiale, l’esperienza ed orizzonti
sufficientemente ampi, possa assumere il tema del cosmopolitismo.
Esiste però un secondo significato di cosmopolitismo. Nel contesto urbano, è possibile che il
termine venga spesso utilizzato in senso lato, per riferirsi semplicemente alla diversità, alla
varietà di persone e stili di vita che si trovano nelle città, e in alcune più di altre. Adottato in
maniera più restrittiva, tuttavia, “cosmopolitismo” significa non soltanto la diversità in se
stessa, ma anche un’apertura, una posizione precisa nei confronti della diversità. In una forma
più pronunciata, tale apertura diventa materia per valutare la diversità di per se, per esplorare
musiche nuove, nuove cucine, nuove persone per puro diletto personale. Eppure,
indipendentemente dal fatto che un tale apprezzamento della diversità esista o meno, molto
spesso il cosmopolitismo viene inteso in termini di abilità nel gestire la diversità, nel vivere la
propria esistenza. Tale abilità può comportare una conoscenza specifica, una sorta di ricetta
pratica per affrontare determinate situazioni che si manifestano nei contesti più disparati,
oppure può trattarsi di una preparazione più generalizzata per affrontare sfide nuove e
8
scarsamente familiari e gestirle in maniera più flessibile, il che richiede una certa dose di
fiducia nella propria capacità di muoversi in questa direzione.
Qual è la relazione esistente tra queste due definizioni di cosmopolitismo, una più politica,
l’altra più culturale ed esperienziale? Sembra alquanto improbabile che possano coesistere
insieme. È tuttavia degno di nota, a mio parere, osservare come spesso i commentatori
abbiano trascurato la possibilità di un collegamento tra queste due forme di cosmopolitismo.
Coloro che ritengono il cosmopolitismo politico troppo superficiale dal punto di vista
culturale, troppo puramente filosofico, sono apparsi inclini a confrontarlo con un tipo di
nazionalismo di forte spessore culturale, denso di simbolismo e di grande profondità storica,
capace di generare un forte spirito di identificazione, accompagnato però da ovvie tendenze
fortemente escludenti e generatrici di conflitti. È utile, a mio parete, portare a paragone un
altro concetto di nazionalismo e un’altra, e corrispondente, visione di cosmopolitismo.
Un po’ più di un decennio fa, lo psicologo politico Michael Billig (1995) identificò un genere
di nazionalismo contemporaneo, forse caratteristico di società particolarmente stabili e
prospere: il cosiddetto "nazionalismo banale," in gran parte benigno, basato su pratiche
ricorrenti ed esperienze di vita quotidiana, che servono a definire cosa significhi appartenere a
uno stato-nazione. Diversi commentatori hanno recentemente avanzato l’ipotesi che ci sia
spazio per il concetto parallelo di “cosmopolitismo banale”, che si rafforza quando la gente si
sente ragionevolmente a casa propria nel mondo, visto che gli incontri e gli impegni ricorrenti
con l’alterità non sono definiti dal sospetto e dalla paura, ma da un certo grado di fiducia nella
propria capacità di gestire la situazione e da riconoscimento e fiducia reciproci. In effetti,
questo cosmopolitismo banale sembra essere alquanto diffuso, pur senza molto clamore, non
necessariamente sotto forma di un attivismo sociale o politico di alto profilo, e senza
guadagnarsi i titoli dei giornali, ma in costante crescita, dato che un numero crescente e
disparato di persone ha esperienze lavorative, stringe nuovi legami di amicizia e di parentela,
incontra interessi e sfide memorabili in luoghi caratterizzati dalla possibilità di incontro con
ciò che all’inizio è culturalmente alieno. Forse è un peccato che un cosmopolitismo banale di
questo genere, o anche un cosmopolitismo a orientamento culturale ed esperienziale in
generale, siano sempre descritti come cosmopolitismo, dato che il suffisso “-ismo” tende a
evocare un programma, un’ideologia, un movimento più o meno organizzato. Sarebbe meglio
parlare di cosmopolitaneità, uno stato mentale e un insieme di pratiche alquanto routinarie.
Eppure, questa cosmopolitaneità potrebbe mostrarsi capace di offrire a un cosmopolitismo più
partecipato quella risonanza culturale che i teorici politici non hanno scoperto, o di cui non si
sono ancora accorti. E sembrerebbe logico che la città come frontiera, con la presenza di
grandi diversità, la coesistenza quotidiana di molti gruppi e stili di vita, si riveli il luogo più
promettente in cui ricercare il cosmopolitismo banale, la cosmopolitaneità.
Quando si scrive sul tema del cosmopolitismo, si presume spesso che i cosmopoliti siano dei
viaggiatori, che acquisiscono la loro esperienza della diversità e la loro capacità di gestirla,
muovendosi da un luogo all’altro. L’idea che facciano parte di un’elite privilegiata è
indubbiamente collegata a questo presupposto. Ovviamente il fatto che soltanto le elite siano
mobili, mentre tutti gli altri sono sedentari non corresponde più alla realtà, se anche lo fosse
stato in passato. Come tuttavia viene spesso evidenziato, oggi le persone, soprattutto nelle
città, possono diventare cosmopolite anche senza viaggiare.
Eppure è possibile che il cosmopolitismo non si sviluppi automaticamente in tutte le realtà in
cui si concentrano in gran numero persone con caratteristiche e background diversi. Alcuni
habitat urbani sono talvolta più cosmopoliti di altri. Robert Park (1952: 47), padre fondatore
9
della scuola di sociologia urbana di Chicago, ha ipotizzato in una definizione ormai classica
che la città potrebbe essere vista come "un mosaico di piccoli mondi che si toccano, ma non
si compenetrano." La metafora del mosaico è ricorrente nelle rappresentazioni della diversità,
globale o urbana, ma può rivelarsi spesso fuorviante. Uno studioso che ha recentemente
affrontato questi temi è il famoso etnografo urbano Elijah Anderson (2004), che ha prestato
gran parte della sua attenzione alla vita di strada degli afro-americani nelle città statunitensi.
In un saggio intitolato “The Cosmopolitan Canopy”, la sua analisi si sviluppa partendo
dall’osservazione di quanto avviene nel Reading Terminal Market, a Filadelfia, la sua città
natale. Il mercato, che si trova in uno spazio che originariamente era occupato da un enorme
deposito ferroviario, gode di una posizione centrale e al suo interno si trovano negozi,
ristoranti e chioschi che offrono una grande varietà di merci e servizi. I commercianti e in
generale la gente che vi lavora provengono da realtà molto diverse che in un certo senso si
rispecchiano nella mercanzia che offrono. I visitatori sono afro-americani, asiatici e bianchi di
diversa provenienza.
Come suggerisce la metafora della “copertura cosmopolita” di Anderson, il Reading Terminal
Market fornisce una sorta di cupola protettiva (ma anche, a quanto pare, attraente) sotto la
quale la gente interagisce, può rilassarsi e sentirsi più sicura e a proprio agio. Anche se le
persone si trovano tra estranei, in gran parte diversi da loro, hanno la possibilità di osservarli
con discrezione, cogliere frammenti di una conversazione, o iniziare un fugace e amichevole
scambio di convenevoli. Si possono trovare adolescenti in gruppo, pensionati, impiegati che si
ritrovano per il pranzo, senza-tetto che cercano un rifugio, cibo e la possibilità di accedere a
servizi igienici gratuiti, con la presenza discreta degli addetti alla sorveglianza. Potrete
sicuramente imbattervi in una donna cinese seduta in una pizzeria e in una famiglia italiana
che assaggia il sushi.
Anderson passa poi a identificare alcuni contesti di Filadelfia che offrono un’analoga
copertura cosmopolita, sebbene su scala più ridotta. Sotto queste cupole cosmopolite,
l’osservazione della gente diventa una sorta di esercizio individuale di “etnografia popolare”.
Si può imparare “come sono le persone” e “come funzionano le cose”, dare un senso alla
propria città. Come conclude Anderson (2004: 29), quando le persone sono ripetutamente
esposte a ciò che non è loro familiare in circostanze di questo tipo, “hanno l’opportunità di
crescere, di espandersi mentalmente, emotivamente e socialmente”. Il punto è, come
suggerisce l’autore, che questi contesti consentono alle persone di condividere uno spazio
comune in maniera civile, senza i sentimenti di paura e di sfiducia prevalenti in molte realtà
urbane negli USA, in particolare lungo lo spartiacque razziale.
Ciò che l’etnografia di Elijah Anderson evoca è che, al posto dei contorni netti e del disegno
statico di un mosaico, l’ambiente cosmopolita come contesto formativo permette o facilita il
processo che rende i confini più indefiniti e confusi. Il cosmopolitismo comporta apertura.
Le città sono dunque destinate a diventare sempre più cosmopolite, più distintamente
caratterizzate sia dalla diversità che dall’apertura? Per quanto si possa parteggiare per il
cosmopolitismo come qualità desiderabile per le città, non possiamo dare per scontato che
assisteremo sempre e comunque a una sua inevitabile crescita. Gli ambienti urbani strutturati,
composti da attrazioni attentamente miscelate e misurate, che le industrie dell’esperienza
sembrano preferire, riguardano soltanto una diversità Ersatz, un surrogato di cosmopolitismo,
una facciata dietro alla quale gli esploratori non possono spingersi. I territori e le comunità
protetti informalmente, in nuove e vecchie forme, limitano l’apertura e tendono a
circoscrivere il cosmopolitismo. L’apertura data dal cosmopolitismo si costruisce soprattutto
10
sulla fiducia e la sicurezza, ma l’opposto di questi sentimenti è spesso la paura; paura e
l’allarme sociale indotto non sono poi così insoliti in contesti di diversità urbana.
La città come territorio selvaggio
In conclusione, vorrei trattare il terzo tema, quello della città come territorio selvaggio, la
giungla. In un certo senso siamo ritornati alle frontiere di cui parlava Frederick Jackson
Turner: i nuovi coloni forse non hanno trovato uno spazio vuoto, ma anche se fosse abitato da
esseri umani, questi ultimi apparirebbero comunque come selvaggi. Dal punto di vista
dell’immaginario della frontiera, con ogni probabilità non sarebbero percepiti come nuovi
vicini amichevoli, ma come selvaggi, bestie pericolose. Anche nelle frontiere urbane
contemporanee, gli abitanti delle città si preoccupano talvolta che tra la folla che li circonda, o
da qualche parte in una strada buia e solitaria, possano sbucare delle bestie umane. E a tutto
ciò si accompagna l’idea della città come luogo pericoloso, in cui si obbedisce soltanto alla
legge della giungla.
Ovviamente, il più delle volte la città non è pericolosa. Considerando le enormi potenzialità di
caos dei contesti urbani, la vita sociale nei luoghi pubblici può effettivamente apparire
straordinariamente ordinata. Ho fatto ricorso all’espressione “relazioni di traffico” per
indicare quelle caratteristiche relazioni urbane che assomigliano molto alla mancanza totale di
relazioni, quelle che intercorrono tra persone che incrociamo per strada, sul marciapiede, che
siedono accanto a noi al cinema, o stanno dietro di noi in fila (Hannerz 1980). Secondo
Erving Goffman (1961), potremmo descriverle come “co-presenze non focalizzate”. Laddove
si riuniscono numerose persone insieme in uno spazio ristretto, come nelle città, esse devono
tenere in considerazione, anche in minima parte, la propria reciproca presenza, semplicemente
per coesistere, in maniera ragionevolmente efficace e senza troppi inconvenienti. Così, nelle
relazioni di traffico, le persone evitano di urtarsi, come i pedoni o gli automobilisti che si
fermano al rosso, e, almeno in alcune società, invece di permettere che si formi una ressa
incontrollata, si dispongono in fila, in attesa di entrare o di essere serviti. Ciò fa parte
dell’educazione urbana di base, che solitamente è sufficiente a tenerci fuori dai guai e a
rendere la città diversa da un luogo selvaggio.
Di solito si presuppone una reciprocità nelle relazioni di traffico: ci si aspetta che tutti
preferiscano mantenerle ridotte al minimo, limitate, non focalizzate. Tuttavia, le relazioni di
traffico possono comportare una sorta di scansione e al loro interno si riscontra sempre la
possibilità di una conversione in qualcosa d’altro. Ci si può soffermare a osservare più da
vicino qualcuno che ci passa accanto, oppure cercare un’occasione per relazionarsi al
prossimo in maniera meno fugace, trasformando gli estranei in conoscenti o perfino in amici.
Ciò può svilupparsi in modo più simmetrico o asimmetrico. Il flaneur, una figura che
conosciamo anche grazie alla Berlino descritta da Georg Simmel un secolo fa, si è già
subdolamente allontanato da una mera relazione di traffico, dato che il suo osservare rimane
in gran parte inosservato, in incognito. Tuttavia egli è essenzialmente innocuo, nel suo
assumere una posizione distaccata e in gran parte estetica nei confronti di chi o cosa lo
circonda. D’altra parte, ci possono essere persone che desiderano, forse perché
improvvisamente ne scoprono l’inclinazione, di sconvolgere le relazioni di traffico,
trasformandole in relazioni tra predatore e preda. Queste sono le persone che abbiamo in
mente quando percepiamo la città come luogo selvaggio.
11
Alcuni propendono maggiormente per questi comportamenti, altri meno, ma non dovremmo
ritenerli soltanto frutto della nostra immaginazione. Molto tempo fa, in quella che
probabilmente fu una delle prime conferenze dedicate alla branca emergente di antropologia
urbana, presentai la prima versione di un contributo dedicato a ciò che descrissi come “The
Management of Danger”, la gestione del pericolo. All’epoca, ritenevo che, considerando il
nuovo interesse degli antropologi per le città, essi sembravano restringere, alquanto
prematuramente, gli ambiti della loro ricerca ed enfatizzare nella vita di città ciò che
paradossalmente si avvicinava più al villaggio, invece di esplorare proprio le caratteristiche
tipicamente urbane, o almeno quelle che erano considerate tali. Il pericolo in luoghi pubblici
ne è sicuramente una componente.
Gli atti di quella conferenza non sono mai stati pubblicati e quell’articolo è rimasto sulla mia
scrivania per parecchio tempo prima che mi decidessi di darlo alle stampe (Hannerz 1981).
Quando lo feci, ebbi l’opportunità di aggiungere un paio di paragrafi dettati dall’esperienza
che avevo vissuto qualche mese dopo la prima presentazione dell’articolo. Mentre camminavo
lungo una strada trafficata di Kingston, in Giamaica, in pieno giorno, sono stato assalito. Uscii
da quell’incontro urbano con una ferita superficiale di coltello dietro al collo e con la
realizzazione che, per ironia della sorte, una piccola banda di ragazzini aveva trovato
involontariamente una vittima esperta e generosamente offerto ad essa uno studio di caso.
Evidentemente non ero esperto abbastanza, perché mi ero trasformato in vittima. Un attimo
prima dell’aggressione, mi ero infatti rammaricato per il fatto che, camminando
soprappensiero a un’andatura leggermente più spedita, avevo superato quei ragazzi. Mi resi
infatti conto che sarebbe stato più furbo averli davanti e non dietro di me. E in quel breve
lasso di tempo in cui mi circondarono, mi ritrovai a contemplare rapidamente, ma con una
calma sorprendente, tre alternative: reagire, cercare di fuggire, o chiamare aiuto. (Scelsi
quest’ultima.)
Il mio articolo trattava precisamente di questo. L’avevo scritto dopo due anni di ricerca
etnografica sul campo in un quartiere povero a maggioranza nera di Washington, DC; mi
aveva colpito il fatto che la percezione del pericolo fosse un elemento della vita quotidiana
degli abitanti del quartiere. “Walking my walk and talking my talk - Fare la propria strada e
parlare la propria lingua”, stava a significare farsi gli affari propri e comportava una serie di
prescrizioni comportamentali, nonché una mappatura concreta di persone, luoghi, tempi e
situazioni. La gestione del pericolo consisteva essenzialmente nell’applicazione di questa
saggezza di strada, una sorta di estensione delle regole dettate dal buon senso per le relazioni
di traffico.
L’esperienza del pericolo tra gli abitanti del mio vecchio quartiere di Washington era tuttavia
qualcosa di locale, costruito sostanzialmente dalla loro esperienza personale e dalle vicende
capitate ad amici, vicini e parenti. Anche la saggezza di strada che si era venuta a delineare
era qualcosa di locale. Non era soltanto una vaga e diffusa sensazione, sebbene potesse
trattarsi anche di questo. È un aspetto che merita di essere sottolineato: molti abitanti della
città possono essere preoccupati per la percezione più o meno pervasiva del pericolo, ma le
elaborazioni su come affrontarlo sono carenti. Quando la città è una frontiera, nel senso di
punto di convergenza di grandi diversità, drammaticamente sentite, ma non effettivamente
comprese, si corre il rischio che i segnali vengano interpretati erroneamente, che la differenza
sia vista come violenza simbolica, confusa a sua volta con la minaccia di vera violenza. Una
cosmopolitaneità che conosce la vita di strada richiede saper discriminare e cogliere la
differenza.
12
Ancora un’altra influenza sembra contribuire a plasmare l’immaginario della realtà urbana
come luogo selvaggio, e deve essere presa in considerazione, agli inizi del ventunesimo
secolo come mai prima d’ora. Non possiamo aspettarci che i media ignorino il pericolo, che
anzi è diventato uno dei generi urbani preferiti per suscitare scandalo e morbosità. Eppure, ora
che i media operano come agenti fondamentali di mediazione tra il globale e il locale, l’idea
di pericolo urbano può essere penetrata parzialmente, non ovunque, ma sopratutto in molte
grandi città del mondo, dall’immaginario del terrore globale. Si ha la sensazione che i
perpetratori di quel terrore ci circondino e che i loro strumenti possano essere poco costosi,
facili da trovare e facili da utilizzare. In alcune città, in diverse parti del mondo, questi
sviluppi possono essere già presenti nella realtà quotidiana. Altrove, l’emergere di un nuovo
scenario geopolitico e geoculturale della paura, che comprende i luoghi e le regioni
recentemente ideati, quali il Londonistan e l’Eurabia, minaccia di portare quello “scontro di
civiltà” nelle strade, sugli autobus, nella stazione della metropolitana più vicini a noi.
Ed è qui che ho scelto di fermarmi e scendere. Forse la panoramica della metafora della città
come frontiera potrebbe essere estesa ulteriormente, ma percepire la città come un luogo
pericoloso e un’arena per gli incontri con la diversità, come una realtà in cui lanciare il
proprio progetto di vita, potrebbe spiegare perché noi ricercatori delle scienze umane
continuiamo a trovare nelle città una materia di studio stimolante e spunto di importanti
riflessioni. Poiché è stato annunciato all’inizio dell’anno che la percentuale della popolazione
umana che vive in comunità urbane ha superato il cinquanta per cento, le città sono frontiere
che, a differenza di ciò che Frederick Jackson Turner scrisse al riguardo, non sono destinate a
scomparire per molto tempo ancora.
13
Bibliografia
Anderson, Elijah. 2004. The Cosmopolitan Canopy. Annals of the American Academy of
Political and Social Science, 393: 14-31.
Billig, Michael. 1995. Banal Nationalism. London: Sage.
Goffman, Erving. 1961. Encounters. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
Hannerz, Ulf. 1980. Exploring the City. New York: Columbia University Press.___ ___
_______. 1981. The Management of Danger. Ethnos, 46: 19-46.
Park, Robert E. 1952. Human Communities. Glencoe, IL: Free Press.
Phillips, Melanie. 2006. Londonistan. London: Gibson Square.
Raban, Jonathan. 1974. Soft City. London: Hamish Hamilton.
Redfield, Robert, and Milton Singer. 1954. The Cultural Role of Cities. Economic
Development and Cultural Change, 3: 53-73.
Simone, AbdouMaliq. 2004. For the City Yet to Come. Durham, NC: Duke University Press.
Turner, Frederick Jackson. 1961 /1893/. The Significance of the Frontier in American
History. In Frontier and Section. Ray A. Billington, ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Turner, Victor. 1974. Dramas, Fields, and Metaphors. Ithaca, NY: Cornell University Press.