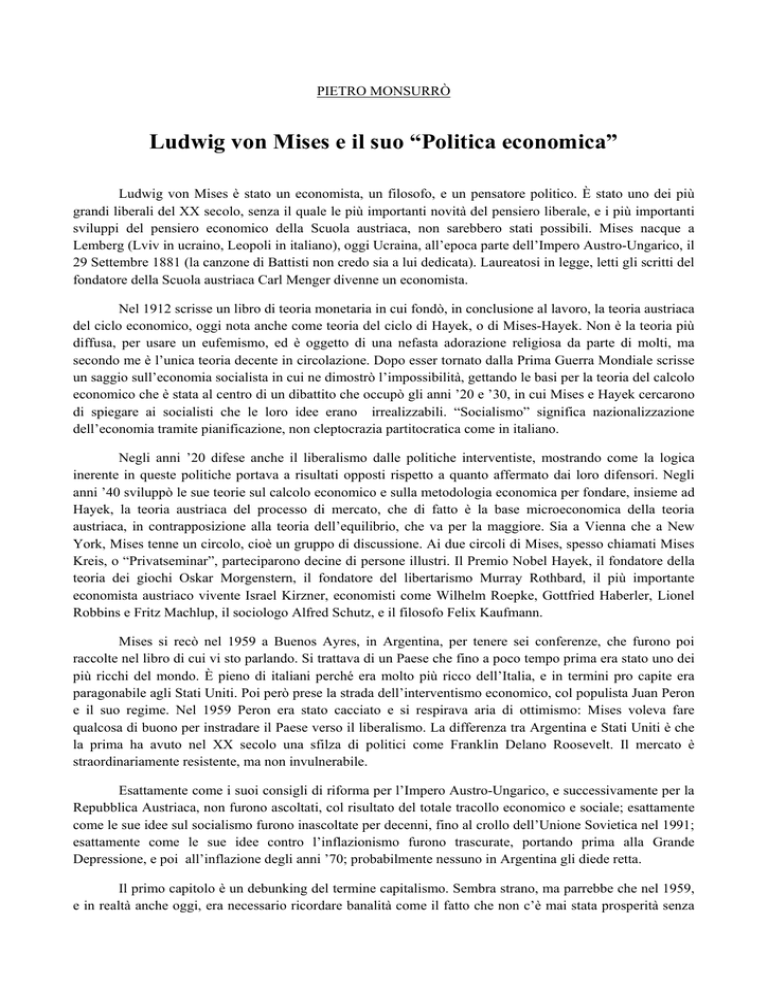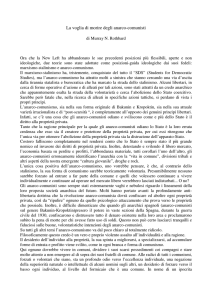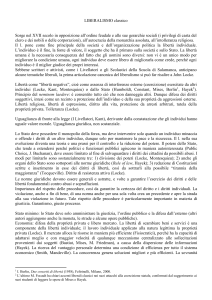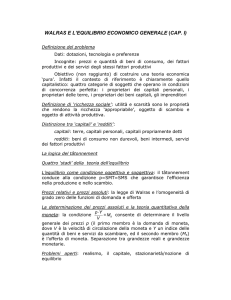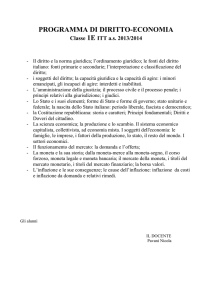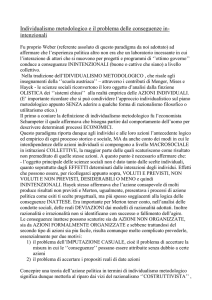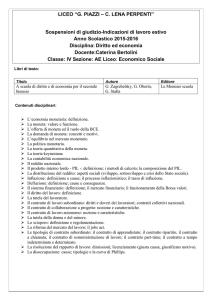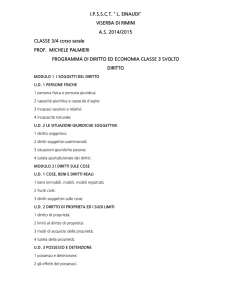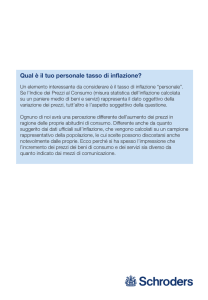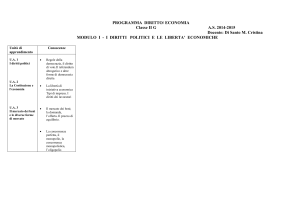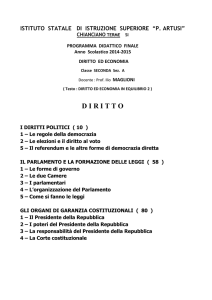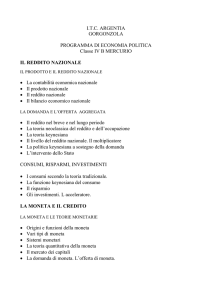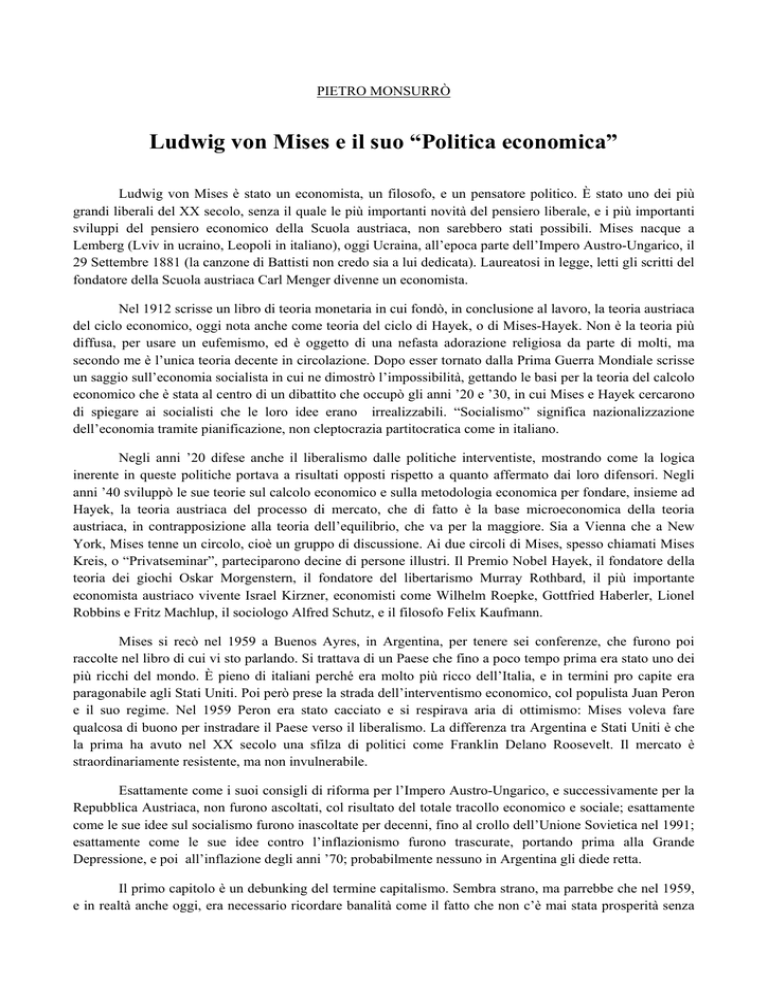
PIETRO MONSURRÒ
Ludwig von Mises e il suo “Politica economica”
Ludwig von Mises è stato un economista, un filosofo, e un pensatore politico. È stato uno dei più
grandi liberali del XX secolo, senza il quale le più importanti novità del pensiero liberale, e i più importanti
sviluppi del pensiero economico della Scuola austriaca, non sarebbero stati possibili. Mises nacque a
Lemberg (Lviv in ucraino, Leopoli in italiano), oggi Ucraina, all’epoca parte dell’Impero Austro-Ungarico, il
29 Settembre 1881 (la canzone di Battisti non credo sia a lui dedicata). Laureatosi in legge, letti gli scritti del
fondatore della Scuola austriaca Carl Menger divenne un economista.
Nel 1912 scrisse un libro di teoria monetaria in cui fondò, in conclusione al lavoro, la teoria austriaca
del ciclo economico, oggi nota anche come teoria del ciclo di Hayek, o di Mises-Hayek. Non è la teoria più
diffusa, per usare un eufemismo, ed è oggetto di una nefasta adorazione religiosa da parte di molti, ma
secondo me è l’unica teoria decente in circolazione. Dopo esser tornato dalla Prima Guerra Mondiale scrisse
un saggio sull’economia socialista in cui ne dimostrò l’impossibilità, gettando le basi per la teoria del calcolo
economico che è stata al centro di un dibattito che occupò gli anni ’20 e ’30, in cui Mises e Hayek cercarono
di spiegare ai socialisti che le loro idee erano irrealizzabili. “Socialismo” significa nazionalizzazione
dell’economia tramite pianificazione, non cleptocrazia partitocratica come in italiano.
Negli anni ’20 difese anche il liberalismo dalle politiche interventiste, mostrando come la logica
inerente in queste politiche portava a risultati opposti rispetto a quanto affermato dai loro difensori. Negli
anni ’40 sviluppò le sue teorie sul calcolo economico e sulla metodologia economica per fondare, insieme ad
Hayek, la teoria austriaca del processo di mercato, che di fatto è la base microeconomica della teoria
austriaca, in contrapposizione alla teoria dell’equilibrio, che va per la maggiore. Sia a Vienna che a New
York, Mises tenne un circolo, cioè un gruppo di discussione. Ai due circoli di Mises, spesso chiamati Mises
Kreis, o “Privatseminar”, parteciparono decine di persone illustri. Il Premio Nobel Hayek, il fondatore della
teoria dei giochi Oskar Morgenstern, il fondatore del libertarismo Murray Rothbard, il più importante
economista austriaco vivente Israel Kirzner, economisti come Wilhelm Roepke, Gottfried Haberler, Lionel
Robbins e Fritz Machlup, il sociologo Alfred Schutz, e il filosofo Felix Kaufmann.
Mises si recò nel 1959 a Buenos Ayres, in Argentina, per tenere sei conferenze, che furono poi
raccolte nel libro di cui vi sto parlando. Si trattava di un Paese che fino a poco tempo prima era stato uno dei
più ricchi del mondo. È pieno di italiani perché era molto più ricco dell’Italia, e in termini pro capite era
paragonabile agli Stati Uniti. Poi però prese la strada dell’interventismo economico, col populista Juan Peron
e il suo regime. Nel 1959 Peron era stato cacciato e si respirava aria di ottimismo: Mises voleva fare
qualcosa di buono per instradare il Paese verso il liberalismo. La differenza tra Argentina e Stati Uniti è che
la prima ha avuto nel XX secolo una sfilza di politici come Franklin Delano Roosevelt. Il mercato è
straordinariamente resistente, ma non invulnerabile.
Esattamente come i suoi consigli di riforma per l’Impero Austro-Ungarico, e successivamente per la
Repubblica Austriaca, non furono ascoltati, col risultato del totale tracollo economico e sociale; esattamente
come le sue idee sul socialismo furono inascoltate per decenni, fino al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991;
esattamente come le sue idee contro l’inflazionismo furono trascurate, portando prima alla Grande
Depressione, e poi all’inflazione degli anni ’70; probabilmente nessuno in Argentina gli diede retta.
Il primo capitolo è un debunking del termine capitalismo. Sembra strano, ma parrebbe che nel 1959,
e in realtà anche oggi, era necessario ricordare banalità come il fatto che non c’è mai stata prosperità senza
capitalismo, e che lo stato naturale dell’uomo non è l’abbondanza ma la miseria. Il capitalismo, dice Mises, è
il diritto di ognuno di servire meglio il consumatore. È un sistema dove non bisogna chiedere il permesso
dello Stato per aprire una pizzeria, portare in giro le persone (taxi e autobus), dare consigli legali, lavorare, e
far lavorare la gente. Non è l’Italia, decisamente.
Mises ricorda poi come l’odio per il capitalismo – rimando a “La fine dell’economia” di Ricossa –
nasce non dai proletari, a cui il capitalismo consentì la sopravvivenza prima e la prosperità poi, ma dagli
aristocratici, preoccupati per il Landflucht (la fuga dalla campagna) dei loro servi verso le città. Il più grave
problema di una società liberale è che non ha bisogno di leader: chi vuole comandare, deve prima minarne le
basi.
Forse su una cosa ci si può sorprendere: che il capitalismo porti ad una forte uguaglianza delle
condizioni. La differenza tra un ricco e un povero è quella che c’è tra una Cadillac e una Chevrolet, dice
Mises. Chi ha osservato gli Stati Uniti, da Tocqueville (1830) a Hoffer (1950) ha sempre sottolineato la forte
uguaglianza delle condizioni e l’assenza di un’aristocrazia. Eppure negli ultimi venti anni c’è stato un
aumento della disuguaglianza all’interno dei Paesi, anche se effettivamente c’è stata anche una diminuzione
di questa tra Paesi grazie alla globalizzazione.
La libertà economica e la libertà sono la stessa cosa. La libertà è infatti il diritto di impiegare i propri
mezzi per perseguire i propri fini: niente libertà sui mezzi (libertà economica) implica niente libertà sui fini.
Senza mercato, in Unione Sovietica chiunque poteva essere mandato a produrre gelati al pistacchio in
Siberia, mentre sul mercato qualsiasi cosa sia considerata utile dagli altri trova di norma un finanziatore.
Cosa sarebbe la libertà senza libertà economica? Nei Paesi dell’Europa Orientale sotto il giogo comunista si
diffuse una forma di lotta non-violenta al regime chiamata Samizdat: la stampa clandestina di libri vietati
dalle autorità, fatta a mano, a volte con la macchina da scrivere e la carta carbone, raramente con tecniche
più avanzate come il ciclostile. Qual era la difficoltà? Che la proprietà privata di queste attrezzature era
vietata, ovviamente per controllare le idee eversive come la libertà. La libertà è una e indivisibile: la
compressione di una libertà porta alla compressione delle altre. Cos’è la libertà di stampa, ad esempio, se i
finanziamenti ai giornali vengono forniti dallo Stato? È la libertà di ingraziarsi i politici.
La libertà, dice Mises, esiste all’interno del sistema di cooperazione sociale. Non è libertà dalla
società, è libertà nella società: è il diritto di scegliere se e come cooperare con gli altri individui. C’è ancora
chi dice che il liberalismo sia atomistico e disdegni la società, e ci sono ignoranti che parlano di Mises come
di un individualista atomista: in realtà il liberalismo disdegna i dittatori sociali – anche democratici – che
vogliono decidere al posto degli altri, ma non la cooperazione sociale. La politica non è la società: la società
è anche e soprattutto collaborazione volontaria, e questa, nel liberalismo, c’è sempre stata. Da qui si evince
l’importante idea di Mises riguardo l’armonia degli interessi: nel lungo termine cooperare con gli altri
permette di vivere meglio, perché la divisione del lavoro, come già notato da Adam Smith ne “La ricchezza
delle nazioni”, permette di creare ricchezza. Lo scambio è un gioco a somma positiva dove un lattaio con due
bicchieri di latte e un pasticcere con due fette di crostata possono scambiare un bicchiere con una fetta e fare
entrambi una colazione completa.
Sul piano teorico la cosa più importante da sapere sul socialismo è il problema del calcolo
economico. Facciamo un esempio. Domani c’è un’inondazione in Cile e la produzione di rame mondiale
diminuisce del 5%. Dopo pochi minuti il prezzo del rame aumenta del 15%. Il giorno dopo una società che
produce fili elettrici si accorge di dover pagare di più la materia prima, e aumenta il prezzo dei cavi. Dopo
due giorni una miniera in Australia viene riaperta perché conviene estrarre rame, al nuovo prezzo. Dopo tre
giorni, le azioni di una società che produce sistemi senza fili aumentano del 20% e i manager decidono di
espandere la produzione per via della nuova domanda di dispositivi che fanno un minor uso di cavi.
Qualcuno di voi pensa che una cosa così complicata possa essere capita da una sola persona? Che un
burocrate possa seguire ogni piccolo aggiustamento conseguente ad un’inondazione in Cile? Che un
economista di Harvard possa capire di quanto deve aumentare il prezzo del prodotto di una società di
dispositivi wireless grazie alla nuova configurazione di prezzi? Che un pianificatore possa sapere dall’alto
del suo ufficio del Reichsfuhrerwirtschaftsministerium (il Ministero dell’Economia della Germania nazionalsocialista) che c’è una miniera abbandonata in Australia?
La pianificazione è impossibile: il mercato è troppo complicato per farlo funzionare come una
caserma. Le informazioni sono troppo decentrate, tacite, diffuse per poter essere accentrate ed usate
efficacemente da un comitato di burocrati, ci ricorda Hayek. Serve un sistema di “divisione del lavoro
intellettuale” (dice Mises altrove) perché il mercato è troppo complicato per l’intelligenza di ogni singolo
individuo: serve che ognuno ne capisca una sola piccola parte, e che un meccanismo impersonale coordini le
azioni individuali. Questo meccanismo è il sistema dei prezzi. I prezzi esistono perché c’è la libertà di
scambiare, che implica la libertà di inserire nel sistema dei prezzi nuove informazioni sulla domanda e
l’offerta di ogni merce. Proprietà, prezzi e profitti sono le tre ‘P’ che rendono possibile il funzionamento del
mercato.
Mises definisce le funzioni proprie dello Stato come la difesa dei diritti di proprietà contro gli
aggressori interni od esterni. Il liberale, dice Mises, non odia lo Stato: il liberale ritiene che lo Stato non
debba fare altro, esattamente come nessuno odia la benzina se ritiene che non sia adatta per dissetarsi.
L’ipotesi di partenza è che esista un diritto indipendente dallo Stato: ipotesi che nel XX secolo è stata
distrutta dall’avvento della legislazione e del giuspositivismo. Ma questa ipotesi è centrale in tutti i pensatori
liberali: solo se i diritti individuali non dipendono dalla politica è possibile parlare di libertà. Senza una legge
superiore allo Stato, non ci sono diritti, non c’è libertà, non c’è giustizia.
La libertà è fatta di diritti negativi: un diritto è negativo quando impone agli altri di non fare
qualcosa, e positivo quando impone agli altri di farla. “Non uccidermi!” è un diritto negativo, “Sfamami!” è
un diritto positivo. Siccome l’effettivo contenuto dei diritti positivi – il costringere gli altri a fare qualcosa
per noi – non è chiaro, questi diritti creano una prateria di interventi politico perché fanno sorgere un’infinità
di contese su cosa effettivamente gli altri devono essere costretti a fare per noi. Non è mai esistita una società
priva di diritti positivi (“devo essere difeso in un tribunale!”), ma la moltiplicazione dei diritti positivi è
esiziale per la libertà: in fin dei conti, i diritti positivi sono una forma di schiavitù.
Cosa è l’interventismo per Mises? Non è l’intervento dello Stato per garantire il funzionamento della
giustizia. Non è neanche avere una municipalizzata o una singola impresa nazionale (queste cose al massimo
producono con una certa spontaneità corruzione ed inefficienza). L’interventismo è la dottrina che sostiene
che si possano influenzare i mercati migliorandone i risultati attraverso il controllo dei prezzi. Lo stesso
discorso si può fare con i salari minimi, che rendono la domanda di lavoro inferiore all’offerta, creando
disoccupazione, soprattutto tra chi ha una bassa produttività, cioè i lavoratori più poveri. Questo è spacciato
per politica sociale, ma è probabilmente la causa del fatto che la disoccupazione di lungo termine è
concentrata soprattutto tra i lavoratori meno produttivi. Questa è una proprietà dell’interventismo: si
introduce per beneficiare i “deboli”, e danneggia soprattutto loro.
Molto spesso si parla di interventismo senza specificare granché, e questo è errato: si usa
l’argomentazione misesiana in maniera lasca, anche dove non può essere applicata, solo perché se ne
apprezzano le conclusioni. I limiti del ragionamento sono ben specificati in “I fallimenti dello Stato
interventista”, un libro di Mises edito da Rubbettino. Gli stessi distinguo andrebbero fatti ogni volta che è
necessario, altrimenti l’argomento diventa come l’Ave Maria in latino, ripetuta a memoria, senza capirla, e
farcendola di errori. Non c’è nulla di più degradante per uno studioso che usare i suoi argomenti come
strumenti, da abusare all’occorrenza, per raggiungere certi fini, anche se sono gli stessi fini dello studioso in
questione.
L’aumento della quantità di moneta ne riduce il valore, cioè ciò che la moneta può comprare: i prezzi
aumentano. Ciò oggi è considerata una banalità, ed è nota come “teoria quantitativa della moneta”: quando
Mises scrisse queste pagine, invece, si credeva alla teoria keynesiana, per cui l’inflazione era impossibile in
assenza della piena occupazione. Alla fine degli anni ’60 un tizio abituato a sbagliarle tutte, tale Paul
Samuelson, dopo aver detto che i fari privati erano impossibili (Coase li trovò subito dopo), e prima di dire
che l’Unione Sovietica era una storia di successo (crollò pochi anni dopo), disse che non c’erano più
dottrinari che credevano che l’inflazione fosse un fenomeno monetario. Poi scoppiò l’inflazione.
Oggi abbiamo imparato a controllare l’inflazione, ma non a controllare la politica monetaria. Dopo
gli eventi degli anni ’70 ci si è resi conto che la moneta è una cosa troppo seria per lasciarla ai politici, ed è
stato introdotto il concetto di “indipendenza” della banca centrale, che significa che la moneta viene gestita
da una tecnocrazia e non dalla politica. Purtroppo nonostante si sia imparato che eccedere nel creare moneta
crea inflazione, come negli anni ’70, non si è ancora imparato che usare la politica monetaria per “facilitare
la vita” alle banche, implica che le banche non hanno più alcun incentivo a comportarsi responsabilmente. Il
risultato è stata la crisi finanziaria iniziata nel 2007, e da cui di fatto non si è ancora usciti.
Mises descrive in maniera chiara come l’aumento della quantità di moneta, e dunque l’inflazione, se
usato come strumento per ridurre il costo del lavoro, e dunque la disoccupazione creata dai sindacati che
impongono con la coercizione salari eccessivi, produce un aumento ulteriore dell’inflazione perché i
sindacalisti si accorgono presto del trucco. Questa idea era già nota a Mises e Hayek negli anni ’30, ma i
macroeconomisti degli anni ’50, ’60 e ’70 non lo sapevano, e costruirono la teoria macroeconomia sull’idea
contraria, che si potesse sistematicamente aumentare l’occupazione attraverso l’inflazione. Questa follia si
chiama “curva di Phillips”. Non si può sottovalutare il contributo della macroeconomia alla stupidità umana.
Il quinto capitolo parla della globalizzazione, una cosa del XIX secolo spazzata via dallo statalismo
nel XX secolo, e venuta nuovamente fuori solo di recente. Nel mezzo tra queste due globalizzazioni, c’è
stato un Medioevo di politiche commerciali protezioniste, di espropriazioni di investimenti esteri, di ostacoli
ai movimenti di capitali, di persone e di merci, di discriminazioni contro gli stranieri. Questi erano i metodi
con cui si cercava di far progredire la società.
Oggi la battaglia contro l’esportazione di capitale verso i Paesi poveri, cioè a favore della
perpetuazione della loro miseria, è portata avanti dalle imprese che cercano protezione, dai contadini che
difendono l’”identità nazionale”, dai movimenti no global, dai sindacati che vogliono la legislazione
“antidumping”. Di fatto, stanno dicendo “niente benessere per i negri”, anche se giustificano le loro idee con
argomenti più etici, e anzi, spesso, parlano di morale con la stessa leggerezza con cui si ingurgitano popcorn
al cinema. Quando la FIAT deve decidere se investire in Polonia o in Italia, si parla della minaccia di non
investire in Italia come un danno ai lavoratori. Quali? Se si investe da una parte, si investe di meno dall’altra:
qualcuno ne verrà danneggiato. Il fatto che non si considerino i lavoratori polacchi non è forse razzismo, ma
certamente è retorica vuota. La “minaccia” di non investire in Italia non è che la decisione di investire
altrove: non è ricatto, ma una scelta su dove impiegare al meglio i propri fondi. E se nessuno straniero
investe in Italia, non lamentiamoci che nessun italiano vorrebbe farlo: il nostro nemico siamo noi stessi.
L’eclissi del liberalismo che si è avuta nel XX secolo, e che perdura tuttora è nata da fattori culturali.
Dietro il nazismo ci furono decine di pensatori, che crearono le categorie del nazionalismo, del razzismo,
dello statalismo, dell’interventismo, del socialismo, dell’inevitabile conflitto tra nazioni. Ovviamente lo
stesso vale per il comunismo, per lo Stato sociale, per l’interventismo economico, per la democrazia
corporativa. Anche le cose buone ovviamente nascono dalle idee, come l’opposizione alla schiavitù. Le idee,
per Mises, sono fondamentali. La politica è, nel lungo termine, il risultato di una continua battaglia di idee.
Lo scopo fondamentale delle ideologie del conflitto è rendere impossibile la cooperazione sociale:
una volta che gli uomini hanno disimparato a vivere pacificamente uno accanto all’altro, hanno bisogno di un
Leviatano che li tiranneggi per dirimere le dispute. Una società di persone incapaci di cooperare è la società
ideale per uno Stato onnipotente. L’Italia è un esempio. Il liberalismo al contrario è basato sull’idea – che
non è un valore ma una teoria della società – che le persone abbiano comuni interessi nel lungo termine, e
che la convivenza pacifica sia benefica per tutti, perché crea ricchezza attraverso lo scambio, la divisione del
lavoro e l’accumulazione di capitale.
Per Mises, nei Parlamenti dell’Ottocento c’era gente che pensava di rappresentare la nazione, cioè gli
interessi di tutti, e si parlava di grandi ideali e principi. Nei Parlamenti del Novecento abbiamo invece il
rappresentante degli zuccherifici, il rappresentante dei metalmeccanici, il rappresentante dei pensionati: tutti
a cercare privilegi per il loro gruppo, tutti a cercare di vivere a spese degli altri. A leggere Bastiat, non si
direbbe che la politica francese dell’Ottocento fosse più sana di quella italiana attuale. E ciò lo conferma
Mises, parlando del parlamentarismo della Terza Repubblica francese. James Madison spese pagine e
pagine, nei “Federalist Papers”, per risolvere il problema delle fazioni, cioè delle lobby che curano il loro
interesse particolare a danno dell’interesse generale, ed era il 1787.
Idee, quindi: le idee sono fondamentali. Ma dobbiamo anche renderci contro che gli uomini non
pensano e non agiscono nel vuoto: pensano in una società, e agiscono per il tramite di istituzioni. La politica
liberale di cui parla Mises è una possibilità, ma quella meno probabile. Le tendenze della politica sono infatti
illiberali, le idee liberali possono opporsi a queste tendenze, ma non è possibile eliminarle.
Non è dunque che l’idea di democrazia liberale era forte nel XIX secolo e poi è stata soppiantata
dall’ideologia del conflitto. È che le idee liberali erano riuscite a tenere a bada, sia attraverso le istituzioni
(come la Costituzione americana) che attraverso la cultura (i valori liberali), tendenze degenerative
connaturali alla politica. Spariti i liberali, il peggio della politica è venuto fuori nella prima metà del XX
Secolo, con la civiltà ad un passo dalla catastrofe finale. Serve una battaglia di idee e di valori per recuperare
margini di mercato e di libertà.
Mises, ormai lo abbiamo capito, è stato la Cassandra del XX secolo: nulla di ciò che è successo lo
avrebbe stupito, e molto di ciò che è successo lo si sarebbe potuto evitare, a dargli retta prima. Le assurdità
che dovette affrontare Mises erano peggiori di quelle che dobbiamo affrontare noi oggi. All’epoca si credeva
che per aumentare i salari occorreva impegnarsi di meno al lavoro, che stampare moneta non causasse
inflazione, che i prezzi si potevano far fissare da un ufficio apposito, che un ufficio di pianificazione avrebbe
potuto gestire centralmente tutta l’attività economica di un’intera nazione.
In Italia però ancora si parla di protezionismo come un modo per creare ricchezza, di politiche
industriali come un modo per pianificare la crescita, di salari minimi come un modo per aiutare i poveri. La
recente crisi finanziaria ha messo in luce che ancora oggi non si prende sufficientemente sul serio il
problema del debito pubblico, e non ci si è resi conto che usare la creazione di credito per aiutare i mercati
durante le crisi li destabilizza sistematicamente. Ancora oggi, quindi, dobbiamo dar retta a Mises.
Ricordandosi della crisi dell’Austria, Mises nella sua Autobiografia scrisse “Le mie teorie spiegano, ma non
possono rallentare, il declino di una grande civiltà. Avevo l’intenzione di diventare un riformatore, ma
divenni soltanto lo storico del declino”. Nonostante questo, siamo riusciti a sconfiggere il nazismo, il
comunismo, l’inflazione, a rendere possibile la globalizzazione, a ridurre le aliquote fiscali.
Se non fosse per la spesa pubblica impazzita, i debiti pubblici fuori controllo e l’intero sistema
finanziario che succhia sangue al contribuente per gentile concessione dei politici, il mondo è più libero oggi
di trenta anni fa, soprattutto grazie al collasso del socialismo reale. Non è impossibile che si capirà presto o
tardi anche che serve tagliare la spesa pubblica, ed evitare di proteggere le banche dalle conseguenze delle
loro azioni. Ma non è facile: la politica tende spontaneamente a fare scelte sciocche.
“Nessuno può trovare un posto sicuro per sé stesso se la società corre verso la distruzione. Quindi
ognuno, nel suo interesse, deve gettarsi con vigore nella battaglia delle idee. Nessuno può starsene da parte
senza sentirsi chiamato in causa; gli interessi di ognuno dipendono dal risultato.” I guasti dello statalismo
sono oggi evidenti, e le idee dello statalismo non sono mai state così deboli. Manca la forza di superare
l’attrito dei cambiamenti istituzionali, e di andare contro gli interessi costituiti. E soprattutto di proporre
un’alternativa concreta allo status quo, e di scuotere le coscienze e gli intelletti dal sonno ottuso e servile in
cui sono sprofondati. Bisogna scegliere: o si dà retta a Mises, e ci si risparmia un mucchio di guai, o si
aspetta che sia la realtà a dargli ragione, e a quel punto sarà troppo tardi per non farsi molto male. La storia è
una maestra severa, Mises è più simpatico.