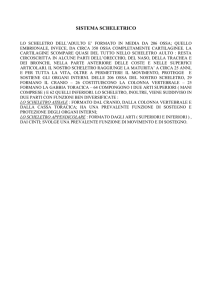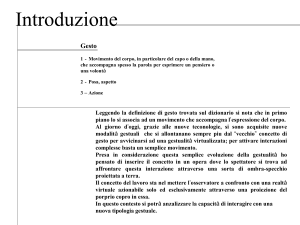Lo spettatore e la deissi della propria morte:
teschio e scheletro in alcune opere del XX e
XXI secolo (narrativa, cinema, arti plastiche)
Annelisa Addolorato Bertuzzi
Sommario
L’immagine del teschio e dello scheletro come anti-icone artistiche. I teschi in cartapesta creati dai fratelli Dinos y Jake Chapman, per esempio,
si presentano come geroglifici d’osso, strani pianeti che ricordano a noi –
esseri umani contemporanei immersi nel perpetuo movimento, nel dedalo
neobarocco di citazione, teatralizzazione, di partecipazione, ricerca della comunicazione globale, nel pieno e costante esercizio di un’ipotetica apertura
verso l’immortalità e dell’esorcismo della morte – un’umanità arcaica.
La rappresentazione del ghigno del teschio e della dinoccolata mobilità dello
scheletro includono il paradosso della morte che celebra la vita, in frequenti
atteggiamenti carnascialeschi: il gusto dell’orrore diventa, tra grottesco e
kitsch, parte integrante del quotidiano panorama antropologico.
Come teorizzato dal miltoniano J. Dennis, la rappresentazione dell’orrido
attraverso il filtro dell’opera d’arte vivifica lo spettatore: qui si mostra come
si possa innescare una relazione tra sublime e fruizione artistica dell’orrido.
L’orrido svolge una funzione declinabile in due aspetti: critica sociale e
trascendenza. L’identificazione o la capacità di oggettivazione dello spettatore nei confronti della rappresentazione di questi due elementi (teschio
e scheletro) inclusi nella categoria estetica dell’orrido rivestono un ruolo
fondamentale nell’equilibrio dinamico tra percezione e fruizione artistica.
c 2007 ITINERA (http://www.filosofia.unimi.it/itinera)
Copyright Il contenuto di queste pagine è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati
internazionali. Il titolo e i copyright relativi alle pagine sono di proprietà di ITINERA. Le
pagine possono essere riprodotte e utilizzate liberamente dagli studenti, dagli istituti di ricerca,
scolastici e universitari afferenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per
scopi istituzionali, non a fine di lucro. Ogni altro utilizzo o riproduzione (ivi incluse, ma non
limitatamente a, le riproduzioni a mezzo stampa, su supporti magnetici o su reti di calcolatori)
in toto o in parte è vietato, se non esplicitamente autorizzato per iscritto, a priori, da parte di
ITINERA. In ogni caso questa nota di copyright non deve essere rimossa e deve essere riportata
anche in utilizzi parziali.
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
L
e recenti tendenze artistiche neobarocche tirano letteralmente “fuori
dall’armadio” la figura e l’immagine del teschio e dello scheletro, riproponendolo quale anti-icona per eccellenza, modificati e superati i
tabù sulla morte e sulla sua rappresentazione.
Gli enormi teschi parlanti di Dinos y Jake Chapman (Young British Artists, 1997-2000, esposti alla mostra di Salamanca intitolata “Barrocos y
neobarrocos. El Infierno de lo Bello”, articolato progetto artistico interattivo dislocato in diversi spazi della città tra il 2004 e il 2006), appoggiati
per terra, costituiscono un paesaggio artificiale, all’interno del quale lo spettatore, visitando la mostra, si può aggirare. Le dimensioni di ogni teschio
sono 120 cm × 170 cm: maschere grottesche di dimensioni spropositate, e
insieme messaggi tridimensionali e tatuati1 . I teschi dei fratelli Chapman,
come il resto della produzione artistica dei due artisti, vogliono essere presenze dissacranti che si snodano in uno spazio in cui lo spettatore diviene a
sua volta parte integrante del complesso scultoreo. Le sculture-teschio sono
totalmente ricoperte di scritte: parole, frasi e locuzioni che si attorcigliano e
snodano sull’intera superficie. Sono teschi muti, che si presentano però come
geroglifici d’osso, strani pianeti che ricordano un’umanità arcaica ai posteri
e agli esseri umani contemporanei immersi nel perpetuo movimento e nel
dedalo neobarocco della citazione, della teatralizzazione, della partecipazione, della ricerca della comunicazione globale, nel pieno e costante esercizio
dell’esorcismo della morte e di un’ipotetica apertura verso l’immortalità.
Il ghigno del teschio porta con sé il grottesco paradosso della morte che
celebra e ricorda costantemente la vita, talvolta in atteggiamento carnascialesco. Le maschere orribili, il gusto dell’orrore, divengono, tra kitsch e neobarocco, parte integrante del panorama antropologico quotidiano. L’orrido,
infatti, è il complemento fondamentale della vita e della vitalità, nella cultura e nella rappresentazione artistica. Il legame essenziale tra vita e morte,
nella religione, viene ribadito e rafforzato dai frequenti riti di purificazione
e rinvigorimento attraverso la mutilazione e distruzione del corpo: la morte
ride, balla, canta, suona, festeggia. Nei rituali propiziatori aztechi, in quelli
incaici, o nel vudù, la compresenza del riso e della tortura è all’ordine del
giorno. L’idea dello smembramento del corpo del dio incarnato, edulcorata nella liturgia cristiana nelle immagini del crocifisso e delle stazioni della
via crucis e il culto delle reliquie, dello scheletro e del teschio degli uomini
che, in qualche modo, sono stati “prescelti”, “santificati”, è presente in modo
consistente anche nel culto azteco.
Tutto ciò viene ripreso nella rappresentazione artistica. Lo spettatore che
vede la rappresentazione della morte, della putrefazione, della deformazione del corpo nelle sue varianti orribili si rende complice della propria morte
e resurrezione, mentre afferma – per contrasto – la propria esistenza dinamica e ancora pulsante. Tale rappresentazione può portare anche al gusto
1
Vd. Figura 1, p. 13.
2
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
voyeuristico, a volte persino masochistico, della condivisione, seppur filtrata,
dell’esperienza del disgustoso e dell’orrido. Ancora, come già teorizzava il
miltoniano J. Dennis2 , la fruizione dell’orrido, attraverso il filtro dell’opera
d’arte, che lo rappresenta e pone dinanzi agli occhi dello spettatore, oltre
alla sua sperimentazione, tende alla vivificazione dell’animo del soggetto che
ne fa esperienza. L’orrore per Dennis era la terza, e più bassa, forma del
sublime. Il piacere, nella fruizione di ciò che è orribile, lo si individua proprio nell’ampliamento del raggio d’azione della spiritualità verso cui spinge,
“commuovendo”, muovendo, appunto, a commozione l’anima del soggetto.
Nella fruizione del disgustoso, dell’orrido, molti teorici hanno trovato che
venga incluso un aspetto peculiare che avvicina queste categorie a quella del
sublime e della sua fruizione.
Octavio Paz, nella sua analisi dell’iconografia delle divinità mesoamericane, ricorda che elidere il carattere “terribile” e “orrido” dalla considerazione
della loro natura, equivale a depauperarle dal loro potere evocativo, dalla loro
autorevolezza, sia religiosa che artistica, che ha fatto dell’esibizione dell’orrido e del mortifero un valore estetico fondante. Egli attribuisce essenzialmente
alla sfera del divino la detenzione del primato dell’orrore. L’orrore, così come
il sublime, svolge in ultima istanza una funzione catartica. Lo spettatore si
avvicina all’inaccessibilità divina proprio attraverso la raffigurazione orribile,
spaventosa degli dei. Nel caso dell’arte e della cultura preispanica messicana,
negare all’immagine divina il suo aspetto orribile equivale, secondo Paz, a
mutilarla irrimediabilmente3 . Paz aggiunge in merito un’osservazione sulla
natura dell’orrore definendolo una vera e propria esperienza che ha il suo
equivalente, nell’ambito della sfera dei sentimenti, nel “paradosso e nell’antinomia spirituale: la divinità è una presenza totale che è un’assenza senza
fine”. Il dio principale, nella cosmologia azteca, è comunque il sole, il cui
primo attributo è ancora il tratto “terribile”, orribile. Il sole dà e toglie la
vita, detiene il primato della contraddizione, dunque della vita. Il ghigno
terribile degli dei si sovrappone e si annulla con l’apparente e perpetuo ghigno del teschio, Paz ci chiede «Forse solo i teschi ridono perpetuamente?»4 .
Così la fruizione dell’orrore potrebbe aprire nello spettatore le porte della
percezione sulla realtà, dei suoi confini o della loro assenza.
Gli effetti prodotti dall’orrido sullo spettatore che si trova davanti alla
terribile potenza dell’arte azteca vengono evocati in modo notevole dal poeta
spagnolo Carlos Barral5 nella sua poesia “Tlaloc en Chapultepec”:
Tlaloc a Chapultepec
2
Cfr. J. Dennis, I luoghi del sublime moderno – Percorso Antologico-critico, a cura
di P. Giordanetti e M. Mazzocut-Mis, Led, Milano 2005, pp. 279-284.
3
O. Paz, Los signos en rotación y otros ensayos, Alianza, Madrid 1983 (I ed. 1971),
p. 26.
4
Ibid., p. 33.
5
Esponente della scuola catalana della Generazione poetica spagnola degli anni
Cinquanta.
3
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Es éste el altar verdadero de la acechante confusión.
Aquí, mi hermano, más que en la antigua pirámide
con lomo de palacio y catedrales y el agua venenosa del estanque,
mucho más que en el recinto de albañales sangrientos y serpientes.
Aquí son las lenguas enroscadas, los ojos impasibles
vítricos de venganza y las bocas de grito,
donde en apariencia la muchacha alborotada y el viejo buscador de
estampas.
Esto, aquí, no es cristal ni vidrio sino quajarón de esperma
de razas exterminadas y estirpes en extinción. Y, ves, al fondo,
lo que parecen nubes es tolvanera amenazante y entre aquellas
breñas viven los que de todos modos ya están muertos
y se conserva la lluvia antiquísima contaminada de orines. [. . . ]6
Qui il poeta spagnolo descrive il legame tra amore, orrore, morte, iniziazione. Nella cultura azteca, ci ricorda sempre Paz, il pulsare e la pienezza
della vita vengono evocati e persino definiti a partire del suo contrario, dalla
morte, dai segni della mancanza della vita.
La morte esercita il suo fascino sullo spettatore, che riconosce e ritrova
nei segni della decomposizione altrui, e persino nei tratti mortali degli dei,
il valore della propria esistenza, per quanto labile ed eterea.
Ven, muerte, tan escondida,
Que no te sienta venir,
Porque el placer de morir
No me torne a dar la vida.7
Cervantes, nel XXXVIII capitolo della seconda parte del Don Quijote
scrive questi versi che verranno illustrati nel 1928 da Carlos Magaz in un
ex-libris8 dove appare il capo, coperto da un elmetto, di uno “scheletro sorridente”. In questa copla Cervantes condensa, con una notevole capacità di
sintesi, una lucida consapevolezza filosofica ed estetica del senso dell’orrido
come forma del sublime e della sua esperienza e fruizione quasi “terapeutiche”. Tale cognizione viene captata da Magaz, che nel suo ex-libris ne illustra
6
C. Barral, Metropolitano, Cantalapiedra, Santander 1957. «È proprio questo l’altare
del caos incombente. / Proprio qui, fratello mio, molto più che nell’antica piramide / con
dorso di palazzo e cattedrali e velenosa acqua stagnante, / molto più che nel recinto di
porcili insanguinati e serpenti. / Le lingue attorcigliate si trovano qui, gli occhi vitrei /
e impassibili della vendetta, le bocche che urlano, / dove apparentemente si trovano la
fanciulla scarmigliata e l’anziano cercatore d’immagini. / Questo non è cristallo né vetro
ma grumo di sperma / di razze sterminate e di stirpi in via d’estinzione. E, vedi, là in
fondo, / quelle che sembrano solo nuvole sono una minacciosa tormenta e tra quegli / sterpi
vivono coloro che sono comunque già morti / e si conserva l’antichissima pioggia sporca di
ruggine. [. . . ]» (tr. it. di A. Addolorato, Poesia spagnola della generazione degli anni ’50,
a cura di A. Addolorato e G. Morelli, Le Lettere, Firenze (in corso di pubblicazione).
7
«Vieni, morte, vieni di nascosto, / Affinché io non ti senta arrivare, / affinché il
piacere di morire / non mi restituisca la vita».
8
Per consultare tutti gli ex-libris e illustrazioni del Don Quijote: http://dqi.tamu.edu,
archivio digitale dell’iconogia testuale del testo cervantino.
4
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
la natura in modo stilizzato e ammiccante. Cervantes descrive l’orrido, nel
suo ruolo di vivificazione, come piacere della morte, come riattivazione dei
sensi, nel paradossale culmine del dolore della perdita della vita, che sembra
poter riportare il soggetto al centro di essa.
Troviamo un’altra rappresentazione del sublime, dell’orrido e di categorie
estetiche limitrofe in Mercurio9 , un recente romanzo della prolifica scrittrice
Amélie Nothomb10 . La storia si intesse a partire dall’arrivo dell’infermiera
Françoise sull’isola di Morte Frontiere, dimora della giovane Hazel e del suo
carceriere, l’anziano Capitano. Quest’ultimo ha assunto l’infermiera per farle accudire Hazel, ma anche, fuor di metafora, per assolvere alla necessità di
trovare in lei una spettatrice. Il Capitano stabilisce ferree regole di comunicazione, che l’infermiera deve rispettare nel suo rapporto con Hazel, la quale
è convinta di essere sfigurata.
Hazel, raccontando la sua storia a Françoise, da poco assunta, le dice:
Ero a Morte Frontiere da tre mesi e l’assenza di specchi, che probabilmente anche lei ha notato, mi incuriosiva. Ne parlai al Capitano:
mi disse di aver fatto togliere tutti gli specchi dalla casa. Gliene chiesi il motivo, e allora lui mi rivelò quello che ancora non sapevo: ero
sfigurata.11
Qui, in un mirabile gioco di specchi mancanti, una sorta di campo degli
“specchi elisi” e di equivoci, le diverse forme del sublime convergono, convivono e vengono riproposte nel ventaglio delle loro sfumature. I protagonisti del
romanzo sono tre: la vittima, il carnefice e la spettatrice. In questo caso la
giovane vittima viene privata della propria immagine, in quanto il carnefice,
un vecchio marinaio e avventuriero, ne fa la propria amante con l’inganno:
eliminando dalla villa in cui la tiene reclusa ogni tipo di superficie riflettente, le fa credere – con l’ausilio di un carnascialesco specchio deformante – di
essere rimasta sfigurata dai bombardamenti che hanno ucciso i suoi genitori.
Il vecchio mina la sua identità, convincendola di essere il suo benefattore.
La spettatrice della segregazione, la giovane infermiera si trova ad essere la
futura custode (o, anche, la seconda carceriera) della sua immagine, figura
che si sostituisce al decrepito, crudele ed astuto avventuriero che ne aveva
fatto la sua concubina. In Mercurio la figura, l’archetipo dello spettatore è
il protagonista attivo della narrazione. Lo spettatore detiene il primato su
ciò che vede. L’immagine della bellezza “sublime” della fanciulla segregata
viene fruita dai suoi carcerieri, ossessionati dall’idea di possederne il segreto e
9
Mercure, uscito in Francia nel 1998.
A. Nothomb, figlia di un diplomatico belga, nasce in Giappone (Kobe), ed esordisce
nel 1992 con il suo romanzo Igiene dell’assassino. Da alcuni suoi libri sono stati tratti
film, e ha vinto vari premi letterari di grande prestigio. Scrittrice in lingua francese, si
autodefinisce grafomane.
11
A. Nothomb, Mercurio, tr. it. di A. Grilli, Voland, Roma 2006 (I ed. italiana 1999),
p. 21.
10
5
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
l’immagine in modo esclusivo. Lo stratagemma che entrambi gli “spettatori”
utilizzano per mantenere vicina a sé la “sublime immagine”, è quello di far
credere a Hazel di essere sfigurata, orribile. All’inizio del romanzo, quando
l’infermiera incontra Hazel, si legge: «Quando Françoise scoprì il volto della
ragazza, ne rimase fortemente scioccata. Fedele alle istruzioni ricevute però,
non lasciò trapelare nulla».12 .
In entrambi i finali Nothomb ribadisce, al momento del climax ascendente
della narrazione, l’ambigua valenza del termine “sublime”.
Nel primo finale, che si chiuderà con la partenza delle due donne verso
una lunga nuova vita insieme a New York, prima che il Capitano si suicidi
lasciando loro in eredità tutti i suoi averi, Françoise svela il segreto a Hazel
in modo repentino:
Françoise – Perché si rifiuta di credermi? Ci tiene tanto a ritenersi
un mostro quando le dico che non ho mai visto nessuno di così bello?
[. . . ].
Hazel – Ricordo benissimo la prima volta che mi ha visto. È rimasta
profondamente scioccata e non è riuscita a nasconderlo.
Françoise – Esatto. E sa perché? Perché non avevo mai visto un viso
così sublime. Perché una bellezza simile è rara e lascia interdetto chi
la vede.13
Nel secondo finale proposto dall’autrice, in cui l’infermiera si sostituisce
al Capitano nella veste di carceriera ed amante di Hazel, sull’isola di Morte
Frontiere, Françoise ormai anziana svela il mistero alla sua “protetta”:
Françoise – Adesso, Hazel, glielo posso anche dire. – E le raccontò
tutto [. . . ]. Haxel era pietrificata. [. . . ]
Hazel – Mi dica. . . mi dica com’ero.
Françoise – Non ci sono parole per dirlo. Lei era così sublime che
neanche per un istante mi sono vergognata del mio delitto. Sappia
almeno questo: mai bellezza è stata meno sprecata della sua. Grazie
alla nostra felicità insulare non ho perso neppure una briciola del suo
bel viso.14
L’intero romanzo della Nothomb si basa su questo malinteso, ovvero sull’elaborazione moderna dell’interpretazione della parola “terribile”, che etimologicamente risale alla dicotomica definizione di essere umano come meraviglioso e terrificante che leggiamo nelle pagine delle tragedie di Sofocle.
Sulla scorta di un simile paradosso linguistico e sostanziale si basa anche l’interpretazione della categoria di “sublime”, che tante riflessioni ha suscitato
in filosofi e studiosi di storia del pensiero e dell’arte.
12
Ibid., p. 13.
Ibid., p. 91.
14
Ibid., pp. 121-122.
13
6
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Nel romanzo la giovane protagonista si immagina deturpata, scarnificata,
consumata. Dunque si ha qui un rovesciamento, rispetto all’esibizione del
teschio, dello scheletro: si vengono a creare un ribaltamento e una mistificazione, attraverso l’appropriazione di una bellezza “terribile”, attraverso
un gioco sadico e sottile. Lo spettatore, il fruitore di tale bellezza gestisce
il potere su ciò che vede. Nell’“esibizione” e rappresentazione del teschio e
dello scheletro si esorcizza la morte, mentre qui la situazione viene rovesciata. La protagonista del romanzo percepisce se stessa come rappresentazione
“terribile”, mentre gli altri – gli spettatori, carcerieri e amanti – traggono
forza dal loro inganno.
C’è chi invece, come Carlos Monsiváis nel suo libro del 1997 intitolato
Cartoline messicane15 , descrive Città del Messico come uno sconfinato palcoscenico in cui le masse riconoscono se stesse nell’esibizione del disagio, in un
ininterrotto spettacolo macabro e tragicomico che viene concepito da attori
e spettatori come una prova generale della fine del mondo, dell’apocalisse.
Oggi, a dieci anni dalla pubblicazione di quel libro, ci troviamo a celebrare
una mostra universale d’arti plastiche dal titolo Biennale della fine del mondo (Brasile 2006) d’ispirazione ecologista, dedicata al tentativo di invertire
la tendenza umana verso la distruzione del pianeta Terra.
Monsiváis nel suo testo evidenzia in modo particolare il ruolo, di derivazione azteca, del volto e della maschera nella società e nella cultura messicane. Sia l’esibizione di una maschera, o “volto collettivo”, che l’esibizione
tragicomica, grottesca del teschio e dello scheletro umani, sono forme complementari di una stessa variante dell’estetica del sublime. In questa interpretazione, si allude al sublime come forma ibrida, nella quale convivono
l’orrido e il ridicolo, dando vita a una sorta di marchingegno-grimaldello
apri-sentimenti.
Troviamo l’applicazione degli stessi canoni estetici all’ambito cinematografico, per esempio, nel film di Marco Bellocchio Nel nome del padre16 ,
laddove il regista mostra, seduti nella platea di uno spettacolo teatrale allestito dai ribelli ospiti adolescenti di un severo collegio religioso, tre scheletri
vestiti di tutto punto, che si confondono tra il pubblico e lo rappresentano
mentre lo contestano, irridendolo.
In particolare, in una scena del film17 , notiamo che, durante una rappresentazione teatrale, uno dei piccoli spettatori (i convittori più giovani)
abbraccia lo scheletro-spettatore, come se quest’ultimo lo proteggesse o gli
fosse comunque già divenuto paradossalmente familiare, pur essendone, tuttavia, spaventato. Ciò che è terribile, orrido, può stimolare, risvegliare l’a15
C. Monsiváis, Mexican Postcards, Verso, 1997, (tr. it di F. Bernabei, Cartoline
messicane, Strategia della lumaca, Roma 1997).
16
(1972) soggetto, sceneggiatura e regia di M. Bellocchio. Con Y. Beneyton (Angelo
Transeunte), R. Scarpa, L. Castel, L. Betti, A. Sassi, P. Vida, L. Di Gaetano, E. Torricella,
T. Maestroni, C. Besestri, G. Burinato.
17
Vd. Figura 2, p. 14.
7
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
spetto vitale nello spettatore, nel fruitore. Il teschio come “compimento”
della testa, del capo, o, ancora lo scheletro si situa come “compimento” del
corpo. Nel film di Marco Bellocchio i collegiali che frequentano l’ultimo anno
di un istituto religioso, i ribelli protagonisti collettivi della pellicola, mettono in scena uno spettacolo teatrale e lo presentano provocatoriamente alla
fine dell’anno scolastico al pubblico degli insegnanti e dei più piccoli ospiti
di scuola e internato. I giovani attori hanno sistemato, prima di far entrare
il pubblico in sala, su alcune poltrone della platea vuota, alcuni manichinischeletro che vengono dapprima guardati con curiosità e raccapriccio dai
bambini spettatori, e poi accolti come bambolotti. L’effetto del messaggio
critico del regista e dei protagonisti del film, nei confronti di un’educazione dogmatica e repressiva, viene potenziato: il regista mostra la platea del
teatrino scolastico, intervallando queste immagini con quelle dello spettacolo il cui testo è fortemente accusatorio nei confronti del sistema educativo
impartito in quella scuola. Dunque ogni spettatore della rappresentazione
teatrale viene paragonato a un “morto vivente”, a uno scheletro. E il regista
esce di metafora mostrandoci direttamente la platea, formata da bambini,
insegnanti e scheletri.
Ancora una volta l’esibizione del teschio e dello scheletro innescano un
meccanismo critico e mimetico insieme.
Gli autori dello spettacolo teatrale in questione esplicitano la loro volontà di terrorizzare il proprio pubblico, per smuovere in essi sentimenti e
reazioni forti, che scuotano e facciano reagire. La vista dei volti spaventati dei bambini, che sono i loro successori nell’iter educativo, fa sorridere di
soddisfazione Angelo Transeunte, dal parodistico, suggestivo e allusivo nome
simbolico, che è il più lucido, attivo e pragmatico dei convittori più grandi.
Nello stesso film, si succedono l’inquadratura della giocosa aggressione
amorosa di un convittore nei confronti di una suora, e quella di un quadro
che adorna le pareti del collegio-prigione e che rappresenta uno scheletro,
probabilmente particolare della rappresentazione pittorica di un “Giudizio
universale”.
Bellocchio identifica con il teschio e lo scheletro amore, morte e apprendistato.
Nel celebre film di Ingmar Bergman18 Il settimo sigillo19 (1956) il capocomico e Jot (Nils Poppe), il menestrello spensierato, si scambiano queste
battute, prima di una rappresentazione teatrale:
Capocomico – Un teschio spesso interessa più di una donna nuda. [. . . ]
Menestrello – Ma vedendo il teschio si spaventano.
Capocomico – E se si spaventano, pensano di più.
18
Il regista svedese (1918-2007) ha segnato la storia del cinema del XX secolo.
Det sjunde inseglet, film svedese del 1956. Scritto e diretto da Ingmar Bergman.
Con M. von Sydow nei panni del protagonista, un malinconico cavaliere al ritorno dalle
Crociate. Altri interpreti: G. Bjrnstrand, B. Ekerot, B. Andersson, N. Poppe.
19
8
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
L’utilizzo da parte del regista e la fruizione da parte dello spettatore della
paura, nel riconoscimento empatico di un se stesso futuribile, si ripresenta
quando lo spettatore, vedendo il teschio, si specchia e vede il proprio volto
assente. In un’altra sequenza del film di Bergman troviamo un efficace esempio del memento mori: vediamo la maschera-teschio degli attori itineranti,
infilata, come se fosse un totem, su un bastone, e viene mostrata dal regista
perfettamente allineata al volto giocondo del menestrello che canta e suona,
allietando il malinconico cavaliere solitario.
Quest’esibizione dell’orrido, rivolta alla fruizione da parte del pubblico,
tanto nel senso della sua identificazione come della sua differenziazione e
allontanamento da esso, si trova agli antipodi dell’allusione, della suspense
creata nell’arte, per esempio, dai chiaroscuri o dall’uso del fuoricampo. Lo
scheletro mostrato ed esibito, invece, diviene sia in pittura che in scultura
che nell’immagine cinematografica, specchio futuribile dello spettatore, suo
doppio errante nel tempo.
Il teschio è maschera vuota, emblema involontario dell’estetica della moltitudine20 di cui parla anche Monsiváis descrivendo Città del Messico: “Città
del Messico è il luogo dove è impossibile che qualcosa fallisca per scarsità di
pubblico. Ce n’è in abbondanza. Nella capitale, per controbilanciare l’insufficienza di cielo limpido, c’è un numero più che sufficiente di abitanti,
spettatori, automobili, pedoni. Città del Messico è il luogo dove l’invivibile
ha le proprie gratificazioni, la prima delle quali è stata l’attribuzione di un
nuovo status sociale alla sopravvivenza” 21 .
La capitale messicana incarna così l’emblema della città post-postmoderna
che si fa scenario. Nella cultura messicana, inoltre, l’attualizzazione della
danse macabre forma parte della cultura popolare, come Ejsenstein ci ricordava nel suo film-documentario, lasciato incompiuto dal regista, ¡Qué viva
México!22 . Qui viene mostrata una festa messicana, in cui i ballerini avanzano vestiti, in modo carnascialesco, da scheletri. L’esibizione del teschio e
dello scheletro, in Messico, è spesso stata rappresentata in modo esotico ed
eccessivamente stilizzato, ma mantenendone in fondo intatto il suo carattere
dissacrante e quotidiano.
Anche Ejsenstein nel suo film ci presenta un Messico folcloristicamente
connotato, in cui tuttavia la cultura azteca mostra il suo volto feroce nelle
vestigia delle sculture e decorazioni mostruose dei templi, e nelle popolari
20
Cfr. C. Monsiváis, op. cit., p. 53.
Ibid., p. 52.
22
Film il cui materiale originale risale al 1933. Produzione Usa-Messico: Thunder Over
Mexico, tradotto in italiano anche con il titolo Lampi sul Messico. Si tratta di un film che
il regista russo lasciò incompiuto, e di cui esistono diverse versioni, realizzate con diversi
montaggi ricavati dal materiale reperito da Ejsenstein durante il suo viaggio documentario
in Messico. Il film era stato girato con attori messicani non professionisti (M. Hernández,
F. Balderas, D. Liceaga) e con la collaborazione degli abitanti di varie regioni e cittadine
messicane. È diviso in un prologo e quattro parti. La versione a cui si fa riferimento qui
fu realizzata nel 1979 da G. Alexandrov e da E. Tobak.
21
9
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
danze macabre. Nel film la natura paesaggistica messicana viene presentata
nei suoi tratti più duri, con i cactus [nopales] alimento e groviglio di spine,
in cui il ballo degli scheletri inscena una danse macabre dove s’incontrano
l’orrore e il ridicolo.
Lo scheletro allo specchio, tra orrore e ridicolo: il volto assente come
protagonista dell’arte contemporanea. La maschera del volto svuotato, il
teschio come icona del post-umano. Lo spettatore viene rapito, viene incantato e incatenato dalla visione e fruizione tout court. In molta dell’iconografia
dell’orrido, in pittura, in scultura, e nell’immagine foto e cinematografica,
troviamo un compiacimento nella fruizione visiva del grottesco e del raccapricciante, nelle sue manifestazioni ed estrinsecazioni. La rappresentazione
dell’orrido attraverso l’esibizione del teschio o dello scheletro, indulge e fa leva
sull’assenza del volto, sull’assenza del corpo, sullo svuotamento dell’umano
dalla sua massa carnale, fatta di vasi sanguigni, capillari, nervi, muscoli, e
che, maschera ripugnante, sostituisce, dissimula, parodizza la presenza del
corpo. Specchio e raffigurazione della più atavica paura umana, il mutamento del corpo vivo e pulsante si confronta con il suo corrispettivo inanimato:
la materia inerte, preda del disfacimento. Per esempio spesso nelle opere di
J. M. Basquiat23 (Triennale, Milano 2006) la protagonista è la maschera del
volto deformato, il teschio e lo scheletro officianti.
L’autoritratto che presentiamo dell’artista statunitense di origine afrohaitiana raffigura un essere nero dall’immenso occhio-ala, uno stregone24 . Il
pittore rappresenta il rituale, mette in atto la sacralizzazione e trasfigurazione del corpo. Nei disegni, quadri e graffiti di Basquiat spesso si trova la
presenza del volto deformato e dello scheletro. Basquiat fa affiorare, e rende
visibili e fruibili dal suo pubblico, le proprie radici culturali haitiane. Pone
spesso così il proprio pubblico davanti a veri e propri altari vudù, instaurando costantemente un dialogo con la dimensione religiosa e animista delle
proprie origini culturali, dialogo in cui fa entrare il pubblico stesso. Egli
riattualizza così la natura e la dimensione della sacralità collettiva propria
del vudù, come ricorda anche Alfred Métraux nel suo saggio del 1958 Il vodu
haitiano – Una religione tra leggenda sanguinaria e realtà etnologica25 .
In Basquiat ritroviamo l’afflato collettivo, che riunisce la dimensione sociale ed artistica, proprio del vudù delle origini, a cui egli attinge per quanto
riguarda uso e raffigurazioni simboliche. In alcuni quadri egli ritrae e presenta se stesso come un vero hungan, ovvero un sacerdote che si rivolge ai
fruitori delle sue opere proprio come il sommo sacerdote si rivolge ai propri
adepti, agli inziati.. Le sue tele e i suoi collages sono veri e propri humfò,
templi e altari vudù, in cui vengono celebrati rituali che portano lo spettatore
23
The Jean Michel Basquiat Show, catalogo della mostra di Milano 19 settembre 2006
– 28 gennaio 2007, a cura di G. Mercurio, Skira, Milano 2006.
24
Vd. Figura 3, p. 15.
25
A. Métraux, Il vodu haitiano – Una religione tra leggenda sanguinaria e realtà
etnologica, tr. it. di A. Spatola, Einaudi, Torino 1971.
10
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
al centro del punto nevralgico dell’incontro tra segno e disegno, tra la parola
e la sua decifrazione. Quella di Basquiat diviene una sorta di grafia a-grafa.
In molte delle sue opere l’artista statunitense-haitiano raffigura simboli relativi alla suprema cerimonia del vudù, ovvero quella definita da Métraux
la “presa degli occhi” 26 . Si tratta della consacrazione del sacerdote vudù e
implica l’attestazione del dono della chiaroveggenza: in molti quadri possiamo ritrovare la raffigurazione dell’occhio umano, a volte presentato anche
sotto forma di geroglifico egizio (l’occhio di Horus). Nelle sue opere appaiono
anche altri simboli vudù, come il tamburo, il bastone, il copricapo, le carte
da gioco (o tarocchi), preposti alla divinazione, e strumenti dell’hungan, o
le sciabole, simboli cari alla divinità di Ogu (che ha anche un corrispettivo
nella santería cubana).
Basquiat ci mostra dunque i ferri del mestiere dello stregone, i simboli e
gli oggetti usati per compiere i wanga, sortilegi. Inserisce questa simbologia
in un contesto metropolitano statunitense, con continui riferimenti alla vita
urbana e quotidiana.
Anche in altri autori contemporanei, anche più recenti di Basquiat, viene
riproposto il teschio come fulcro, figura centrale dell’opera d’arte, sia essa
pittorica o scultorea. Ricordiamo alcuni di questi autori, e di queste opere,
raccolte nella mostra “Barrocos y neobarrocos. El Infierno de lo Bello”. Qui
Pablo Alonso, per esempio, inscrive un teschio in una cornice nera, spumosa,
fatta di polistirolo espanso (200 cm × 250 cm, acrilico e polistirolo su tela,
2004). Dal teschio sembra irradiarsi un’aura, si diffondono raggi luminosi,
che ne definiscono il carattere iconico e anche ironico27 .
Anche Marina Abramoviç, definita una neo-mistica del corpo (dalla mostra Balkan Epic, Hangar Bicocca, Milano 2006), riprende la tematica dello
scheletro, ridotto però alla sua consunzione appena precedente la trasformazione in polvere delle ossa: l’artista presenta in un video se stessa impegnata
nel pulire con un’enorme spazzola un cumulo di ossa enormi. In questo caso
non si tratta di ossa umane, bensì animali. Davanti al video, fuori dallo
schermo, lo spettatore trova davanti a sé esposte le stesse ossa pulite dall’artista nel video. Qui non si pone più la questione del volto umano ridotto
alla propria struttura ossea, inespressiva, amorfa e anonima, ma si ripropone
comunque l’idea di una esibizione del corpo ridotto a materia inanimata.
Dagli esempi analizzati si è visto che, attraverso l’esibizione del teschio e
dello scheletro, sussiste una relazione tra la rappresentazione, fruizione (da
parte dello spettatore) dell’orrido e il sublime. L’orrido svolge una funzione
che si potrebbe declinare in due principali filoni: quello della critica sociale,
come per esempio avviene nel film di Bellocchio, e quello della trascendenza,
del rapporto con la religione e con l’esorcizzazione della morte. L’identificazione o il distanziamento dello spettatore con la rappresentazione di questi
26
27
Ibid., p. 67.
Vd. Figura 4, p. 16.
11
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
due elementi relazionati con la categoria estetica dell’orrido (teschio e scheletro), hanno quindi un ruolo fondamentale nell’equilibrio dinamico della
percezione e fruizione artistica.
Annelisa Addolorato Bertuzzi
Annelisa Addolorato Bertuzzi è Dottore di ricerca in Filologia spagnola (Universidad Complutense di Madrid), con la tesi dal titolo Mística y voz poética en la obra de Clara Janés.
De la tradición a las vanguardias e la poesía actual. Análisis filosófico-Literario. Laureata
in estetica (Università degli Studi di Milano) con una tesi su Octavio Paz. Dal 2003 è
docente a contratto presso le Università degli Studi di Milano e di Pavia – ha insegnato
Letteratura spagnola, Letterature ispanofone, Lingua e traduzione; attualmente insegna
Cultura spagnola, Lingua spagnola e traduzione.
È corrispondente italiana del portale sull’ispanismo internazionale Academiasofia
(http://www.rediris.es/list/info/academiasofia.es.html). Dal 2003 forma parte della Red
de Arte Joven de Madrid, come poetessa bilingue, con al suo attivo varie pubblicazioni
poetiche (anche in antologie e riviste: Sial, Hiperion, Slovento, http://afinidadesafectivas.
blogspot.com, e altre).
Autrice del libro La parola danzante. Octavio Paz tra poesia e filosofia (Mimesis, Milano 2001), di alcuni articoli e recensioni su poesia e arte contemporanea, pubblicati in
Arte Estetica, Materiali di estetica, Studi di letterature iberiche e iberoamericane, Il confronto letterario, Rocinante. Traduttrice, principalmente da spagnolo, catalano, inglese, e
curatrice di volumi di poesia e critica letteraria.
12
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Figura 1: Dinos e Jack Chapman, Teschi (1997-2000).
13
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Figura 2: Fotogrammi dal film Nel nome del padre, scritto e diretto da
Marco Bellocchio (1972).
14
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Figura 3: J.M. Basquiat, Autoritratto (1986).
15
ITIN ER A – R ivista di F ilosofia e di Teoria delle Arti e della Letteratura
Figura 4: Pablo Alonso (2004).
16