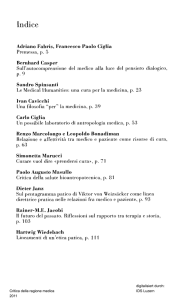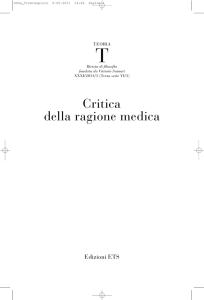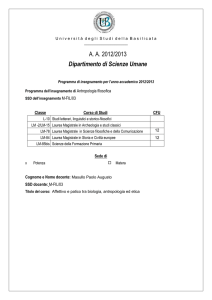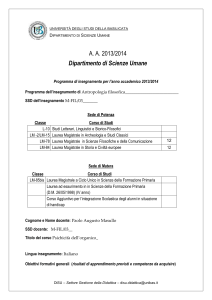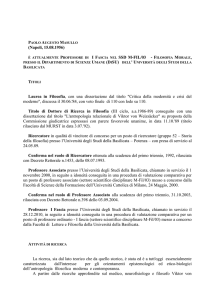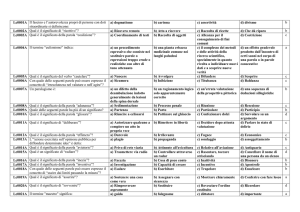RECENSIONI&REPORTS recensione Vicktor von Weizsäcker Filosofia della medicina a cura di Thomas Henkelmann, Guerini e Associati, Milano 1990, € 24 «Mi fu data libertà di scegliere la mia professione. Ma ero ancora in grado di giovarmi veramente di tale libertà? Avevo davvero fiducia di poter scegliere un’autentica professione? La stima di me stesso dipendeva da Te più che da ogni altra cosa, da Te, ad esempio, più che da un buon successo ottenuto» (F. Kafka, Lettera al padre, 1972, p. 38). Se Vicktor von Weizsäcker avesse avuto la stessa disperata sensibilità di Kafka, avrebbe potuto indirizzare una lettera analoga al padre Karl quando accantonò la sua vocazione filosofica in favore dell’esercizio della professione medica. Forse per questa inconfessata ragione non smise mai d’interrogarsi sul senso del “mestiere” di medico, sull’imperscrutabilità di tale occupazione. E quando si trattò di scegliere fra dovere e inclinazione, Weizsäcker – come nota Henkelmann nell’ampio saggio introduttivo – elevò l’indecisione a principio, radicando così, in quell’intimo dissidio, la sua innata capacità di vedere i contrasti per poi superarli, di mantenerli inoperosi l’uno accanto all’altro. L’andamento della sua speculazione è antilogico e, parimenti, se la scienza medica vuol progredire nelle sue indagini bisogna che assuma anch’essa un’andatura simile. Filosofia della medicina è una raccolta di saggi scritti nell’arco di un ventennio (dagli Elementi per un’antropologia medica del 1926 agli Anonyma Scriptura del ’46) che esprime l’esigenza di quest’interrogazione fondamentale. Il 350
S&F_n. 13_2015 buon medico si riconosce, essenzialmente, da una domanda: che cos’è che non va? Essa «chiede “cosa” e conserva nell’“a te” implicito l’elemento personale stabilito nell’“io”» (p. 94). In origine non c’è il sapere ma c’è il domandare: questa semplice formula istituisce il dialogo tra medico e paziente, ed è il primo passo verso l’avanzamento di ogni esame medico. Così come il primo sodalizio tra chi soffre e chi è chiamato a guarire si radica in un alone prelogico: l’atto terapeutico primigenio è la mano che tocca, reiterando quella bella immagine posta in esergo al saggio Il dolore – la «scena primaria» come la definisce Weizsäcker – della piccola samaritana che vedendo soffrire il fratello «con affetto cerca la sua mano e, amorevolmente, lo tocca dove gli fa male» (p. 97). In questo modo ha inizio «il primo concetto dell’operare medico, la prima tecnica della terapia» (ibid.). In tal senso, che Weizsäcker sia considerato il capostipite e principale esponente della medicina psicosomatica è un amaro scherzo del destino. Secondo il fisiologo tedesco, infatti, la psicosomatica deve costituire l’atteggiamento principale di ogni operare medico e non una disciplina a sé stante. Solo quando «la terapia diviene terapia psicosomatica, il suo cammino assume l’aspetto di un percorso circolare» (p. 140). La connessione tra psicoterapia e pratica clinica, ad esempio, non va interpretata come conflitto o scissione, bensì come conforto e sostegno reciproco. Weizsäcker utilizza a tal proposito la seguente formula: «dall’Es deve diventare Io, e dall’Io deve diventare Es» (p. 142); in questo duplice processo prende avvio la terapia. E tuttavia la medicina classica ci mantiene distanti da una tale comprensione, essa deve innanzitutto interrogarsi su se stessa, sul proprio compito e su i propri limiti, su ciò che indagabile e su ciò che non lo è. La questione è messa bene in luce nel saggio del ’45, Il concetto di vita. «La vita è forse l’inconciliabile opposto della scienza» (p. 146), già nelle dispute tra vitalisti e meccanicisti Weizsäcker individua come ragione fondante il fatto 351
RECENSIONI&REPORTS recensione semplice che «la nostra valutazione degli esseri viventi deve essere in sé contradditoria e che non si può mai contare sull’eliminazione di tale contraddizione» (p. 146). D’altronde, la scienza degli esseri viventi ha a che fare con oggetti del tutto particolari, che contengono essi stessi un soggetto. Dalla dichiarazione di Copenaghen in poi, la stessa scienza fisica sembra muoversi nella direzione di tale inserimento del soggetto nell’oggetto. Una volta dato per buono ciò, le vecchie pretese scientiste di universalismo e di rappresentabilità del mondo devono decadere. Si deve imparare a far ricerca rinunciando all’ideale della Weltanschauung. Non si può afferrare il senso della vita direttamente, ogni risposta assomiglierebbe all’eco di una grotta, «ma lo si può apprendere e patire» (p. 154). Quest’apprendistato, in Weizsäcker, ha inizio col determinare ciò che chiama il “rapporto di fondo”: ciò che accomuna il vivente alla vita non è un rapporto tra le cose, viceversa quello che s’instaura con un fondamento, qualcosa di simile a ciò che intendeva Merleau‐Ponty quando rielaborava il concetto husserliano di Stiftung e lo traduceva con Institution, nel senso del cominciamento e dell’orizzonte del precategoriale. Ecco perché, secondo Weizsäcker, «in biologia occorre necessariamente muoversi all’interno di un tale rapporto‐di‐fondo, senza poter tuttavia coglierne il fondamento stesso (...) per comprendere il vivente, bisogna innanzitutto prender parte alla vita» (p. 178). Non si tratta di una petizione di principio, ma di un circolo virtuoso, figura che – non a caso – è eletta da Weizsäcker come tema della sua patosofia. Negli Anonyma Scriptura il fisiologo rielabora alcuni concetti cardine della sua teoria del Gestaltkreis, e definisce quelli che sono i caratteri del patico. In primo luogo il patico si differenzia dall’ontico: in ragione di ciò il rapporto della vita col vivente non è mai un rapporto tra cose ma sempre un rapporto di dipendenza riferita al rapporto di fondo. In secondo luogo il patico è personale: «se si prova a separare le 352
S&F_n. 13_2015 asserzioni patiche dall’”io”, ci si accorgerà immediatamente che quest’ultimo può venire senz’altro sostituito con “tu”, “egli”, “noi”, ecc; al contrario, la frase diventa insensata quando si fa ricorso a cose inanimate: una pietra, cioè un “esso”, non vuole né deve» (p. 179). Gli esseri viventi, inoltre, s’incontrano e non si trattengono in uno spazio, creano eventi, divengono. Insomma sono percorsi da una componente antilogica: «il vivente è sempre qualcosa di permanente che muta – come l’uomo» (p. 180). L’atto biologico, perciò, è «un’unità comprensiva» (p. 183), qualcosa che realizza l’armonia degli opposti. Questo ritornare a se stessi restando nel movimento descrive la figura del Gestaltkreis, definita da Weizsäcker come «la struttura essenziale dell’atto vivente afferrato in modo patico» (ibid.). Ma tale principio non si può possedere nella sua pienezza, lo si può soltanto percorrere, resta occultato fra le pieghe della vita, espressione dell’ineffabile trascendenza dell’atto biologico. Il pensiero di Weizsäcker più che manifestarsi come resa filosofica rappresenta, agli occhi di noi lettori contemporanei, l’esigenza di rimodulare i criteri interpretativi tra scienza e filosofia, di profilare una nuova antropologia medica. «Come la maggior parte dei miei amici, ho tentato, nella ricerca, di nuotare controcorrente e al posto della biologia e medicina classico‐naturalistica, quindi fisicalisticamente orientata, ho tentato di figurarne una antropologica. Mutamento di funzione e Gestaltkreis erano teorie che (...) non riuscirono a guadagnarsi nessun vero successo nella scuola e tra i miei colleghi coetanei. Un’accettazione di queste basi può essere avvenuta, se mai, solo per mezzo di un salto nella generazione futura (...) Scientia facit saltus» (pp. 74‐75). Data l’importanza che ancora oggi rivestono i suoi studi e il carattere innovativo riconosciutogli da diversi esponenti della filosofia contemporanea, è lecito affermare che l’augurio di Weizsäcker non è rimasto inascoltato. ALESSANDRA SCOTTI
353