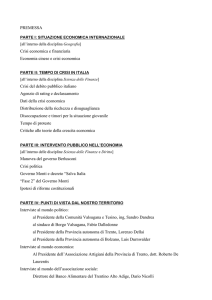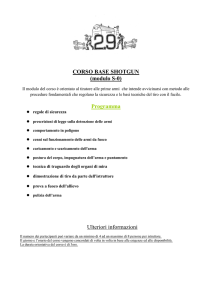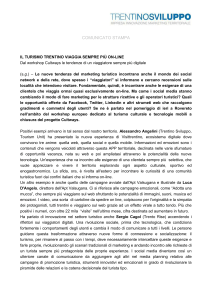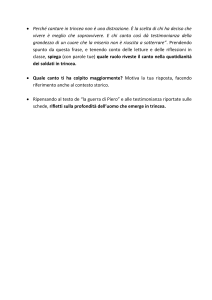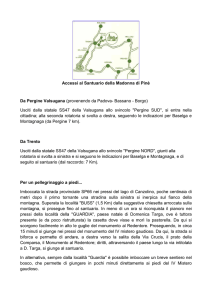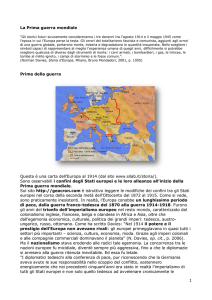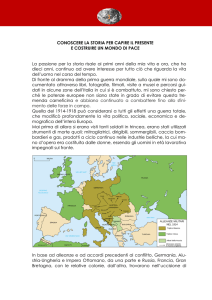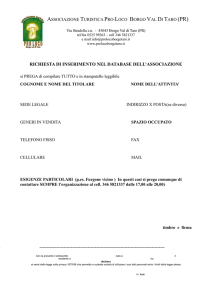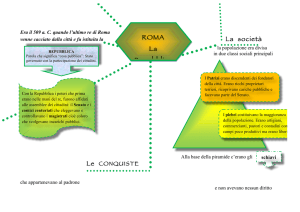il nostromuseo
Guida alla Mostra Permanente
della Grande Guerra
in Valsugana e sul Lagorai
A cura delle classi. VAL e VBL
Istituto di Istruzione A. Degasperi - Borgo Valsugana
(Foto Giacomo Bianchi)
coordinate dal prof. Pierluigi Pizzitola
Supervisione scientifica: Luca Girotto, Fulvio Alberini
1
2
Allestita all’interno dell’ex Mulino Spagolla in uno degli angoli fluviali più suggestivi del centro storico di
Borgo, la Mostra Permanente della Grande Guerra in Valsugana e sul Lagorai è il risultato dell’impegno
dell’Associazione Storico-Culturale della Valsugana Orientale e del Tesino (ASCVOT) che ha tra i suoi
scopi quello di conservare e valorizzare le testimonianze materiali, bibliografiche, archivistiche e fotografiche sulla Grande Guerra nell’area compresa tra la Valsugana e la catena del Lagorai-Cima d’Asta.
L’esposizione, inaugurata nell’ottobre 2002, ma ampliata e radicalmente rinnovata nella forma attuale a
fine 2005, occupa due ambienti strettamente connessi ma radicalmente diversi.
La prima parte si snoda in un ampio e luminoso locale a colonne, dove le vetrine si alternano a pannelli
fotografici e diorami. Articolata in spazi tematici, essa racconta al visitatore l’evolversi delle operazioni
militari, illustrando con materiale fotografico dell’epoca i campi di battaglia e le distruzioni subite dai
paesi della valle.
Anche il contemporaneo progredire dell’arte della guerra si dipana spaziando dall’evoluzione del copricapo alle trasformazioni dell’uniforme da combattimento, dal modernizzarsi delle armi da fuoco individuali alla progressiva perdita d’importanza della baionetta e all’apparizione del pugnale da trincea.
Nelle bacheche compaiono pezzi eccezionali, come il cavalletto italiano e austriaco per il tiro fisso, i prototipi di “berretto corazzato” che diedero avvio all’evoluzione dell’elmetto metallico, o le corazze “Farina”,
antesignane dei moderni giubbotti antiproiettile utilizzate dai guastatori italiani.
Suggestivi diorami illustrano scene di vita di trincea, o ci mostrano il riposo di militari annidati in una
baracca d’alta quota. Ariose vetrine ospitano poi fedeli ricostruzioni delle uniformi, realizzate con preziosi
materiali originali dell’epoca.
Questa pubblicazione fornisce un utile supporto alla visita ed è stata realizzata grazie al prezioso impegno delle classi VA e VB del Liceo scientifico Degasperi di Borgo Valsugana. Coordinati dal professor
Pierluigi Pizzitola, gli studenti hanno aderito con entusiasmo all’attività sperimentale Il Nostro Museo
che s’inserisce nel progetto Museo Diffuso finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e
Rovereto. Tale iniziativa è nata con lo scopo di mettere in dialogo i diversi spazi culturali e musei della
Valsugana orientale per valorizzare e comunicare con maggiore forza le ricchezze naturali e culturali di
questo territorio.
Organizzato in sezioni tematiche, il testo offre la possibilità di immergersi negli spazi della mostra e di
soddisfare le curiosità, il desiderio di approfondimento e conoscenza che naturalmente nasce nel corso
della visita al museo.
Nella sezione conclusiva una breve appendice racconta nel dettaglio il progetto, le motivazioni metodologiche, culturali e didattiche che lo hanno animato.
Guida alla
Mostra
Permanente
della Grande
Guerra in
Valsugana e
sul Lagorai
3
Un’introduzione allo sco
Grande Guerra in Valsug
Non è possibile trattare gli eventi di una singola zona, ancor più se
periferica, senza fare un accenno al quadro storico che racconta la
dimensione e la complessità del primo conflitto mondiale.
4
Sarajevo, 28 giugno 1914: il nazionalista serbo Gavrilo Princip
uccide l’Arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’AustroUngheria, e la moglie Sofia Chotek.
L’evento provoca la reazione politica imperiale, che sfocia in un
inaccettabile ultimatum alla Serbia e porta, una volta rifiutato, allo
scoppio di un conflitto fra i due Stati. Il gioco di alleanze fra le principali nazioni europee fin dall’inizio del secolo (principalmente la
Triplice Alleanza e la Triplice Intesa) dà il via a un “effetto cascata” di
ultimatum e dichiarazioni di guerra.
Fra il 28 luglio e il 5 agosto 1914, si trovano coinvolte nel conflitto
anche Germania, Francia, Inghilterra e Russia: uno scontro regionale si trasforma in una guerra totale europea.
L’allargamento del fronte richiede sempre più truppe: all’indomani dello scoppio del conflitto vengono richiamati tutti i riservisti. In
Valsugana, come nelle altre province dell’impero Asburgico, vanno sotto le armi tutti gli uomini abili fra i 21 e i 42 anni che vengono
inquadrati in unità etnicamente miste (sia italiani che tedeschi) nei
reggimenti Landschutzen e Kaiserjager. Questi reparti vengono in
seguito inviati principalmente sul fronte Galiziano.
Le notizie che arrivano dal fronte diffondono l’idea di un conflitto
che si sarebbe vinto in poco tempo e con poche perdite. In seguito, i racconti dei feriti e dei convalescenti o reduci avrebbero
coppio della
ugana
raccontato una storia ben diversa, in cui dominavano i tre fattori determinanti
della Prima guerra Mondiale: la trincea, il baluardo della difesa ma che spesso era il regno del fango, di topi, insetti e malattie; il reticolato, disteso in barriere
fitte e impenetrabili che dovevano essere aperte con gran difficoltà ed alto costo
in vite umane; la mitragliatrice, che da sola poteva falciare centinaia di uomini.
L’entrata dell’Italia nel conflitto il 24 maggio 1915 trasforma il Trentino in vero e
proprio campo di battaglia: la linea del fronte austriaca viene tuttavia attaccata
solo da una delle cinque armate Italiane, mentre le altre quattro si concentrano
ad est e nord-est, tra Cadore, Carnia, alto e basso Isonzo e costiera adriatica.
All’inizio del 1915 l’Austria registra già la perdita di 2 milioni di uomini fra caduti,
feriti,dispersi e prigionieri. Vengono destinati alla difesa anche giovani con meno
di 21 anni e gli uomini fino ai 50, in generale male equipaggiati e scarsamente
addestrati.
Gli italiani cominciano a risalire la valle da Grigno verso Borgo Valsugana. Nonostante la mancanza di resistenza austriaca, impiegano tre mesi per arrivare
a Borgo Valsugana, che viene occupato il 24 agosto. Nel frattempo gli Austriaci
arretrano a Levico e occupano le zone montane circostanti individuando, in particolare, la Panarotta come punto di osservazione della valle.
Fra il luglio e il dicembre 1915 le regie truppe conquistano Telve e Olle, oltre a
varie alture tatticamente rilevanti fra cui il Monte Lefre, un fondamentale osservatorio per le artiglierie, e la Val di Sella. In questa fase gli Italiani procedono senza
opposizioni, salvo scontrarsi con poche pattuglie.
Dopo la battaglia di Sant’Osvaldo (aprile 1916), la situazione cambia radicalmente il 15 maggio 1916 quando gli Austriaci danno il via alla Strafexpedition
(Spedizione punitiva), l’offensiva con la quale le forze imperiali riescono a sfondare la linea italiana, dilagando sull’altipiano dei Sette Comuni vicentini. La Val di
Sella viene rapidamente rioccupata, gli Austriaci rientrano quindi a Borgo Valsugana e Olle (devastati da bombardamenti incendiari) costringendo gli Italiani alla
fuga. Anche Telve, Torcegno e l’altura del Civeron tornano in mano austriaca,
costringendo gli Italiani a ripiegare su Agnedo e Ospedaletto e al caposaldo di
Monte Lefre. Il fronte si sposta quindi alla confluenza del Maso col Brenta, mentre gli Italiani si aggrappano all’estremità orientale del Civeron.
Gli imperiali, il 24 maggio attaccano anche la zona di Samone, su Monte Cima
- chiave per l’accesso al settore di Strigno e del Tesino - dove però la puntata
offensiva viene respinta grazie alla resistenza dei battaglioni alpini.
Il 1917 culmina sull’Ortigara, senza risultati tangibili per gli italiani. Sul fondovalle
l’offensiva Italiana su Carzano si conclude in un massacro costato oltre 1300
perdite.
Con l’offensiva di Caporetto ed il conseguente ripiegamento italiano, il fronte si
sposta sul Grappa ponendo fine alle operazioni in Valsugana fino al novembre
dell’anno successivo, quando il crollo dell’apparato militare dell’Austria-Ungheria
permette alle regie truppe di risalire velocemente il corso del Brenta fino a Borgo,
Levico e Caldonazzo.
Quando gli sfollati e i reduci rientrano ai paesi natii, alla fine del 1918, trovano
abitati vuoti e in rovina, gravemente danneggiati dagli scontri e dagli scambi tra le
opposte artiglierie; le campagne, solcate dai trinceramenti, devastate e incolte;
il patrimonio pastorale distrutto ed i boschi bruciati dai bombardamenti o abbattuti per ricavare la legna. Un’economia e una società devastate, che dovettero
ripartire da zero per costruire una prospettiva di vita a una popolazione che nella
quasi totalità non aveva neppure immaginato l’idea diventare italiana.
Simone Lenzi, Andrea Zambiasi, 5BL
5
Le divise
Principali evoluzioni
nel corso della guerra
6
La tradizione militare dell’Esercito Austro-Ungarico era una
delle più antiche fra quelle esistenti all’epoca. I vari corpi
erano caratterizzati da una combinazione di mostreggiature e profilature colorate, bottoni metallici numerati e copricapi che potevano essere uguali per il Corpo e con differenze minime a seconda della specialità alla quale il militare
era destinato. In seguito al cambiamento delle condizioni
di guerra/battaglia si abbandonarono le uniformi tradizionali
con colori vivaci e bottoni luccicanti per dotare le truppe di
un abbigliamento mimetico e meno appariscente, adatto
agli ambienti rocciosi. La fanteria e l’artiglieria dell’esercito
comune adottarono così un’uniforme da combattimento
più moderna di panno grigio-azzurro.
I Tiroler Kaiserjager, i cosiddetti “cacciatori dell’Imperatore”, erano un corpo di
fanteria leggera. La nuova uniforme, di colore grigio-azzurro, aveva un taglio più
confortevole e pratico per muoversi più rapidamente nelle operazioni. La giacca era caratterizzata dalla fattura del colletto “in piedi” con applicate all’esterno
le mostrine rettangolari di panno verde erba, tipiche del Reggimento di appartenenza, sulle quali erano cucite le eventuali stellette di grado. A completare
l’uniforme c’era il berretto da campo di panno grigio-azzurro con la visiera rigida
su cui era fissata frontalmente una coccarda con il ricamo del monogramma
imperiale FJI. La tenuta era completata da un cinturone in cuoio con fibbia rettangolare in ottone, prodotta in diversi modelli, prima e durante la guerra.
I Tiroler Kaiserschutzen erano gli “alpini” austriaci. Il colore delle divise era il
Feldgrau (simile al colore dell’uniforme germanica). La giubba da truppa aveva
il bavero rivoltato con mostrine verde erba e il ricamo degli Edelveissabzeichen
che distinguevano le truppe da montagna. I pantaloni, ampi sulle cosce e stretti
sotto il ginocchio, venivano portati con gambaletti di lana al polpaccio; questi
ultimi erano privi del piede, avvolto di solito con pezze di cotone. Gli scarponi in
cuoio robusto alti fino alla caviglia, avevano suole e tacchi rinforzati da una fitta
chiodatura. Il berretto, di feltro impermeabile aveva un risvolto con taschino nel
quale era infilato il Federschmuck di penne di gallo forcello. Il fregio frontale recava il monogramma coronato dell’Imperatore Karl I. Al seguito dei soldati, pochi
ma essenziali oggetti per la sopravvivenza in montagna.
Le Sturmtruppen furono le ardimentose truppe d’assalto austro-ungariche della
Prima Guerra Mondiale. Istituite nel 1916, sull’esempio di quelle tedesche, erano
equipaggiate con una divisa rinforzata con toppe di cuoio su gomiti e ginocchia,
elmetto d’acciaio, tascapane con provviste, torcia elettrica, carabina, baionetta,
bombe a mano e pugnale d’assalto, spesso costruito dagli stessi soldati. La
giubba grigio-verde era aperta, con decorazioni sul bavero, un maglione a collo
rovesciato al posto del colletto chiuso e pantaloni all’alpina; l’equipaggiamento
era rappresentato da materiali comodi e leggeri. La giubba aveva inoltre un distintivo: il cosiddetto brevetto Sturmtrupp in lega di zinco, marchiato frontalmente
con la lettera “G“.
L’Uniforme del soldato italiano era composta da una giubba e pantalone di pan-
no pesanti, con piccole differenze per le Armi a Piedi (Fanteria, alcune specialità
di Artiglieria e Genio) o le Armi a Cavallo (Cavalleria, Artiglieria e Carabinieri). La
giubba, ampia e comoda, era a un petto con colletto in piedi ed era chiusa da
una bottoniera nascosta. Degli spallini a salsicciotto erano fissati all’attaccatura
delle maniche che terminavano con dei paramano a punta. Sotto la giacca, un
gilet di taglio classico.
Il soldato di fanteria apparteneva alla famosa brigata Sassari (come indicano le
mostrine della giubba) ed era armato di fucile con baionetta. L’uniforme, di colore grigio-verde, era composta da una giubba a un petto priva di tasche esterne,
pantaloni lunghi, stretti alla caviglia da due laccetti e ricoperti nella parte inferiore
dalle fasce mollettiere, stivaletti in cuoio ed elmetto metallico Adrian, oltre, a
scopo protettivo, degli occhiali paraschegge.
L’ufficiale di fanteria aveva un’uniforme da combattimento in panno grigio-verde. La giubba aveva quattro tasche esterne, sul bavero in piedi erano applicate
delle mostrine con stellette da ufficiale. Indossava pantaloni per truppe montate,
molto in uso tra gli ufficiali, corti e stretti sotto il ginocchio con fasce mollettiere in
panno che coprivano la parte inferiore delle gambe. Gli stivaletti, del modello per
truppe da montagna, avevano una chiodatura pesante della suola. Portava un
elmetto Adrian scuro di fornitura francese.
Caterina Giacobbo, Martina Natali 5AL
7
Le maschere
anti
gas
8
Durante la Prima Guerra Mondiale una delle innovazioni
che più cambiò la natura dei combattimenti fu il gas. Le
armi chimiche vennero utilizzate in larga scala grazie ai
notevoli progressi dell’industria che aveva messo a punto
sostanze sempre più nocive.
Il primo Stato a utilizzare questa nuova arma fu la Germania nel 1915. Solo due anni dopo, nel 1917 circa, i tedeschi lanciarono un attacco contro gli italiani utilizzando tali
armi; fu impiegato un nuovo composto, l’iprite, (chiamata
dai francesi Gas Moutarde a causa del suo forte odore di
mostarda) un liquido che impregnava il terreno per molto
tempo, provocando gravi lesioni alla pelle in caso di contatto e la morte se respirato.
Per difendersi i soldati iniziarono a usare tute gommate e
maschere protettive. Si sperimentarono poi nuovi composti e le tecniche per
l’impiego dei gas progredirono velocemente; dalle semplici bombole si passò
alle bombarde, ai proiettili e alle bombe a mano caricate a gas. Contemporaneamente però si svilupparono anche sostanze neutralizzanti e maschere che
proteggevano l’apparato respiratorio contro aggressivi chimici come il fosgene,
i lacrimogeni (irritanti per le mucose) o dall’iprite (tossica per l’organismo). Nonostante l’effetto dei gas fosse disastroso, la buona riuscita degli attacchi dipendeva dall’effetto sorpresa (che scomparve quasi subito a causa degli allarmi
adottati: sirene, fischietti, segnali luminosi) e dalla direzione del vento, che poteva
far cambiare la traiettoria ai gas, disperdendoli ed eliminando il loro effetto. L’Italia
non ricorse immediatamente a protezioni valide e per questo i gas tossici fecero
inizialmente molte più vittime del previsto.
L’utilizzo di questa metodologia offensiva basata sull’emissione di nubi di gas
asfissianti fu abbandonato dal nemico dopo l’attacco del 29 giugno 1916 a San
Michele in cui gli effetti furono inferiori alle aspettative. Si passò quindi all’impiego
di bombe da bombarda e di proiettili d’artiglieria “a liquidi speciali”, che assicuravano maggiormente l’effetto sorpresa. Episodi come quelli del S. Michele
aumentarono il terrore dei soldati anche se i mezzi per la neutralizzazione dei gas
erano diventati parte integrante dell’equipaggiamento. Le maschere limitavano
però l’udito, non permettevano di parlare e affaticavano la respirazione (molti soldati morivano proprio perché toglievano la maschera, non riuscendo a respirare
bene con essa), le lenti si appannavano facilmente.
Tra le armi chimiche utilizzate dai tedeschi si ricordano anche i proiettili a “croce
verde”, la cui miscela rendeva inizialmente insopportabile la maschera e poi,
una volta che essa veniva tolta, sviluppava un’azione soffocante; e i proiettili a
“croce gialla” per contaminare il terreno.
Le prime protezioni contro queste armi erano all’inizio semplici tamponi in garza
che coprivano naso e bocca; il soldato, al momento dell’utilizzo, doveva impregnare i tamponi con la sostanza neutralizzante contenuta in una boccetta
di vetro. La migliore si dimostrò essere l’inglese Small Box Respirator. Era un
oggetto complesso, formato da maschera in tela cerata, provvista di oculari,
pinza stringi-naso, boccaglio di gomma e un tubo che collegava la maschera
alla scatola del filtro. Nel kit c’era un tubetto di pasta antiappannante per le lenti.
Un’altra buona protezione fu la M2 francese, un tampone a numerosi strati con 2
neutralizzanti: era ricoperta di tela cerata per impedire l’evaporazione dei neutralizzanti e veniva riposta in una busta, oppure dentro una scatola in latta e sempre
portata a tracolla. La superficie di filtrazione era estesa a tutta la maschera, che
comprendeva anche la protezione per gli occhi.
Le maschere di produzione italiana erano composte inizialmente da tamponi a
diversi strati di garza da impregnare, o già imbevuti di neutralizzanti, che coprivano naso e bocca ad azione monovalente. Nel ‘17 si arrivò a quella polivalente
con occhiali incorporati.
La maschera antigas italiana polivalente a protezione unica ricopriva completamente viso e guance. Gli occhiali erano incorporati con lenti in acetilcellulosa. Era contenuta in un astuccio di latta a tracolla. Oltre a non proteggere contro i
gas vescicanti, era lenta da adattare al viso e l’astuccio di latta, ingombrante, era
spesso abbandonato in trincea.
La Gummimaske di produzione austriaca era in tela gommata e caucciù,
con lenti in celluloide. Nel filtro era contenuta pomice granulare imbevuta di potassa, urotropina e carbone attivo impermeabile ai gas e - altra novità - proteggeva totalmente anche gli occhi, grazie a due lenti cerchiate da anelli in metallo.
Inizialmente era contenuta in una custodia di stoffa, con il filtro supplementare
smontato poi, vista la scarsa praticità, la custodia fu sostituita con una in metallo
con la maschera già munita di filtro, pronta per l’uso.
La Lederschutzmasche fu prodotta nel giugno del 1917, era in cuoio impermeabilizzato, per sopperire alla penuria di caucciù. Lo spazio interno era
ridotto per facilitare la respirazione e per avere una maggiore aderenza al viso.
I visori erano composti di una lente esterna in acetilcellulosa con una griglia di
protezione metallica e una lente interna anti-appannamento intercambiabile.
Fra esse vi era uno strato di miscela di gelatina e cellulosa. Alla fine del 1917,
fu distribuito un filtro supplementare di 1,5 cm d’altezza da applicare al filtro
originale, contro le arsine.
Bora Mullameti, Giacomo Nicoletti 5BL
9
Guerra
e sanità
L’equipaggiamento di un medico,
le condizioni sanitarie sul fronte
10
La guerra determinò il richiamo di personale medico e infermieristico composto da
medici “anziani” e studenti. Generalmente gli studenti di medicina appena laureati si
trovarono a lavorare negli ospedaletti di prima linea, dove affluiva quotidianamente
un’enorme quantità di feriti.
I treni-ospedale e le navi-ospedale furono una soluzione al problema dello smistamento rapido dei feriti, dal momento che molti di essi necessitavano di cure immediate. Di queste strutture si avvalsero soprattutto i medici che lavoravano in prima linea
per prestare tempestivamente le prime cure (soprattutto per le ferite all’addome, le più
difficili da curare e che spesso i chirurghi si rifiutavano di operare perché le complicanze dell’operazione portavano facilmente alla morte).
Un ruolo molto importante venne svolto anche dalla croce rossa (CR) che mobilitò
800 infermiere volontarie, attrezzò più di 70 ospedali da campo mobili e 40 ambulanze
da montagna e radiologiche. Vennero aperti nuovi centri per il ricovero, sfruttando
scuole, conventi, ville, ospedali neuro-psichiatrici, centri per la rieducazione, sanatori
tubercolari.
Molto spesso la ricerca dei feriti sui campi di battaglia avveniva durante la notte.
Per il recupero ci si avvalse di cani di varie razze che dovevano perlustrare il
territorio: una volta trovato il ferito, il cane ritornava dal suo accompagnatore o si
accucciava a fianco della vittima e iniziava ad abbaiare per ottenere l’attenzione
degli uomini di soccorso.
Da ricordare il sacrificio delle infermiere volontarie che in numero rilevante rimasero ferite, uccise o vennero catturate.
La vetrina dedicata alla sanità militare austriaca propone la figura di uno Standschutze di sanità.
I Tiroler Standschützen erano stati mobilitati con la leva di massa nel 1915; chiamati anche “scizzeri” o “bersaglieri immatricolati”, vi appartenevano gli iscritti ai
tirassegno locali del Tirolo scartati alle visite di leva dell’esercito regolare o non
più (o non ancora) richiamabili per ragioni d’età (sotto i 20 o sopra i 50 anni). Si
trattava quindi di giovani e vecchi con una certa abilità nell’usare le armi, anche
se non avevano ancora ricevuto un formale addestramento militare o lo avevano
ricevuto decenni prima. Per privilegio imperiale avevano da secoli la concessione di combattere esclusivamente in patria, per difendere i confini del Tirolo.
I reparti regolari avevano ovviamente la precedenza su di essi in termini di rifornimenti ed equipaggiamenti e gli Standschütze ricevettero quindi quasi sempre
dotazioni obsolete.
Per gli infermieri la dotazione prevedeva un tascapane modificato, un bracciale
bianco con la croce rossa, una speciale giberna - cioè un astuccio di cuoio o di
tela, borracce, una daga detta “di sanità” (che faceva parte dell’equipaggiamento, ma non era considerata come un’arma, servendo per tagliare rami e creare
barelle di circostanza).
Quando molti feriti arrivavano negli ospedaletti di prima linea, spesso i più gravi
dovevano essere lasciati morire per dare la precedenza ai feriti “recuperabili”.
A causa della mancanza di antibiotici anche la più semplice operazione poteva
diventare fatale, provocare infezioni che portavano all’amputazione, a setticemie
e alla morte.
Fra le cause di morte c’era anche il dissanguamento: la pratica della trasfusione
era poco usata a causa dei problemi di coagulazione e di trasporto del sangue.
Il pacchetto di medicazione fornito al soldato era di garze per tamponare le ferite,
una benda per reggerle e, a volte, una fialetta di tintura di iodio da usare come
disinfettante.
La guerra portò però anche a rapidi miglioramenti della medicina, soprattutto
nella chirurgia addominale e ortopedica. Migliorarono anche i sistemi di anestesia: inizialmente si usava l’alcool per addormentare il ferito oppure, in mancanza
di questo, si operava senza anestesia. In questo periodo fece la sua comparsa
anche l’impianto radiologico da campo.
Venne introdotta la pratica della vaccinazione di massa contro alcune malattie
come il tifo, il tetano e il colera; i soldati erano comunque periodicamente affetti
da altre patologie come l’enterite batterica, la meningite, la malaria, i reumatismi
e i congelamenti. I militari erano inoltre facile preda delle infezioni anche a causa
della malnutrizione e delle scarse condizioni igieniche. A questa già precaria
situazione si aggiungeva la triste condizione di coloro che erano a contatto con
i cadaveri, a volte per lungo tempo sparpagliati nelle trincee o in prossimità di
esse. Inoltre, causa della durata del conflitto, si estendeva sempre più l’abitudine
ad avviare alla guerra uomini non perfettamente sani.
Sui campi di battaglia fecero la loro comparsa le malattie neuropsichiatriche che
colpivano i soldati costretti a vivere costantemente con l’immagine incombente
della morte. I danni psicologici spesso non avevano una cura poiché le conoscenze in merito erano ancora molto ridotte. Nelle trincee si diffusero anche
malattie a trasmissione sessuale, come la sifilide e la gonorrea, che però vennero per lungo tempo censurate: esse venivano portate al fronte dai militari che
frequentavano i bordelli che erano nati rapidamente nelle immediate retrovie.
Per rassicurare la popolazione circa il conflitto, venivano pubblicati degli opuscoli
informativi sull’andamento delle guerra e sui problemi politici e economici. Fra di
esse una riguardò la preparazione sanitaria dell’esercito in cui venivano elencati
i mezzi utilizzati dai medici e dalle infermiere, si affrontava il tema della preparazione sanitaria nell’esercito e venivano elencate delle statistiche sui i morti e i
feriti (statistiche che però erano riferite a guerre passate e perciò non avevano
nessuna corrispondenza con gli esiti del “nuovo conflitto”).
Nadia Bernardi, Silvia Purin 5BL
11
La trincea
12
Le operazioni militari su tutti i fronti subirono fasi alterne,
caratterizzate da manovre offensive e altre in cui gli eserciti impegnavano le loro forze a difendersi piuttosto che
ad attaccare. Così alla guerra di movimento subentrò una
logorante guerra di posizione: la trincea divenne allora il
tragico simbolo della Grande Guerra. Se inizialmente
erano state concepite come rifugi provvisori per le truppe
in attesa di un assalto, in seguito divennero la sede permanente dei reparti di prima linea, sempre più difficilmente
espugnabili.
La modalità di costruzione della trincea era connessa alle
condizioni del luogo in cui doveva essere realizzata. In alta
quota si scavavano gallerie tra neve e pietrame, con ricoveri in posti impossibili, giungendo alla realizzazione di veri
e propri paesi sulla roccia e nel ghiaccio. Nel fondovalle,
invece, si preferivano costruzioni in sasso e la creazione di
pianori per l’accampamento militare.
In entrambi i casi era indispensabile che i soldati fossero in
grado di costruire in breve tempo trincee e caposaldi, eseguendo il lavoro a mano. Non mancava, tra mille difficoltà,
l’uso di materiali di fortuna e riciclo.
La profondità della trincea era pari almeno all’altezza di un
uomo: era uno scavo collocato al di sotto del livello del
terreno e aveva come parapetto dei sacchi di sabbia sporgenti, punto debole
della struttura in quanto principale bersaglio. Col passare del tempo furono allargate, dotate di ripari, di “nidi” di mitragliatrici, e protette da reticolati di filo spinato.
Oltre alle barriere in sacchi a terra, situate in prossimità delle trincee, la prima tra
le “difese passive” era il filo spinato: un’arma semplice ma efficace. L’ostacolo
inizialmente era costituito solo da filo di ferro; poi si scoprì che poteva essere
spinato con appositi macchinari, sostenuto dai pali a coda di porco o dai cavalli
di Frisia, teso per chilometri fino a formare profondi sbarramenti di centinaia di
metri talvolta attraversati da corrente elettrica. Una variante del filo spinato era la
catena-reticolata, costituita da anelli legati fra loro e muniti di un paio di aculei
contrapposti, valida per il suo effetto a sorpresa nello sbarramento nei corsi d’acqua poco profondi o negli stretti passaggi in montagna.
La fuciliera era invece uno schermo antiproiettile dotato di una feritoia per il fucile
attraverso la quale era possibile anche osservare i movimenti nemici. I fucili venivano bloccati su un cavalletto e puntati sulla feritoia avversaria. All’interno della
trincea, vicino al bordo, vi erano gradini di tiro sui quali il soldato poteva affacciarsi
e sparare al nemico.
Se il soldato tentava di superare il filo spinato, vi rimaneva impigliato, diventando
facile bersaglio per il nemico. In aggiunta venivano utilizzate delle trance taglia
fili (all’inizio semplici cesoie da giardiniere procurate nei paesi di retrovia) per
recidere i fili del groviglio spinoso che proteggeva la trincea avversaria.
Di fronte all’imprendibilità delle trincee austriache in roccia, protette da multipli
sbarramenti di reticolato e da cavalli di Frisia (sul Carso e sulle montagne tirolesi),
al Comando supremo italiano la pinza taglia reticolato era apparsa come “la
soluzione”. Infatti il filo spinato austriaco, a differenza di quello italiano, era molto
più grosso, molto difficile da tranciare e con aculei e lamine di svariate forme
incastrate nell’intreccio. Per demolire il reticolato, i soldati italiani impiegavano
anche le bombarde e nel caso di fili percorsi da corrente elettrica dei taglia fili
con impugnature in bachelite o gomma isolante.
La zona tra due trincee nemiche era chiamata “terra di nessuno”. In essa erano disseminate, oltre a mine antiuomo, anche pericolose trappole, che potevano essere mortali. Vi erano i chiodi a 4 punte, grandi dai 2 ai 6 cm che, cadendo
a terra, mantenevano una punta rivolta verso l’alto. Essi venivano sparpagliati
dinnanzi alle trincee, tra i reticolati, o anche lungo le strade e i sentieri, celati da
terra e vegetazione, rendendo impossibile l’avanzata carponi dei soldati.
La tagliola antiuomo fu un’arma, inizialmente utilizzata dalla parte austriaca, simile al dispositivo impiegato per gli animali.
Vi erano poi fasci di palline in ferro appuntite, i cosiddetti istrici, lunghi 1 m e
tenuti insieme da un anello fisso che potevano essere posizionati sia orizzontalmente, come sbarramento, sia verticalmente, nascosti nelle “bocche di lupo”.
Per rafforzare la funzione del filo spinato venivano impiegate lamine di ferro
seghettate a denti grossi, fissate a tronchi o a pali o ai cavalli di Frisia.
Un’altra arma particolare era la freccia volante simile a una matita, con una
punta acuminata, spesso raccolta in mazzi e lanciata dagli aerei. Era un’arma
semplice ma micidiale, anche se non andava facilmente a bersaglio.
I cannoncini da trincea erano armi di dimensioni ridotte, che venivano impiegate all’interno della trincea, in particolare per colpire i sacchi si sabbia della
struttura delle trincee avversarie.
All’interno della trincea poteva essere impiegato anche un binocolo periscopico
che permetteva, attraverso ingrandimenti notevoli, di tenere sorvegliata la “Terra
di nessuno” e di controllare i movimenti nemici. Grazie alla sua struttura, permetteva all’osservatore di essere defilato rimanendo al sicuro al di sotto dell’orlo
del parapetto di sacchi di sabbia e di non essere esposto direttamente al fuoco
nemico.
La vita nelle trincee, monotona e rischiosa al tempo stesso, logorava i combattenti nel morale oltre che nel fisico gettandoli in uno stato di apatia e di torpore
mentale. Soldati e ufficiali potevano restare in prima linea per intere settimane
senza ricevere cambio, vivendo in condizioni igieniche deplorevoli e senza potersi lavare né cambiare. Erano esposti al caldo, al freddo e alle intemperie, oltre che ai bombardamenti dell’artiglieria nemica. Non uscivano dalle trincee se
non per compiere qualche pericolosa azione notturna di pattuglia o per lanciarsi
all’attacco delle trincee nemiche nelle prime ore del mattino.
Maddalena Galvan, Evelin Furlan 5AL
13
Le corazze
14
La corazza “Corsi” era costituita da 5 fasce a breve curvatura, incernierate a coda di gambero da due strisce di tela
parallele e collocate anteriormente. Permetteva una discreta agilità, poteva essere indossata anche sotto la giubba,
ma aveva scarsa resistenza ai proiettili di fucile. Garantiva la
protezione da una fucilata del fucile mod. 91 cal. 6.5 mm
sparata da 300 metri di distanza. Non essendo mai stata
ufficialmente adottata dall’esercito poteva essere acquistata privatamente da soldati e ufficiali.
L’elmetto da trincea Farina pesava dai 1.680 ai 1880 kg
fu il primo copricapo di protezione metallico usato dalle
truppe italiane. A causa dell’elevato costo e della sua pesantezza gli venne preferito l’elmo Adrian mod. 15, meno
costoso e meno resistente.
Il Daigrè alto era un esemplare di corazza pettorale di pro-
duzione francese, replicato poi in Italia dalla ditta Ansaldo; la protezione venne
effettivamente testata nelle trincee del fronte italo-austriaco. Si tratta di una piastra
di acciaio a strato unico, rivestita da uno strato di un particolare tipo di resina
chiamata “woodenite”, sul quale si colloca un guscio di spesso feltro. Offriva
una buona protezione essendo capace di fermare un proiettile sparato dal fucile
mod. 91 a 150 metri. Tuttavia, a causa del suo peso, si preferì farne uso come
scudo da trincea.
Nel museo è esposto il completo Ing. Farina, costituito da elmo, corazza pettorale e corazza ventrale. L’elmo, il secondo tipo prodotto dall’azienda, era più
pesante, con falda frontale di 7.5 mm di spessore; era dato come resistente
al proiettile da 6.5 mm del fucile italiano mod. 91 sparato da almeno 175 metri
di distanza. Aveva una calotta in lamiera alla quale era fissata la falda protettiva
composta da 4 fogli d’ acciaio con un’incisura per favorire la visione.
La corazza pettorale pesava 9.250 kg, era formata da un piastrone principale di
5 fogli d’acciaio e da due paraspalle. Era resistente al proiettile da 6.5 mm di una
fucilata sparata da 175 metri di distanza.
La corazza ventrale o ventriera, semplice e molto raro modello sperimentale,
probabilmente riservato alle vedette, aveva un peso simile a quella pettorale e
possedeva due elementi mobili liberabili verso il basso per proteggere la parte
anteriore superiore della coscia. Nella vetrina è presente una corazza pettorale
leggera, di produzione francese sperimentata sul fronte italo-austriaco e formata
da due pezzi inseribili in apposite tasche in tela da indossare sopra l’uniforme.
Le corazze, per la loro eccessiva pesantezza e scomodità, erano in genere malviste dai soldati, che spesso finivano per adoperarle come semplici scudi sui
parapetti delle trincee.
Nella vetrina del museo si possono notare la corazza pettorale mod. Daigrè
ridotto e la corazza frontale mod. Dunand per elmo Adrian. La prima fu prodotta in Italia modificando il “modello alto” per eliminazione della parte inferiore
arrotondata.
La seconda, prodotta in Francia, pur venendo effettivamente sperimentata in
prima linea, non fu mai adottata ufficialmente dal regio esercito.
Sulla sinistra della vetrina si trova una delle più efficaci combinazioni corazzate
utilizzate durante il primo conflitto mondiale, formata dalla corazza per sentinel-
la Sappenpanzern, di produzione germanica, in acciaio al manganese, e dalla
corazza frontale per sentinella Stirnpanzern, prodotta in Germania e montata alla
parte frontale dell’ elmo M16.
La Sappenpanzer era composta di una pesante piastra pettorale tondeggiante
che assicurava la protezione dal busto al collo. Le due spalline di sostegno
servivano per sostenere l’armatura agganciandola alle spalle. La protezione del
ventre era invece assicurata da una ventriera costituita da tre piastre minori.
La Stirnpanzern era invece una conchiglia metallica spessa circa 5 mm, allacciata dietro l’elmo tramite una cinghia in cuoio ed agganciata agli areatori laterali,
che offriva protezione antiproiettile alla parte frontale dell’ elmo mod. 16. Pesava
più o meno 2kg.
Infine, nella parte inferiore della vetrina, è presente uno scudo individuale d’attacco, probabilmente di produzione francese. Esso garantiva protezione contro
i proiettili mentre veniva spinto in avanti dal singolo militare.
Orgher Dalipi, Francesco Meneghello 5BL
15
Foto di Borgo Valsugana:
il passaggio della guerra nella cittadina
La maggior parte degli scatti che testimoniano le condizioni dei paesi della
Valsugana negli anni dopo la guerra sono stati fatti e conservati da don Cesare
Refatti, amato sacerdote di Borgo. Per le sue idee italianizzanti fu considerato pericoloso dall’Impero e per questo nell’estate del ‘17 venne arrestato dalle
guardie austriache e condotto al campo di Katzenau e poi trasferito nel convento di Reichersburg. Venne rilasciato solo dopo la fine della guerra, nel ‘18.
Tornato a Borgo si dedicò al difficile compito di raccogliere i resti dei Caduti e della loro identificazione. Strinse anche una forte amicizia con Alcide De Gasperi
che partecipò commosso al suo funerale con l’intera cittadinanza.
pletamente distrutte. La popolazione trovò rifugio nelle cascine di Prae o di Sella.
Il paese di Borgo Valsugana, considerato il “capoluogo della valle”, subì violentemente il passaggio delle truppe.
Delle 490 case 10 furono completamente distrutte, 160 scoperchiate e tutte le
altre fortemente danneggiate. Anche la chiesa arcipretale vanne colpita nei numerosi bombardamenti austriaci: sono state contate 2500 granate (lanciate dalla
Panarotta) in soli 10 mesi più vari attacchi aerei.
Quando la popolazione rientrò a Borgo, dopo essere stata prudentemente evacuata, trovò anche le campagne in condizioni disastrose e in più mancavano
luoghi dove riparare gli eventuali raccolti.
Grazie alle iniziative private dei cittadini, l’economia andò via via riprendendosi e
anche la vita iniziò a tornare alla normalità come può testimoniare la foto che ritrae
il ritorno del circo nella piazza di Borgo.
A Carzano i 500 abitanti trovarono riparo in 12 baracche o nelle cantine: su 101
case 99 furono distrutte, le altre 2 danneggiate.
Anche Olle fu ridotta ad un ammasso di rovine: su 178 case 128 furono com-
16
Roncegno, come Borgo, subì i bombardamenti austriaci dalla Panarotta che
distrussero 700 delle 880 case (cifra inclusiva degli innumerevoli masi sparsi
sulle pendici della montagna) presenti prima della guerra. Gli sfollati trovarono
riparo nello stabilimento termale.
Torcegno invece fu completamente distrutto (colpite 83 case su 84) da attacchi
partiti dal monte Collo.
Anche Telve si trovò in condizioni critiche dal momento che ai conflitti sopravvissero solo 5 case su 255.
Telve di sopra era il paese dove gli Austriaci avevano piazzato 3 loro cannoni.
Per questo subì dal monte Lefre gli attacchi italiani che distrussero 134 case sulle
137 presenti.
Silvia Pedri, Valeria Imburgia 5BL
17
Bombe
e proiettili
All’inizio del Primo Conflitto Mondiale la Germania si rivelò
più avanzata delle altre potenze internazionali: nel 1914
poteva già disporre di circa 70.000 pezzi, affiancati da
106.000 appositamente realizzati per essere innestati
su bacchetta e lanciati con il fucile.
Contrariamente a quanto si pensa spesso ai giorni nostri, l’arma impiegata maggiormente per gli assalti alle
trincee era proprio la granata o la bomba a mano, e
non la baionetta o il fucile.
In seguito all’introduzione di questi ordigni vennero
nacquero pattuglie di “granatieri” addestrate al lancio
degli ordigni esplosivi. Subito dopo un attacco, i granatieri “ripulivano” i tortuosi labirinti di una trincea con
una notevole quantità di ordigni esplosivi da lancio:
operazione particolarmente utile per convincere alla
resa eventuali superstiti rifugiati nelle “ridotte” o nelle
piccole caverne e ricoveri collegati ai camminamenti.
Fino al 1900 le bombe a mano rappresentavano an-
cora un’arma impiegata occasionalmente, il loro sviluppo non era stato
in alcun modo incentivato dall’industria bellica né tanto meno dalle
alte sfere militari: gli ordigni in dotazione all’inizio del conflitto erano
pertanto rudimentali, pesanti e di limitata efficacia.
La crescente importanza acquisita dalle bombe a mano nei combattimenti in trincea e a breve distanza sin dalle prime battute della
grande guerra, ebbe però l’effetto di stimolare le innovazioni in questo campo da parte dell’industria.
Il passaggio dall’iniziale guerra di movimento, tipica dei conflitti risorgimentali, alla molto più statica guerra di trincea rese necessaria la
presenza di questi ordigni in grado di sviluppare una grande potenza
distruttiva contro le fanterie a breve distanza.
Di forma solitamente sferica, con un foro per l’entrata della miccia,
l’involucro si doveva infrangere in schegge potenzialmente lesive e
al tempo stesso essere sufficientemente resistente da poter essere
maneggiato nelle fasi del combattimento ravvicinato. Specialmente nelle prime fasi del conflitto furono frequenti gli incidenti dovuti a
esplosioni accidentali, dato che la produzione di queste armi relativamente nuove era nella maggior parte dei casi ad uno stadio poco
18
più che sperimentale.
L’esercito italiano entrò in guerra con una dotazione di pochi rudimentali modelli,
in tutto meno di 2000: granate Aasen da fucile e a mano, granate a mano Baldari
e bombe da fucile Carcano. Questa carenza iniziale stimolò una tumultuosa e
scoordinata “produzione nazionale”. Prima che una spontanea selezione mantenesse in produzione solamente i tipi più pratici e meno costosi, arrivarono in
trincea innumerevoli congegni spesso complicati e pericolosi.
Vennero definite difensive le granate che esigevano la protezione del lanciatore
a causa delle schegge prodotte. Erano invece considerate offensive quelle
granate, denominate anche “petardi”, che potevano essere utilizzate rimanendo
allo scoperto, dato che lo scoppio immediato al momento dell’urto e le poche
e schegge generate non rappresentavano un pericolo per chi le adoperava.
Le granate “offensive” erano pertanto l’arma ideale per “ripulire” le posizioni avversarie da ogni resistenza nelle sequenze del combattimento corpo a corpo.
Anche i sistemi d’accensione si diversificarono: il più diffuso fu quello a tempo,
basato su una miccia a lenta combustione accesa tramite sfregamento della capocchia fosforosa terminale contro una piastrina di pasta svedese che il
combattente teneva al polso o al collo oppure tramite lo scoppio di una capsula
detonante.
Un terzo sistema di innesco per ordigni a tempo, poco usato dagli italiani e molto invece dagli austro-ungarici, era quello dell’accenditore “a frizione”, dove
l’accensione si otteneva tirando una funicella irruvidita ed avvolta nell’impasto
combustibile che ricopriva un capo della miccia.
Il dispositivo di accensione a tempo aveva però alcuni inconvenienti che in
combattimento potevano rivelarsi fatali: temeva l’umidità, che ne comprometteva spesso il funzionamento, inoltre, i lunghi secondi necessari alla combustione della miccia obbligavano il lanciatore ad una pericolosa attesa in posizione
esposta o comunque ad una sosta prima dello scoppio. La necessità di disporre, durante l’assalto ad una posizione nemica, di granate che esplodessero
all’impatto con il terreno (quindi senza che il lanciatore dovesse aspettare allo
scoperto prima di avanzare), determinò lo sviluppo dei sistemi a percussione:
1
grazie ad essi la granata, una volta privata del fermo di sicurezza, esplodeva al
momento dell’urto con il suolo.
Nel 1915, dopo varie sperimentazioni, la B.E.F. 1 fu dotata di un gran numero
di granate Mills, che divennero ben presto parte integrante dell’armamento di
ogni soldato inglese. Questo tipo di bomba a mano divenne subito popolarissima: si trattava del primo tipo di granata a frammentazione, che al momento
dell’esplosione si sbriciolava in una miriade di scheggie-proiettili. Al momento
del lancio, il soldato rilasciava bomba e levetta di sicurezza e quest’ultima attivava il detonatore tarato per 4 secondi.
A causa della sua forma sferica e poco pratica, veniva trasportata con secchi e
contenitori improvvisati, al seguito delle truppe attaccanti.
Nel 1915 l’esercito italiano aveva comunque in dotazione delle granate munite di
un’asticciola in metallo o legno alla base. Questi modelli vennero poi sostituiti da
altri più sicuri ed efficienti, rimanendo però in uso fino ad esaurimento delle scorte. Accanto alle bombe da fucile, anche le regie truppe disponevano comunque
di vari lanciabombe meccanici.
Al di là dei vari dispositivi di lancio, comunque, la bomba a mano divenne nel
1916 la regina indiscussa della guerra di fanteria sul fronte italiano. A quell’epoca
iniziarono i corsi di istruzione per l’impiego di queste armi estesi a livello di plotone, questo era l’unico metodo per far prendere confidenza al soldato con un
ordigno da sempre temuto come più pericoloso per sé che non per il nemico.
I modelli in dotazione al regio esercito furono molto vari agli esordi del conflitto,
ma andarono uniformandosi e riducendosi man mano che l’impiego sul campo
ne confermava o smentiva l’efficacia.
Francesca Bertoni, Gianna Campestrin, Mariana Guazzi 5AL
British Expeditionary Force: l’esiguo ma agguerrito “Corpo di Spedizione Britannico”, inviato sul continente ad inizio guerra a supporto delle armate francesi e belghe.
19
Fucili e baionette
Le armi lunghe rappresentano l’evoluzione degli armamenti del regio esercito Italiano e dell’esercito imperiale austroungarico. Nella mostra sono esposti tre modelli di armi
da fuoco lunghe della fanteria austriaca che rappresentano l’evoluzione progressiva dell’armamento individuale:
20
Werndl M67
Arma di foggia tipicamente risorgimentale, rappresenta sicuramente il modello più obsoleto.
Dopo l’umiliante sconfitta subita nella guerra contro la
Prussia del 1866, lo stato maggiore dell’Impero AustroUngarico aveva compreso che l’armamento individuale
dell’esercito doveva essere aggiornato e modernizzato.
Nacquero così i fucili con sistema a blocco ribaltabile Wanzel Mod. 1867 in calibro 14x32,5R a percussione anulare, ottenuti in gran parte trasformando le migliaia di avancariche presenti negli arsenali in armi a retrocarica, soprattutto per
ottimizzare i costi.
Mauser 1888
Quest’arma, calibro 7,92 mm a ripetizione ordinaria con chiusura ad otturatore
girevole e con caricatore da 5 colpi, fu prodotta dall’industria degli armamenti germanica e successivamente (s)venduta all’ Austria-Ungheria non appena
rivelatasi di concezione antiquata e non priva da gravi difetti come quello di arrugginire per il ristagno di condensa nel copricanna. Impiegata per sopperire alla
generale carenza di armi lunghe da fuoco che afflisse sin dal ’14 l’armata imperiale asburgica, fu utilizzata dai fanti austriaci in tutti i fronti della Grande Guerra.
Mannlicher M95”Stutzen”
Lo Steyr-Mannlicher M1895 è una versione migliorata del suo otturatore a trazione diretta. Fu usato dall’Imperial regio esercito per tutta la durata della prima
guerra mondiale. L’M95 è insolito tra i fucili dell’epoca, in quanto usa un otturatore a trazione diretta, più veloce dell’otturatore girevole-scorrevole degli altri fucili,
aveva infatti bisogno di soli due movimenti (indietro, avanti) per essere azionato.
Questo permise di effettuare circa un colpo al secondo, insieme ad una buona
robustezza e affidabilità, anche se per mantenere una buona operatività, il fucile
richiedeva relativamente maggior cura e pulizia degli altri contemporanei.
Il modello venne utilizzato anche dopo il conflitto: gli vennero infatti dati sia un
soprannome onomatopeico “Ruck-Zuck”, dato dai militari austro-ungarici per
via del rumore dell’otturatore, sia un soprannome italiano “Ta-pum” (da cui la
canzoneTapum) in riferimento alla velocità del proiettile che determinava un inconfondibile doppio suono al momento dello sparo.
ravicino, è un fucile ad otturatore girevole-scorrevole adottato dal Regio Esercito
nel1891 per sostituire il vecchio Vetterli-Vitali modello 1870/1887. Fu sviluppato
da Salvatore Carcano delle fabbrica d’armi di Torino con la collaborazione del
generale Parravicino e adotta il sistema di caricamento Mannlicher (austriaco).
Mannlicher-Carcano modello 91 TS (Truppe Speciali)
Quest’arma è il frutto del lavoro di ammodernamento del modello 91.
Per giungere alla versione definitiva TS si passò attraverso il modello per cavalleria 91, progettato nel 1893 e di dimensioni più contenute (910 mm e 3,16 kg).
Finalmente venne poi sviluppato il TS, destinato particolarmente ai genieri ed
agli artiglieri; nonostante fosse simile in lunghezza e peso a quello per cavalleria,
esso non era dotato di baionetta incorporata e il suo aspetto era più simile a
quella del fucile originale modello 91.
Fiat Revelli Villar Perosa M1915
La Villar Perosa viene ritenuta da molti la prima pistola mitragliatrice della storia.
La sua struttura è relativamente distante dalla configurazione classica comunemente associata ad un’arma di tale categoria. Fu continuamente rimaneggiata
nel corso del conflitto e costituì l’arma di punta dei neonati Reparti d’Assalto.
Anche gli austriaci ne apprezzarono la leggerezza, praticità e potenza di fuoco,
al punto da produrre nel ’18 una versione austriaca letteralmente “copiata” dal
modello italiano.
Leonardo Tecchio, Riccardo Ganarin 5BL
In mostra sono visibili anche due versioni più note dell’arma lunga della fanteria
italiana e un esemplare unico di Fiat-Revelli M1915 modificata da fanti austriaci.
Il fucile Carcano Mod. 91, anche conosciuto come Mannlicher-Carcano-Par-
21
Gli elmetti
22
L’elmo, come la divisa, denotava l’appartenenza del soldato ad una determinata nazione, uno degli ausili protettivi
essenziali in battaglia. Durante il primo conflitto mondiale
il suo impiego e la sua evoluzione hanno condizionato il
destino di innumerevoli uomini. Con lo scoppio della prima guerra mondiale, l’impiego dei pittoreschi elmi ottocenteschi, come il puntuto pickelhaube germanico o il
sontuoso elmo da dragone austriaco, era inutile se non
addirittura dannoso in una guerra “di trincea”.
Inizialmente i vecchi copricapi vennero sostituiti da semplici berretti di panno o da caschi in cuoio, ma in seguito, le
varie potenze svilupparno i propri modelli di elmo in metallo. Le caratteristiche principali di un elmo erano il colore
mimetico (i francesi scelsero il “bleu horizon”, gli italiani il
grigio terra, mentre la fazione austro-tedesca optò per il
classico verde campo) dalla robustezza (garantita dai ma-
teriali e dallo spessore) e dalla forma, che doveva invece risultare la più protettiva
possibile senza però intralciare vista e mobilità del combattente. La qualità e i
miglioramenti dei copricapi venivano verificate costantemente dai produttori, ma
spesso, i veri collaudi avvenivano sul campo di battaglia a spese della sicurezza
e della salute del soldato.
Elmo modello “Farina”
Il primo modello di elmo in acciaio venne distribuito alle truppe italiane della 2a e
3a armata nell’estate del 1915. Esso viene considerato il progenitore degli elmi
di moderna concezione. Ne furono realizzate due versioni: il modello basso,
denominato “elmetto da trincea” ed un modello alto, “elmo pesante”, dato in
dotazione alle compagnie della morte e ai reparti maggiormente soggetti all’offesa avversaria in quanto destinati ad operare nella terra di nessuno (genieri,
sminatori, vedette). Il modello alto aveva la falda anteriore composta da quattro
(a volte cinque) strati d’acciaio sovrapposti e tenuti insieme da una serie di chiodini. Il suo peso era di 2.250 gr.
Il modello basso era quasi identico, con l’unica differenza che la parte anteriore
era alta solo 8 cm ed il peso complessivo era di 1.850 gr. In entrambi i casi comunque non furono previsti nè un sistema di aerazione, né un’imbottitura interna.
L’elmo Farina infatti era considerato un accessorio molto scomodo da usare
in battaglia e la sua produzione finì quando venne introdotto il famoso modello
francese Adrian mod. 15, molto più pratico e leggero, di cui vennero dotati in
zona di guerra tutti i reparti del regio esercito.
Modello “Adrian”
La Francia all’inizio del 1915 aveva ideato un elmetto in acciaio molto più pratico
e leggero del Farina. Si trattava dell’elmetto “Adrian” mod. 15; era composto
da una calotta, una visiera anteriore, un coprinuca posteriore simile alla visiera
anteriore, ed una crestina che fungeva da copertura dello sfiatatoio. Questi quattro pezzi, ottenuti da una lamiera di acciaio con spessore 0,7 mm stampata a
freddo, erano assemblati tra loro mediante coppiglie o chiodi. L’imbottitura era
costituita da una cuffia di pelle stretta da un laccio, il lamierino ondulato fissato
ai lati interni della calotta facilitava l’aerazione e permetteva, con la aggiunta o la
rimozione di alcuni elementi, di variarne la taglia. L’elmo, nelle tre taglie, pesava dai 670 ai 750 grammi, il costo andava dai 5 e i 6 franchi. Una particolarità
dell’elmo Adrian è che non fu sottoposto a test balistici, contrariamente a quelli
tedeschi ed inglesi. Dal lato estetico era un elmo ben riuscito, ma la particolare
tecnica di assemblaggio dei quattro pezzi e il ridotto spessore lo rendevano fragile. Per questo nel 1916 l’Italia ne produsse una nuova versione, l’Adrian mod.
16, di fattura teoricamente più solida perché composto da due pezzi anziché
quattro, ma di qualità inferiore in quanto realizzato con lamiera ancora più sottile
e meno resistente.
“Stahlhelme” M16
Le truppe Austro-Tedesche adottarono un elmetto dalle forme innovative, lo
Stahlhelme M16. Il suo disegno fu opera del dr. Friedrich Shwerd che nel 1915
produsse un elmetto di “forma a campana” in grado di proteggere non solo il
capo, ma anche parti di viso e collo dei soldati. Esso però venne introdotto al
fronte solo all’inizio del 1916, prendendo appunto il nome “Model 1916”, mentre
all’inizio del conflitto si adoperarono pickelhaube senza fregi o “berretti corazzati”. Al posto dell’acciaio al manganese usato dalle nazioni nemiche, i tedeschi
utilizzarono un acciaio più duro, al silicio-nickel. L’impiego di questo materiale e
la forma dell’elmetto comportarono una lavorazione a caldo di gran lunga superiore a quello degli elmetti “Adrian”. L’M1916 aveva degli occhielli di ventilazione
laterali, simili a piccole corna.
Il rivestimento interno consisteva in una fascia circolare in cuoio (metallica nella
versione austriaca) con tre sacche in cuoio, ognuna contenente materiale d’imbottitura. I primi camuffamenti in stoffa regolamentari, in bianco e grigio, apparvero fra il 1916 e il 1917. Durissimi test di valutazione dei singoli lotti di produzione
decretarono la loro qualità superiore.
Per l’esercito Austro-Ungarico, il primo elmetto fu il modello M1916 su licenza
dall’esercito alleato.
Riccardo Dalledonne, Ivano Carraro 5AL
23
Le armi bianche
La Prima Guerra Mondiale è un connubio di elementi moderni ed antichi, caratteristica che si evidenzia anche negli armamenti: dall’innovativo uso di armi
automatiche e gas tossici, alle primitive mazze ferrate utilizzate per liberarsi del
nemico in modo particolarmente cruento.
Da parte austroungarica, per dare maggiore efficacia al confronto “corpo a
corpo”, vennero utilizzate abbastanza diffusamente le mazze ferrate, uno strumento di morte arcaico, che si ispirava ai modelli d’arma medioevali; particolarmente cruenta e brutale la mazza ferrata fu messa in campo per la prima volta
dalle truppe austro-ungariche nella prima parte del 1916 sul fronte dell’Isonzo. La
produzione di queste armi aveva, per alcuni modelli “raffinati”, un vero e proprio
carattere industriale. I soldati italiani, non essendo prevista la dotazione di simili
ordigni nel proprio armamento, rimasero sconvolti quando, per la prima volta,
ne videro gli effetti sui caduti del monte San Michele sul Carso. Queste armi
non erano intese come strumenti per sferrare il colpo di grazia, bensì come una
24
potente implementazione del cosiddetto ”armamento da botta” del combattente. L’esercito italiano si adeguò ben presto a questo stile di guerra, ricorrendo
per iniziativa di singoli a mazze artigianali oppure sostituendole con attrezzi da
trincea.
Nella mente semplice del soldato, come dell’opinione pubblica italiana, il binomio mazze-gas era atroce: il livello di cinismo che pareva così raggiungersi
sconvolse gli uomini, i militari, i giornalisti. Gas e mazze, il moderno e l’antico,
fecero sì che la Prima Guerra Mondiale fosse l’ultima guerra “vecchio stile” e la
prima “guerra moderna”.
Mattia Bonomi, Alberto Refatti 5AL
Le bottiglie
È necessario accennare a cosa bevessero gli uomini impegnati nelle fatiche della guerra: in questo
periodo il vino fu sempre abbondante e considerato indispensabile al soldato. Oltre che come mezzo
per distrarsi e dimenticare, questa bevanda, facente parte della razione quotidiana del combattente,
aiutava a colmare le carenze caloriche dovute alla scarsità di viveri. In Italia il vino era una bevanda dal
prezzo proibitivo, che veniva dato in quantità minime (un quarto di litro solo tre volte a settimana); gli austriaci potevano invece usufruirne in maggiori quantità. All’esercito italiano venivano distribuite grappe e
birre che, a differenza del vino, risultavano di larga disponibilità.
L’alcool offriva coraggio per resistere sotto le granate e quella per uscire allo scoperto ed andare
all’assalto. I militari facevano uso di alcolici per semplice piacere, perché convinti di venirne fortificati,
per resistere più facilmente alle difficoltà che la prima linea richiedeva. Infatti era abitudine distribuire
maggiori quantità di cioccolata, cognac, rum o grappa prima di ogni assalto. Oltre alle bevande alcoliche erano presenti anche bevande stimolanti, quali il caffè che, tuttavia, non rientrava nella alimentazione quotidiana se non durante i periodi di maggior lavoro o in combattimento.
Nelle trincee austriache del Lagorai, sono state ritrovate svariate tipologie di bottiglie: quasi sempre in
vetro, avevano svariate forme a seconda della bevanda contenuta: i contenitori che racchiudevano il
vino erano solitamente i fiaschi, ma non mancavano le semplici bottiglie.
Alcune borracce erano fatte di vetro soffiato ricoperto da alluminio, contenevano svariati ricostituenti o
linimenti; tra esse un esempio può essere “DIANA”, consigliato contro i reumatismi. In Italia il più famoso di questi prodotti rinforzanti era il “PROTON”, aveva effetti benefici e aumentava il vigore fisico del
soldato. Altra funzione dei contenitori era quella di racchiudere l’”ODOL”, polvere per l’igiene orale, del
quale ne sono stati ritrovati alcuni reperti sulle nostre montagne.
Manuela Bressanini, Valentina Gerola, Linda Tomaselli, 5BL
25
I mezzi
di trasporto
26
Gli animali
Non si può dimenticare, quando si parla della prima guerra mondiale, dell’apporto dato al conflitto dalla forza animale: un aiuto che spaziò dai lavori di fatica,
passando per compiti delicati come portare ordini o ricercare feriti, fino ad un
ausilio di tipo terapeutico. Gli animali infatti offrivano compagnia ai soldati al fronte. Un animale che è diventato l’emblema della Grande Guerra e degli alpini è il
mulo. Durante la Grande Guerra era l’unico mezzo di trasporto sui sentieri alpini,
che non a caso continuano a essere chiamati “mulattiere”. Autentico mezzo
da combattimento, il mulo fu fondamentale per trasportare le armi e supportare
la logistica in alta montagna. Sui muli era basato lo spostamento delle derrate
alimentari e di ogni materiale necessario al sostentamento delle truppe.
Nell’impero austro-ungarico un’organizzazione impeccabile si preoccupava dei
periodici censimenti, di “reclutarli” e distribuirli. L’esercito austro-ungarico ebbe
a disposizione circa 4 milioni di capi, ma queste creature, come gli uomini, subirono pesanti perdite. Durante la guerra vennero studiati i mezzi per migliorare
le prestazioni degli animali da soma, soprattutto in montagna: la chiodatura da
applicare ai ferri per permettere agli animali di camminare su sentieri ripidi e scoscesi o in zone ghiacciate. Anche gli animali furono considerati, al pari dei soldati, nemici da colpire: si fabbricarono trappole, chiodi di ferro di varie dimensioni
e a quattro punte, che venivano sparse sul terreno accidentato. Se un uomo vi
s’imbatteva, era spesso necessario ricorrere all’amputazione per arrestare l’infezione, gli animali venivano invece soppressi.
Le biciclette
Durante la Prima Guerra Mondiale tutte le nazioni belligeranti hanno utilizzato la
bicicletta come mezzo di trasporto: gli esploratori, i portaordini, gli elementi portanti ciclo-montati dell’ambulanza.
In Italia le biciclette vennero utilizzate dai bersaglieri (unità di fanteria). Nell’esercito tedesco dagli Jäger (i battaglioni della fanteria). L’esercito austroungarico
ebbe un solo “battaglione ciclisti”, utilizzato nel 1916 anche in Valsugana e nella
parte orientale del Lagorai.
Anche se molto utilizzati, tali mezzi vennero col tempo rimpiazzati da mezzi di
trasporto motorizzati, ma rimasero comunque in uso costante fino alla fine delle
ostilità, in virtù della possibilità di trasportare grandi carichi.
Nella Prima Guerra Mondiale i battaglioni ciclisti dei bersaglieri italiani furono separati dalle altre unità per rimanere in carico ai comandi e sfruttarne al meglio
la mobilità. Circa a metà del 1917 fu costituita una compagnia di mitragliatrici
pesanti con sei armi per ogni battaglione, su biciclette modificate.
La conformazione del fronte italiano rese difficoltoso qualunque spostamento
logistico, in particolare durante i mesi invernali. Ciò fu causa di buona parte delle
difficoltà dei nostri soldati che non vedevano arrivare i rifornimenti mandati loro
da casa.
Simone Agostini, Alessandro Lira 5AL
27
La storia di
Paolo Monelli
28
Paolo Monelli nasce a Fiorano Modenese il 15 Luglio 1891
e termina gli studi conseguendo la laurea alla facoltà di giurisprudenza. Partecipa come alpino alla Grande Guerra. La
moglie è Palma Bucarelli. Muore a Roma il 19 Novembre
1984.
Sebbene esentato dal servizio militare, in qualità di figlio
unico fa domanda per arruolarsi nella Milizia Territoriale
specialità alpini. Combatte nelle battaglia di S. Osvaldo,
sul Ciste, a monte Setole; prende anche parte alle operazioni di contrasto alla “Strafexpedition”. Nel dicembre
del 1915 raggiunge il Battaglione Val Cismon. Con questo
battaglione resta fino alla fine dell’inverno ’16 -’17 per poi
passare al battaglione Cuneo, con il compito di addestrare
gli alpini all’uso degli sci; dopo la battaglia dell’Ortigara, alla
quale prende parte attiva, passa al battaglione Marmolada con il quale prosegue la guerra fino alla battaglia delle
Melette. Nel dicembre 1917 viene catturato proprio nella
battaglia d’arresto alle Melette e portato prima a Salisburgo e poi in Boemia.
Torna in Italia alla fine del conflitto.
Nel dopoguerra inizia la carriera di giornalista, redattore e corrispondente di
testate nazionali quali il “Corriere della Sera”, la “Gazzetta”, “Il mattino” e
“La Stampa”.
Nel 1921 scrive la sua opera principale, il diario di guerra intitolato: “Le scarpe
al sole”, da cui verrà anche tratta una trasposizione cinematografica nel 1935.
È corrispondente all’estero anche durante tutto il periodo fascista e del secondo conflitto mondiale. Tra le sue altre opere troviamo testi di documentazione
storica, una biografia di Mussolini, testi sul suo mestiere, sulla lingua e la cultura
italiana…
Le foto in mostra provengono dall’esposizione “1915-1918: al fronte con Paolo Monelli” a cura di Giuseppe Ielen e Luca Girotto, dell’Associazione storico
culturale della Valsugana Orientale e del Tesino in collaborazione con il sistema
culturale Valsugana Orientale. Sono foto scattate dallo stesso Monelli durante il
conflitto, rinvenute e riconosciute nel “fondo fotografico Monelli” della biblioteca
A.Baldini di Roma.
Tra gli oggetti in mostra ci sono gli scarponi che ricordano il titolo “le scarpe al
sole”: nel gergo militare “volgere le scarpe al sole” era un amaro eufemismo che
significava morire.
Si possono osservare anche un modello di macchina fotografica simile a quello
utilizzato da Monelli, gli attestati del Ministero della guerra italiano per il conferimento di una delle tre medaglie di bronzo ottenute per le azioni condotte in
Valsugana, nelle zone Ortigara, Tondacar e Castelgomberto, e un distintivo del
1916, trovato a Marter.
La prima delle due bacheche presenta due missive scritte da Monelli. La prima
è una lettera che, in prigionia, invia da Salisburgo, dove è stato mandato dopo
essere stato catturato; la seconda è indirizzata al padre per informarlo di essere
stato promosso tenente.
Sono visibili inoltre una foto di Paolo Monelli con laccetto 7° Val Cismon e un suo
bracciale, ricavato dalla corona di forzamento in rame di un proiettile d’artiglieria,
con scritto “Monte Setole, Valpiana Maggio 1916”.
La seconda bacheca presenta altri reperti storici di Monelli: una copia originale,
con le correzioni dell’autore, del 1922 del romanzo “le scarpe al sole”, inizialmente privo di foto. L’importanza del romanzo è dimostrata anche dal fatto che
di esso è stata fatta addirittura una traduzione in inglese.
Altri oggetti presenti sono una croce di merito di guerra, insieme al tesserino di
riconoscimento di Monelli, dei manualetti, una pipa e una tabacchiera.
Rodolfo D’Agostini, Deborah Rosso 5BL
29
La “Compagnia
della morte”
I componenti della “Compagnia della Morte”, nel primo dopoguerra, furono a lungo considerati i precursori degli
“Arditi”, un particolare corpo dell’esercito italiano organizzato nei cosiddetti “Reparti d’Assalto”, attivo dalla fine del ‘17
al novembre 1918. La Compagnia della Morte, un reparto autonomo, più correttamente denominato “compagnia
volontari esploratori della 15° divisione”, era composta da pattuglie speciali di fanteria o del genio, che effettuavano ricognizioni nella “terra di nessuno”, adibite al taglio dei reticolati, per aprire dei varchi nelle difese nemiche. Chi
vi aderiva lo faceva spesso per motivi economici, concessione di licenze, o per ottenere l’annullamento di una pena.
I volontari erano facilmente riconoscibili per l’uso di corazze ed elmi (principalmente l’elmo pesante “Farina”). In
combattimento erano forniti di tascapane, al cui interno erano contenute una borraccia ed eventuali bombe a mano,
giberne per le munizioni da fucile, una lunga cesoia con baionetta, occhiali paraschegge, passamontagna in lana
e corazza “Farina”. La divisa invece era quella della fanteria, ma cambiava da persona a persona: infatti, i volontari
mantenevano le mostrine e la tenuta del corpo da cui provenivano. Tutti indossavano, però, la stella nera degli
esploratori, che era dunque l’unico simbolo di riconoscimento.
Il nome pomposo di compagnia della morte era stato in realtà affibbiato al corpo dell’esercito quasi esclusivamente
per propaganda. Non era solo questo l’appellativo con cui era conosciuto. Venivano chiamati anche “Compagnia
Baseggio”, dal nome del loro capo del reparto che ne era stato anche l’ispiratore ed il propugnatore, o “Compagnia
esploratori volontari” nome che era stato deciso alla nascita del distaccamento il 16 ottobre 1915, alla sua costituzione ufficiale, allo scopo di eseguire operazioni ardite, compiti di avanguardia, esplorazioni, ricognizioni, prese di
posizioni. In queste azioni la compagnia era sempre animata da un grande spirito di corpo.
Componevano il gruppo, che non raggiunse mai un numero superiore alle 200 unità, volontari provenienti da ogni
30
regione d’Italia, dai reggimenti di fanteria o dai battaglioni alpini.
La compagnia fu impiegata solamente sui monti e
nei paesi della Valsugana, dove si era formata: da
notare che nei paesi di Ospedaletto, Borgo, Spera, Telve e Scurelle rimase vivo il loro ricordo anche
dopo la fine del conflitto.
Il 6 aprile 1916, a S.Osvaldo, a Roncegno, si registra la definitiva fine della compagnia della morte,
Da questa battaglia solo una cinquantina di componenti il nucleo uscirono superstiti illesi che, prima
di ritornare ai reparti d’appartenenza, si riunirono
un’ultima volta a Scurelle. La compagnia venne infatti sciolta, sia per difficoltà nel reintegrare il numero
di volontari persi, sia perché oramai non vi era più la
necessità di un reparto autonomo esplorante, dato
che le linee italiane ed austriache erano giunte quasi
a contatto.
Cristian Prai, Mauro Tomasini, 5AL
31
Le armi
corte
32
Le prime pistole distribuite alle truppe austroungariche furono destinate ad equipaggiare i cavalleggeri, che avevano bisogno di sostituire le loro lance obsolete con un’arma
da fuoco maneggiabile con una sola mano. In seguito le
pistole vennero introdotte solo per la difesa personale negli
scontri ravvicinati. Per questo motivo all’inizio della guerra le
pistole contenevano pochi proiettili, ma dovevano garantire
la massima affidabilità agli ufficiali inferiori e ai sottufficiali
privi di fucile. Tutte le pistole d’ordinanza erano munite di
un anello al quale doveva essere agganciato mediante un
piccolo moschettone un laccio di cotone “feldgrau” da
portare attorno al collo per evitare di perdere l’arma durante
il combattimento.
Nel corso della guerra l’esercito austro-ungarico impiegò
ufficialmente 6 modelli di pistole semiautomatiche. Di questi sei modelli di pistole vediamo qui esposte: la Dreyse
calibro 7,65mm, la Frommer Stop 7,65mm, la Roth-Steyr 9mm mod. 1907, la
Steyr 6,35mm mod. 1908, la Steyr 9mm mod. 1912 ed infine un revolver Gasser
9 mm.
Pistola semiautomatica Steyr mod. 1912 cal. 9mm (9mm M. 12 Steyrpistole). Lunga 216 mm alta 143 mm e pesante 970 g scarica, ha un serbatoio
fisso ricavato all’interno dell’impugnatura, contiene una lastrina di alimentazione
da 8 colpi. Questa pistola d’ordinanza era distribuita prevalentemente agli ufficiali
inferiori e ad i sottufficiali dei reparti combattenti privi di fucile.
Pistola semiautomatica Roth-Steyr mod. 1907 cal. 8mm (8mm Repetierpistole M. 7), lunga 232 mm, alta 159 mm e pesante 1002 g scarica, era stata
progettata per la cavalleria ed era priva dei dispositivi manuali di sicurezza. Le
truppe della cavalleria furono gradualmente appiedate dopo l’inizio della guerra
e impiegate in trincea al pari dei reparti di fanteria, dei quali ricevettero lo stesso
armamento. La pistola fu destinata perciò ad integrare le insufficienti dotazioni
di Steyr M. 12, e distribuita prevalentemente ai sottufficiali dei reparti mitraglieri e
dell’artiglieria.
Pistola semiautomatica Frommer Stop mod. 1912 cal. 7,65 mm (7,65
mm Frommer-Pistole) lunga 165 mm, alta 115 mm e pesante 582 g scarica.
Queste armi furono distribuite nel corso della guerra per integrare la dotazione
di pistole d’ordinanza di maggior calibro, e destinate agli ufficiali superiori o dei
servizi non combattenti.
Pistola semiautomatica Steyr mod. 1908 cal. 6,35 mm a 7 colpi lunga
116 mm alta 81 mm e pesante 348 g scarica. A differenza delle pistole semiautomatiche calibro 7,65 mm prodotte in origine per il mercato civile, ma impiegate
diffusamente dall’esercito austro-ungarico per armare gli ufficiali superiori e dei
servizi di retrovia, quest’arma era scelta personalmente dagli interessati, che di
solito ricoprivano i più alti gradi della gerarchia militare e risiedevano in comandi
situati lontano dal fronte.
Pistola semiautomatica Dreyse cal. 7,65 mm (7,65 mm Selbstladepistole) lunga 159 mm, alta 109 mm e pesante 107 g scarica. L’arma era prodotta da
una ditta tedesca della quale porta il monogramma “RMF” sull’impugnatura. Fu
destinata agli ufficiali di grado superiore o in servizio nei reparti non combattenti.
Revolver Rast & Gasser mod. 1898 cal. 8 mm (8mm Rast & Gasser Re-
volver M. 98) lungo 226 mm, alto 147 mm, pesante 940 g scarico. Fu distribuito
prevalentemente ai sottufficiali privi di fucile e ai mitraglieri, che potevano aver
bisogno di un’arma a fuoco rapido per difendere la loro postazione da un’eventuale irruzione del nemico.
Per quanto concerne l’esercito italiano, gli esemplari più significativi sono una
pistola semiautomatica Glisenti mod. 1910 ed un revolver Bodeo:
1. Pistola semiautomatica Glisenti Mod. 1910, cal. 9 mm, lunga 211 mm,
peso (scarica) pari a 800 g. Venne adottata dal regio esercito come arma di
ordinanza nel 1910. Venne data in dotazione agli ufficiali italiani fino alla sua sostituzione dovuta alla poca robustezza e praticità dell’arma nonché ai suoi elevati
costi di produzione.
2. Revolver “Bodeo” Ordinanza Italiana Mod. 1889 cal. 10,35 mm. Lungo
275 mm e pesante 890 g, con tamburo contenente 6 colpi da 10,35 mm. Fu
inventato dall’armaiolo napoletano Bodeo il quale riunì in esso tutte le innovazioni
dell’epoca. Durante la Grande Guerra i militari italiani dovevano comprarsi autonomamente l’arma da fianco, la cui fornitura non era prevista nella dotazione;
in seguito anche gli ufficiali furono costretti a comperare loro stessi l’arma corta
a causa della scarsità dei fondi dell’esercito. Le aziende italiane non riuscivano inoltre a fare fronte alle richieste seguite alla mobilitazione del Regno d’Italia,
così parecchie “Bodeo” furono prodotte all’estero, principalmente in Spagna.
Il modello originale, qui esposto, è riconoscibile per la presenza di un grilletto
snodato e per la mancanza del ponticello, cioè l’elemento ad anello che circonda e racchiude il grilletto, evitando lo sparo accidentale. Tutti i modelli hanno la
caratteristica di poter essere completamente smontati senza l’ausilio di alcun
attrezzo: per questo motivo la loro produzione continuò fino al 1945.
Fabio Capraro, Diego Giampiccolo 5AL
33
La vita in
trincea
34
Tutti gli oggetti hanno la funzione di legare il passato al presente e ci permettono di ricostruire la storia, hanno il valore
di un documento unico; sono racconti tridimensionali, delle esperienze di vita. Il museo espone una serie di oggetti
costruiti con i materiali di guerra riciclati, messi insieme da
soldati, prigionieri civili, internati, dietro le linee del fronte.
Due esempi sono il tascapane e la gavetta. Il primo permetteva al soldato di essere autonomo: veniva portato a
tracolla e conteneva generi di prima necessità e oggetti
personali.
I tascapani austriaci e italiani erano simili: di tela impermeabile piuttosto grossa, differivano solamen-
te per la rifinitura in cuoio di quelli italiani. I prodotti contenuti in questa sacca
erano: pane, gavette, scatolame, pacchetto per la medicazione, tasca per
il cucito, scatola di cibo in conserva, spazzola da scarpe, tazza o gavettino per bere e un cucchiaio. In quello austrico vi erano anche un fornelletto pieghevole, un tubo contenente dei chiodi e una scatola di grasso.
La gavetta invece era il recipiente in cui soldato riceveva e consumava il rancio.
Poteva fungere anche da pentola (soprattutto in trincea) per scaldare razioni in
scatola. Quelle degli alpini erano più grandi perché dovevano contenere rancio
doppio, per chi la portava e per il compagno che doveva portare la legna. I
soldati potevano essere riforniti di armi e suppellettili, ogni altro semplice oggetto
i militari dovevano produrlo da se’: l’abilità risiedeva proprio in questo, nella capacità di saper ricavare da qualsiasi materiale, soprattutto quello di scarto, utili
oggetti.
Il soldato doveva essere sempre presentabile e ben vestito, ma non aveva sempre a disposizione gli strumenti per la cura della sua persona: con i bossoli e i
ciuffi di peli di mulo posti sopra cartucce vuote era in grado di realizzare pennelli
da barba rudimentali. In prima linea, le scatole di carne del rancio venivano riciclate inoltre come tazze. La razione tipica del soldato era: 150 g di riso o pasta,
350 di legumi, patate, verdure, 15 g di caffè, 20 g di zucchero, 1/4 di litro di vino.
Il pasto del fronte era più calorico e ricco di alcool, le truppe di alta montagna
avevano come supplemento lardo, pancetta e latte condensato.
Nelle trincee sono stati trovati numerosi oggetti di vita quotidiana: qui i soldati
trascorrevano la maggior parte del tempo sopportando la logorante guerra di
posizione. Tra gli oggetti rinvenuti ci sono accendini, portasigarette, pennini ricavati dal bossolo di un fucile, spazzolini da denti, calamai, una dentiera d’alluminio
(ritrovata sul monte Civeron) e l’elmetto Farina - forato da proiettili a testimonianza
della sua scarsa efficacia - e le “scarpe de paja”, sopra-scarpe in vimini usate
in alta montagna. Sorprendente è il grado di conservazione dei cappelli alpini e
berretti austriaci, recuperati dopo anni di immersione nel ghiaccio di cima Presena.
Dopo la Grande Guerra, il materiale rimasto sul terreno servì ai civili per sopravvivere; oggetti come le stufette in ghisa o ferro utilizzate per scaldare le baracche
dei militari oggi sono impiegate ad esempio come porta fiori. Anche il reticolato,
proprio quello impiegato durante la grande guerra oltre novant’anni orsono, ora
serve da decenni a delimitare i pascoli.
Michela Frisanco, Francesca Domenegoni,
Alessandra Betti, 5BL
35
La storia di
Mario Scotoni
36
Mario Scotoni (1883 – 1958) apparteneva all’alta borghesia
di Trento, studiò ad Innsbruck dove venne coinvolto attivamente negli scontri che contrapponevano ad inizio secolo i giovani
universitari tirolesi di lingua italiana ai coetanei germanofoni.
Fu arrestato più volte e schedato dalla gendarmeria austriaca
per “sospette attività antipatriottiche”. Fu membro attivo della
“Lega Nazionale”, un’associazione ufficialmente dedita alla
promozione delle attività sportive tra i giovani cittadini del Tirolo
italiano, ma in realtà impegnata nella diffusione di sentimenti e
degli ideali irredentistici.
Fu membro, prima della guerra, del direttivo della Società Alpinistica Tridentina, associazione che all’epoca era un vero
“covo” di irredentismo riunendo gli alpinisti ed escursionisti
trentini di lingua italiana, ma cittadini austroungarici, in contrapposizione al “Deutsche-Oesterreichisce Alpen Verein”
(Club Alpino Austro-Germanico).
Ai primi del ‘900 partecipò in veste di “esperto” alla scelta del
sito sul quale sarebbe sorto poco dopo il rifugio Ottone Brentari in Cima d’Asta.
Prima dello scoppio del conflitto con l’Italia, avendo già adempiuto agli obblighi militari con l’esercito austriaco, aveva trovato abbastanza semplice spostarsi in territorio italiano, dove si
trovava all’atto della dichiarazione di guerra dell’Italia. Si arruolò
quindi nell’esercito italiano e venne indirizzato ad un battaglione alpino del 7° reggimento. Entrò poi a far parte dell’ufficio
I.T.O. (Informazioni Truppe Operanti) del colonnello Tullio Marchetti (altro irredentista di origini trentine), che rappresentava
un embrione di servizio informazioni della 1° Armata italiana
operante sul fronte trentino.
Partecipò nell’estate 1917 alla progettazione e all’esecuzione
dell’azione di Carzano (la cosiddetta “occasione perduta”) durante la quale fece da interprete (parlava perfettamente il tedesco) e da guida ad una delle colonne destinate ad eseguire
l’irruzione nelle linee austriache rese accessibili dal tradimento
di alcuni ufficiali e soldati di un battaglione bosniaco.
Dopo il fallimento dell’operazione, per la quale fu decorato con
medaglia di bronzo al valor militare, ritornò ai servizi di spionaggio nei quali rimase fino al termine della guerra.
Nel dopoguerra aderì alla Legione Trentina e successivamente al fascismo. La Legione trentina fu costituita a Firenze
nel 1917 per iniziativa di alcuni fuoriusciti trentini che intendevano unire tutti i volontari trentini arruolatisi nell’esercito italiano. Si
proponeva di “raccogliere notizie riguardanti i volontari”, offrire
un appoggio morale e materiale agli aderenti, “onorare i martiri
e i caduti”. I compiti dell’associazione non si esaurirono col
finire della guerra: in seguito svolse attività in difesa dell’idea
nazionale e all’affermazione del confine al Brennero fino al
1988. Negli anni ’30 Mario Scotoni divenne podestà di Trento;
sotto al sua amministrazione venne completata la realizzazione dell’acropoli alpina sul Verruca (l’odierno “Doss Trent”) e
della ”strada degli Alpini” che ad esso conduce.
Alberto De Bellis, Luca Laner 5AL
37
Presentazione del progetto
“Il Nostro museo”
A cura delle classi VAL e VBL
(Istituto di Istruzione “A. Degasperi” di Borgo Valsugana)
Anno scolastico 2010/2011
Coordinamento, prof. Pierluigi Pizzitola
Supervisione scientifica: Fulvio Alberini, Luca Girotto
Il Museo Diffuso è un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto che si declina in una serie di azioni volte alla valorizzazione delle realtà museali e spazi culturali1 della Valsugana orientale. Nell’ambito di questa
iniziativa, che si svolge in fase sperimentale, abbiamo rivolto la proposta a degli
studenti del liceo scientifico dell’Istituto Alcide Degasperi di Borgo Valsugana, di
prendersi cura di un museo della Valsugana orientale.
La scelta è caduta sulla Mostra Permanente della Grande Guerra di Borgo Valsugana.
Lo spazio, fisicamente adiacente all’Istituto, si è prestato perfettamente, anche
da un punto di vista didattico e metodologico, a questo scopo.
L’azione, divisa in due momenti, uno in classe, l’altro sul campo, ha immaginato nuove modalità di relazione fra le realtà culturali della rete e la popolazione
giovanile, al fine di attivare la creatività, lo spirito di iniziativa, il senso di responsabilità e la consapevolezza nei confronti del patrimonio storico-artistico ed etnoantropologico locale.
Finalità del progetto
L’iniziativa “Il Nostro museo” ha permesso di approfondire il tema della Grande
Guerra in Trentino e in Valsugana Orientale attraverso un lavoro di preparazione e
di successiva ricerca e scrittura di materiali didattici da parte degli studenti della
classi VAL e VBL dell’Istituto De Gasperi, coordinate dal prof. Pizzitola.
Alcuni studenti hanno elaborato un’introduzione alla grande Guerra in Valsugana,
mentre la maggioranza dei ragazzi ha sviluppato dei brevi testi per realizzare un
addendum alla guida del 2007 alla Mostra Permanente della Grande Guerra.
Il tutto si è sviluppato con la collaborazione del Comune di Borgo Valsugana, del
Museo Diffuso della Valsugana Orientale, della Biblioteca di Borgo Valsugana e
dell’Istituto “A. Degasperi” e verrà presentato pubblicamente nell’ambito di Palazzi Aperti 2011.
Si è voluto, da una parte, offrire agli studenti uno sguardo d’insieme sulla storia
del Trentino e sul suo passaggio all’Italia rendendo i ragazzi diretti protagonisti
della “costruzione storica” e, dall’altra, renderli parte attiva nella promozione e va-
1
Fanno parte del Museo Diffuso della Valsugana orientale: a Borgo Valsugana la Mostra permanente della Grande Guerra in Valsugana e sul Lagorai, la Sala Alcide Degasperi, la Sala Galvan, lo Spazio Klien, a
Olle Casa Andriollo: SoggettoMontagnaDonna e la Fucina Tognolli, a Roncegno la casa degli spaventapasseri, nei comuni di Carzano, Telve, Telve di Sopra e Torcegno L’ecomuseo del Lagorai, a Grigno il riparo
Dalmeri.. http://www.valsuganacultura.it/museodiffuso.html
38
lorizzazione di una parte del nostro patrimonio museale in Valsugana Orientale.
Motivazioni didattico-metodologiche
Lo studio della storia “locale” può diventare, quando è strutturata su parametri di
serietà e scientificità, un’efficace leva di stimolo nello studio della storia generale.
In questo modo molti fenomeni trovano, nel loro muoversi tra locale e generale,
una chiara esemplificazione. Esiste quindi un continuo richiamo tra le due dimensioni spaziali: entrambe possono vicendevolmente sostenersi e contribuire
alla costruzione del senso di sé sociale e civile dei giovani.
Il progetto ha offerto la possibilità di attivare pratiche didattiche cognitive e metodologiche più attive. Le attività laboratoriali hanno avuto un ruolo centrale nello
stimolare negli studenti le abilità del metodo storico, attraverso la lettura e l’interpretazione di vari testi e documenti trovati, in particolare, alla Mostra Permanente
della Grande Guerra di Borgo Valsugana.
Lo studio e la ricostruzione della storia richiedono un approccio critico, non
mnemonico e ripetitivo, che riproduca, sia pure in parte, il lavoro di ricerca dello
storico.
Si è innanzitutto scelto, insieme ai ragazzi, un argomento di studio e lo si è diviso
tra diversi gruppi di lavoro. Ogni ragazzo si è assunto l’incarico di valorizzare una
vetrina della Mostra permanente della Grande Guerra in Valsugana.
I primi spunti di riflessione sono arrivati dalla visita alla Mostra “Paesaggi di Guerra” presso spazio Klien a Borgo Valsugana.
Si è poi iniziato a raccogliere il materiale di studio attraverso una ricerca al museo,
alla Biblioteca comunale di Borgo Valsugana, sui siti e archivi presenti in internet
e sulle fonti documentali a stampa.
In questa prima fase si è tenuto un incontro introduttivo sulla Grande Guerra
in Trentino per analizzare i diversi temi di studio su cui i ragazzi avrebbero poi
lavorato. In quell’occasione è stato presentato alle classi il progetto il ”Nostro
museo”.
Le classi hanno poi svolto due visite guidate alla Mostra Permanente della Grande Guerra di Borgo Valsugana, accompagnati dalle dott.sse Paola Morizzo e
Giovanna Sartori.
La sera di venerdì 14 gennaio 2011, alle ore 20.30, si è tenuta una lezione sulla
Grande Guerra in Valsugana presso l’Auditorium dell’Istituto “A. Degasperi” di
Borgo Valsugana con il dott. Luca Girotto.
Ogni studente ha in seguito approfondito e illustrato alcuni oggetti in esposizione
nelle diverse vetrine del museo di Borgo.
Il materiale prodotto dai ragazzi è stato rieditato per realizzare questa piccola
ma densa brochure, frutto dell’impegno e dell’entusiasmo di due classi davvero
speciali.
Ringraziamenti
Luca Girotto e Fulvio Alberini, per l’infinita disponibilità e la collaborazione scientifica.
Paola Morizzo e Giovanna Sartori, per le illuminanti visite guidate al museo.
Il dirigente scolastico Paolo Pendenza, per l’adesione al progetto.
La biblioteca e il Comune di Borgo Valsugana, per il supporto organizzativo.
L’Assessore alla cultura di Borgo Valsugana, Enrico Galvan, per la disponibilità
e presenza costante.
Cristina Tomio, per la collaborazione nella gestione e nel coordinamento del progetto.
Un grande ringraziamento a tutti i ragazzi, nella speranza che quest’esperienza
sia diventata un piccolo ma utile tassello della loro formazione.
Pierluigi Pizzitola
Gruppo di lavoro Museo Diffuso della Valsugana orientale
Borgo Valsugana, venerdì 20 maggio 2011
39
40