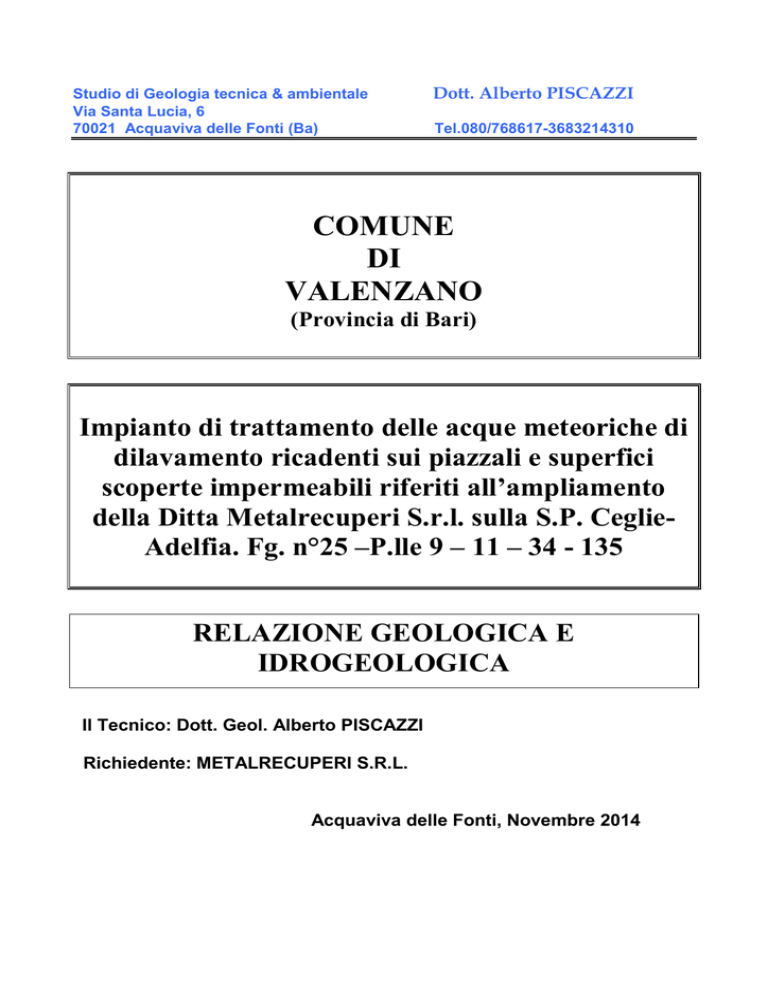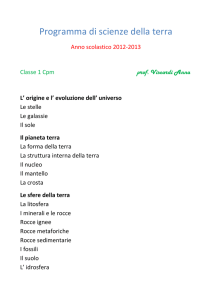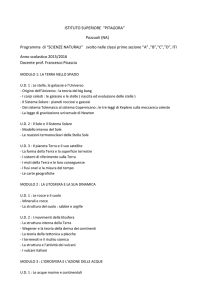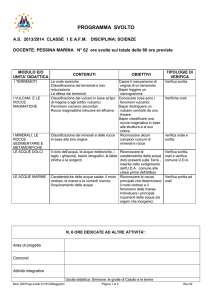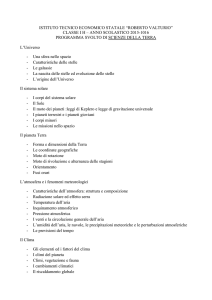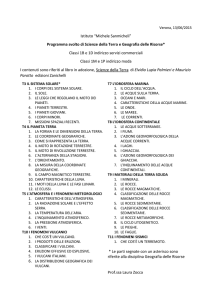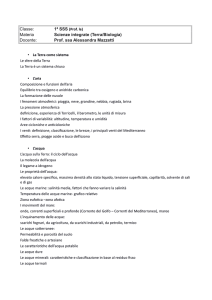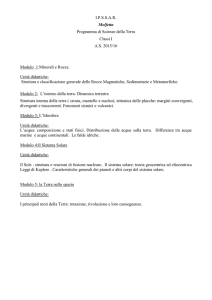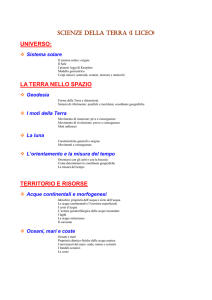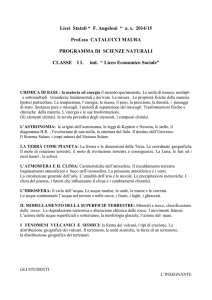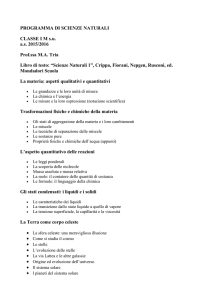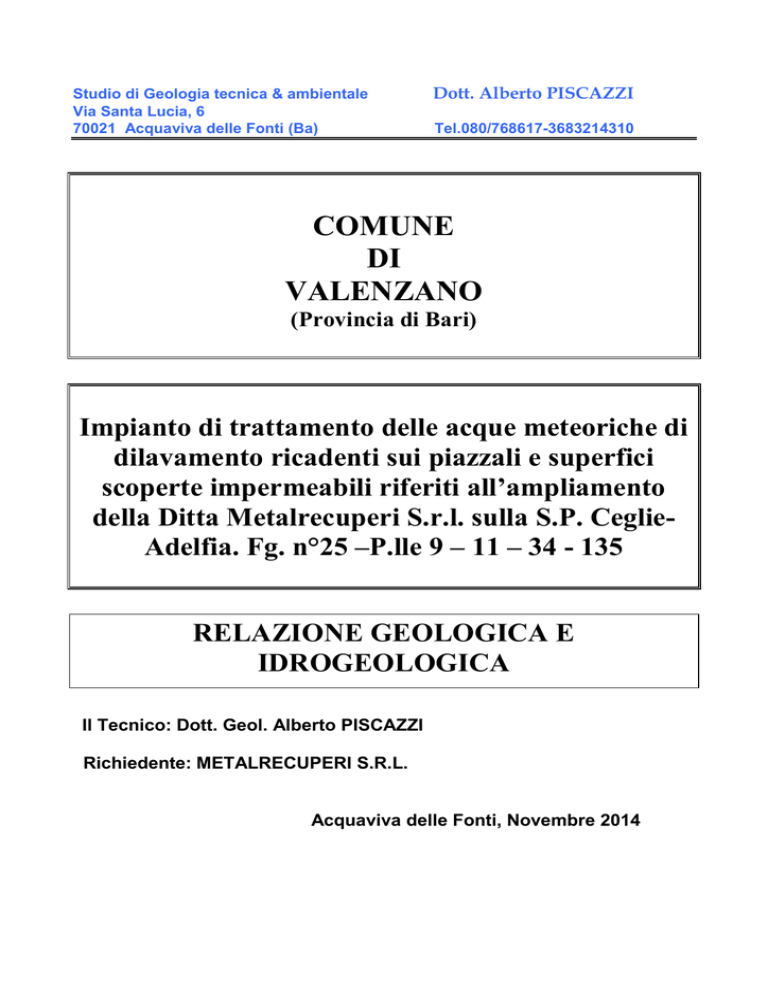
Studio di Geologia tecnica & ambientale
Via Santa Lucia, 6
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Dott. Alberto PISCAZZI
Tel.080/768617-3683214310
COMUNE
DI
VALENZANO
(Provincia di Bari)
Impianto di trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento ricadenti sui piazzali e superfici
scoperte impermeabili riferiti all’ampliamento
della Ditta Metalrecuperi S.r.l. sulla S.P. CeglieAdelfia. Fg. n°25 –P.lle 9 – 11 – 34 - 135
RELAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA
Il Tecnico: Dott. Geol. Alberto PISCAZZI
Richiedente: METALRECUPERI S.R.L.
Acquaviva delle Fonti, Novembre 2014
PREMESSA
La presente relazione geologica e idrogeologica riguarda il sistema di raccolta e
trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali scoperti dell’area in ampliamento
della Ditta Metalrecuperi S.r.l. L’area è ubicata in territorio di Valenzano ed è distinta in
Catasto al Fg. 25 P.lle 9 – 11 - 34 – 135. Le acque di prima pioggia, stoccate
separatamente in una vasca, saranno depurate e smaltite sul suolo con condotte fuori
terra. Le acque di seconda pioggia subiranno processi fisici di grigliatura, disabbiatura e
disoleazione e, dopo accumulo in vasca, saranno smaltite nei primi strati del sottosuolo. I
processi di trattamento previsti sono meglio descritti nella relazione tecnica descrittiva.
Il trattamento delle acque di dilavamento è disciplinato dal R.R. n°26/2013, in
attuazione dell’art.113 del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii.
L’area, nella Cartografia Ufficiale delI’IGM ricade nel F°177 II S.E.
Il richiedente ha incaricato lo scrivente, Dott. Alberto PISCAZZI, di redigere la
presente relazione. In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente nazionale
e regionale la relazione riferisce della situazione morfologica, geologica ed idrogeologica
dell’area interessata al fine della salvaguardia degli aspetti ambientali e della valutazione
dei rischi idraulici e idrogeologici del suolo e sottosuolo interessato.
1
1. LINEAMENTI MORFOLOGICI E GEOLOGICI GENERALI DEL TERRITORIO
L’area oggetto di studio si colloca nel settore centrale della Tavoletta II S.E. del
F°177 dell’IGMI. Le quote dell’area, relativamente alle zone strettamente interessate, si
aggirano intorno ai 90 m s.l.m.
Stralcio Cartografia I.G.M. F°177 Tav. II SE (Scala 1:25.000)
Nel complesso si ha un’area digradante verso i settori settentrionali con pendenze
naturali variabili.
L’area di interesse ricade nel territorio pedemurgiano e risulta essere interessata
in maniera lieve dal fenomeno carsico. Sull’area, affiorano rocce calcaree che, risultano
spesso ricoperte da materiale terroso rossastro. Le acque meteoriche che insistono sul
2
territorio vengono convogliate verso nord-nordest attraverso i sistemi di impluvio naturale
esistenti sul territorio. Tali impluvi si sono formati in corrispondenza di quelle aree dove
la roccia calcarea presenta delle scadenti qualità fisiche (discontinuità primarie e
secondarie). L’azione carsica delle acque meteoriche, ha contribuito ad allargare le
fratturazioni esistenti e a provocare, localmente, fenomeni di crollo con formazione di
avvallamenti. Il ruscellamento delle acque nelle lame si sviluppa finché le stesse non
permeano nel sottosuolo attraverso l’intenso sistema di fratture e discontinuità presenti
nel substrato roccioso. La velocità di assorbimento delle acque presenti in questi solchi
dipende molto anche dalla quantità e granulometria dei materiali eluviali presenti sul
fondo degli stessi.
Le acque ricadenti sui piazzali scoperti della ditta Metalrecuperi S.r.l. non
interferiscono con l’assetto idrogeologico del territorio.
Sul territorio le formazioni geologiche affioranti dal basso verso l’alto sono le
seguenti(riferite alla Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 F° 177 “Bari”):
- CALCARE DI BARI (Cretaceo):
Affiora estesamente tra i territori di Valenzano e Loseto. Più a nord dell’area
interessata risulta ricoperto da litologie sabbiose e calcarenitiche quaternarie. Dal
punto di vista litologico, il Calcare di Bari è costituito da una successione di calcari
micritici di colore biancastro alternati a calcari dolomitici e a dolomie di colore grigiastro
molto compatti.
Nel complesso, risulta che le rocce calcaree e calcareo-dolomitiche sono
regolarmente stratificate con inclinazioni di pochi gradi rispetto all’orizzontale, e con
immersioni variabili da zona a zona.
- TUFI DELLE MURGE O DEPOSITI MARINI TERRAZZATI (Pleistocene): si tratta di
depositi calcareo-arenacei e calcareo-arenaceo-argillosi con presenza di livelli
fossiliferi. Nel territorio si ritrovano, in trasgressione sul Calcare di Bari. Si tratta di
depositi sia sabbiosi che argillosi con presenza nella parte inferiore di arenarie molto
compatte (carparo). La parte più grossolana è costituita da depositi bioclastici e
3
litoclastici di colore bianco o giallastro. Il cemento è calcareo e il grado di diagenesi
variabile li rende a luoghi friabili e variamente porosi.
-
DEPOSITI ALLUVIONALI (Olocene): si tratta di depositi di riempimento del fondo
delle “lame”; sono costituiti da ciottolame calcareo eterometrico proveniente dal
disfacimento delle rocce calcaree, e da materiale terroso, tipo terra rossa, quale
prodotto residuale derivante dalla dissoluzione delle rocce.
STRALCIO DI CARTA GEOLOGICA F°177 “BARI” (Ingrandito1: 50.000)
LEGENDA:
CALCARE DI BARI (Cretaceo Inf.)
TUFI DELLE
pleistocenici)
MURGE
O
DEPOSITI
MARINI
TERRAZZATI
(Plio-
DEPOSITI ALLUVIONALI (Olocene)
Area oggetto di studio
4
2. GEOLOGIA DELL’AREA DI INTERESSE
La quota dell’area di interesse è di circa 90 metri s.l.m.
I rilevamenti geologici compiuti nell’ambito della zona hanno evidenziato che
sull’area affiorano rocce calcaree, anche se spesso ricoperte da depositi di terra rossa.
Le rocce calcaree, nella parte superiore della successione degli strati, risultano
poco compatte e intaccate da numerose fratture e da alterazioni dovute all’azione
carsica delle acque. La stratificazione della parte rocciosa, rilevata nelle zone di
affioramento, è appena visibile ed è costituita da straterelli (spessore variabile da 10 cm
a 50 cm) di calcari micritici di colore dal bianco al nocciola. Le discontinuità secondarie
sono spesso riempite da materiale terroso di colore brunastro. I rilevamenti effettuati
fanno ritenere che la roccia in posto, nella sua successione verticale, non presenti
sempre la stessa permeabilità, ma, questa, risulta essere più bassa per i primi metri di
spessore roccioso, e aumentare più in profondità.
3. CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO
Il territorio murgiano è caratterizzato dalla notevole estensione in affioramento
delle rocce carbonatiche mesozoiche, solo in piccola parte ricoperte per trasgressione da
sedimenti calcarenitici quaternari.
La successione carbonatica, formata dall’alternanza di calcari, calcari dolomitici e
dolomie, risulta, nel complesso, permeabile per fessurazione e carsismo, ed è sede di
una estesa falda idrica sotterranea, caratterizzata da notevole potenzialità e spessore.
La falda trae alimentazione dalle precipitazioni atmosferiche che ricadono su tutto
il territorio murgiano. L’area di ricarica di questa falda è situata, in prevalenza, in
corrispondenza delle zone più interne della Murgia, dove l’entità delle precipitazioni è
maggiore. In queste zone, inoltre, l’infiltrazione delle stesse acque è favorita dalla diffusa
presenza in superficie e in profondità di forme carsiche più o meno sviluppate.
I livelli piezometrici si attestano intorno ai 15-20 m sul livello del mare, mentre i
gradienti idraulici sono abbastanza elevati.
5
Le caratteristiche dell’acquifero sono legate alle condizioni strutturali e litologiche
delle rocce che lo costituiscono. Il frequente alternarsi, sia in senso orizzontale sia
verticale, di livelli rocciosi più o meno fratturati e carsificati, diversamente permeabili,
determina una forte disomogeneità delle caratteristiche idrauliche. La falda si rinviene
confinata tra livelli rocciosi poco permeabili, anche al di sotto del livello del mare.
L’alternanza, ai livelli acquiferi, di strati rocciosi poco fratturati determina il frazionamento
della falda idrica in più orizzonti a differenti profondità.
La circolazione idrica inoltre è influenzata dall’abbondante terra rossa inclusa nelle
cavità carsiche e nelle fessurazioni della roccia che ne riduce il grado di permeabilità.
Solo in presenza di rocce ampiamente carsificate e fessurate, non interessate da
riempimenti di terra rossa, il carico idraulico della falda tende a ridursi notevolmente e a
portarsi al valore del livello del mare. In questo caso la falda acquifera può rinvenirsi a
pelo libero e risentire degli effetti di una falda circolante in equilibrio sulle acque marine
di invasione continentale.
La permeabilità d’insieme dell’acquifero è indefinita in quanto rappresentata da
livelli delle stesse rocce calcareo-dolomitiche che con la profondità presentano un grado
di fratturazione, porosità d’insieme e permeabilità via via decrescente.
4.
CARATTERISTICHE
DALL’IMMISSIONE
IDROGEOLOGICHE
DELL’AREA
INTERESSATA
La situazione idrogeologica dell’area in studio è stata desunta, nei particolari, dai
dati stratigrafici e idraulici a disposizione di alcuni pozzi dell’Ente Irrigazione presenti nei
territori limitrofi.
In generale la zona insatura è costituita da uno spessore di circa 90 m di calcari
fratturati, alternati a calcari dolomitici sufficientemente compatti.
Risulta difficile ipotizzare una continuità laterale delle suddescritte condizioni
idrogeologiche su grande scala, poiché le caratteristiche idrauliche degli acquiferi
possono variare sia in verticale che in orizzontale, a causa del differente grado di
fratturazione e carsificazione delle rocce.
6
Di seguito è stato rappresentato uno schema di sezione idrogeologica applicabile
all’area interessata dall’immissione.
SCHEMA DI SEZIONE IDROGEOLOGICA
5. VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO DEL TERRENO AI
FINI DELLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SUL SUOLO
Le acque di prima pioggia, successivamente al trattamento, saranno smaltite sul
suolo. Il calcolo della capacità di assorbimento del suolo è stato effettuato in un pozzetto
appositamente scavato, della profondità di 1,20 metri, e delle dimensioni di base di 0.60
x 0.60 m. Il pozzetto è stato prima portato a saturazione, e dopo il suo completo
svuotamento, è stato nuovamente riempito fino all’altezza di circa 20 cm dal fondo. Si è
successivamente misurato il tempo necessario affinché il livello scendesse di 5 cm.
7
La seguente formula ci permette di calcolare la capacità di assorbimento (C) del
terreno, espressa come i litri che il terreno assorbe in un ora per metro quadrato.
[
]
C = (V1 − V2 ): (t 2 − t1 ) : S b
dove:
Sb = 0,84 m²
(superficie bagnata);
V1 − V2 = 18 l
(volume di acqua assorbito nel corso della prova);
t 2 − t1 = 0,08 h
(tempo in ore di durata della prova).
Effettuando i calcoli si ricava:
C = (18 : 0,08):0,84 = 267,86
l
l
= 0,074 2
2
hm
sm
6. VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ DI ASS0RBIMENTO DEI PRIMI STRATI DEL
SOTTOSOTTOSUOLO E DIMENSIONAMENTO DEL POZZO ASSORBENTE
.
Le acque di seconda pioggia saranno immesse nei primi strati del sottosuolo. Di
seguito viene calcolata la profondità dei dreni verticali assorbenti. In base alla portata da
smaltire q= 4,03⋅10
−2
m 3 / s e al coefficiente di permeabilità (k) del sottosuolo, stimato
pari a 7 ⋅10 −5 m/s. Il calcolo viene effettuato con la seguente formula:
0,423
4∆h
K =
q Log
2
∆h
d
dove:
K = coefficiente di permeabilità ( 7 ⋅ 10 −5 m / s );
∆h = altezza (in m) della colonna drenante;
q = portata d’acqua da smaltire (0,0403 mc/s)
d = diametro del pozzo assorbente (0,2 m);
8
Per garantire una superficie drenante pienamente sufficiente allo smaltimento
delle acque, si consiglia, in maniera cautelativa, la realizzazione di due pozzi drenanti
della profondità di 35 m ciascuno. I pozzi dovranno essere dotati di una vasca
(avanpozzo) a tenuta, con funzione di accumulo e sedimentazione, allo scopo di
trattenere eventuali residui di materiali di sedimentazione. Tale accorgimento preserverà
i dreni dal progressivo intasamento dei materiali in sospensione trasportati dall’acqua.
Nella fase di esercizio si avrà cura di effettuare interventi di pulizia e
manutenzione della vasca di raccolta e sedimentazione.
Considerate le condizioni idrostrutturali del sottosuolo che, per l’area in
esame, consistono in una zona insatura di circa 90 metri dal piano campagna, il
franco esistente per la zona insatura, in rapporto alle oscillazioni della falda idrica,
è sufficientemente protettivo.
9
SCHEMA DI CIASCUN POZZO
DRENANTE PROFONDO 35 METRI
220 mm
Tratto di pozzo con
rivestimento
sfinestrato
10 m
25 m
200 mm
10
7. ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO, E IDROGEOLOGICO E DEFINIZIONE DEL
FRANCO DI SICUREZZA
Considerate le condizioni morfologiche delle aree strettamente limitrofe all’area di
dispersione, non si rileva alcun tipo di rischio idraulico in rapporto alle portate di acqua
da immettere.
La tipologia delle acque da smaltire non procurerà odori molesti.
Le acque meteoriche di dilavamento del piazzale dopo gli opportuni trattamenti
(vedi relazione tecnica generale), sono acque con bassi agenti inquinanti. Se si
considera lo schema idrogeologico descritto in precedenza, si capisce come queste
acque, durante la percolazione nella zona insatura, subiranno ulteriori processi
autodepurativi e di dispersione meccanica. I processi autodepurativi saranno favoriti
dalle interazioni chimico-fisiche tra i minerali argillosi contenuti nelle terre rosse e gli
eventuali inquinanti ancora presenti. I processi di dispersione avverranno per
mescolamento con le acque vadose all’interno dei condotti carsici.
Nella zona insatura è presente un acquitardo, costituito da calcari e calcari
dolomitici sufficientemente compatti, con bassa conducibilità, che funge da strato
protettivo nei confronti della sottostante falda idrica. Tale strato, infatti, ritarda la
propagazione delle acque in percolazione.
Da quanto descritto, anche il rischio idrogeologico è praticamente nullo, in quanto:
•
Il franco esistente tra il livello di immissione delle acque meteoriche
trattate e la prima falda carsica presente è sufficientemente protettivo;
•
La zona insatura è costituita da uno spessore di rocce calcaree e
calcareo-dolomitiche, la cui parte inferiore risulta essere compatta e
con permeabilità bassissima. Tale ultimo spessore rappresenta una
barriera protettiva nei confronti della falda idrica sottostante.
11
8. Indicazione di pozzi eventualmente presenti nelle zone limitrofe a
quella dell’area in studio
Sulla base delle informazioni disponibili e della consultazione della Tavola 6.4
“Ubicazione dei punti d’acqua censiti” allegata al Piano di Tutela delle Acque della
regione Puglia, nel raggio di 500 metri dalla Ditta Metalrecuperi S.r.l. non si rilevano
pozzi per uso irriguo, mentre in un raggio di 1000 metri non si rilevano pozzi per uso
potabile.
Acquaviva delle Fonti, Novembre 2014
Dott. Geol. Alberto PISCAZZI
12
13