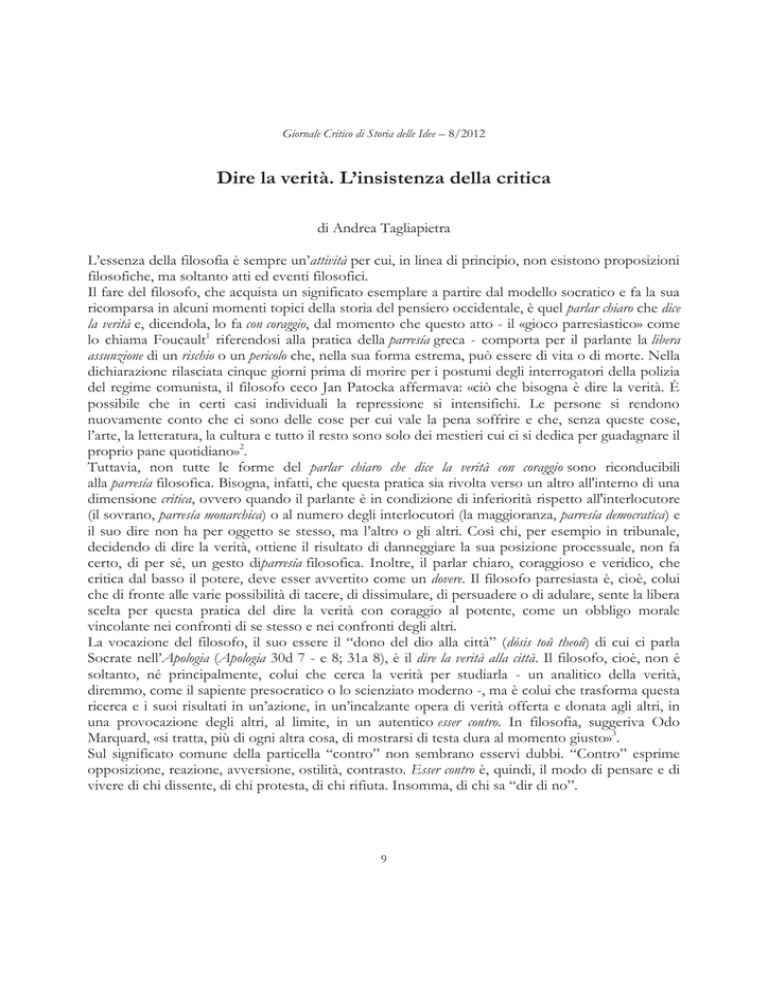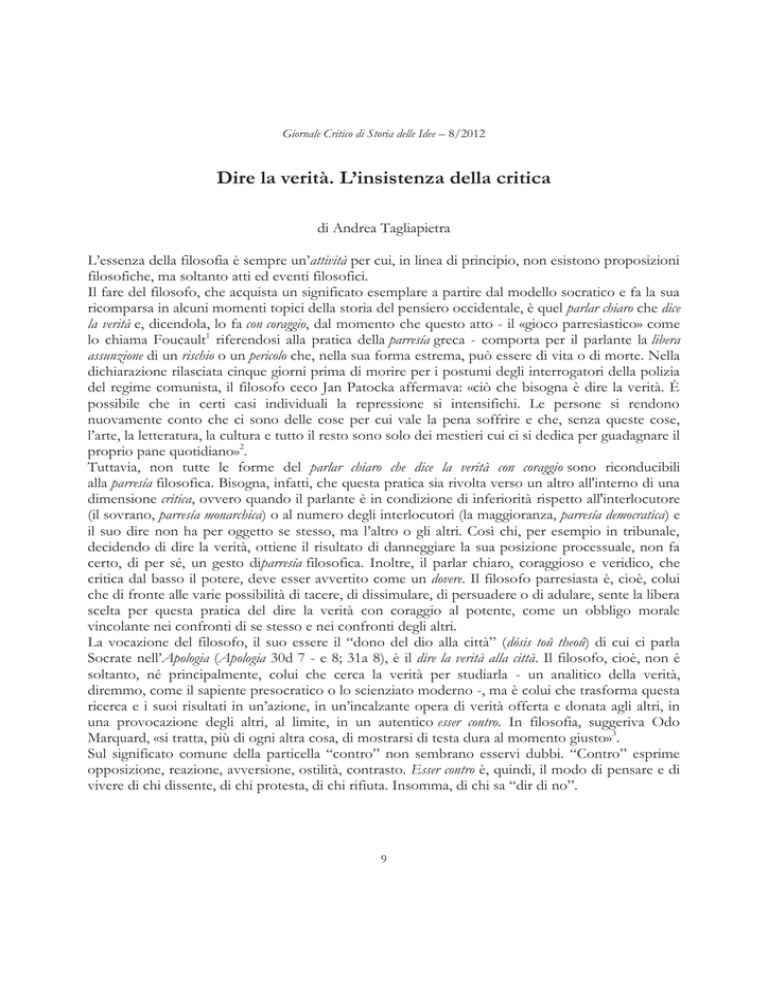
Giornale Critico di Storia delle Idee – 8/2012
Dire la verità. L’insistenza della critica
di Andrea Tagliapietra
L’essenza della filosofia è sempre un’attività per cui, in linea di principio, non esistono proposizioni
filosofiche, ma soltanto atti ed eventi filosofici.
Il fare del filosofo, che acquista un significato esemplare a partire dal modello socratico e fa la sua
ricomparsa in alcuni momenti topici della storia del pensiero occidentale, è quel parlar chiaro che dice
la verità e, dicendola, lo fa con coraggio, dal momento che questo atto - il «gioco parresiastico» come
lo chiama Foucault1 riferendosi alla pratica della parresía greca - comporta per il parlante la libera
assunzione di un rischio o un pericolo che, nella sua forma estrema, può essere di vita o di morte. Nella
dichiarazione rilasciata cinque giorni prima di morire per i postumi degli interrogatori della polizia
del regime comunista, il filosofo ceco Jan Patocka affermava: «ciò che bisogna è dire la verità. È
possibile che in certi casi individuali la repressione si intensifichi. Le persone si rendono
nuovamente conto che ci sono delle cose per cui vale la pena soffrire e che, senza queste cose,
l’arte, la letteratura, la cultura e tutto il resto sono solo dei mestieri cui ci si dedica per guadagnare il
proprio pane quotidiano»2.
Tuttavia, non tutte le forme del parlar chiaro che dice la verità con coraggio sono riconducibili
alla parresía filosofica. Bisogna, infatti, che questa pratica sia rivolta verso un altro all'interno di una
dimensione critica, ovvero quando il parlante è in condizione di inferiorità rispetto all'interlocutore
(il sovrano, parresía monarchica) o al numero degli interlocutori (la maggioranza, parresía democratica) e
il suo dire non ha per oggetto se stesso, ma l’altro o gli altri. Così chi, per esempio in tribunale,
decidendo di dire la verità, ottiene il risultato di danneggiare la sua posizione processuale, non fa
certo, di per sé, un gesto diparresía filosofica. Inoltre, il parlar chiaro, coraggioso e veridico, che
critica dal basso il potere, deve esser avvertito come un dovere. Il filosofo parresiasta è, cioè, colui
che di fronte alle varie possibilità di tacere, di dissimulare, di persuadere o di adulare, sente la libera
scelta per questa pratica del dire la verità con coraggio al potente, come un obbligo morale
vincolante nei confronti di se stesso e nei confronti degli altri.
La vocazione del filosofo, il suo essere il “dono del dio alla città” (dósis toû theoû) di cui ci parla
Socrate nell’Apologia (Apologia 30d 7 - e 8; 31a 8), è il dire la verità alla città. Il filosofo, cioè, non è
soltanto, né principalmente, colui che cerca la verità per studiarla - un analitico della verità,
diremmo, come il sapiente presocratico o lo scienziato moderno -, ma è colui che trasforma questa
ricerca e i suoi risultati in un’azione, in un’incalzante opera di verità offerta e donata agli altri, in
una provocazione degli altri, al limite, in un autentico esser contro. In filosofia, suggeriva Odo
Marquard, «si tratta, più di ogni altra cosa, di mostrarsi di testa dura al momento giusto»3.
Sul significato comune della particella “contro” non sembrano esservi dubbi. “Contro” esprime
opposizione, reazione, avversione, ostilità, contrasto. Esser contro è, quindi, il modo di pensare e di
vivere di chi dissente, di chi protesta, di chi rifiuta. Insomma, di chi sa “dir di no”.
9
Andrea Tagliapietra, Dire la verità. L’insistenza della critica – GCSI 8/2012
Nelle società tradizionali, basate sul conformismo e sull’adesione passiva ad una configurazione di
valori prestabiliti, la posizione di chi non acconsente non è mai stata comoda. A volte è stata resa
persino impossibile.
I miti e le saghe delle principali civiltà antiche, da Prometeo ad Adamo, da Ulisse a Saul, da Enkidu
a Loki, raccontano la ribellione di chi “dice di no” in termini di condanna, di sconfitta e di
maledizione. Lo stesso nome del Maligno nella tradizione ebraica, ossia ha satan, significa, alla
lettera, “colui che si oppone”, “colui che è d’ostacolo”, “colui che sta contro”.Anti-christos, cioè
“contro-Cristo”, è il nome greco dell’avversario escatologico che guiderà le schiere del Male nello
scenario degli ultimi tempi, prima della fine della storia. «Sono lo spirito che sempre dice no (Ich bin
der Geist, der stets verneint)»(Faust I, 1338): con queste parole Mefistofele si presenta a Faust,
nell’omonimo capolavoro di Goethe. Nella descrizione della corte celeste con cui si apre il libro di
Giobbe, Satan è l’accusatore - il pubblico ministero - il cui compito è quello di mettere alla prova il
giusto (Giobbe 1,6-12). È questa, forse, l’origine più antica di quell’espressione che, nella banalità
del linguaggio comune, si impiega per descrivere chi “parla contro”, chi si assume il ruolo del
“bastian contrario”, ossia chi fa l’“avvocato del diavolo”.
Ma la tradizione biblica ci descrive anche un altro esempio di vite orientate all’esser contro, questa
volta, tuttavia, connotate positivamente. Si tratta di quelle figure eroiche e grandiose che in ebraico
si chiamano nebiim, ovvero i “profeti”. Tutte le civiltà hanno i “sapienti”, i “consiglieri del
principe”, che mangiano dalle mani dei potenti, godono della loro protezione e riproducono e
rafforzano le strutture del sapere tradizionale e dell’ordine costituito. Solo la civiltà ebraica ha i
“profeti”, ossia degli uomini che “parlano contro”, che esortano, che denunciano, che accusano le
forme del potere stesso.
«Su, va a Ninive, la grande città, e grida contro di essa»(Giona 1,2) è il comando di Dio a Giona. La
figura del profeta scuote il popolo dal torpore dell’inautentico, dalle cattive abitudini, dalla falsità e
dalle menzogne. La sua azione è un “portar fuori”, un “esodo” dalla permanenza nella non verità
e, insieme, un “mutare direzione”, un “convertire” rispetto alla deriva, al procedere per inerzia
dell’errore. Nel tipo del “profeta” la civiltà occidentale sperimenta per la prima volta il modello di
un’esistenza orientata sul “potere” esclusivo della parola. Un potere inteso come contro
potere rispetto all’economia e all’organizzazione materiale dello status quo della forza, una parola che,
fondandosi solo su se stessa, dà voce agli umili, ai poveri e ai servi contro le consuetudini e il
sapere dei padroni.
Il “contro” è, come suggerisce l’immagine del deserto, il luogo utopico dei profeti, il “vuoto”
radicale rispetto al “pieno” della città verso cui il messaggio del nabi’ invece è rivolto. Quella del
profeta, ha scritto Klaus Heinrich, autore di un bel libro Sulla difficoltà di dire di no4, è
un’autentica protesta ontologica che si condensa nell’esercizio ostinato della potenza del no, del
negativo, della negazione. Negare, del resto, richiede un grande dispendio di energia rispetto a tutte
quelle prestazioni dell’essere vivente che assecondano e si adattano alla realtà in qualche modo
riflettendola e corrispondendole. La negazione, nel suo significato più generale, è una sospensione
del mondo, un contrapporsi ad esso, un affiorare di quel “mondo” che, innanzi al “no”, appare per la
prima volta in quanto tale, ossia nel suo aspetto di mancanza, di vuoto, di smarrimento, di assenza
di senso, di meccanica connessione di stimoli e risposte.
10
Giornale Critico di Storia delle Idee – 8/2012
Anticamente il verbo latino protestari indicava la professione di fede rilasciata innanzi ad autorevoli
testimoni, in primis a quel testimone per antonomasia, dal momento che ha le qualità
dell’onniscienza e dell’ubiquità, che è Dio stesso. La protesta ontologica del “no” ha, quindi, una
portata ben più vasta della singola accusa o della ricusazione particolare, dal momento che essa
manifesta la presa di posizione in favore della verità come continuità del senso che non può essere
sottoposta al limite della determinazione di un mondo che appare nella forma dell’isolamento e
dell’esaurimento. Essa è, dunque, quel primo “dir di no”, quella cellula generatrice da cui sgorga
ogni altra parola, e ogni linguaggio. È una negazione che si esercita non sull’essere, che in qualche
modo la sua stessa posizione dischiude5, ma su quelle negazioni determinate che gli stanno contro
e che, a loro volta, minacciano, con il loro non essere, la pienezza e l’autenticità della vita.
Il ruolo del profeta, come ha ben visto Leo Strauss6, possiede nella figura di Socrate, il
protofilosofo, il suo corrispondente greco. Non c’è filosofo degno di questo nome il quale, per
quanto lontano dalle tesi che, storicamente, la tradizione ha attribuito al maestro ateniese, non
senta con Socrate una sorta di aria di famiglia e, all’occorrenza, non sia in grado di identificarsi con
lui. Lo stesso Nietzsche - filosoficamente uno dei suoi più acerrimi nemici - affida ad un breve
frammento dei suoi taccuini la confessione che «Socrate mi è talmente vicino, che devo quasi
sempre combattere contro di lui»(FP 1875-1876, 6 [3])7. E nella terza delle “Considerazioni
inattuali”, quella dedicata a Schopenhauer come educatore, là dove si nega a chi sia un semplice
professore di filosofia e un «funzionario statale», come Kant, il nome di filosofo, non è difficile
scorgere, invece, nella descrizione dei requisiti essenziali di quest’ultimo, nella capacità di dare un
esempio con la vita e non con i libri, i tratti inconfondibili del profilo socratico: «se però dovesse
presentarsi un uomo che realmente facesse capire di voler affrontare tutto, anche lo Stato, con il
coltello della verità (mit dem Messer der Wahrheit), lo Stato, dato che innanzitutto afferma la propria
esistenza, avrebbe ragione di escludere da se stesso tale uomo e di trattarlo come suo nemico»(§
8)8.
A somiglianza del profeta, anche Socrate sta dalla parte della negazione. Il suo sapere, come lui
stesso ci ricorda nell'Apologia, è un “sapere di non sapere”, è un “contro sapere”, è quella “dotta
ignoranza” a partire dalla quale egli può interrogare i cittadini di Atene su ciò che essi credono di
conoscere, smantellando le false convinzioni, i valori e i presunti assolutismi su cui poggia l’intera
vita della città (Apologia 20d 6-23d 2).
Isaia e Socrate, il profeta e il filosofo, sono i due tipi ideali da cui discende, attraverso il fiume della
storia, ciò che nella società moderna si è soliti chiamare l’“intellettuale”. L’intellettuale, sostiene
Edward W. Said9, è colui che mette continuamente in discussione la realtà e si fa autore ed attore di
un linguaggio che porta, in sé, la vocazione di dire la verità al potere. Questo “dire la verità”, questa
parresía, questa coraggiosa e appassionata franchezza si riscontra nella ricerca della pubblicità che
l’intellettuale organico, insediato nel “centro” del sapere ufficiale, teme e controlla (il sapere, per
lui, è ancora affare di “segretezza”, di “gergo tecnico” e di “ordine professionale”), mentre
l’intellettuale indipendente, dai margini della periferia - «il pensiero critico», scriveva Enrique
Dussel, «sorge dalla periferia (ci sarebbe da aggiungere la periferia sociale, le classi oppresse,
i Lumpen) e finisce sempre per rivolgersi verso il centro»10 –, spesso dalla concreta esperienza
dell’esilio, la persegue, a volte ne ha bisogno quale garanzia stessa della sua sopravvivenza. Il vero
11
Andrea Tagliapietra, Dire la verità. L’insistenza della critica – GCSI 8/2012
intellettuale è, come accadde a Voltaire, un outsider, un contestatore, un esiliato, un “dilettante” sia
nel senso etimologico che in quello comune.
La figura dell’intellettuale si sviluppa e assume consistenza, quindi, con l’apertura di quello spazio
d’autonomia di pensiero e di vita rispetto alle istituzioni del potere e del sapere che ha preso il
nome di illuminismo11. L’illuminismo, diceva Kant, «implica molto meno di quanto non immaginino
coloro che ritengono che l’illuminismo consista di conoscenze: è piuttosto un principio negativo
dell’uso della facoltà di conoscere»12, ossia un vaglio dei suoi limiti. L’illuminismo è il «tempo della
critica (Zeitalter der Kritik), a cui tutto deve sottostare»13.
La parola “critica” ci riporta, attraverso l’etimologia, all’immagine del tribunale, all’esame dei “pro”
e dei “contro”, ad una concezione drammatica e dibattimentale della verità, ossia come risultato di
un processo confutatorio e polivoco, che era apparsa per la prima volta in Grecia, al tempo dei
sofisti e dei poeti tragici, là dove la nascita della filosofia e quella del teatro scoprono la loro
comune radice. Eppure la critica non consiste nel cercare di giustificare le cose come stanno, ma
nel sentire altrimenti e diversamente, nel contrapporre alla realtà un nuovo modo di vedere e
un’altra sensibilità. La critica, notava Michel Foucault, non è altro che «l’arte di non essere
eccessivamente governati»14, e un modo per non essere governati di più è quello di mettere il potere
in contraddizione con se stesso, costringere il potere a dividersi e, quindi, a depotenziarsi,
perdendo la pretesa del suo assolutismo. Il principio di non contraddizione che sorregge l’analitica della
verità dell’impresa filosofica e scientifica implica quel dire contro che, nei luoghi originari della
filosofia15, trasforma la verità in verità critica. La critica, a sua volta, ha per scopo finale la divisione
dei poteri – dove «l’effetto di libertà politica caratteristico della divisione politica dei poteri è
soltanto un caso particolare dell’effetto di libertà proprio dell’universale policromia della realtà»16 –,
ovvero la creazione di spazi interstiziali di autonomia sempre più ampi e differenziati, che
dispiegano le possibilità della nostra esperienza.
La critica filosofica conserva una natura asimmetrica e manifesta un legame fondamentale tra
rapporti di forza e relazioni di verità. Per produrre la pratica di verità su se stesso e sugli altri il
filosofo ha bisogno di contrapporsi alla non verità del potere che gli si oppone con la forza.
La situazione critica necessita, quindi, della non indifferenza del potere nei confronti della verità (di qui
le difficoltà della critica di fronte ad un potere della maggioranza indifferente al valore strategico
della verità, come accade, talvolta, nelle democrazie contemporanee, dove si può dire tutto - e
quindi anche la verità -, ma quasi nessuno, ormai, vi presta più attenzione). La verità parresiastica,
anche se aspira alla neutralità mediante il disinteresse sovrano che il filosofo professa con la messa in
gioco della sua stessa vita, incrina quel rapporto fra verità e méson, ovvero fra verità e posizione
mediana del neutro – oggi diremmo fra verità e conformismo - che nelle società tradizionali, come
quella greca ai tempi di Socrate e Platone, appare caratterizzare la configurazione aconflittuale e
neutrale della verità.
Allora, la verità abbandona la sua posizione di pace ed entra giocoforza in una dimensione di
tensione e di conflitto: «si dirà tanto più la verità quanto più si è situati all’interno di un certo
campo. È l’appartenenza a un campo - la posizione decentrata - a permettere di decifrare la verità e
di denunciare le illusioni e gli errori attraverso cui vien fatto credere - gli avversari fanno credere che ci si trova in un mondo ordinato e pacificato. “Più mi decentro, più vedo la verità; più
12
Giornale Critico di Storia delle Idee – 8/2012
accentuo il rapporto di forza, più mi batto, e più la verità si dispiegherà effettivamente dinanzi a
me, e all’interno di questa prospettiva della lotta, della sopravvivenza e della vittoria”»17. Il filosofo
che dice la verità si decentra rispetto al presunto centro della verità pacificata. Non cerca il conflitto,
ma è, in qualche modo, il conflitto perché si pone deliberatamente fuori dal centro del potere
pensato come unica realtà possibile. Il differimento della verità, la dilazione di quell’urgenza della
verità che si esprime nei termini della coazione, della necessità e dell’automatismo, consente di
porre la domanda critica sul “perché ci urge la verità?”, smascherando l’effettiva funzione
autoritaria e repressiva del suo uso.
Non c’è critica e, dunque, non c’è vera autonomia dell’individuo, senza un esser contro, senza un
opporsi, senza una protesta. Il Novecento, che si era aperto fra i bagliori di ribellione, ancora
vividi, delcontro potere degli intellettuali, chiamati a raccolta dal “J’accuse” di Zola per l’“affaire
Dreyfus”18, si è chiuso con il declino dell’intellettuale, con il suo assorbimento nelle strutture
organiche del consenso alla Megamacchina globale, come la chiama Latouche19, nell’ossequio dei
luoghi comuni del pensare gregario, ma sempre trendy, aggiornato, “alla moda”, in quel
“conformismo dell’anticonformismo” che viene contrabbandato dai media come la massima
espressione della libertà d’opinione. Così l’esser contro diventa un giro di valzer e gli intellettuali dei
“ballerini” che, come ironizzava Kundera in un suo romanzo20, piroettano, compiaciuti e
incoerenti, da un contrario all’altro, dando l’impressione di sfidare il mondo, ma, in realtà, senza
rischiare sul serio più nulla. Perché esser contro significa avere il coraggio di stare fino in fondo dalla
parte del torto, dell’insuccesso, vuoi anche della sconfitta o, infine, come ha saputo fare Socrate,
della morte stessa.
L’esser contro è, allora, ciò che Adorno, discutendo sul concetto di filosofia in una delle sue lezioni,
descriveva con il termine insistenza. «L’insistenza», egli sostiene, «la fermezza nel non lasciarsi
fuorviare, è un gesto, anzi il gesto spirituale della filosofia. Esso è diverso da quello della scienza
generale. Ciò che mette in contatto un uomo con la filosofia è questo gesto. È molto difficile
condurre alla filosofia chi non ha un debole per esso, e qui», conclude Adorno, «sta il piccolo
granello di verità dell’esoterismo»21, ovvero, detto in altri termini, l’elemento singolare, volontario e
non deducibile razionalmente, unico e irripetibilmente ripetibile, della filosofia.
Socrate esibisce la struttura testimoniale della verità critica non quando argomenta secondo ragione
innanzi ai suoi interlocutori, ma quando rifiuta di sottrarsi alla sentenza di morte del tribunale di
Atene in sintonia con il contenuto di quelle stesse argomentazioni. È, insomma, sul diverso
atteggiamento nei confronti del nesso fra le teorie e la vita, fra la sete di conoscenze e l’atto di
verità, fra lo “sguardo da nessun luogo”22 e la posizione personale, fra la verità astratta che non ha
mai fatto male a nessuno e il gioco delle forze reali che costituiscono il pensiero, che si può
distinguere, come ha fatto Bertolt Brecht, le condotta di Giordano Bruno, che muore sul rogo
senza ritrattare le proprie idee, da quella del fisico pisano che, dopo aver abiurato, all’allievo
Andrea Sarti confessa: «io ti ho insegnato la scienza e poi ho rinnegato la verità»(Vita di Galilei, sc.
XIV)23.
Ma quale verità rinnega Galilei? Non certo la verità particolare delle sue scoperte scientifiche, che
rimane tale anche dopo la sua ritrattazione. Egli rinnega il valore della verità come libertà di poterla
cercare, ovvero il significato emancipatorio di quell’atto di verità che abbiamo chiamato verità
13
Andrea Tagliapietra, Dire la verità. L’insistenza della critica – GCSI 8/2012
critica. Quando lo scienziato sostiene che i tre angoli di un triangolo sono uguali a due angoli retti
nessuno si sogna di chiedergli se crede o no a quello che dice. Né gli si domanda se per affermare
questa proposizione è disposto a morire. Per questo, nella storia della scienza moderna non si
registrano atti eroici. Del resto, anche prendendo in esame l’ipotesi sostenuta da Thomas Hobbes
(Leviathan I,XI)24, che suppone che un giorno a qualcuno di molto potente interessi negare che i tre
angoli di un triangolo sono uguali a due angoli retti, bruciando tutti i libri di geometria – è
un’ipotesi che allude direttamente alle resistenze ideologiche che la scienza moderna ha dovuto
affrontare nel secolo di Galilei -, ci sembra che il rischio che una verità di questo genere possa
essere messa a tacere per sempre o anche per qualche tempo sia molto basso, in quanto riteniamo,
come suggeriva Hannah Arendt, che il risultato di una verità scientifica sia frutto di una facoltà
mentale umana impersonale e, eventualmente, ripetibile e riproducibile altrimenti.
Ma non solo. Alla verità scientifica, anche quando questa riguarda la sfera più astratta del sapere, si
associa, ormai, almeno sin dai tempi di Francesco Bacone, la prospettiva di un aumento di potenza
e di efficacia nei confronti della realtà, l’«incremento indefinito della capacità di realizzare scopi» 25
– il fenomeno della tecnica -, che manifesta la logica stessa del potere e del voler avere di più,
dell’economia utilitaristica e dell’accumulazione, ovvero la sua assolutizzazione disciplinare. Di
conseguenza è assai più probabile che lo scienziato metta la propria curiosità e il proprio desiderio
di sapere al servizio del potere e dell’avidità del potere, come Leonardo da Vinci, che disegnava
magnifiche e terribili macchine belliche per i prìncipi della sua epoca. Invece, rispetto al rapporto
con la verità dello scienziato, il filosofo appare nelle umili vesti del testimone che, a proprie spese,
rende testimonianza di qualcosa che, in ultima istanza, non può essere verificato in nessun altro
modo. L’argomentazione razionale non è sufficiente a fare il filosofo – forse basta appena a fare
quello che già Kant chiamava un «tecnico della ragione (Vernunftkünstler)»26 –, cioè se alla sua base
non c’è l’impegno personale, l’investimento per la verità. Per Kant il tecnico della ragione dispone di
una scorta sufficiente di conoscenze razionali e di una connessione sistematica di queste secondo
l’idea di un tutto, ma rinunciando alla domanda critica sui limiti dell’organo di queste conoscenze,
che implica necessariamente la domanda sulla loro finalità, rende, di fatto, quell’organo stesso,
ovvero la ragione, impotente e inutile di per se stessa, ossia come centro di forza autonoma,
perché in relazione di dipendenza diretta da una forza esterna. Invece, la filosofia come scienza dei
fini ultimi della ragione umana non è un’abilità, ma una dottrina della saggezza, Weltweisheit, in cui il
filosofo non è un tecnico della ragione, ma il suo legislatore. Di conseguenza, solo questo pensatore in
proprio (Selbstdenker), maestro della saggezza tramite l’insegnamento e l’esempio, è l’autentico
filosofo.
La verità filosofica ha, come la verità dell’opera d’arte, un tratto che la lega alla dimensione più
fragile della verità, quella dell’unicità testimoniale e della singolarità delle verità di fatto.
L’«insegnamento attraverso l’esempio», prosegue la Arendt, «è, in effetti, l’unica forma di
“persuasione” di cui la verità filosofica è capace senza perversione o distorsione; per la stessa
ragione, la verità filosofica può diventare “pratica” e ispirare l’azione senza violare le regole
dell’ambito politico, soltanto quando riesce a diventare manifesta sotto forma di esempio. Questa è
l’unica possibilità per un principio etico di essere verificato e convalidato»27.
14
Giornale Critico di Storia delle Idee – 8/2012
Ma ciò non si limita al circuito critico fra principio etico e spazio politico descritto dalla Arendt. In
senso più generale si potrebbe affermare che il disinteresse è il riflesso immediato della filosofia nel
mondo della vita. Anzi, quest’inutilità – questa negazione di quanto è considerato, di volta in volta,
l’utile movente dell’agire umano individuale e collettivo - è ciò che, nella filosofia come canone di
opere e di sistemi di pensiero, è e rimane costante, apparentemente senza storia. È il punto di
resistenza e di insistenza, ovvero ciò che più assomiglia all’astoricità strategica che, all’interno del
discorso filosofico, si vorrebbe assegnare al concetto di verità.
Nel corso della vita, ogni uomo ingaggia una dura lotta con la verità. Ne ha bisogno, ma la teme.
Talvolta la cerca disperatamente e, tuttavia, molto spesso si dà da fare per metterla a tacere e poi
nasconderla. Eppure, assai raramente, in questo aspro confronto, egli si chiede cosa significhi la
verità in sé. Per l'uomo, in generale, sarà più importante ascoltare una parola, acquisire un sapere,
possedere un oggetto, conoscere i precisi dettagli di un fatto - tutte cose alle quali, di volta in volta,
si dà il nome di verità -, piuttosto che interrogarsi sulla verità medesima. Gli uomini che dicono di
volere la verità, in fondo, sono solo alla ricerca di spiegazioni, di cause e di colpe, di un sistema di
esoneri e di consolazioni in grado di rendere più sopportabile il peso della vita all’interno di un
programma di verità che è, per essi, trasparente e inavvertito come la boccia di vetro in cui
nuotano i pesci rossi.
Ecco allora che di fronte alla generalità del comportamento degli uomini, il filosofo è quell’uomo
che non si accontenta della rassegna delle spiegazioni particolari, ma chiede e pretende di più, che
aspira ad un gesto tanto inutile, nella prospettiva del sistema di esoneri e spiegazioni di cui si
diceva, quanto sovrano.
Socrate "dice la verità" non perché abbia raggiunto l'esattezza del vero a proposito di qualcosa o
per formulare una teoria della verità razionale universalmente valida - e se ciò appare è difficile
scacciare il sospetto di un riverbero retroattivo di ciò che pensa Platone -, ma per indurre il
proprio antagonista «a render conto (didónai lógon) di sé e del modo con cui ha trascorso la sua
vita»(Lachete 187e 10). La verità, quindi, non è ciò che c’è già, un’esistenza oggettiva di cui si
ricupera la continuità e l’autorità normativa risalendo oltre l’oscurità della memoria e dell’anima
individuale, la nebbia dei sensi o il conflitto delle passioni, in una pretesa di legittimità che
conserva il tratto arcaico dell’eredità, bensì è ciò che sta davanti come vita mia o altrui, nella
problematicità per cui queste vite si liberano e non appaiono più condizionate da nulla. Così la
verità, per il filosofo, non può essere possesso, ma diventa iniziativa e, in quanto tale, ha storia,
diventando forma cangiante delle relazioni di sapere e di potere che innervano le pratiche e le
teorie che accompagnano l’avventura dell’umanità.
Il dire la verità è, cioè, qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla verità come fatto o come teoria
di cui danno prova le scienze. Il dire la verità implica una questione più ampia e di vasta portata,
intrinsecamente connessa con il concetto di verità, ma, in qualche modo, distinta. Ecco allora che,
riprendendo la differenziazione, ancora una volta, da Foucault, si potrebbe parlare di storicità della
verità almeno in due sensi, ovvero della storia di una verità interna ai discorsi epistemologici e alle
continuità disciplinari – quella che un filosofo come Bernard Williams chiamerebbe la «storia delle
teorie filosofiche della verità»28 –, ma, soprattutto, per quanto concerne l’insistenza della critica,
della storia di una verità esterna, ossia di quell’incessante modificazione delle relazioni tra l’uomo e
15
Andrea Tagliapietra, Dire la verità. L’insistenza della critica – GCSI 8/2012
ciò che, di volta in volta, viene istituito come verità, che definisce «le regole del gioco a partire dalle
quali si vedono nascere certe forme di soggettività, certi ambiti di oggetto, certi tipi di sapere»29.
Ecco che il dire la verità della critica è anche e soprattutto uno smascherare la funzione disciplinare
dei programmi di verità che plasmano le soggettività e i saperi, favorendone la moltiplicazione
nella prospettiva di un mondo più libero e più vario.
Note
1
Cfr. M. Foucault, Discourse and Truth. The Problematization of Parresia, Northwestern University Press, Evanston Ill.
1985; tr. it., Discorso e verità nella Grecia antica, Donzelli, Roma 1996. Si tratta di un corso di lezioni, tenute fra ottobre e
novembre del 1983, a Berkeley in California.
2 J. Patocka, Dichiarazione dell’8 marzo 1977, il testo si trova all’interno di un articolo in memoria di Patocka
pubblicato da Roman Jakobson su “The New Republic” 176, n. 19, del 7 maggio 1977, pp. 26-28; tr. it., Curriculum vitae
di un filosofo ceco, in J. Patočka, Kacirské eseje o filosofii dejin (1973-1976); tr. it., Saggi eretici sulla filosofia della storia, a c. di M.
Carbone, pref. di P. Ricoeur, con uno scritto di R. Jakobson, Einaudi, Torino 2008, p. 177.
3 O. Marquard, Aesthetica und Anaesthetica: philosophische Überlegungen, Schöningh, Paderborn 1989; tr. it., Estetica e
anestetica, il Mulino, Bologna 1994, p. 43.
4 K. Heinrich, Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen, Stroemfeld/Roter Stern, Basel-Frankfurt a. M. 1985. A
proposito del confronto della figura del profeta biblico con quella del sapiente presocratico a cui si fa risalire la
scoperta dell’”essere”, cfr. Id., Parmenides und Jona (1964), Strömfeld/Roter Stern, Frankfurt a. M. 1982; tr. it., Parmenide
e Giona, Guida, Napoli 1988.
5 In questa direzione si può forse interpretare la lettura teoretica della negazione condotta da M. Donà, Sulla negazione,
Bompiani, Milano 2004.
6 L. Strauss, Jerusalem and Athens. Some Introductory Reflections, in “Commentary”, XLIII (1967), pp. 45-57; tr.
it., Gerusalemme e Atene. Riflessioni preliminari, in Id., Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero politico dell’Occidente, Einaudi,
Torino 1998, in particolare pp. 29-36 (Socrate e i profeti).
7 F. Nietzsche, Frammenti postumi 1875-1876, in Opere di Friedrich Nietzsche, edizione italiana condotta sul testo critico
stabilito da G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano 1964-ss, vol. IV, tomo 1, p. 159.
8 F. Nietzsche, Unzeitgemässe Betrachtungen. Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher (1874) in Id., Werke, Kritische
Gesamtausgabe, herausgegeben von G. Colli und M. Montinari, De Gruyter & Co., Berlin 1964-ss, Abt. III, Bd. 1; tr.
it., Schopenhauer come educatore, in Opere di Friedrich Nietzsche, cit., vol. III, tomo 1, edizione in volume singolo, Adelphi,
Milano 1985, p. 88.
9 E. W. Said, Representations of the intellectual, Pantheon Books, New York 1994; tr. it., Dire la verità. Gli intellettuali e il
potere, Feltrinelli, Milano 1995.
10 E. Dussel, Filosofía de la liberación, Editorial Edicol, México D. F. 1977; tr. it., Filosofia della liberazione, Queriniana,
Brescia 1992, p. 51.
11 Rinvio in proposito a A. Tagliapietra (a c. di), Che cos’è l’illuminismo? I testi e la genealogia del concetto, Bruno Mondadori,
Milano 1997.
12 I. Kant, Was heisst: Sich im Denken orientieren?, in "Berlinische Monatsschrift" VIII, (1786), pp. 304-330; ora in Kant's
Gesammelte Schriften, edizione dalla Königlich Preussischen [poi Deutschen] Akademie der Wissenschaften, de Gruyter,
Berlin-Leipzig 1900-ss. (voll. I-IX: Werke; voll. X-XIII: Briefwechsel; voll. XIV-XXIII: Handschriftlicher Nachlass;
voll. XXIII-ss.:Vorlesungen [a cura della Akademie der Wissenschaften zu Göttingen]), vol. VIII, pp. 131-147, p. 147
nota *; tr. it., Cosa significa orientarsi nel pensare, in Id., Scritti sul criticismo, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 13-29, p. 29, nota
*.
13 I. Kant, Kritik der rainen Vernunft, Königsberg 1781, ora in Kant's Gesammelte Schriften, cit., vol. IV (ed. 1781 [A]), vol.
III (ed. 1787 [B]), p. XII [A]; tr. it., condotta sull'edizione B, Critica della ragion pura, in 2 voll., Laterza, Roma-Bari 1983,
vol. I, p. 7, nota 1.
16
Giornale Critico di Storia delle Idee – 8/2012
14
M. Foucault, Qu'est-ce que la critique? (Critique et Aufklärung), (conferenza, Sorbona, maggio 1978), ora in "Bullettin de
la Société Française de Philosophie" avril-juin 1990, 2, pp. 35-63; tr. it., Illuminismo e critica, Donzelli, Roma 1997, p. 38.
15 Si veda, a proposito della matrice agonistica della sapienza greca da cui, secondo l’autore, discende il pensiero
filosofico, il saggio di G. Colli, La nascita della filosofia, Adelphi, Milano 1975.
16 O. Marquard, Apologie der Zufälligen, Reclam, Stuttgart 1987; tr. it., Apologia del caso, il Mulino, Bologna 1991, p. 156.
17 M. Foucault, "Il faut défendre la société". Collège de France, Cour 1975-1976, Hautes Études Seuil-Gallimard, Paris 1997; tr.
it., "Bisogna difendere la società", a c. di M. Bertani e A. Fontana, Feltrinelli, Milano 1998, p. 51.
18 Il celebre articolo di Émile Zola, in forma di lettera aperta al presidente della Repubblica francese Félix Faure, fu
pubblicato su “L’Aurore” il 13 gennaio 1898.
19 S. Latouche, La Megamachine. Raison technoscientifique, raison economique et mythe du progres. Essais a la memoire de Jacques
Ellul, Éditions La Découverte, Paris 1995; tr. it., La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del
progresso. Saggi in memoria di Jacques Ellul, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
20 M. Kundera, La lenteur, Gallimard, Paris 1995; tr. it., La lentezza, Adelphi, Milano 1995, pp. 25-29.
21 T. W. Adorno, Der Begriff der Philosophie, Edition Text-Kritik, München 1993, lezione del 18 dicembre 1951; tr. it., Il
concetto di filosofia, Manifestolibri, Roma 2005, p. 63.
22 T. Nagel, The view from nowhere, Oxford University Press, Oxford-New York 1986; tr. it., Uno sguardo da nessun luogo, il
Saggiatore, Milano 1988.
23 B. Brecht, Leben des Galilei (1938-1939; 1945-1946; 1953-1955), Suhrkamp, Berlin 1955; tr. it., Vita di Galileo, in id., I
capolavori, in 2 voll., Einaudi, Torino 1998, vol. 2, p. 112.
24 T. Hobbes, Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Common-Wealth Ecclesiasticall And Civill, Crooke, London
1651; tr. it., Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno stato ecclesiastico e civile, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 83.
25 E. Severino, Il destino della tecnica, Rizzoli, Milano 1998, p. 11.
26 I. Kant, Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen, in Kant's Gesammelte Schriften, cit., vol. IX, pp. 24-27; tr. it., Logica, cit., pp.
18-21.
27 H. Arendt, Truth and Politics, in "The New Yorker", 25 febbraio 1967, pp. 49-88, ora in Id., Between Past and Future.
Eight Exercices in Political Thought, The Viking Press, New York 1968; tr. it., Verità e politica, Bollati Boringhieri, Torino
1995, pp. 29-76, p. 56.
28 B. Williams, Truth and Truthfulness. An Essay in Genealogy, Princeton University Press, Princeton 2002; tr. it., Genealogia
della verità. Storia e virtù del dire il vero, tr. di G. Pellegrino, Fazi Editore, Roma 2005, pp. 61-62.
29M. Foucault, A verdade e as formas juridicas, in “Cadernos da P.U.C.”, n. 16, giugno 1974, pp. 5-133 (Conferenze tenute
alla Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, dal 21 al 25 maggio 1973), poi in Id., Dits et Écrits, in 4 voll., a c. di
F. Ewald e D. Defert, Éditions Gallimard 1994, vol. 2; tr. it., La verità e le forme giuridiche, in Archivio Foucault. Interventi,
colloqui, interviste. 2. 1971-1977, Poteri, saperi, strategie, a c. di A. Dal Lago, Feltrinelli, Milano 1997, pp. 83-165, p. 86.
17