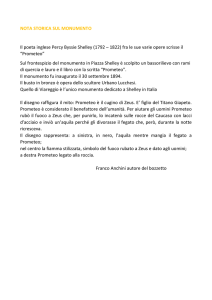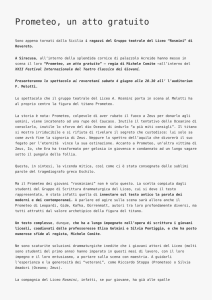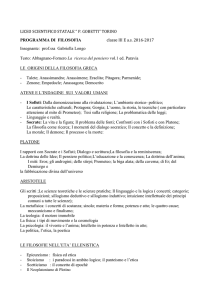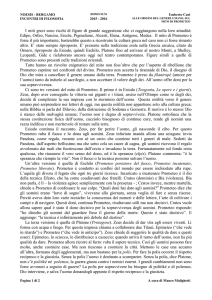DE ARTIS MEDIETATE
VEL
Пερί του τέχνης μεταξύ
Ossia il carattere intermediario della
tecnica
di
Andrea Beghini
Liceo ginnasio statale “G.Chiabrera”
2008
1
Indice:
1. Introduzione: un problema complesso.
2. I Greci e la τέχνη: tra mito e società.
3. La questione della tecnica: prospettive filosofiche e scorci
artistico- letterari.
4. L’età della tecnica: lo smarrimento del senso.
5. Dal formalismo al Gestell.
6. De artis medietate.
“Ciò che è veramente inquietante non è
che il mondo si trasformi in un
completo dominio della tecnica. Di gran
lunga più inquietante è che l’uomo non
è affatto preparato a questo radicale
mutamento del mondo. Di gran lunga
più inquietante è che non siamo ancora
capaci di raggiungere, attraverso un
pensiero meditato, un confronto
adeguato con ciò che sta realmente
emergendo dalla nostra epoca”
MARTIN HEIDEGGER, L’abbandono.
2
DE ARTIS MEDIETATE
VEL
Пερί του τέχνης μεταξύ
Ossia il carattere intermediario della tecnica
Introduzione: un problema complesso.
Già Sofocle nel primo stasimo dell’Antigone scrisse: “πολλά τά δεινά κουδέν ανθρώπου
δεινότερον πέλει”1 dando così voce ad un’inquietudine di fondo, un brivido sottile di
serpeggiante irrazionalità rispetto alla figura di un’umanità ambigua, dai moti spesso
incontrollabili che oscillano da una polarità all’altra, dal vertice di positività all’estremo di
negatività. Proprio questo carattere ambiguo si amplifica nelle attività tramite cui l’uomo si
rapporta con il mondo, attività che trovano a loro volta espressione massima nella tecnica
intesa sia come progresso tecnologico, sia più sottilmente come quel pensiero tecnico che
presiede allo svolgimento delle attività umane (a tale proposito il Dizionario di filosofia di
Nicola Abbagnano la definisce come “insieme di regole adatte a dirigere efficacemente
un’attività qualsiasi”2). Dunque, così come l’agire dell’uomo richiede una riflessione etica
sull’agire, la tecnica, che si presenta come un’aggrovigliata matassa di problematiche che
riguardano l’agire e l’essere stesso dell’uomo, non richiede a sua volta una riflessione
sulla tecnica?
La tecnica, intesa nei due sensi prima enunciati, offre all’uomo, cioè al soggetto, la facoltà
di intervenire e, in un certo senso, di realizzarsi costruttivamente producendo, regolando e
modificando tanto il pensiero- se è tecnica di pensiero- quanto la realtà - se è tecnologia-.
Parimenti l’effetto prodotto, regolato, modificato interviene e muta il modo proprio di essere
dell’uomo. Pertanto, con questa trattazione, si intende esaminare le problematiche che la
tecnica ha sollevato nel tempo e solleva tuttora, analizzando alcuni scorci del pensiero
occidentale. Partendo così dalle sue radici, l’alveo della cultura greca, si arriverà ad
esaminare, in tempi più recenti nell’ambito della cosiddetta “questione della tecnica”, le
inquietudini che percorsero gli animi a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo.
Ricorrendo poi a interpretazioni più recenti, si cercherà di definire le implicazioni che l’età
della tecnica riporta sul modo stesso che l’uomo ha di comprendere il mondo e la propria
umanità. Per esemplificare queste problematiche a livello di tecnica di pensiero, si
1
“Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uomo” in SOFOCLE, Antigone, trad. di Raffaele
Cantarella, Mondadori, 1991, Milano.
2
NICOLA ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, p. 1070, terza edizione aggiornata e a ampliata da Giovanni
Fornero, UTET, 1998, Torino.
3
proporrà una breve analisi del formalismo hilbertiano, mentre, per dimostrare come la
portata della questione della tecnica abbia raggiunto una dimensione epocale, si
approderà alla teoria heideggeriana del Gestell. In conclusione, anche per dare chiarezza
di un titolo forse enigmatico, proporrò, attraverso un’operazione di estensione teoretica del
problema, la mia interpretazione del senso della tecnica.
I Greci e la τέχνη: tra mito e società.
Lapidaria è l’affermazione del Prometeo di Eschilo: ”I mortali possiedono tutte le arti grazie
a Prometeo”3. Il grande tragediografo ateniese, nel riprendere il mito del Titano in quella
che doveva essere una trilogia legata comprendente, oltre al pervenuto Пρομηθεύς
δησμώτης, anche un Пρομηθεύς πυρφόρος e un Пρομηθεύς λυόμενος, accetta la
tradizione già esiodea che fa di Prometeo l’autore del furto del fuoco agli dei. In verità le
versioni del mito sono anche in questo caso molteplici e di ardua interpretazione. Esiste,
infatti, anche una tradizione mitologenica che individua l’inventore dell’arte di conservare e
riprodurre il fuoco in Hermes. È il caso dell’Inno omerico ad Hermes:
…Là, dopo aver ben pasciuto d’erba le vacche dal profondo muggito,
e averle spinte tutte insieme nella stalla
mentre ruminavano il trifoglio e il cipero rugiadoso,
raccolse molta legna, e sperimentò l’arte del fuoco.
Prese uno splendido ramo d’alloro, e lo fece girare in un ramo di melograno,
tenendolo saldamente fra le mani: ne emanava un caldo soffio.
In verità Hermes per primo rivelò il fuoco, e gli strumenti per accenderlo.
Raccolse molta legna asciutta e dura, e in un fosso scavato nel terreno
la accumulò in abbondanza; e lampeggiò la fiamma
diffondendo per largo tratto la vampa del fuoco, che intensamente ardeva.4
Il giovane dio presenta le caratteristiche del trickster, della deità scherzosa e ambigua che
funge da intermediario tra il mondo degli dei e quello degli uomini e che ora si arma
dell’inganno e dell’astuzia ora viene incontro alle esigenze vitali dell’umanità. Il carattere
ambiguo proprio di Hermes, che è ad un tempo dio protettore dei ladri e solenne
psicopompo, è comune al personaggio mitico di Prometeo: da un lato, egli è il sovversivo,
il non consenziente per eccellenza rispetto a un ordine universale che è volontà di Zeus e
che si esprime nell’implacabile Necessità; dall’altro, egli è lo spirito creatore mosso da un
incontenibile amore per l’umanità sofferente. L’ambigua figura del Titano ha portato nello
sviluppo della letteratura occidentale a due filoni interpretativi del suo significato, uno
positivo e uno negativo. Quello positivo vede in Prometeo l’entusiastica vitalità di una
fantasia libera e creatrice, quasi artistica, e il simbolo stesso dell’universale condizione
3
4
ESCHILO, Prometeo incatenato, v. 507, trad. di Monica Centanni, Mondadori, 2007, Milano.
Inno a Hermes IV, vv. 105- 114, trad. di F. Cassola.
4
umana. Tutto il genere umano, come afferma Werner Jaeger in Paideia, si sente
rappresentato in quel possente Titano legato eternamente alla parete del monte Caucaso,
ed ogni stirpe della terra, ogni popolo e nazione, ogni singolo uomo può sentire su di sé le
catene della sofferenza di Prometeo, perché in Prometeo il dolore umano “si immilla”. Da
qui l’intuizione che doveva essere profetica rispetto al messaggio cristiano: solo l’Ecce
Homo, ossia la divinizzazione del dolore, avrebbe acquisito altrettanta e superiore forza
simbolica.
Il filone negativo vede in Prometeo l’eterna sconfitta dell’uomo: il Titano, violando l’ordine
cosmico, libera un flusso di forze arcane e primordiali che non è in grado di controllare
rimanendo così travolto dal turbine dirompente della sua stessa hybris che lo ha indotto ad
elevarsi oltre la sua propria misura. Se la lettura positiva celebrava il Titano nella sua
sconfitta, la lettura negativa vede solo l’annichilimento che deriva dalla sconfitta:
Prometeo, ribelle, ha voluto infrangere l’autorità assoluta del padre degli dei, ha voluto
mettere alla prova l’Olimpio in una gara d’astuzia, ma è risultato sconfitto. Se, infatti,
Prometeo può contare su un’intelligenza fatta di calcolo e di ingegno, Zeus ha dalla sua
parte la forza della necessità; così anche Prometeo, come Agamennone, dovrà piegare il
capo sotto il giogo della Necessità tanto da arrivare a riconoscere che: “La mia arte è di
gran lunga meno potente della necessità”5.
allegoria
Goethe ha espresso con una mirabile
una condizione analoga a quella del Titano nella ballata dell’Apprendista
stregone: il giovane negromante, in assenza del maestro, cerca di evocare le forze
magiche come più volte ha visto fare dal suo mentore. L’esito sarà catastrofico: la magia
scatenata dal giovane apprendista presto sfuggirà al suo controllo e si ritorcerà contro di
lui, solo l’intervento del maestro potrà placare il risultato della spregiudicatezza dell’allievo.
Il vecchio maestro stregone
S’è finalmente allontanato!
Ed ora vorrei che i suoi spiritelli
Facessero un pochino a modo mio.
Mi ricordo delle parole
e dei gesti, e come li usava,
e con la forza dello spirito so fare miracoli anch’io.
…
che cascata spaventosa!
Signore e maestro, ascolta il mio grido!Ecco viene il maestro!
Padrone il momento è grave.
Gli spiriti che ho chiamato,
5
ESCHILO, Prometeo incatenato, v. 514, trad. di Monica Centanni, Mondadori, 2007, Milano. Dove “arte” è appunto
traduzione del termine τέχνη.
5
non me ne posso liberare.6
L’ambivalenza di Prometeo, che è ambiguità, come si è visto, per lo più morale, si
rintraccia anche nella possibile origine del mito. Sèchan concorda con Wilamowitz nel
distinguere due tradizioni cultuali: quella di Pròmethos, divinità ionico- attica delle industrie
del fuoco, vasaio e metallurgo venerato nei Prometheia; e quella del Prometheus beoticolocrese che è propriamente il Titano ribelle. Anche per quel che riguarda l’origine del nome
gli studiosi non concordano all’unanimità; tuttavia, in questo caso, nonostante tesi come
quelle di Curtius e Kuhn che farebbero derivare “Prometeo” dal sanscrito vedico
pramantha, termine designante il bastone con cui ci si procurava il fuoco per frizione, i più
propendono per ricollegare il nome proprio alla radice metis con il significato ben noto di
“colui che arriva prima col pensiero”, rispetto a “colui che pensa dopo”, il fratello Epimeteo.
Sarebbe comunque dalla fusione dei due miti sopra citati che Eschilo e, prima di lui,
Esiodo avrebbero attinto il proprio materiale facendo entrare Prometeo nel novero delle
divinità legate all’arte del fuoco (Atena ed Efesto) che a sua volta contraddistingue la
categoria sociale degli artigiani e più in generale i mestieri specializzati praticati al di fuori
delle mura domestiche. Ed è Esiodo il primo a segnalare l’ambivalenza morale del “dio
intelligente”7 attribuendogli i due epiteti “valente figlio di Iapeto” e “essere dai pensieri
scaltri”, in contrapposizione a Zeus che, con i suoi matrimoni con Metis e Themis, è il
garante ufficiale dell’ordine e della giustizia. Esiodo, inoltre, distingue chiaramente le due
frodi di cui Prometeo si fa autore e i loro esiti nefasti per il destino dell’umanità: la
spartizione del cibo e il furto del fuoco. Prometeo, nel sacrificare un grande bue agli dei,
separò, all’insaputa di Zeus, le ossa, che furono immolate insieme al grasso, dalle carni,
che furono nascoste per la stirpe degli uomini. L’audace ed empia spartizione del Titano
provocò la spartizione tra la genia degli dei e quella degli uomini, tra la razza degli
immortali e quella dei mortali. La seconda frode, il ben noto furto del fuoco, determinò a
sua volta un nuovo radicale mutamento della condizione umana: il fuoco, padre di tutte le
tecniche, segnò l’indipendenza degli uomini dai ritmi naturali ma, di conseguenza, anche
la loro dipendenza dal lavoro tecnico che subentrò allo spontaneo generarsi dei frutti della
terra; segnò la fine dell’età dell’oro e l’inizio di un processo di decadenza che si sviluppa
nel corso del mito delle cinque età fino all’età del ferro, quando gli uomini sono ormai
destinati all’infelice vecchiaia, alle seduzioni del bel male, che è la donna (Pandora), e al
sudore del lavoro. Il lavoro, in particolare, è l’immediata conseguenza -positiva e negativa
perché libera l’uomo e lo condanna alla sua eterna “mortalità”- dell’ introduzione delle
tecniche che derivano dall’arte del fuoco. Il lavoro, infatti, è il termine medio che consente
6
7
J. W. GOETHE, L’apprendista stregone, trad. di Liliana Scalero, da Opere V, Sansoni, 1961, Firenze.
J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci (Il lavoro e il pensiero tecnico), Einaudi, 1978, Torino.
6
di ripristinare un equilibrio fra gli dei e gli uomini poiché “grazie al lavoro gli uomini hanno
grandi armenti e son ricchi;/ e lavorando, sarai molto più caro agli immortali”8.
Il mito di Prometeo è ripreso, in chiave filosofica, da Platone nel Protagora: il sofista, dal
cui nome deriva il titolo del dialogo, espone a Socrate la versione del mito per cui
Epimeteo, il fratello stolido del Titano, nel distribuire le qualità agli esseri viventi, si
sarebbe dimenticato degli uomini. Per riparare al danno, Prometeo avrebbe sottratto alle
officine degli immortali il fuoco, maestro di tutte le tecniche. Tuttavia, tra le arti che
derivano dal fuoco non sono comprese né l’arte politica né l’arte militare che sono
conoscenze esclusive di Zeus. Dovrà essere il padre degli dei a concedere agli uomini,
tramite Hermes, l’arte di governare la città. Già da questo aspetto si può osservare
un’evidente incompatibilità tra l’impegno attivo nella dimensione della πόλις e l’esercizio di
un mestiere, tra la funzione politica e la funzione tecnica. È ben noto, infatti, come lo
spirito aristocratico di Platone inducesse il filosofo ad un rifiuto della concezione politica di
Pericle e di Protagora, ossia di una democrazia aperta alla partecipazione alla vita politica
da parte di tutti i cittadini, artigiani compresi. Così Protagora, convinto dell’efficacia del
modello paideutico sofistico, afferma senza riserve: “Adeguatamente, Socrate, ti è stato
dimostrato, in conclusione, come almeno mi sembra, che non a torto i tuoi concittadini
permettono che un fabbro, un calzolaio, chiunque si faccia parte diligente nelle
deliberazioni politiche, e che non a torto la virtù sia insegnabile e si possa acquisire.”9
Per Platone la tecnica ha una funzione meramente sociale che non contempla la
concezione dell’uomo politico. La tecnica è, infatti, essenziale per lo sviluppo della società
umana: la stessa specializzazione tecnica ha consentito in tempi remoti l’associazione
degli individui in comunità organizzate dove ciascuno riveste una funzione specifica e ad
un tempo indispensabile per il funzionamento della dimensione collettiva. La rinuncia alle
attività tecniche riporterebbe l’uomo ad una condizione di primitiva solitudine e non
renderebbe possibile l’esercizio di quelle nobili funzioni politiche (nel senso di “legate alla
realtà della πόλις”) cui l’uomo è votato. E tuttavia, Platone, riflettendo quel predominante
interesse degli Elleni per la teoresi, non riconosce, come fece Esiodo -caso eccezionale
nella Grecità-, la tensione del lavoro come sforzo umano, né l’artificio tecnico come
invenzione intelligente, né il pensiero tecnico nel suo ruolo formatore della Ragione. Per
Platone la tecnica riveste un gradino inferiore dell’intelligenza umana, anzi “si trova in lui la
cura di separare e d’opporre l’intelligenza tecnica e l’intelligenza, l’uomo tecnico e il suo
ideale d’uomo, così come egli separa e oppone nella città la funzione tecnica e le altre
due.”10 Questo porta ad alcune brevi considerazioni, sulla scia dell’analisi proposta da
Vernant nel testo citato in nota, sulla concezione platonica della società “tripartita” esposta
8
ESIODO, Le opere e i giorni, vv. 308-9, trad. di G. Arrighetti, Monadori, 2007, Milano.
PLATONE, Protagora, 324 c, trad. di Francesco Adorno, Laterza, 2003, Bari.
10
J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci (Il lavoro e il pensiero tecnico), p. 280, Einaudi, 1978, Torino.
9
7
nel IV libro della Repubblica. Nel distinguere le tre classi11, quella dei filosofi o governanti,
quella dei guerrieri o custodi, e quella dei lavoratori e in particolar modo degli artigiani ( i
depositari della funzione tecnica), Platone attribuisce a ciascuna di esse una virtù
peculiare. Alla prima classe spetta la “saggezza” (επιστήμη o σοφία), alla seconda classe
spetta il coraggio (ανδρεια); quando viene il momento di indicare la virtù propria della terza
classe, Platone si limita a riconoscerle quell’unica qualità che è comune a tutte le classi: la
σωφροσύνη, la moderazione. Si esprime così in modo manifesto il rifiuto di accordare una
virtù positiva a coloro la cui funzione sociale è costituita dal lavoro, cioè dalla conditio sine
qua i membri delle altre due classi non potrebbero espletare le loro specifiche funzioni
politiche per ragioni di mera sopravvivenza quotidiana.
Per cercare di comprendere quale ruolo avesse il lavoro nella società della Grecia antica,
quali rapporti esistessero tra il lavoro e le altre attività umane e quali contenuti psicologici
si possono rintracciare nella concezione che gli Elleni avevano del lavoro è possibile
incominciare col prendere in esame i termini che i Greci utilizzavano. Emerge, infatti, che
la ricchezza della lingua greca non dispone di un termine unitario equivalente al nostro
“lavoro”: pònos , ad esempio, si riferisce a tutte quelle attività che implicano fatica e sforzo
(equivalente al latino labor), mentre il verbo ergàzesthai si riferisce a due ambiti
fondamentali: al lavoro dei campi, tà érga, e più in generale a tutte le attività che
consentono di produrre qualcosa, tò érgon, in funzione di una propria virtù, areté. Le
parole che invece derivano dalla radice indoeuropea tek-, come la nostra “tecnica”,
alludono piuttosto alla sfera della fabbricazione, a una proiezione invasiva dell’oggetto
artificiale nella realtà, all’attività dell’artigiano che compie un’operazione che rientra
nell’ordine del verbo poiein (il medesimo utilizzato per i poeti) e che si contrappone al
pràttein. Infatti, mentre il primo verbo esprime una tensione all’oggetto prodotto, il secondo
è tutto concentrato sull’attività fine a se stessa e non riferita a qualche cosa altro da sé. La
differenza che intercorre tra pràttein e poiein è riconducibile a quella che in italiano
sussiste tra “agire” e “fabbricare”, dove “agire” è in genere caricato da uno spessore di
positività etica. Tali sottigliezze linguistiche suggeriscono gradi di differenza tra le singole
attività lavorative ben più profondi della tripartizione platonica, anche perché legati alla
struttura reale della società.
Esiodo, negli Erga, distingue, tra le attività legate alla terra, l’arboricoltura dall’agricoltura.
Tale distinzione non avviene tanto su base economica, quanto per ragioni religiosocultuali. L’arboricoltura rappresenta la piena armonia dei rapporti tra uomo e natura: essa
è tipica dell’età dell’oro in quanto è la terra a offrire spontaneamente i suoi frutti e all’uomo
non resta altro da fare che attendere il ciclo delle stagioni per il raccolto. In questa ciclica
11
Tengo a precisare l’uso storicamente improprio, ma funzionale ai fini della chiarezza espositiva e avvalorato da una
lunga consuetudine di traduzione, del termine “classe” appartenente piuttosto al lessico economico-sociale tardo
settecentesco e poi socialista ottocentesco.
8
ripetitività dei ritmi naturali si possono leggere le movenze di un culto della natura
incarnata in divinità come le Horai e le Charites, completamente armonizzate con il vivere
degli uomini. Da questa condizione tipica dell’età dell’oro, l’umanità, come si è visto nel
mito di Prometeo, è destinata a precipitare nell’età del ferro, quando dovrà procurarsi di
che vivere bagnando di sudore i campi. E questa è l’attività in cui Esiodo si riconosce:
l’agricoltura. Essa, come già si è accennato, implica rapporti di nuova natura tra gli uomini
e gli dei: Demetra, dea del raccolto e delle messi, non interviene elargendo i doni della
terra agli uomini, ma assicura un ordine regolare cui gli uomini devono contribuire con la
fatica del lavoro nei campi. È significativo che tale lavoro agricolo non richieda nessuna
competenza tecnica particolare, nessuna preparazione, in quanto esso è la dimostrazione
della virtù con cui gli uomini dosano e concentrano le proprie forze, è una “forma di vita
morale”12 e pertanto rientra nella dimensione del pràttein, dell’agire fine a se stesso con lo
sguardo sempre rivolto alla comunione con la divinità. Lo stesso concetto è ripreso da
Senofonte nell’Economico dove il lavoro della terra è esplicitamente qualificato, al pari
dell’attività guerresca, come manifestazione di un certo tipo di areté, tanto che esso
contribuisce alla salute e alla vigoria del fisico oltre che della mente13. Alla guerra e
all’agricoltura, dunque, non si addice il termine téchne, che è l’indice di un sapere
specializzato dai tratti quasi esoterici, poiché nella guerra come nell’agricoltura tutti
possono dimostrare il loro intimo valore e tutti percepiscono l’universale dipendenza dalle
forze divine. In questo aspetto sta il contenuto cultuale della religiosità arcaica: un
sentimento che riconosce il legame reciproco con la divinità e che rifiuta di intervenire,
come invece fa la tecnica degli artigiani, sulla natura per modificarla o riprodurla.
L’evoluzione del pensiero tecnico procede, pertanto, parallelamente all’evoluzione del
pensiero razionale-positivo14, tanto che quest’ultimo arriva a determinare una radicale
revisione della stessa concezione del lavoro agricolo: con il passare del tempo l’attività
manuale dei campi sarà dequalificata a lavoro servile proprio perché non necessitante di
particolare predisposizione che non sia quella fisica. Ma non si tratta soltanto di
un’evoluzione del pensiero; entra in gioco, infatti, in questa mutata concezione, l’affermarsi
di nuovi assetti socio-politici: si passa gradatamente dal nucleo della famiglia o del clan a
quello della πόλις dove il lavoro della terra non può essere più considerato come l’attività
fondamentale per un mantenimento “autarchico” ma solo come il tassello di un mosaico di
più attività tecniche specializzate che dipendono e si sostengono le une con le altre. Il
12
J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci (Il lavoro e il pensiero tecnico), p. 280, Einaudi, 1978, Torino. Tutta
l’analisi sopra proposta intorno ai contenuti psicologici del lavoro presso gli antichi Greci fa riferimento allo studio di
Vernant tratto dal saggio citato.
13
SENOFONTE, Economico, IV 24.
14
Credo sia opportuno precisare, sulla scia delle considerazioni di Jaeger in Paideia, che l’età arcaica non deve essere
ritenuta al di fuori del pensiero razionale, poiché, se essa non fu caratterizzata da quelle forme che il pensiero acquisì
nell’età classica grazie al contributo della filosofia, tuttavia contribuì alla genesi di tali forme in un processo di lineare e
continua evoluzione. Non parlerei, pertanto, di pre-razionalità arcaica, quanto di proto-razionalità arcaica; tanto più che
il pensiero razionale greco non poteva prescindere, ancora in età classica, da quel straordinario apporto interpretativoconoscitivo di una religiosità immanente che è il mito.
9
grande corpo della πόλις può funzionare economicamente e politicamente solo se,
attraverso tutti i suoi membri, può coprire ogni campo d’azione. In questo modello
ciascuno occupa il proprio posto senza poter essere sostituito da altri: ciò che accomuna
tutti i cittadini dovranno essere le virtù morali e politiche che sono dono di Zeus.
Non bisogna pensare, tuttavia, che presso i Greci l’attività tecnica e l’esercizio dei mestieri
siano rivolti ad una produzione finalizzata al solo incremento della ricchezza. No, essi
oscillano tra due poli: l’abilità, dynamis, dell’artigiano e il bisogno, chreia, dell’utente. Ossia
rappresentano l’esercizio e il graduale miglioramento di un’abilità per soddisfare un
particolare bisogno di un individuo altro da sé e la téchne in senso stretto è l’insieme delle
modalità con cui l’abilità dell’artigiano si può esplicare nella fabbricazione di un oggetto
non naturale. Questo significa che la téchne, come la potenza da cui ha origine, non è
aperta ad un indefinito progresso, ma si esaurisce nei limiti che la rendono possibile: limite
delle risorse e limite dei bisogni umani. L’artigiano greco, infatti, non ha alcun interesse ad
intervenire al di fuori della portata delle esigenze naturali, chreiai, degli utenti in quanto
non intende intervenire sulla natura umanizzandola, ma inserire la propria abilità
nell’ordine naturale naturalizzandola.
Tornando al mito di Prometeo, Jean Pierre Vernant osserva come l’interpretazione
eschilea abbia tenuto conto di alcune componenti assenti nel testo platonico. Se nel
Protagora alla tecnica veniva riservata una mera funzione morale, nel Prometeo
incatenato le implicazioni tra tecnica e dimensione etica si fanno più strette. “L’intelligenza
e la ragione, in quel che hanno di propriamente umano- scrive Vernant a proposito della
tragedia- appaiono come tecniche: è la scoperta successiva delle arti che segna le tappe
del loro progresso”15
Prima, avevano occhi e non vedevano, orecchie e non sentivano, ma come le immagini
nei sogni vivevano confusamente una vita lunga, inconsapevole. Non sapevano costruire
edifici, case all’aperto, non sapevano lavorare il legno: abitavano sottoterra come brulicanti
formiche, in caverne profonde senza la luce del sole.16
Appare chiaro come Eschilo metta l’accento sull’originaria infirmitas del genere umano,
così debole, immaturo, privo di autonomia spirituale e quindi tanto più necessitante di una
fulgida guida che gli illumini la via della sapienza tecnica per vivere realmente nel mondo.
Aggiunge Vernant: “In Eschilo si sente un orientamento morale e sociale differente e,
parallelamente, la possibilità di integrare meglio il lavoro all’umano: certi tratti nel quadro
dell’uomo rivelano l’importanza accordata al tecnico”17. Resta, però, rimarchevole la
difficile modalità di accesso del tecnico al valore morale. Le stesse conseguenze cui la
15
J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi, 1978, Torino
ESCHILO, Prometeo incatenato, vv. 447-453, trad. di Monica Centanni, Mondadori, 2007, Milano
17
J. P. VERNANT, Mito e pensiero presso i Greci, Einaudi, 1978, Torino
16
10
tragedia approda mostrano una condanna del padre di tutte le tecniche piuttosto che una
sua glorificazione. Sulla complessa interpretazione del mito di Prometeo già si è discusso
in apertura di capitolo: resta da discutere, però, un aspetto direttamente generato dal
contrasto tra la funzione tecnica e il valore morale. Dalla tragedia, infatti, emergono due
atteggiamenti conoscitivi del mondo: il primo si basa sulla σοφία, ossia sulla saggezza che
si fonda a sua volta sui due principi della morale delfico-solonica del nulla di troppo e del
conosci te stesso; il secondo invece è rappresentato dal σοφίσμα, che è piuttosto lo
stratagemma e che ha come suo mezzo le τέχναι. “Il termine σοφός è usato in tutta la
tragedia in relazione a colui che si rende conto della situazione e conseguentemente si
comporta con moderazione e assennatezza. Dal momento che il termine era impegnato in
questo senso, esso non poteva essere usato per Prometeo. E nemmeno il termine σοφία
viene usato in riferimento a Prometeo. Invece della coppia σοφός /σοφία per Prometeo
viene usata la coppia σοφιστής /σόφισμα (…). Nemmeno in relazione alle arti che sono
state date agli uomini Prometeo viene chiamato da Eschilo σοφός o a lui viene
riconosciuta la σοφία. Le invenzioni sono dette al v. 459 σόφισματα (…). È interessante
anche il fatto che Hermes equipari Prometeo al puledro che da poco è stato aggiogato e
che mordendo il freno cerca di far forza e combatte contro le briglie. L’immagine, è facile
rendersene conto, ha un chiaro contenuto ideologico (…). In conclusione, dunque, mentre
il Coro si pone su una linea che è quella del riconoscimento della necessità e della σοφία,
in quanto comportamento assennato, Prometeo invece si colloca su una linea che si
contrappone a questa e si caratterizza per una sapienza di tipo pratico-conoscitivo”.18
Da una parte abbiamo Prometeo e il genere umano tutto, dall’altra il principio regolatore
del cosmo; da una parte si trova il σόφισμα, un sapere tutto polarizzato sull’oggetto, sul
mezzo, un sapere pratico-conoscitivo formale, esteriore. Dall’altra c’è la σοφία che è la
saggezza della vita, o meglio l’arte di saper vivere intesa nella sua profondità eticospirituale. La σοφία è il riconoscimento dell’ordine universale del mondo e l’unica strada
per vivere con esso in armonia. Tale strada, a sua volta, prevede due diramazioni
complementari: una norma di esplorazione della coscienza che apra gli orizzonti
dell’interiorità (conosci te stesso) e una norma di regolazione della coscienza e della vita
che pratichi la rigorosa via di mezzo, l’unica via che, se non ripara del tutto, almeno
attutisce le sferzate della Τύχη (nulla di troppo).
Così, anche, Prometeo dovrà piegarsi al “giogo di necessità”19 e “convertirsi” all’esercizio
della σοφία, riconoscendo al v. 514, come si è accennato in precedenza, l‘inferiorità della
18
19
V. DI BENEDETTO, Ideologia del potere e tragedia greca, Einaudi, 1978, Torino.
ESCHILO, Agamennone, v. 218, trad. di M. Centenni, , Mondadori, 2007, Milano.
11
“sua” tecnica rispetto alla forza coercitiva della necessità e il Coro puntualizzerà:”Saggio è
chi si inchina di fronte all’Inevitabile”20.
Con ciò si è voluto evidenziare che l’introduzione della tecnica nella vita dell’individuo ha
aperto una nuova dimensione al pensiero occidentale: essa pone nuove problematiche
che confluiscono in complesse implicazioni sociali, psicologiche e che coinvolgono l’uomo
fin nella sua più intima essenza, lo coinvolgono ontologicamente poiché intervenire,
tramite la tecnica, sulla realtà significa trasferire qualcosa di sé in ciò che è altro da sé,
stabilire un nesso profondo verso la dimensione dell’oggetto. Si è voluto evidenziare come
la rosa di nuove problematiche fosse stata colta già dalla sensibilità intellettuale del popolo
ellenico per quanto essa non avesse ancora avuto modo di manifestarsi come questione
dell’essere quanto, piuttosto, come questione morale.
La questione della tecnica: prospettive filosofiche e scorci artisticoletterari.
In senso stretto la “questione della tecnica” si affaccia alla soglia del pensiero occidentale
soltanto in quella congiuntura sociale politica e culturale, a cavallo tra la fine del
diciannovesimo secolo e gli inizi del ventesimo, che, per le inquietudini che la
percorrevano e che in qualche modo anticipavano il drammatico quanto inarrestabile
volgere degli eventi, fu definita da Auden age of anxiety. Nella società di produzione di
massa che portava con sé il lascito del pensiero positivistico e che si apriva alle nuove
prospettive del capitalismo organizzato, l’individuo che smarrisce se stesso e il senso della
sua esistenza nella potenza livellatrice e omologante della massa, l’individuo che perde la
propria identità ripiegandosi sulla tecnica, indispensabile strumento del modello
economico, quasi confondendo il proprio corpo con le braccia delle macchine, e infine
l’individuo che perde la propria umana dignità riducendosi a puro mezzo in un razionale
sistema di produzione furono solo alcune delle problematiche sollevate da una vera e
propria reazione all’ottimismo tecnico scientifico del Positivismo.
Se da una parte si trovavano i profeti della decadenza dell’Occidente che, come Spengler,
annunciavano l’imminente morte della cultura occidentale ormai “civilizzata”, dall’altra si
trovava chi come Husserl imputava il trionfo della dimensione tecnica a un tradimento
delle funzioni della Ragione, ossia alla rinuncia alla dimensione puramente speculativa. Il
mondo dominato dalla macchina è, secondo questa interpretazione, un mondo
senz’anima, livellatore, mortificante: un mondo nel quale la quantità ha preso il posto della
qualità e in cui il culto dei valori dello spirito è stato sostituito dal culto di valori strumentali
e
utilitari.
Le
principali
conseguenze
della
“questione
della
tecnica”
sono:
l’assoggettamento del lavoro umano alle esigenze dell’automazione, che tende a fare
20
ESCHILO, Prometeo incatenato, v. 936, trad. di Monica Centanni, Mondadori, 2007, Milano.
12
dell’uomo un accessorio della macchina; e l’incapacità della tecnica di venire incontro ai
bisogni estetici, affettivi e morali dell’uomo; quindi la sua tendenza a favorire o a
determinare l’isolamento dei singoli individui e la loro reciproca incomunicabilità21.
Il Positivismo, si è detto, aveva fatto della scienza la guida assoluta della condotta
intellettuale umana in ogni aspetto e dimensione della conoscenza, della morale,
dell’estetica e della religione. Il metodo sperimentale scientifico risultava applicabile tanto
alle scienze cosiddette naturali, quanto alle nuove discipline scientifiche che si
proponevano lo studio e l’esplorazione della condotta e della psiche degli individui
(psicologia), o del loro comportamento nelle comunità organizzate (sociologia). Il mondo
della cultura e dell’arte, almeno nella seconda metà dell’Ottocento, non stentò a
manifestare il suo vivo interesse, se non un certo entusiasmo, per la nuova temperie
culturale. Il desiderio di sondare scientificamente le possibilità minime, quasi particellari,
dei mezzi e delle tecniche artistiche o letterarie e la volontà, erede della poetica della
realtà del Romanticismo, di rappresentare il reale così come esso appare, senza alcuna
finalità accessoria o interpretazione di fondo, sia essa morale, politica o sociale, portò ad
esperienze quali quella del Realismo, soprattutto nell’ambito delle arti figurative, del
Naturalismo francese in campo letterario e del Verismo in Italia (per quanto non si possa
stabilire una netta scansione cronologica tra una corrente e l’altra). L’interesse per il vero
secondo parametri di oggettività, impersonalità e scientificità procedeva parallelamente ai
nuovi e sempre più precisi strumenti del progresso tecnologico. La fotografia, in
particolare, segnò una vera e propria cesura nel destino delle arti: da una parte esautorò
la pittura del compito di riprodurre mimeticamente il reale, aprendole la via alla volta di
nuove sperimentazioni, dall’altra stimolò ulteriormente artisti e letterati a concentrarsi i
primi sullo studio delle forme, delle luci e della materia (penso in modo particolare al
pointillisme di Seurat), i secondi a tratteggiare sulla pagina del romanzo una realtà nitida e
asettica quale quella della fotografia.
Significativo è il giudizio programmatico di una nuova letteratura, quella naturalista, che
Émile Zola espresse ne Il romanzo sperimentale:
Quando avremo provato che il corpo dell’uomo è una macchina di cui un giorno si
potranno smontare e rimontare gli ingranaggi a piacimento dello sperimentatore, si dovrà
ben passare alle manifestazioni passionali ed intellettuali dell’uomo. Da quel momento
entreremo in quel dominio che, apparteneva alla filosofia e alla letteratura; sarà la
conquista decisiva da parte della scienza, delle ipotesi dei filosofi e degli scrittori. Vi sono
21
N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, p. 1070, terza edizione aggiornata e a ampliata da Giovanni Fornero,
UTET, 1998, Torino.
13
la fisica e la chimica sperimentali; vi sarà la fisiologia sperimentale e, più tardi ancora, si
avrà il romanzo sperimentale.22
Quale è il compito dello scienziato, tale è il compito dello scrittore che, con lo stesso
metodo scientifico adottato dal chimico o dal biologo, procede all’indagine dei moti dello
spirito, all’analisi anatomica del sentimento e della passione nelle forme del romanzo
sperimentale. Ma la considerazione di Zola sottende la ricerca di un meccanismo di
conquista delle manifestazioni intellettuali e dei fenomeni umani che va ben al di là della
semplice sfera letteraria. Essa implica che l’uomo e la mente umana possano essere fatti
oggetto di studio in modo non dissimile dalle macchine con i loro ingranaggi. Ma, a sua
volta, la posta equazione uomo = macchina giustifica l’intercambiabilità dei due termini e
ne consente l’identificazione. Ora, identificare l’uomo con la macchina significa portare il
fine a coincidere con il mezzo, cioè significa rovesciare la seconda formulazione
dell’imperativo categorico kantiano.
Una risposta contraria al Positivismo si può leggere nella cultura del Decadentismo che,
con la sua attenzione per una realtà in disfacimento e per le civiltà in declino, vede nella
rincorsa al progresso scientifico- tecnologico soltanto gli ultimi spasimi di un corpo in
agonia. Al di là delle manifestazioni più à rebour della cultura decadente, quali il
simbolismo di Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmè o l’estetismo di Wilde e di
D’Annunzio, il Decadentismo è caratterizzato da una più generica cultura della crisi che
include, in ambito filosofico, il risveglio di prospettive irrazionalistiche e spiritualistiche.
Così, da una parte si avrà la riscoperta degli impulsi assoluti che guidano le azioni degli
uomini (dalla Wille zur Macht di Nietzsche,
all’esplorazione dell’inconscio da parte di
Freud), dall’altra la rivalutazione della dimensione interiore-spirituale e quindi delle
proprietà non misurabili o quantificabili dell’animo umano. Particolarmente significativo
risulta in tal senso il contributo della filosofia di Henri Bergson. Egli, nell’Introduzione alla
metafisica, distingue due tipologie essenziali di conoscenza, quella relativa e quella
assoluta. Se la prima procede scomponendo l’oggetto in parti analitiche prescindendo
dall’unità dell’intuizione e spiega le singole parti mediante le singole immagini, la seconda
avviene mediante uno sforzo d’intuizione grazie al quale la realtà propria e interna di un
oggetto è subito presente alla coscienza. La prima è propria dell’analisi scientifica che
considera le espressioni parziali e non le parti componenti dell’io, operando sull’immobilità,
ossia astraendo punti del movimento, che in realtà non esistono se non come oggetti dei
nostri concetti poiché sono parti di durata svincolati da essa per fini pratici, cioè per
l’azione. Se, infatti, ci si ripropone di ricostruire l’unità partendo dai singoli punti non si
riesce a risalire al movimento: analizzare secondo questi parametri la realtà significa
leggere praticamente la qualità sulla base della categoria dell’immobilità ed è come se la
22
ÈMILE ZOLA, Il romanzo sperimentale, trad. dal francese di I. Zaffagnini, Pratiche Editrice, Parma, 1992.
14
nostra intelligenza prendesse “da lontano delle vedute quasi istantanee sulla mobilità
indivisa del reale”23. La seconda, invece, è propria della metafisica, la quale procede
tramite l’intuizione che, a sua volta, permette di cogliere la durata, ossia la nostra persona,
il nostro io, che dura e che è sintesi di molteplicità e unità. L’intuizione, pertanto, ci
inserisce nella mobilità della durata e la metafisica diventa “una matematica delle qualità”
in quanto trascende i simboli facendosi esperienza integrale.
I tratti della filosofia di Bergson qui brevemente sintetizzati consentono almeno in parte di
mettere in luce la nota distinzione tra tempo esteriore, astratto e cronologico, e tempo
interiore, concreto, indiviso ed eterno. Essa sta alla base di una più radicale distinzione tra
la dimensione interiore del soggetto e quella esteriore del mondo oggettivo e soprattutto di
una distinzione tra quelle che Dilthey chiamerà scienze dello spirito e scienze naturali,
dimostrando come non sia pensabile applicare uno stesso metodo di studio analiticosperimentale tanto alle scienze esatte quanto alle scienze umane. Tra i due saperi, infatti,
intercorre una distinzione sostanziale tra studio, per così dire, della struttura e studio del
senso interno; e, di conseguenza, anche una distinzione delle strategie conoscitive. Se le
scienze tradizionali ricorrono, secondo Bergson, allo strumento dell’analisi, le “scienze
dello spirito” e la filosofia nello specifico fanno ricorso all’intuizione immediata dell’essenza
di una cosa.
Chiamiamo qui intuizione quella simpatia mediante la quale ci si inserisce nell’interiorità di
un oggetto per coincidere con ciò che c’è in esso di unico e quindi di inesprimibile24
Questo è il contesto filosofico in cui matura la stessa evoluzione degli studi scientifici e in
particolar modo fisici se si pensa alla elaborazione della teoria della relatività da parte di
Albert Einstein destinata a rivoluzionare epistemologicamente la fisica classica. E il
relativismo accanto all’irrazionalismo e allo spiritualismo si colloca come nuova prospettiva
di riflessione. Luigi Pirandello, che particolarmente sensibile era stato nei confronti della
multistratificazione dei punti di vista nella definizione della personalità in Uno, nessuno,
centomila e che già ne L’esclusa accenna alla teorizzazione di una possibile “etica
relativa”, non mancò di notare il dramma dell’individuo alienato, o meglio, identificato con
la dimensione tecnica. L’universo dei piani intrecciati, dei paradossi e dei rovesciamenti
situazionali di Pirandello partorisce un personaggio di sconcertante potenza tragica.
Serafino Gubbio, operatore, è una di quelle figure minime che, come Zeno o Emilio
Brentani di Svevo, incarnano, in una dimensione parcellizzata, l’uomo di inizio ventesimo
secolo. Il suo humus sociale è quella compagine grigia e uniforme che quasi ha perso
memoria della sua origine ottocentesca, quando ancora aveva un senso chiamarla ceto
medio. Con l’arrivo prorompente del proletariato, infatti, il mondo della borghesia
23
24
HENRI BERGSON, Introduzione alla metafisica, trad. di Armando Veraldi, Sansoni, Firenze 1949.
Ibi.
15
benpensante si è come ritratto inorridito nel suo guscio d’alte sfere lasciando dietro di sé
una scia di scorie, di piccoli reietti anonimi e spaesati, un mondo di impiegati e di piccoli
funzionari di provincia. Serafino Gubbio è uno di costoro, vanta un’ istruzione classica alle
spalle ed è operatore per una casa cinematografica e, poi, la cosa più importante, è una
mano che gira una manovella.
Un signore, venuto a curiosare, una volta mi domandò: - Scusi non si è trovato ancor
modo di far girare la macchinetta da sé?- Vedo ancora la faccia di questo signore: gracile,
pallida, con radi capelli biondi; occhi cilestri, arguti; barbetta a punta, gialliccia, sotto la
quale si nascondeva un sorrisetto, che voleva parer timido e cortese ma era malizioso.
Perché con quella domanda voleva dirmi: “Siete proprio necessario voi? Che cosa siete
voi? Una mano che gira la manovella. Non si potrebbe fare a meno di questa mano? Non
potreste essere soppresso, sostituito da un qualche meccanismo?”. Sorrisi e risposi: Forse col tempo, signore. A dir vero, la qualità precipua che si richiede in uno che faccia la
mia professione è l’impassibilità di fronte all’azione che si svolge davanti alla macchina.
Un meccanismo, per questo riguardo, sarebbe senza dubbio più adatto e da preferire a un
uomo. Ma la difficoltà più grave, per ora, è questa: trovare un meccanismo, che possa
regolare il movimento secondo l’azione che si svolge davanti alla macchina. Giacchè io,
caro signore, non giro sempre allo stesso modo la manovella, ma ora più presto ora più
piano, secondo il bisogno. Non dubito però, che col tempo – sissignore – si arriverà a
sopprimermi. La macchinetta- anche questa macchinetta, come tante altre macchinettegirerà da sé. Ma che cosa poi farà l’uomo quando tutte le macchinette gireranno da sé,
questo, caro signore, resta ancora da vedere.
Attraverso le annotazioni e le riflessioni del protagonista si assiste ad un tempo alla sua
metamorfosi e alla dolorosa presa di coscienza di tale trasformazione.la metamorfosi è il
perfetto adeguamento alla parte che gli è stata assegnata: egli è sì Serafino Gubbio, ma è
Serafino Gubbio operatore. La maschera sociale assume sostanzialità complementare
rispetto all’individualità del protagonista. Ancora un volta, in Pirandello, si consuma il
“gioco delle parti”, ma questa volta si aggiunge una nota di ulteriore e più profonda
tragicità: la meccanizzazione del protagonista. L’attività di Serafino Gubbio consiste nel
riprendere le scene del cinematografo girando la manovella della macchina da presa. Egli
è dunque un operatore che gira la manovella; ma questo girare, questa azione reiterata un
numero incalcolabile di volte non è forse il solo vero nesso che collega Serafino Gubbio
alla società in cui vive? Egli è necessario, certo, ma solo per quel piccolo dettaglio. Mi
spiego meglio: se non fosse per la sua mano che gira meccanicamente, Serafino Gubbio
sarebbe socialmente improduttivo e cioè inutile, sarebbe solo un’ombra; a nessuno
importerebbe di Serafino Gubbio perché per la società della tecnica tutto assume un parasenso solo in vista della funzionalità
e dell’effetto. Il destino del povero operatore è
16
dunque o quello di non esistere o quello di svolgere mitemente la propria mansione
secondo il parametro che meglio si addice a una mano che gira una manovella: l’assoluta
impassibilità. Infelice destino quello di Serafino Gubbio: morire per vivere da uomo o
vivere per morire da macchina! Ciò che il mondo chiede all’operatore è di svuotarsi
completamente di ogni umanità: non importa riflettere, non conta pensare, né ricordare, né
amare, né commuoversi e in generale sentire qualcosa dentro di sé. L’anima, quel quid
inafferrabile, che è come una presenza dell’uomo a se stesso, può spegnersi, la poesia
può tacere e la musica del mondo con lei. Il senso di tutto è girare una manovella. Quanto
più è simile a una macchina, tanto meglio Serafino Gubbio compie il suo lavoro, tanto più
sarà apprezzato e lodato, o forse neppure questo perché ciò che fanno le macchine lo si
dà per scontato, passa sotto silenzio:
Cominciava ad avvertire che la mia persona non era necessaria; ma che la mia presenza
lì aveva la necessità d’una cosa, ch’ella ancora non comprendeva; e che stavo così muto
per questo.
E quando il sentimento si risveglia, perché sollecitato da un ricordo lontano sfumato nel
tempo come la casa di nonna Rosa, o una riflessione con un amico come Simone Pau, o il
sentimento indefinito e non ricambiato della signorina Luisetta, ecco che l’anima si
risveglia e trovandosi ingabbiata nella scorza d’una cosa, si irrigidisce nella percezione del
silenzio e del nulla. Ma verrà il giorno in cui anche l’impassibile efficienza di Serafino
Gubbio risulterà superflua perché la sua mano potrà essere sostituita dall’opera
infaticabile di un’autentica macchina.
Il turbine travolgente della tecnica non imbriglia Gubbio solo, ma anche tutti gli altri
personaggi che, secondo la tradizione pirandelliana, si alienano in un’ossessione, una
parvenza di realtà qualsiasi: il signor Cavalena, marito succube della pazzia della moglie,
che si appiglia al suo status di medico per giustificarsi della perduta dignità, la signorina
Luisetta che si identifica in un amore non suo per un uomo che non la considera, Carlo
Ferro e Aldo Nuti, uomini dalla differente personalità, che esauriscono le proprie energie in
una passione cieca per una donna dalla bellezza medusea, l’attrice Nestoroff. Ma tutti non
sono altro che comparse su una pellicola, artifici di una macchina, di quella stessa
macchina che Gubbio aziona e che riprende il mondo divorandolo come le fauci di
un’orrenda Cariddi. La macchina da presa è tutto, è il prima e il dopo, è l’essere e il non
essre, perché sulla pellicola la vita si imprime indelebile e sempre uguale a se stessa,
senza scampo. Resta ancora la tigre, simbolo di una natura inquieta e selvaggia, sfregiata
e oltraggiata dalla tracotanza dell’uomo, la tigre che appena viene immessa sulla scena
divora l’attore Aldo Nuti –uno per tutta l’umanità- così come la Natura con il suo vecchio
leone sbrana l’Islandese nella ben nota operetta morale di Leopardi. Eppure questa volta
non è la Natura a imporre il suo silenzio, ma la Macchina che tutto riprende con il suo
17
ronzio, anche la scena di morte, perché la mano continua impassibile a girare. La
Macchina, creatura mostruosa spesso paragonata a un grosso ragno nero, ha in sé la vita
e la morte, mentre la metamorfosi del povero operatore si completa: egli non trova la forza
di intervenire di fronte alla scena cruenta, in parte perché paralizzato dal terrore, in parte
perché la manovella deve comunque sempre girare. Ma Serafino Gubbio operatore,
traumatizzato dal fatto, perderà la voce:
Girare ho girato. Ho mantenuto la parola: fino all’ultimo. Ma la vendetta che ho voluto
compiere dell’obbligo che m’è fatto, come servitore d’una macchina, di dare in pasto a
questa macchina la vita, sul più bello la vita ha voluto ritorcerla contro di me. Sta bene.
Nessuno intanto potrà negare ch’io non abbia ora raggiunto la mia perfezione. Come
operatore io sono ora veramente perfetto.
Ho avuto modo di citare in questa breve analisi del romanzo pirandelliano il poeta di
Recanati. Credo sia curioso e quanto mai significativo che già nel suo tempo Giacomo
Leopardi presentisse l’enorme carica problematica dello sviluppo tecnico e meccanico in
relazione ai condizionamenti e ai mutamenti della forma mentis individuale e collettiva. In
un’operetta morale, forse meno nota rispetto agli illustri titoli riportati nelle antologie
scolastiche, Leopardi dimostra quella eccezionale sensibilità, propria degli spiriti eletti, di
cogliere i dati presenti allorché accadono e di antivederne, non per profetica dote, ma per
altezza d’ingegno, gli effetti futuri. Così nella Proposta di premi fatta dall’Accademia dei
Sillografi25, con quella nota ironico- sardonica che percorre tutte le Operette e che già si
può evincere dal titolo26, l’autore riconosce che il tempo in cui vive potrebbe anche essere
chiamato “l’età delle macchine…non solo perché gli uomini di oggidì procedono e vivono
forse più meccanicamente di tutti i passati, ma eziandio per rispetto al grandissimo
numero delle macchine inventate di fresco ed accomodate o che si vanno tutto giorno
trovando ed accomodando a tanti e così vari esercizi, che oramai non gli uomini ma le
macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita.” Dopo aver
affermato la sostituibilità dell’uomo con la macchina, egli passa a enumerare i principali
vantaggi, o presunti tali, che dovrebbero derivare da tale sostituzione; in primis la
possibilità di intervenire non solo sulla vita materiale dell’uomo ma anche su quella
spirituale onde portare l’umanità intera al compimento tanto agognato della sua
perfezione, curando i pregi e sopprimendo i difetti del genere umano.
L’una si è che ella confida dovere in successo di tempo gli uffici e gli usi delle macchine
venire a comprendere oltre le cose materiali, anche le spirituali; onde nella guisa che per
virtù di esse macchine siamo già liberi e sicuri dalle offese dei fulmini e delle grandini, e da
25
L’operetta fu composta a Recanati tra il 22 e il 25 febbraio 1824 e fu pubblicata per la prima volta nell’edizione
Stella, Milano, 1827.
26
I Sillografi sono propriamente gli scrittori di Silloi, componimenti che nell’antica Grecia avevano carattere burlesco e
satirico.
18
molti simili mali e spaventi si abbiano a ritrovare per modo di esempio…qualche
parainvidia, qualche paracalunnie o paraperfidia o parafrodi, qualche filo di salute o altro
ingegno che ci scampi dall’egoismo, dal predominio della mediocrità, dalla prospera
fortuna degli insensati, de’ ribaldi e de’ vili,…L’altra cagione e la principale si è che
disperando la miglior parte dei filosofi di potersi mai curare i difetti del genere umano, i
quali, come si crede, sono assai maggiori e in più numero delle virtù; e tenendosi per certo
che sia piuttosto possibile di rifarlo del tutto in una nuova stampa, o di sostituire in suo
luogo un altro che di emendarlo;”
L’età della Tecnica: lo smarrimento del senso.
L’uomo pre- tecnologico agiva in vista di scopi iscritti in un orizzonte di senso, ossia le sue
azioni non si esaurivano in sé ma tendevano ad un oltre, ad un fine, sia esso trascendente
o immanente, che in ogni caso trascendeva l’azione per proiettarla in una sfera ordinata di
significati che contribuivano a costruire e ad arricchire nella totalità l’individuo e la sua
concezione del mondo. Faro di questo atteggiamento culturale pre- tecnologico è la
cultura umanistica che dai suoi albori rinascimentali ha effuso sulla storia del mondo la
luce del libero e autonomo esercizio del pensiero nel rispetto e nel compimento della
dignità della persona umana. Centro di tale concezione è l’uomo nella sua vita esteriore e
soprattutto nella sua vita interiore: è il percorso dell’uomo alla conoscenza di sé, non in
senso esistenzialistico, ma metastorico, in qualità di idea assoluta di Uomo, dove cioè ogni
mezzo resta uno strumento esteriore per approfondire la portata spirituale dei fini,
incondizionati ed altri rispetto ai mezzi, e per attribuire all’azione un senso che accresca
ulteriormente la comprensione che l’uomo ha del mondo. Se il fine è il senso delle cose e
del mondo, e se il senso è la loro comprensione da parte dell’uomo, allora il fine dei fini è
la comprensione che l’uomo ha di sé. Di conseguenza emerge chiaramente che l’uomo, in
funzione della portata profondamente spirituale della sua esistenza, non può esaurirsi,
nell’ottica umanistica, all’area esteriore dei mezzi: cioè il senso che l’uomo ha della vita è
in quello che l’uomo fa ma non è quello che l’uomo fa.
Ora, la tecnica, intesa come universo dei mezzi cioè tecnologie, ma anche come
razionalità che presiede al loro impiego in termini di funzionalità ed efficienza, almeno per
lo sviluppo che essa ha attraversato in età post-positivistica, è arrivata a oscurare questo
scenario umanistico. La tecnica, infatti, di per sé, non promuove un senso in quanto
appartiene allo scenario dei mezzi, cioè degli strumenti funzionali all’approfondimento
della comprensione del senso. Tuttavia, oggi, il mezzo tecnico si è così ingigantito in
termini di potenza ed estensione da determinare un sostanziale capovolgimento della
quantità in qualità, da diventare indispensabile al punto che l’uomo non può farne a meno
per esprimersi. In verità la dipendenza problematica dell’uomo da ogni sorta di tecnica da
lui partorita nel corso della storia è già stata analizzata sotto il profilo antropologico nel
19
primo capitolo di questa trattazione; un conto però è riconoscere la dipendenza positiva
dalla tecnica, cioè il carattere necessario del mezzo per il benessere dell’uomo stesso, e
un altro conto è portare questa dipendenza alle forme dell’identificazione, cioè tradurre il
mezzo in fine e la tecnica in essenza dell’uomo. Se la tecnica, ovvero il mezzo, diventa il
fine, esso si connota di quei tratti che sono propri del mezzo, cioè la sostanziale
assolutezza da ogni produzione di senso che non ricada in sé. Perciò, “chi aziona
l’apparato tecnico o vi è semplicemente inserito, senza poter più distinguere se è attivo o
se è a sua volta azionato, non si domanda se lo scopo, per cui l’apparato tecnico è messo
in azione sia giustificabile o abbia semplicemente un senso, perché questo significherebbe
dubitare
della tecnica senza di cui nessun senso e nessuno scopo sarebbero
raggiungibili, e allora la responsabilità viene affidata al responso tecnico, dove è sotteso
l’imperativo che si deve fare tutto ciò che si può fare”27.
Là dove la vita è per intero generata e resa possibile dall’apparato tecnico, l’uomo diventa
un funzionario di detto apparato e la sua identità viene per intero risolta nella sua
funzionalità, per cui è possibile dire che nell’età della tecnica l’uomo è presso di sé solo in
quanto è funzionale a quell’altro da sé che è la tecnica. Pertanto, non si parla più in
termini di alienazione dell’individuo, come ebbero a fare Feuerbach e Marx mutuando
l’espressione da Hegel, ma di identificazione tra individuo e apparato tecnico: non si tratta
soltanto di un’inversione dei rapporti di predicazione per cui l’uomo, da soggetto, diviene
predicato dell’apparato tecnico, e la tecnica, da predicato, diventa soggetto, ma l’uomo
stesso diventa strumento tecnico, cioè è valutato secondo il para-senso della funzionalità.
Se la concezione umanistica aveva visto nell’uomo il soggetto della storia, stante
l’identificazione tra essenza dell’uomo e tecnica, la tecnica stessa diventa soggetto della
storia che si avvia alla volta di una nuova età. Questo implica una ridefinizione di tutti i
modi tradizionali di intendere la ragione, la natura, la verità, l’etica, la politica, la religione e
l’antropologia. Sotto quest’ultimo aspetto appare con chiarezza come i concetti di uomo,
persona e individuo soprattutto, perdano il significato che la tradizione filosofica
occidentale ha da sempre loro attribuito. Essi infatti sono intrinsecamente legati alla
dimensione spirituale dell’uomo: egli arriva a comprendere la propria umana dignità in
quanto si percepisce intimamente come unico e insostituibile. Se questa posizione è stata
approfondita, soprattutto nel suo carattere angoscioso e disperante, dalla filosofia
esistenzialistica in risposta a quei modelli razionalistici che, eredi diretti delle pretese
assolutistiche del Romanticismo ottocentesco, avevano imbrigliato il pensiero e così
l’esistenza individuale in una tecnica del λόγος (è il caso del sistema hegeliano o dello
scientismo positivistico), la nascita della categoria di individuo è da rintracciare nel
pensiero religioso. Per il Cristianesimo in particolare l’individuo è tale in quanto detentore
27
U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Introduzione, pp. 40-41, Feltrinelli, Milano, 2000.
20
di anima, cioè la sua essenza non è mai pienamente legata al mondo che lo circonda in
relazioni intramondane, ma tende infinitamente ad una realizzazione ultramondana.
La società individualistica di matrice cristiana, dopo essere passata attraverso quella che
Galimberti chiama epoca critica, cioè attraverso la rivendicazione della libertà,
dell’uguaglianza degli individui e dell’autonomia della loro ragione, sarebbe approdata ad
un’epoca organica in cui le leggi, che regolano i rapporti interpersonali, sono legate
all’ordine economico e quindi sempre più alla subordinazione dell’uomo alla sua funzione.
Il passo per giungere al materialismo storico e al concetto marxiano di alienazione è
breve: al di là della quadruplice alienazione del lavoratore rispetto alla macchina, rispetto
al proprio lavoro, rispetto al prodotto e rispetto al capitalista, l’individuo è ridotto a
personificazione dei suoi interessi economici. Scrive Galimberti: “Quando la razionalità,
prima economica e poi tecnica, abolisce quella distanza sempre intercorsa tra cultura e
produzione che consentiva all’individuo spazi espressivi socialmente significanti proprio
perché non immediatamente produttivi, all’individuo non resta che l’omologazione alla
razionalità che fa dell’apparato una semplice risposta funzionale alle sue esigenze. Con
ciò non si vuol dire che l’apparato sopprima la libertà degli individui, ma solo che
appiattisce il concetto di libertà su quello di competenza, il quale garantisce agli individui
unicamente la capacità di muoversi nei circuiti funzionali dell’apparato, più interessato ai
meccanismi di pianificazione, organizzazione
e centralizzazione che alle sorti
dell’individuo”.28 Il passaggio dalla società dominata dalle leggi economiche a quella
regolata dal primato della tecnica è rappresentato dall’assunzione di un carattere
universale dell’alienazione: essa non riguarda più solo alcuni gruppo sociali quali forze di
produzione, dal momento che, nella società della tecnica, nessuno può darsi se non come
forza di produzione, ossia è valutato ed esiste solo in nome della propria funzionalità e
competenza tecnica. La categoria di individuo viene sostituita da quella di funzionario
nello stesso modo in cui la categoria di fine viene sostituita da quella di mezzo: l’azione
non tende più a un orizzonte di senso perché diviene automatica operazione volta a
potenziare ulteriormente le possibilità del mezzo. Il risultato è l’appiattimento, è
l’identificazione dell’uomo, del soggetto nell’oggetto: questa operazione non è una
semplice oggettivazione. Essa infatti implicherebbe la permanenza del soggetto in qualche
forma in relazione alla quale sarebbe sensato parlare di oggetto: non c’è oggetto senza un
soggetto che lo pensi come tale e non c’è soggetto senza un oggetto che lo faccia sentire
tale. L’identificazione dei due porta allo smarrimento del senso di entrambi: il risultato è
una nuova realtà, fine a se stessa, dove regna la funzionalità del mezzo e dove non si può
più parlare di unicità o di insostituibilità poichè ogni parte dell’apparato tecnico può essere
indiscriminatamente sostituita e moltiplicata. L’uomo non resta altro che un organo
28
U. GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica. Antropologia della tecnica. P. 543, Feltrinelli,
Milano, 2000
21
dell’apparato, a sua volta composto da altri organi dell’apparato tecnico. È l’età della
tecnica.
La funzionalità diventa categoria dell’essere, dell’etica, ma anche del pensiero. È con
questa declinazione di significato che Galimberti parla di pensiero funzionale, ossia di un
ordine logico di strutture di pensiero che prescindono dal significato dell’apparato tecnico
per dare giustificazione alla realtà tecnica.
Dal formalismo al Gestell.
Il formalismo hilbertiano si presenta come una risposta interessante non solo nell’ambito
della crisi dei fondamenti della matematica, inaugurato all’alba del ventesimo secolo da
Russell, ma per la stessa temperie culturale in cui è maturata. Sono, infatti, gli anni del
Circolo di Vienna che per eccellenza rappresentò le nuove tendenze neopositiviste, le
quali, con le dovute distinzioni rispetto al Positivismo ottocentesco, mostravano crescente
interesse per la fondazione delle scienze e per i controversi rapporti tra logica ed
esperienza. Ma soprattutto sono anni in cui la corsa al progresso e, quindi, al
potenziamento dell’apparato tecnico–industriale, di cui si è detto ampiamente in
precedenza, andava assumendo proporzioni sempre crescenti. Almeno apparentemente
lontana da “questioni della tecnica”, la risposta di Hilbert alla crisi dei fondamenti della
matematica non può non richiamare, seppur indirettamente, quell’insidiosa operazione di
affermazione di una logica utilitaristica della funzionalità e il conseguente tramonto dei
significati che, come si è detto, caratterizza l’età della tecnica.
La preoccupazione di Hilbert è, in prima istanza, quella di assicurare, tramite
l’elaborazione di teorie formali, la fondatezza della matematica risolvendo i problemi
causati dall’introduzione del concetto di infinito nell’ambito della teoria degli insiemi. Ossia
si propone di giustificare l’applicazione della matematica infinitaria, fondata su concetti
ideali e perciò astratti e indefiniti, tramite la matematica finitaria, i cui soli contenuti hanno
un significato in quanto derivanti, per mutuare l’espressione kantiana, da un’intuizione
sensibile pura (essa tratta e manipola oggetti finiti e simboli). Più precisamente Hilbert si
propone di elaborare una teoria che consenta di formalizzare la matematica infinitaria
senza dover ricorrere all’intuizione e allo sforzo di comprensione dei suoi enunciati astratti.
Sostanzialmente è come se si riducesse la matematica ad un gioco formale che non
indaga sul significato dei suoi oggetti, anzi, il formalismo “nega che la matematica sia
conoscenza di qualche realtà, e la considera più vicina ad un’attività puramente deduttiva
e ludica”29 al pari del gioco degli scacchi dove la regola e le combinazioni delle regole, nel
quadro complessivo della partita, non solo definiscono il singolo pezzo, ma lo definiscono
in funzione esclusiva della regola, per cui esso di per sé non ha alcun significato. Ne
consegue che due sono i momenti fondamentali del sistema formale, quello della
29
GABRIELE LOLLI, Filosofia della matematica. Formalismo. Il Mulino. Bologna. 2002.
22
deduzione meccanica che consiste nella pura applicazione delle regole e quello della
costruzione del sistema stesso, ossia la scelta del linguaggio, delle regole e degli assiomi
che consentono il funzionamento del gioco. Gli unici principi che aprioristicamente devono
essere comunque rispettati sono quelli che Hilbert aveva già individuato per la costruzione
dei modelli, ovvero l’indipendenza, la completezza e la coerenza o non contraddittorietà30.
A loro volta queste caratteristiche non potranno essere dimostrate se non all’interno del
sistema formale e tramite le regole che sono state assunte internamente al sistema
(siccome non si può evidenziare uno scarto cronologico tra assunzione delle regole, loro
applicazione e loro fondazione sulla base di principi assiomatici, tali regole avrebbero
dunque la pretesa di auto-dimostrare la loro fondazione nella loro stessa operatività).
Tuttavia - e proprio per questo - il sistema formale resta conchiuso in se stesso, cioè non
dà di per sé ragione dell’applicabilità della matematica. ”I sistemi formali sono il modo di
presentare le teorie matematiche assiomatizzate quando si precisi il linguaggio e si
convenga di usare una logica ricorsivamente enumerabile, una logica cioè in cui le
conseguenze si ottengono iterando l’applicazione di alcune regole sintattiche”31. Attraverso
queste costruzioni formali, l’intento di Hilbert sarebbe appunto quello di dimostrare che
elementi ideali come il concetto di infinito possono essere liberamente applicati senza
necessitare di un’autonoma interpretazione, dal momento che non aggiungono nulla alle
verità dei domini finiti ed anzi sono giustificabili sulla base della logica classica già
applicata negli insiemi finiti. Nonostante il fallimento del progetto hilbertiano (cfr.30), il
formalismo ha continuato e continua ad essere una strada percorsa nell’ambito della
filosofia della matematica. Sua preoccupazione precipua resta tuttavia quella di liberare la
matematica da ogni assunzione metafisica, vale a dire da ogni forma di contenutismo. In
tal senso un formalista moderno come Haskell Curry “chiama formalismo ogni filosofia in
cui gli oggetti della matematica non sono specificati, o, se lo sono, la loro natura non è
rilevante
per la validità dei teoremi, sicchè questi siano invarianti rispetto alla loro
eventuale sostituzione.”32 Al centro di tutto il formalismo ortodosso si colloca dunque la
dimostrazione, mentre, venendo meno ogni interesse per il contenuto, decade anche ogni
interesse per il significato che si situa nella comprensione dell’oggetto nella totalità delle
strutture intrinseche alla sua natura, e che si manifesta nello studio della rete di relazioni
che il significato produce con altri significati.
Da quanto detto finora e soprattutto dall’impiego di espressioni e termini come “soggetto”,
“oggetto”, “essenza”, “totalità”, parrebbe scorgere in un pensare di tipo metafisico la
soluzione o almeno un contro- altare ad ogni pensiero di tipo tecnico o formalistico; non
può dunque mancare un riferimento a Heidegger che, paradossalmente rispetto a quanto
30
Gödel, con il secondo teorema di incompletezza, dimostrò che la non contraddittorietà di un sistema non può essere
dimostrata all’interno del sistema stesso.
31
GABRIELE LOLLI, Filosofia della matematica. Formalismo. Il Mulino. Bologna. 2002
32
GABRIELE LOLLI, Filosofia della matematica. Formalismo. Il Mulino. Bologna. 2002
23
detto, proprio nella metafisica tradizionale non solo ha scorto la prefigurazione della
tecnica, ma ha identificato la tecnica come la suprema realizzazione della metafisica. La
tecnica infatti è il grado più rilevante cui l’oblio dell’essere sia giunto, ossia è il trionfo più
eclatante del processo di “entizzazione” dell’essere. È opportuno precisare che Heidegger,
dopo la tanto discussa Kehre, orienta la sua riflessione, sempre polarizzata intorno alla
cruciale domanda dell’essere, nei confronti di una strutturale polemica con il modo
tradizionale di pensare metafisicamente. La metafisica nella storia del pensiero
occidentale, almeno dopo Platone, non si è più preoccupata di interrogarsi intorno
all’essere e quindi di chiarirne l’essenza, ma ha concentrato la sua attenzione sull’essenza
degli enti che dell’essere sono mero momento o manifestazione. Dunque per Heidegger,
la riproposizione della domanda dell’essere dal punto di vista non più dell’ente ma
dell’essere stesso richiede l’abbandono dell’ottica della metafisica tradizionale, il cui
stesso linguaggio si rivela insufficiente e inadeguato, per abbracciare un nuovo modo di
pensare l’essere post-metafisico. La tecnica, pertanto, in quanto realizzazione di quello
che per Heidegger è un nichilismo metafisico, rappresenta la completa riduzione
dell’essere a ente, il dominio dell’ente. Tuttavia, il suo modo di concepire la tecnica è più
problematico: essa per il suo carattere globale e per il coinvolgimento della totalità della
natura stessa nei suoi processi risulta, nella sua essenza, qualcosa di non tecnico, e
quindi non ontico, ma ontologico; essa, cioè, è nella sua essenza una forma di
disvelamento dell’essere, heideggerianamente inteso come Ereignis. La tecnica, infatti, se
all’epoca dei Greci riguardava la sfera del poiein, cioè del produrre, nell’età moderna si
configura come una pro-vocazione (Herausforden) che è in grado di trarre fuori dalla
natura energia che può essere accumulata e successivamente impiegata. L’elemento
naturale è visto come una fonte da sfruttare, anzi non è più visto in sé, ma è guardato alla
luce di un elemento di fondo, che è la riserva di energia. Così Heidegger fa l’esempio del
Reno che, interrotto dalla centrale idroelettrica, è incorporato nella costruzione stessa
della centrale. La provocazione è l’impossessamento da parte della tecnica di quelle
condizioni naturali che precedentemente consentivano la produzione. Per designare postmetafisicamente la tecnica, Heidegger usa il termine Gestell, che significa letteralmente
impianto o im-posizione, e che tradurrebbe la totalità dell’imporre tecnico nella riduzione
della realtà a fondo. Con queste caratteristiche, il Gestell, come evento dell’essere, non è
affatto un mezzo dell’attività dell’uomo –come la tecnica è stata lungamente e
tradizionalmente intesa- ma esso stesso comprende l’uomo nella sua totalità. Donde, i
pericoli che corre l’uomo a considerare la tecnica al di fuori della sua essenza, che non è
affatto cosa tecnica, ma è evento dell’essere, sono quelli di smarrire la propria essenza di
“pastore dell’essere” e l’essenza della verità. Il punto nodale del ragionamento di
Heidegger è che la tecnica, pur essendo forma di disvelamento dell’essere, è solo una
possibile forma del disvelamento, e non la forma definitiva e immutabile, cioè non è
24
l’essere. Assumere che il Gestell sia l’ente significa ricadere nella realizzazione della
metafisica di cui prima si diceva.
De artis medietate.
Ben lungi dal voler, e dal poter, “dare” una soluzione all’intricatissima rete di problematiche
messe in campo dalla questione della tecnica stricto sensu e, più in generale,
dall’evoluzione del pensiero tecnico e della tecnologia nella storia dell’uomo, cercherò,
quantomeno, di
avanzare timidamente un mio personale contributo, una proposta di
riflessione. A tale scopo, tuttavia, mi è utile fare un passo indietro, non cronologicamente,
ma con il pensiero, ossia cercare di guardare la questione fino ad ora trattata da un altro
punto di vista, come se mi arrampicassi su di una vetta teoretica per assicurarmi una
visione d’insieme del panorama che circonda il problema particolare. Mi sia lecito, dunque,
introdurre una delle molteplici vexatae quaestiones della storia del pensiero occidentale,
quella del dualismo, per introdurre poi la mia interpretazione della funzione della tecnica.
Il dualismo ha radici metafisiche e gnoseologiche: è stato definito da Platone, è rimasto
insoluto per Aristotele ed è stato ribadito da Cartesio nella formulazione oppositiva della
res cogitans e della res extensa, ossia del soggetto pensante rispetto all’oggetto reale e
pensato. In Kant, benché con un habitus differente, il dualismo permane nella forma del
rapporto tra fenomeno e noumeno, tra conoscibile e non conoscibile in forza delle umane
facoltà. Hegel riesce a dare una risposta risolutiva, ma essa rimane valida solo all’interno
del suo sistema panlogistico idealistico.
Una delle forme più significative di dualismo, lontana dal dualismo ontologico- idealistico in
senso platonico, è quella rappresentata dal già citato rapporto soggetto- oggetto che nella
storia del pensiero occidentale ha assunto vesti e formulazioni le più diverse ma sempre
riconducibili alla matrice comune di opposizione tra una dimensione interiore ed una
esteriore. Già per gli stoici l’ agathòn, il bonum, ossia il vero bene, aveva la propria sede
nell’anima, ossia intus, nell’interiorità, (e così anche il vero male, il kakòn o malum, era
piuttosto il male dell’anima) laddove le suggestioni fallaci e transeunte dei beni e quindi
anche dei mali esteriori ricadevano nell’ampio quanto eterogeneo contenitore degli
externa, che non escludeva neppure il corpo, mero bagaglio dell’anima.
Dal dualismo, oserei definirlo “etico”, degli stoici si passa così ad un dualismo più
antropologico: quello del rapporto anima- corpo, uno dei cardini della filosofia cristiana che
ha raggiunto le vette più alte d’espressione nella Scolastica e soprattutto nella Summa
theologiae di S. Tommaso d’Aquino. La filosofia moderna, almeno da Cartesio in poi, ha
ereditato le aporie della Scolastica medievale, sostituendo, però, al termine anima quello
meno compromesso dal punto di vista religioso di “mente”. Il rapporto mente- corpo
sottende la problematica questione che nasce dal fatto che ogni soggetto pensante ha
immediata evidenza della propria coscienza (l’autocoscienza che cartesianamente si
25
riassume nel cogito, ergo sum) ma non della realtà oggettuale che lo circonda. Uno iato
incolmabile si apre tra il soggetto che vive la realtà e la realtà che è vissuta dal soggetto,
per cui la realtà del reale non può mai acquisire quel grado di evidenza che è fornito
dall’autocoscienza. La questione è stata espressa recentemente in modo sintetico ed
efficace da Thomas Nagel che concentra la riflessione su tre domande: “1. è una
possibilità insensata che l’interno della nostra mente sia la sola cosa che esiste – o che,
anche se vi è un mondo esterno alla nostra mente, esso sia totalmente dissimile da quello
che crediamo sia? 2. se questo è possibile, hai qualche modo di provare a te stesso che
effettivamente non è vero? 3. se non puoi provare che esiste qualcosa all’esterno della tua
mente, è giusto continuare a credere comunque nel mondo esterno?”33 .
Il dualismo nella storia del pensiero occidentale è risolto attraverso due vie: o ricorrendo
ad un monismo di matrice parmenidea o “scavalcando” l’alveo stesso in cui la questione è
stata originariamente concepita, la metafisica. Almeno a partire da Nietzsche e dalla sua
critica radicale ad ogni costruzione che ponga il senso dell’essere al di là dell’essere e che
stabilisca la distinzione tra mondo reale e mondo apparente, la concezione della
metafisica tradizionale, come dimostra anche Heidegger, non avrebbe più ragione di
essere. Tuttavia il “dualismo kantiano” è tale, pur non avendo matrice metafisica in senso
tradizionale, ma trascendentale. Dunque, la questione del dualismo, che, come si è visto,
si manifesta anche in sede etica e antropologica, trascende a sua volta ogni superamento
della concezione tradizionale della metafisica: è, per così dire, un problema postmetafisico a tutti gli effetti (per non dire “meta- metafisico”!) e, dunque, per usare il lessico
di Heidegger, riguarda l’essere nella sua essenza.
Ed è a questo punto che mi permetto di introdurre un concetto che chiamerò termine
medio, medium, o μεταξύ, in cui confluiscono i termini opposti del dualismo senza che essi
perciò si confondano l’uno con l’altro. Il termine medio dà così certezza e dignità
ontologica a entrambi i termini opposti senza, tuttavia, che uno esautori l’altro o si
identifichi con l’altro: è un ago della bilancia. Ho detto dignità ontologica: effettivamente il
medium si potrebbe intendere anche in senso trascendentale, come “categoria delle
categorie” (la categoria delle lenti per mezzo delle quali vediamo il mondo); ma in tal caso
si ritornerebbe al punto di partenza. Preferisco, dunque, mutuare l’espressione da
Heidegger ed intendere il medium come la modalità di disvelamento dell’essere.
Il
medium, quindi, non è da confondere con la sintesi hegeliana come conclusione di una
triade dialettica: esso consiste in un principio che si pone come terzo, sottile margine di
convergenza verso cui si riversano la dimensione del soggetto e quella dell’oggetto. Userò
una metafora matematica: il medium, intuitivamente (molto intuitivamente!), rappresenta
tra soggetto e oggetto quel “termine unificatore” che, sulla retta dei numeri reali, il numero
33
Thomas Nagel, Una brevissima introduzione alla filosofia, p. 23, Il Saggiatore Net, 2002, Milano.
26
irrazionale rappresenta per la successione dei numeri razionali. In quanto principio
“ontologico”, il medium riguarda direttamente l’essenza dell’essere, ma assume nell’essere
e, quindi, per l’ente determinazioni differenti e vesti differenti, una delle quali è appunto la
tecnica. La medietà della tecnica (in latino ars) è caratteristica materialmente e
quotidianamente verificabile. Essa è la chiave con cui giornalmente ci apriamo al mondo:
ha modificato i nostri spazi (basta pensare ad Internet) e i nostri tempi (basta pensare alla
possibilità di registrare un’azione e di rivederla più e più volte), insomma il nostro modo di
concepire la realtà; eppure la realtà non è meno reale di quella in cui non esistevano
computer o televisioni, non è la realtà ad essere mutata, né il soggetto che tale realtà
conosce, ma è cambiato il medium che, come si è detto, realtà e soggetto unifica (il che
equivale a dire che entrambi sono cambiati senza che nessun dei due possa rendere
intelligibile il cambiamento). La tecnica, pertanto, non è il medium, ma è un medium
possibile, cioè l’investimento mediatico attualmente assunto dall’essere, che è solo una
delle possibili manifestazioni del termine medio. L’equivoco che contraddistingue l’età
della tecnica è pertanto quello di vedere nella tecnica il medium per eccellenza.
Nota bibliografica dei testi letti e/o consultati.
•
ABBAGNANO NICOLA - FORNERO GIOVANNI, Protagonisti e testi della Filosofia,
Paravia, 2000, Varese.
•
ABBAGNANO NICOLA, Dizionario di filosofia, terza edizione aggiornata e a
ampliata da Giovanni Fornero, UTET, 1998, Torino.
•
BERGSON HENRI, Introduzione alla metafisica, trad. di Armando Veraldi, Sansoni,
1949, Firenze.
•
CELLUCCI CARLO, La filosofia della matematica del Novecento, Laterza, 2007,
Bari.
•
DI BENEDETTO VINCENZO, Ideologia del potere e tragedia greca, Einaudi, 1978,
Torino.
•
ESCHILO, Prometeo incatenato,
Milano
•
ESIODO, Le opere e i giorni, trad. di G. Arrighetti, Monadori, 2007, Milano.
•
GALIMBERTI UMBERTO, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica.
Antropologia della tecnica, Feltrinelli, Milano, 2000.
•
GOETHE JOHANN WOLFGANG, L’apprendista stregone, trad. di Liliana Scalero,
da Opere V, Sansoni, 1961, Firenze.
•
GUIDORIZZI GIULIO, Il mondo letterario greco, Einaudi scuola, 2005, Milano.
•
JAEGER WERNER, Paideia, Nuova Italia, 1953, Firenze.
•
LEOPARDI GIACOMO, Canti Operette morali, a cura di Giorgio Ficara, Mondadori,
1988, Milano.
•
LOLLI GABRIELE, Filosofia della matematica. Formalismo. Il Mulino. Bologna.
2002
trad. di Monica Centanni, Mondadori, 2007,
27
•
NAGEL THOMAS, Una brevissima introduzione alla filosofia, Il Saggiatore Net,
2002, Milano.
•
PIRANDELLO LUIGI, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Mondadori, 1973,
Milano.
•
PLATONE, Protagora, trad. di Francesco Adorno, Laterza, 2003, Bari.
•
VERNANT JEANNE PIERRE, Mito e pensiero presso i Greci (Il lavoro e il pensiero
tecnico), Einaudi, 1978, Torino.
•
ZOLA ÈMILE, Il romanzo sperimentale, trad. dal francese di I. Zaffagnini, Pratiche
Editrice, 1992, Parma.
28