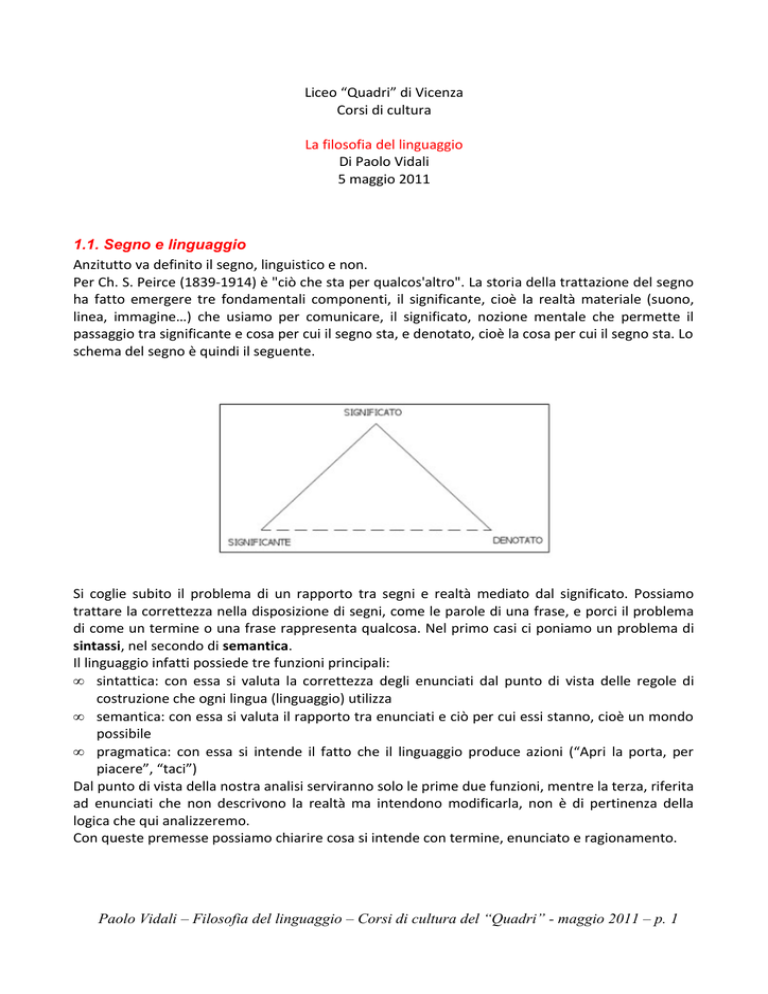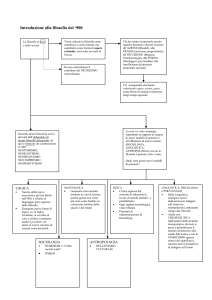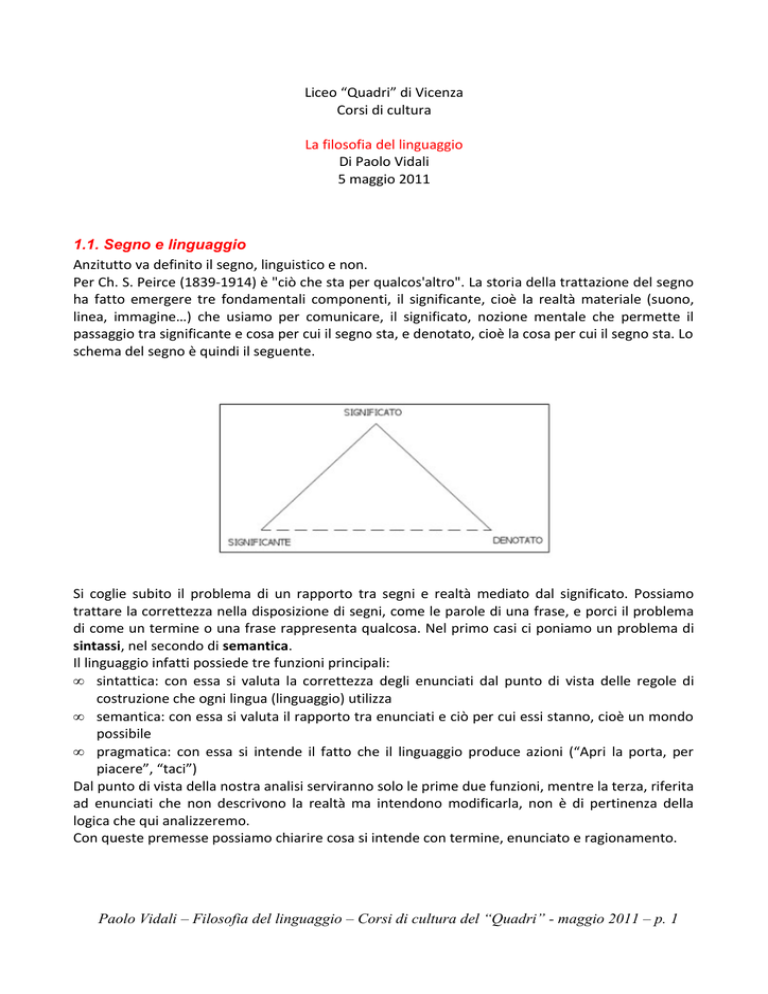
Liceo “Quadri” di Vicenza
Corsi di cultura
La filosofia del linguaggio
Di Paolo Vidali
5 maggio 2011
1.1. Segno e linguaggio
Anzitutto va definito il segno, linguistico e non.
Per Ch. S. Peirce (1839-1914) è "ciò che sta per qualcos'altro". La storia della trattazione del segno
ha fatto emergere tre fondamentali componenti, il significante, cioè la realtà materiale (suono,
linea, immagine…) che usiamo per comunicare, il significato, nozione mentale che permette il
passaggio tra significante e cosa per cui il segno sta, e denotato, cioè la cosa per cui il segno sta. Lo
schema del segno è quindi il seguente.
Si coglie subito il problema di un rapporto tra segni e realtà mediato dal significato. Possiamo
trattare la correttezza nella disposizione di segni, come le parole di una frase, e porci il problema
di come un termine o una frase rappresenta qualcosa. Nel primo casi ci poniamo un problema di
sintassi, nel secondo di semantica.
Il linguaggio infatti possiede tre funzioni principali:
• sintattica: con essa si valuta la correttezza degli enunciati dal punto di vista delle regole di
costruzione che ogni lingua (linguaggio) utilizza
• semantica: con essa si valuta il rapporto tra enunciati e ciò per cui essi stanno, cioè un mondo
possibile
• pragmatica: con essa si intende il fatto che il linguaggio produce azioni (“Apri la porta, per
piacere”, “taci”)
Dal punto di vista della nostra analisi serviranno solo le prime due funzioni, mentre la terza, riferita
ad enunciati che non descrivono la realtà ma intendono modificarla, non è di pertinenza della
logica che qui analizzeremo.
Con queste premesse possiamo chiarire cosa si intende con termine, enunciato e ragionamento.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 1
1.2 Il termine
“Mario”, “bianco”, “corre”, sono termini, cioè nomi, verbi, avverbi, aggettivi dotati di senso. Una
frase, Per esempio “Il tavolo è bianco”, è composta da termini.
Vi sono però anche altri termini, come gli articoli, le preposizioni, le congiunzioni…, che non hanno
un senso in sé, ma solo nel contesto della frase. “Per”, “il”, “e” significano qualcosa solo in
rapporto ad altri termini: per esempio “Mario e Giovanni sono fratelli”. Tali termini sono utili
perché con la loro presenza si modifica il senso della frase, come avviene utilizzando la negazione:
“Mario non è italiano”.
Vi sono quindi due tipi di termini:
• termini categorematici (o semantici), ovvero quelli in sé dotati di senso;
• termini sincategorematici (o sinsemantici), ovvero quelli in sé non dotati di senso ma che lo
acquistano collegandosi (sin) con quelli dotati di senso, secondo le regole della sintassi del
linguaggio in questione.
Finora abbiamo affermato che i termini sono o non sono dotati di senso proprio. E’ la stessa cosa
chiederci se sono veri o falsi? Qui appare una distinzione fondamentale, da tenere sempre
presente: la distinzione tra termini ed enunciati.
1.3. L’enunciato
Con enunciato siintende quella forma linguistica caratterizzata grammaticalmente da un soggetto,
una copula e un predicato.
Dallo studio della grammatica sappiamo che esistono diversi tipi di enunciati. Per i nostri scopi
basterà ricordarne due:
• enunciati dichiarativi, che descrivono una qualche situazione: “Mario è italiano”, “Mario
corre”;
• enunciati ipotetici, che esprimono una ipotesi intorno a una qualche situazione: “Se
Mario corre, allora arriva prima”, “Domani potrebbe nevicare”.
1.4 Linguaggio e verità
Gli enunciati sono composti da termini, ma qui appare quell’importante distinzione che prima
menzionavamo. I termini non possono essere veri o falsi: solo gli enunciati sono veri o falsi.
Cerchiamo di capire perché.
“tavolo” è un termine dotato di senso dal momento che dicendo “tavolo” sappiamo che cosa
vogliamo dire. Ma se diciamo solo “tavolo”, abbiamo detto qualcosa che non è né vero né falso.
Solo se passiamo a “Il tavolo è bianco" affermiamo qualcosa che può essere vero o falso. Quando
costruiamo una frase che afferma o nega certe relazioni tra termini, quindi quando usiamo
enunciati dichiarativi, o semplicemente enunciati, solo allora possiamo parlare di verità o falsità.
Se il tavolo a cui ci riferiamo nell’enunciato è proprio quel tavolo bianco che ci sta davanti e
diciamo “Il tavolo è bianco”, allora questo è un enunciato vero; se invece diciamo “Il tavolo non è
bianco” quell’enunciato è falso.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 2
2. La filosofia del linguaggio tra antichità e medioevo
La filosofia greca ed ellenistica si era concentrata sul tema dell'origine del linguaggio, sulla sua
naturalità o convenzionalità, sul rapporto tra parole e cose. Gran parte di questi problemi ha
ricevuto significative risposte da Platone, da Aristotele, dagli stoici, risposte che la filosofia
medievale eredita senza imbarazzi,.
Kai ò logos sarx egéneto: e il logos si fece carne (Gv 1, 14). Sono queste parole, tratte dall'inizio del
Vangelo di Giovanni, il punto di partenza migliore per riflettere sul linguaggio nella filosofia
medievale. Il cristianesimo, come l'ebraismo, è infatti una religione profondamente legata al tema
della parola, del libro, della scrittura e in generale del linguaggio. Dio ha parlato e il mondo ha
cominciato ad esistere, la Bibbia è verità rivelata attraverso la parola di Dio, Gesù è Verbum, parola
fatta carne per abitare con noi, le auctoritates sono testi e sentenze, la preghiera è discorso
umano rivolto a Dio, la parola giunge a dire quella trascendenza a cui lo sguardo sensibile non può
arrivare… Il linguaggio è al centro della riflessione cristiana per motivi religiosi, ma lo è anche che
per ragioni filosofiche.
Tuttavia il nuovo scenario portato dall'annuncio cristiano sposta molti termini della questione. E'
Dio stesso che crea usando la parola: Adamo è colui che dà un nome umano alle cose e il problema
classico dell'origine del linguaggio trova così una risposta. Dono di natura, come lo chiama san
Basilio (330 ca-379), derivato direttamente da Dio, come dice Tertulliano (160 ca - 220 ca), il
linguaggio è un segno della benevolenza divina, tuttavia non privo di ambiguità: nella vicenda
biblica della torre di Babele il gesto di superbia degli uomini che unendosi vogliono sfidare Dio
viene da Lui annullato confondendo le loro lingue. Anche per questo il problema della
convenzionalità o naturalità del linguaggio trova una sua soluzione: la diversità delle lingue è
l'esito di una colpa a cui si deve rimediare volgendo lo sguardo proprio alla Parola che Dio ha
rivolto agli uomini per offrire loro la salvezza.
Il problema centrale attorno a cui ruota la riflessione medievale è quello del significato dei termini.
Quando affermo che l'"uomo" è un animale razionale e quando dico che questo "uomo" è vecchio,
uso il termine nello stesso significato? In che cosa consiste la differenza?
A margine di questo problema, come una sorta di domanda di controllo, seguiremo una pista
secondaria, anche se collegata al problema principale. Proprio la potenzialità riconosciuta al
linguaggio lo rende in gran parte autonomo dalla realtà sensibile: il linguaggio dice Dio, nel
cristianesimo, e quindi non può limitare la sua significatività al mondo visibile, non possono essere
i sensi il criterio della sua validità. Ma allora, si chiederanno in molti, che valore hanno i termini
che rimandano ad enti non esistenti? Dire "nulla" significa qualcosa? Qual è il significato dei
termini che denotano qualcosa di non esistente?
2.1 il problema degli universali
Porfirio (233 – 305 ca), nella sua Isagogé, cioè Introduzione alle Categorie di Aristotele, si interroga
sulla natura dei termini universali, cioè genere (per esempio "animale") e specie (per esempio
"uomo"), e lo fa ponendo tre domande: 1) gli universali sono enti reali o concetti? 2) se sono enti,
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 3
sono oggetto di conoscenza sensibile? 3) sono separati dalle cose sensibili o vincolati Per esse? Le
posizioni che si preciseranno nel dibattito sono sostanzialmente tre.
Per i realisti, come Guglielmo di Champeaux (1070-1121), gli universali sono vere e proprie
componenti della realtà, per questo diventano concetti nella nostra mente ed espressioni del
nostro linguaggio.
Opposta è la posizione dei nominalisti: con Roscellino di Compiègne (†1123 ca) essi non accettano
né concetti né oggetti ma solo termini universali. Gli universali sono quindi espressioni
linguistiche, che dipendono dai singoli enti conosciuti e senza i quali non esisterebbero.
La terza posizione, che si rifà ad Abelardo (1079-1142), è quella dei concettualisti. Essi ammettono
l'esistenza di concetti e di termini universali, ma negano che vi siano enti universali. Il nostro
intelletto conosce e classifica l'esperienza, generando concetti universali che poi assumono forma
linguistica. In questa posizione è l'intelletto a giustificare e fondare il valore degli universali.
2.2. Significatio e nominatio
L'universale per Abelardo (1079-1142 è quindi un problema di predicazione (Logica Ingredientibus
p. 16): solo capendo l'uso linguistico, grammaticale e logico della predicazione si può fare luce
sulla questione degli universali.
La premessa da cui muove Abelardo è la differenza tra dire "uomo" e dire "essere un uomo": solo
la seconda espressione denota un ente preciso e definito, mentre la prima non rimanda a nulla.
Ma allora, perché diciamo che "Socrate è un uomo"? Perché esiste una capacità astrattiva
dell'intelletto che da più persone coglie quelle proprietà che insieme definiscono il concetto uomo.
Tali proprietà sono colte e riunite dall'intelletto nella nozione uomo e non serve un'essenza
realmente esistente per poterle cogliere.
Su queste basi la differenza tra termini universali e termini particolare diventa chiara: al nome
universale "uomo" corrisponde un'immagine comune a molte cose pur se confusa, mentre al
nome singolare "Socrate" corrisponde una forma unica e precisa che si riferisce ad un ente
determinato.
Pur con una qualche incertezza nei termini, Abelardo arriva a distinguere questi due modi di usare
i termini, o meglio queste due funzioni del segno:
1) la significatio, che coincide con il significato del termine, cioè con il riscontro concettuale della
parola "uomo";
2) la nominatio, che coincide con la denotazione, con quella che Anselmo chiamava appellatio e
che è il rimandare del termine all'ente realmente esistente.
Che cosa significa "rosa" senza le rose?
Alle tre questioni poste da Porfirio circa la natura degli universali, Abelardo aggiunge una quarta
domanda, destinata a suscitare ampie discussioni: gli universali avrebbero ancora un significato se
gli individui a cui rimandano cessassero di esistere? Detto diversamente, il termine "rosa" avrebbe
un significato anche senza le rose?
Come nome "rosa" continuerebbe a significare anche senza gli enti a cui rimanda. Infatti sarebbe
ancora comprensibile la frase "le rose non esistono". Il significato infatti è dato dal concetto, non
dalla realtà. Quando le cose non esistono più, il significato permane, ma non può riferirsi ad
alcunché di esistente. E se le cose nominate non sono mai esistite, come per la chimera o
l'ippogrifo? Allora la situazione è diversa, perché senza individui non si può astrarre nemmeno il
concetto, il che rende vuota la significazione.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 4
Come in Anselmo, anche in Abelardo la perdita di referenzialità non svuota il segno, semmai ne
esalta l'autonomia. I termini significano anche in assenza delle cose, perché ciò che dà valore è
l'operazione intellettuale dell'astrarre e del significare. Certo, è in rapporto alle cose che ci
formiamo nozioni a cui poi associamo delle parole: ma il confronto con la realtà non è tale da
rendere inefficace la parola in assenza delle cose.
2.3. La prova a priori dell’esistenza di Dio
Il contributo più importante e destinato a una enorme fortuna nella filosofia successiva è la prova
dell’esistenza di Dio detta “argomento ontologico”, sviluppato nel Proslogion. L’ambizione è
trovare un argomento che non abbia bisogno di altro al di fuori di sé solo, sia per sostenersi, sia
per provare che Dio esiste veramente. Così Anselmo immagina una sorta di dialogo fra un filosofo
e un ateo, chiamato “stolto” al pari del personaggio del Salmo XIII che affermava in cuor suo che
Dio non esiste. Il filosofo stimola l’ateo a produrre, apparentemente per amore di discussione, una
definizione di Dio; l’ateo, pur affermando che egli in ogni modo non crede all’esistenza di un tale
ente, trova un accordo col filosofo nella definizione di Dio come ciò di cui non si può pensare nulla
di maggiore. Tale concetto appare inizialmente neutro, cioè ammissibile sia dal credente che dal
non credente: per il credente Dio è esattamente questo ente ed esiste, per l’ateo lo sarebbe se
esistesse, cosa che lui tuttavia non è disposto a concedere.
Eppure proprio qui scatta l’argomento anselmiano: un essere che ha tutte le perfezioni non può
esistere solo nel intelletto, altrimenti se ne potrebbe pensare uno di ancora più ricco perché tale
da possedere in aggiunta l’esistenza reale (dal momento che una cosa reale è maggiore, cioè “più
perfetta”, della stessa cosa solo pensata). Chi asserisce che Dio è l’essere che possiede tutte le
perfezioni ma poi afferma che non esiste, non sta in effetti pensando quell’essere e dunque si sta
contraddicendo. Costui secondo Anselmo è stolto non solo perché non crede in Dio, ma anche
perché fonda le sue argomentazioni su un presupposto gnoseologico erroneo (e cioè che si possa
dire esistente solo quanto è constatabile coi sensi) e quindi perché sviluppa un’argomentazione
autocontraddittoria: dice di pensare l’essere che ha tutte le perfezioni e poi invece pensa l’essere
che ha tutte le perfezioni meno una (l’esistenza, appunto); pensa la parola ma non riesce a
cogliere tutta la portata del concetto significato da questa. Questo significa che, una volta
ammesso che nel nostro intelletto esiste il concetto di Dio secondo la definizione appena
formulata (in possesso dunque di quella che i medievali chiamavamo la existentia in intellectu),
siamo costretti ad ammettere che deve esistere anche nella realtà l’ente definito, Dio (che
possiede pertanto anche la existentia in re) (→ Testo ).
Le obiezioni all’argomento ontologico nel Medioevo
L’argomento ontologico suscitò una serie di obiezioni e riserve. Il monaco Gaunilone (sec. XI)
oppose al Proslogion un breve testo intitolato Difesa dello stolto in cui osservava che io potrei
immaginare un oggetto dotato di tutte le perfezioni pensabili come delle isole di fantasia, che lui
battezza Isole Beate, di cui non è possibile pensare isole più belle da nessun punto di vista. Ciò non
toglie che, come sappiamo fin dall’inizio, esse siano per l’appunto una pura creazione della
fantasia e che non esistano affatto: insomma per Gaunilone il passaggio dalla existentia in
intellectu a quella in re è un salto indebito, che Anselmo non argomenta. Gaunilone usa qui un
argomento quasi-deduttivo detto l’autofagia; lo si impiega quando si mostra che, applicando senza
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 5
eccezioni una regola, si arriva a distruggerla poiché alcune sue conseguenze sono in
contraddizione con essa.
Anselmo controreplicò (nella sua Risposta) che l’obiezione è scorretta perché le isole
possono avere solo le perfezioni del loro genere, cioè quelle che possono spettare a un’isola; Dio
invece le possiede tutte e per questo non si può escluderne l’esistenza. In tal modo Anselmo cerca
di evitare l’accusa di autofagia, affermando che solo nel caso di Dio in cui si può applicare
l’argomento a priori: solo per Dio (e proprio in quanto è l’unico essere dotato di tutte le perfezioni)
vale quindi il passaggio dall’existentia in re all’existentia in intellectu. In realtà Gaunilone poneva
un serissimo rilievo proprio sulla legittimità del passaggio dal concetto alla realtà: la pura e
semplice possibilità logica di un concetto non ci autorizza infatti ad asserire nulla sulla sua
esistenza effettiva, come in seguito parecchi altri filosofi anche scolastici, a cominciare da
Tommaso, rilevarono.
La seconda obiezione di Gaunilone appare altrettanto temibile: se il filosofo e l’ateo si
accordassero su un’altra definizione di Dio (che potrebbe essere “l’essere onnipotente”, “l’essere
più misericordioso” e via dicendo), allora tutta l’argomentazione di Anselmo non potrebbe più
decollare. La definizione “ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore” è essenziale, ma in realtà
solo perché contiene già la nozione della esistenza reale di Dio: l’argomento ontologico non è
autenticamente una dimostrazione, ma si limita a esplicitare qualcosa che era già da sempre
contenuto in essa, come un prestigiatore riesce a estrarre dal suo cilindro un coniglio solo se ce
l’ha gia messo dentro prima. Si tratta, in termini più tecnici, di una petizione di principio: una
argomentazione dove la tesi che si vuole dimostrare è già presente nella premessa, un circolo
vizioso (detto dai logici diallele).
Questo passo è tratto dal Proslogion, verosimilmente redatto negli anni 1077-1078, e riporta il nerbo dell’argomento
ontologico. Se la fede è una conquista a cui l’uomo non arriva solo grazie alle sue forze ma con l’aiuto
della grazia, la ragione non è per questo esonerata dal tentativo di comprendere. E mentre le prove a
posteriori sviluppate da Anselmo nel Monologion gli apparivano una serie di argomentazioni le cui
premesse richiedevano ulteriori giustificazioni, l’argomento ontologico gli pare l’unica dimostrazione
dell’esistenza di Dio davvero autosufficiente
1. Dunque, o Signore, tu che dai l’intelletto della fede, concedimi di intendere, per quanto tu sai
essere utile, che tu esisti come crediamo e che tu sei quello che crediamo. Ora noi crediamo che tu
sia qualcosa di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore.
2. O forse non esiste qualche natura siffatta, poiché «l’insipiente ha detto in cuor suo: “Dio non
esiste”» (Sal. 14, 1 e 53, 1)? Ma certamente quel medesimo insipiente, quando ode ciò che io dico,
cioè «qualcosa di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore», intende ciò che sente dire; e ciò
che intende è nel suo intelletto, anche se egli non intende che ciò esiste.
3. Altro infatti è che una cosa esista nell’intelletto e altro intendere che una cosa esista. …
4. Dunque anche l’insipiente deve convincersi che almeno nell’intelletto esiste qualcosa di cui non
può pensarsi nessuna cosa maggiore, poiché egli lo intende, quando lo sente dire, e tutto ciò che si
intende esiste nell’intelletto. Ma certamente ciò di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore
non può esistere nel solo intelletto. Infatti, se esiste nel solo intelletto, si può pensarlo esistente
anche nella realtà e questo allora sarebbe maggiore.
5. Di conseguenza se ciò di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore esiste nel solo intelletto,
ciò di cui non può pensarsi nessuna cosa maggiore è ciò di cui può pensarsi una cosa maggiore.
Questo evidentemente non può essere. Dunque, senza dubbio, qualcosa di, cui non può pensarsi
nessuna cosa maggiore esiste sia nell’intelletto che nella realtà.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 6
[Anselmo, Proslogion, II, 1-5; trad. it. Rizzoli, Milano 1992, pp. 81-85]
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 7
3. La filosofia moderna del linguaggio
Che cosa accade quando la filosofia europea moderna affronta le tematiche linguistiche?
Da un lato recupera e approfondisce, su basi nuove, il problema semantico, cioè il rapporto tra
parole, significati e concetti. Anzi è proprio l’idea, tipicamente moderna, di una ragione unica e
presente in ogni uomo a saldare il piano del pensiero e quello del linguaggio. Da qui, come
vedremo, si aprono strade diverse, volte ad analizzare il processo con cui attribuiamo significati
alle parole, a correggere errori ed abusi del linguaggio e, in certi casi, anche ad inventare una
lingua universale che preservi da tali errori. A questi temi si dedicheranno tanto i filosofi di
tradizione empirista, come Bacone, Hobbes, Locke, quanto quelli di tradizione razionalista, come
Cartesio, i logici di Port Royal e Leibniz.
Al di là delle differenze, il problema su cui tutti finiscono per riflettere è se il linguaggio determina,
condiziona e talvolta confonde il pensiero, oppure se, viceversa, il linguaggio non sia una
condizione necessaria del pensiero.
D’altro canto il pensiero moderno riflette, con nuovo interesse, sul problema dell’origine,
questione più greca che medievale. In effetti la linguistica moderna valorizza proprio quanto il
medioevo aveva trascurato. Il latino resta la lingua dei dotti, ma la nascita e il rafforzarsi delle
lingue volgari, nel Cinquecento e nel Seicento, è ormai un fatto acquisito. Si rafforzano gli stati
nazionali e con essi acquistano dignità sempre maggiore le grandi lingue europee. A questa varietà
di lingue si affianca la scoperta di una ancora più grande diversità di idiomi, frutto dei nuovi
rapporti commerciali legati alle rotte oceaniche.
Si comincia così a porre la questione del rapporto tra popolo e lingua, e quella connessa del
rapporto tra lingua e progresso storico, una tematica che si afferma in epoca moderna per
consolidarsi definitivamente nell’Ottocento. La lingua, infatti, è lo specificarsi del linguaggio, la
condivisione di un codice per una comunità di parlanti. Il passaggio dal piano generale del
linguaggio a quello più specifico delle lingue parlate corrisponde ad una maggiore attenzione agli
elementi storici, sociali, pragmatici del linguaggio. In questo direzione vanno i contributi di Vico, e
Condillac, in diverso modo tesi ad indagare il nesso che unisce storia e linguaggio.
Riassumendo possiamo dire che le questioni centrali attorno a cui ruota il dibattito sono due,
articolate a loro volta in due sottotemi:
1. Linguaggio e conoscenza
1.1. teoria degli abusi e degli errori nel rapporto tra linguaggio e pensiero;
1.2. correzione di tali errori, anche attraverso la costruzione di una lingua universale:
2. Lingua e storia
2.1. genesi delle lingue e studio del rapporto tra lingue storiche e popoli che le parlano;
2.2. storicità del processo linguistico e primi passi della cosiddetta linguistica storica.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 8
4. La riflessione ottocentesca sul linguaggio
4.1 Von Humboldt e la lingua come visione del mondo
Karl Wilhelm von Humboldt (1767-1835) rappresenta una delle personalità intellettuali più ricche
e articolate di tutto il romanticismo. Figlio di una nobile famiglia prussiana, studia giurisprudenza,
filologia, filosofia e storia, frequenta tutti i maggiori pensatori e letterati del mondo tedesco,
assume incarichi politici di primo piano – ambasciatore a Roma, plenipotenziario prussiano al
Congresso di Vienna, riformatore del sistema scolastico e fondatore dell’Università di Berlino – ma
la sua fama rimane legata agli studi sul linguaggio, vera passione intellettuale che attraversa tutta
la sua vita. Egli parla perfettamente una decina di lingue europee, studia e conosce molte lingue
amerinde, l’egiziano, il cinese, il giapponese, il sanscrito, il malese e il giavanese. La sua
competenza linguistica non si limita, tuttavia, al piano comunicativo, ma si addentra nello studio
della linguistica comparata e nella stessa filosofia del linguaggio.
La lingua come espressione dello spirito
Per Humboldt la concezione del linguaggio risente profondamente del contesto romantico in cui
egli opera: le lingue sono una produzione spirituale, frutto di una energia creativa e di un processo
infinito. La lingua non è un’opera (érgon) ma un’attività (enérgheia). Essa “è il lavoro eternamente
reiterato dello spirito, volto a rendere il suono articolato capace di rendere il pensiero” (La
diversità delle lingue, 1830-1835, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 36). La lingua diventa così la
principale mediazione tra natura e spirito, tra sfera sensibile e sfera intellettuale, tra infinità dello
spirito e finitezza dei suoni e delle esperienze. Il linguaggio, scrive Humboldt, deve fare un uso
infinito di mezzi finiti ed è in grado di farlo perché tanto il pensiero quanto il linguaggio derivano
dall’unica forza spirituale infinita che li anima entrambi (ivi pp.78-79).
Lingue e popoli
Ma come si sviluppa la forza spirituale che genera tanto la lingua quanto il pensiero?
La risposta di Humboldt mette in campo, in modo determinato, il ruolo delle nazioni. Sono i popoli
gli autentici soggetti del parlare, poiché le lingue sono espressione di soggettività allargate. La
lingua, infatti, è un’attività collettiva, altrimenti non è strumento di comunicazione. Il rapporto tra
popolo e lingua riprende, in contesto romantico, il tema del “genio della lingua” proposto da
Condillac, allargandolo e approfondendolo. Humboldt, in un testo del 1806 (Latium und Hellas)
sostiene che clima, geografia, religione, politica, costumi e lingua determinano una nazione:
tuttavia la lingua lo fa in modo prevalente. Essa è l’anima stessa di una nazione ed è inseparabile
dal suo sviluppo. La lingua, quindi, è una condizione necessaria dello sviluppo spirituale di una
nazione e per questa ragione in essa si inscrive la più autentica identità di un popolo. “La lingua –
scrive Humboldt – è la manifestazione fenomenica dello spirito dei popoli: la loro lingua è il loro
spirito e il loro spirito è la loro lingua” (ivi, p. 33).
Perché, allora, le lingue sono diverse, posto che lo spirito che anima l’umanità è unico?
Servendosi di un argomento di causa, Humboldt fa risalire la diversità delle lingue ad una causa
comune: essa, infatti, dipende dalla necessità dello spirito di produrre forme sempre nuove. Le
singole lingue, come i singoli popoli, sono punti di vista parziali dello sviluppo umano, della unica
forza che lo attraversa e lo anima. Con una vigorosa inversione, Humboldt rovescia l’argomento
principale tradizionalmente utilizzato da chi sostiene l’origine empirica e occasionale del
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 9
linguaggio. La diversità delle lingue, si sosteneva, è un segno evidente dell’impossibilità a ravvisarvi
una causa o un’origine comune e depone a favore di una varietà di situazioni da cui prende avvio il
segno e la parola. Per Humboldt, invece, lo spirito è causa unica del linguaggio, del pensiero e in
genere dell’attività umana, perché tale spirito va inteso nella sua poliedrica attività: “dobbiamo
vedere nella forza spirituale delle nazioni l’effettivo principio esplicativo e la vera causa che
determina la diversità delle lingue” (ivi, p. 33).
“La vera ragione della molteplicità delle lingue è l’intimo bisogno dello spirito umano di produrre
una molteplicità di forme intellettuali che trova il proprio limite nel modo, a noi parimenti ignoto,
in cui lo trova la molteplicità delle forme viventi della natura” (Scritti sul linguaggio, Guida, Napoli
1989, p. 69) Quella di Humboldt è una visione laica, cosmopolita ed egualitaria della differenza di
popoli e lingue. Una visione che l’Europa dell’imperialismo ottocentesco non farà sua.
La lingua come visione del mondo
Altra tesi che Humboldt sostiene con forza è quella dell’identità di pensiero e linguaggio
Come in Hamann e in Herder, il linguaggio è visto innegabilmente connesso ad ogni tipo di attività
intellettuale. Tanto il pensiero quanto la lingua derivano dal medesimo spirito. Per la coerenza
degli effetti data l’unicità della causa, tra lingua e pensiero vi è corrispondenza stretta: come la
materia del pensare e l’infinità delle sue combinazioni è inesauribile, così è per gli elementi della
lingua. Non solo, la lingua porta con sé una strutturazione dell’esperienza, della realtà, del vissuto
che si traduce in una Weltanschauung, cioè in una visione del mondo. Ogni lingua rappresenta un
punto di vista nella visione del mondo, contiene la trama di concetti e di forme di
rappresentazione della realtà. Parlare una lingua, usarla come veicolo di comunicazione, abitarla
come lingua madre significa pensare in quella lingua. “Ogni lingua traccia attorno al popolo a cui
appartiene un cerchio dal quale è possibile uscire solo passando nel cerchio di un’altra lingua”
(Einleitung zum Kawi Werk, § 14, Werke III, p. 434).
Così, come abbiamo visto in Herder, anche in Humboldt il linguaggio da un lato forma il pensiero
ma, dall’altro, lo imprigiona. La lingua manifesta ed esterna il pensiero, ma tiene l’uomo
prigioniero nei suoi confini, precludendogli la possibilità di superarli. Non si può uscire dal cerchio
della lingua ricorrendo al solo pensiero - la definizione di un concetto è fatta comunque di parole né utilizzando una lingua diversa - la traduzione porta comunque all’interno di un altro schema
linguistico.
Eppure, come abbiamo visto, questa determinatezza della lingua sul pensiero non è vista da
Humboldt come un limite, ma come una risorsa. Attraverso il linguaggio trapela l’infinita ricchezza
dello spirito umano, che “non può mai essere conosciuto esaurientemente attraverso un numero
finito di punti di vista” (Latium und Hellas, Werke II, pp. 60-61)
Soprattutto quest’ultimo aspetto ha trovato, nel Novecento, una grande eco. Si vede in Humboldt
un fondatore della contemporanea filosofia del linguaggio proprio perché ha insegnato a vedere in
ogni lingua una peculiare visione del mondo.
Humboldt: la lingua come visione del mondo
Gli studi linguistici di Humboldt si concentrano in particolare dopo il 1820, anno in cui abbandona, deluso, la scena
politica. Segno di questa attività è l’opera in tre volumi Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, che uscirà postuma
nel 1836-1839. Ad essa Humboldt fa precedere un’ampia introduzione dedicata alla diversità di struttura delle lingue
umane e al loro influsso sullo sviluppo spirituale dell’umanità, comunemente nota come Einleitung zum Kawi-Werk e in
italiano come La diversità delle lingue. In essa Humboldt espone la sua più matura e completa elaborazione di una
filosofia del linguaggio.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 10
Solo ad un più attento esame e, in tal caso, in modo chiaro e distinto, si potrà individuare il carattere della diversa
concezione del mondo che i popoli hanno fissata nel valore delle parole. Già in precedenza ho spiegato che è difficile
che una qualsiasi parola, a meno che non venga usata nel momento contingente come segno materiale del suo
concetto, venga accolta nella rappresentazione al medesimo modo da individui diversi. Pertanto si può senz'altro
affermare che in ciascuna è insito alcunché, non distinguibile a sua volta con parole, e che, quantunque designino nel
complesso gli stessi concetti, nondimeno le parole appartenenti a più lingue non sono mai veri e propri sinonimi. Una
definizione, a rigor di termini, non le può comprendere e spesso è possibile solo, per così dire, indicare il posto che
esse occupano nel campo di cui fanno parte. Ho già parimenti ricordato in qual modo ciò si verifichi perfino nelle
designazioni di oggetti materiali. Ma il campo in cui davvero affiora il diverso valore delle parole è la designazione di
concetti spirituali. Di rado qui una parola esprime senza differenze molto evidenti lo stesso concetto espresso da una
parola di un'altra lingua. […] Presso le nazioni caratterizzate da una grande vivacità di spirito questo valore, se lo si
ricerca fin nelle più sottili gradazioni, resta per così dire in flusso perpetuo. Ogni epoca, ogni scrittore originale,
involontariamente vi aggiunge qualcosa di suo oppure lo modifica, perché non può fare a meno di fissare la propria
individualità nella lingua, la quale fa insorgere in essa un nuovo bisogno di espressione.
W. von Humboldt, Sulla diversità delle lingue, 1836, § 20, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 156-157.
4.2 Nietzsche e il linguaggio come metafisica popolare
Friedrich Nietzsche (1844-1900) è un pensatore inattuale. Inattuale per il suo tempo, dominato da
una solida fiducia nella ragione e nei valori etici del cristianesimo, mentre Nietzsche è tutto volto a
mostrare che anche la più nobile azione umana è frutto degli istinti e del bisogno. Inattuale per i
temi che affronta, come la morte di Dio, cioè la caduta di tutti i valori assoluti, o l’annuncio
dell’oltre-uomo, cioè di una umanità superiore capace di creare nuovi valori e di dare senso alla
realtà. Inattuale infine anche per il tema che stiamo affrontando, quello del rapporto tra
linguaggio e ragione, posto che tanto l’uno quanto l’altra sono, per Nietzsche, tracce di una
mentalità gregaria, di un bisogno di comunicazione basato sulla debolezza, di un’illusione cui ci
siamo abituati ma che va finalmente smascherata e distrutta.
Proprio tale inattualità fa di Nietzsche un pensatore contemporaneo: il suo pensiero asistematico,
fatto di aforismi e frammenti, anticipa le più meditate riflessioni critiche su cui si concentrerà il
Novecento, aprendo uno sguardo disincantato sulla natura umana, sui suoi limiti e sulle sue
illusioni.
La genealogia del linguaggio
Per Nietzsche la realtà di cui l’uomo è parte consiste in un perenne fluire, in un divenire in cui
forze, istinti e pulsioni si fronteggiano allo scopo di prevalere. Il divenire è la nota dominante di
questa realtà: eppure l’uomo ha cercato costantemente di imporle la stabilità dell’essere. Così è
nata la metafisica, la morale dei valori assoluti, la stessa idea di ragione, che cerca identità laddove
esistono solo differenze, che cerca permanenze laddove esiste solo il creativo porre e distruggere.
Il metodo che Nietzsche utilizza per smascherare l’invenzione dell’essere è la genealogia. Essa
consiste nel giustificare per via diversa, cioè storica, psicologica, sociale o antropologica, idee e
valori ritenuti perenni, astorici, assoluti.
Anche l’analisi del linguaggio ripercorre la stessa strada, nell’intento di mostrare che esso non è un
dono divino o comunque la traccia della superiorità umana sugli altri viventi, ma solo il frutto di
una più dimessa esigenza.
Nel ricostruire genealogicamente la nascita della coscienza, Nietzsche offre infatti un’analisi del
ruolo che il linguaggio ha svolto in questo processo. La coscienza, per Nietzsche, è frutto del
bisogno umano di comunicazione, della necessità di comprendersi in maniera rapida e sottile.
L’uomo infatti è un animale costantemente in pericolo e per questo ha bisogno dei suoi simili. Ma
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 11
tale esigenza produce la necessità di “sapere” che cosa serve, come agire, che ruolo svolgere. “Il
pensiero consapevole si determina in parole, cioè in segni di comunicazione, con la qual cosa si
rivela l'origine della coscienza medesima. Per dirla in breve, lo sviluppo della lingua e quello della
coscienza […] procedono di pari passo”(Gaia Scienza, 1882, § 354).
La tesi del bisogno naturale di comunicazione che sta alla base del linguaggio non è nuova: nuove
sono le considerazioni che Nietzsche trae da questa genealogia. Il bisogno di comunicare con gli
altri uomini spinge a dare importanza a ciò che appare uguale, comune, condiviso, cancellando
invece come non comunicabile quanto è individuale e originale. La coscienza si è sviluppata solo in
rapporto ad una utilità comunitaria e gregaria e di conseguenza ognuno di noi tende a sviluppare
un pensiero “adeguato alla maggioranza e ritradotto nella prospettiva del gregge […] Ciò di cui
possiamo aver coscienza è solo un mondo di superfici e di segni, un mondo generalizzato,
volgarizzato” (ivi).
Il linguaggio è la traccia di un mondo superficiale, fatto di segni comunicabili e di apparenza
immediatamente comprensibile: la “superficialità della coscienza e del linguaggio sono, per
Nietzsche, l’esatto opposto della profondità che la tradizione occidentale ha riservato al pensiero e
alla parola.
La metafisica del linguaggio
Ma il linguaggio non si limita a enfatizzare la superficie: esso trasforma e condiziona il pensiero,
imponendogli la sua struttura: “il linguaggio porta con sé grandi pregiudizi e li coltiva” (Frammenti
postumi 1879-1881, 6 [45]). L’errore ha il costante patrocinio del nostro linguaggio, scrive
Nietzsche, in particolare quando ci fa credere che dietro alla parola ci sia un evento, una cosa, un
ente.
Il bisogno di stabilità ci spinge a cercare unità, identità, durata, sostanza, causa, essere, e il
linguaggio asseconda tale bisogno, fino a determinarlo: viviamo la “metafisica del linguaggio”. Da
qui il nostro uso del nome come se esso identificasse sempre un ente, qualcosa di esistente, di
definito e stabile.
Anche il verbo, sia attivo che passivo, nasconde e contemporaneamente esprime il nostro bisogno
di vedere ovunque un autore. Anche quando un autore non c’è, la struttura del linguaggio ne
impone uno. Quando diciamo: “il lampo illumina” cadiamo nella trappola che il linguaggio ha teso
al nostro pensiero. E’ il linguaggio a spingerci a stabilire un autore – il lampo – e un’azione l’illuminare - come se fossero due stati diversi, mentre, di fatto, sono un solo evento. In forza del
linguaggio il lampo è divenuto qualcosa, un soggetto che compie un’azione. “Porre l’accadere
come un agire e l’effetto come un essere: è questo il duplice errore, o interpretazione, di cui ci
rendiamo colpevoli” (Frammenti postumi 1887-1888, 2 [84]).
E’ così che il nostro pensare si impiglia “nei lacci della grammatica (la metafisica popolare)” ( La
gaia scienza, (1882) § 354) quando vediamo dappertutto uomini che agiscono (soggetti), azioni
(verbi), effetti di cause (complementi oggetto). Per Nietzsche è il linguaggio stesso, coerentemente
con la sua origine, che impone l’essere all’esperienza del divenire. I mezzi espressivi del linguaggio,
infatti, “non servono per esprimere il divenire, ma l’essere, il permanere, il conservare (Frammenti
postumi 1879-1881, 11 [73]).
Un esempio di questa tendenza viene ravvisato in Cartesio: quando questi afferma “si pensa,
quindi c’è qualcosa che pensa” egli opera assecondando “la nostra abitudine grammaticale che fa
corrispondere a un fare uno che fa” (Frammenti postumi 1887-1888, 10 [158])
Nietzsche conclude la sua analisi sul feticismo della ragione con una frase ad effetto: “Temo che
non ci sbarazzeremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica” (Crepuscolo degli idoli, in
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 12
Opere, v.VI, t.III, p. 73). Vuol dire che la struttura di pensiero importata dalla lingua, almeno da
quelle di matrice indoeuropea, ci spinge a vedere sempre una causa (soggetto) che agisce (verbo)
producendo effetti (complemento oggetto). Se guardiamo un filo d’erba, il prato, la montagna, il
paesaggio intero e pensiamo al mondo e all’universo, ecco che scatta per ognuno di questi livelli di
realtà il meccanismo di ricerca della causa, indotto dal linguaggio: chi l’ha fatto? chi ne è l’autore?
se questo è l’effetto, quale ne è la causa? Per questa via si giunge a Dio, credendo alla grammatica.
Anche qui, con un radicale ricorso all’argomento del superfluo, Nietzsche spiega la usatissima via
ex causis alla esistenza di Dio. Ricordiamo che già Tommaso, nella sua seconda via, partendo
dall’esistenza di un ordine nel mondo, inferiva la necessità di una serie di cause, fino a giungere ad
una causa prima (non si può procedere all’infinito né una causa può essere prodotta dal suo
effetto) Per Nietzsche, tale modo di ragionare è semplicemente il frutto della gabbia linguistica in
cui opera il nostro linguaggio.
Nietzsche: il linguaggio e ragione
Nietzsche scrive il Crepuscolo degli idoli, ovvero come si filosofa col martello prima entro un più generale progetto di
stesura della Volontà di potenza, che non vedrà mai la luce, poi come testo a sé. Egli definisce questo materiale come
“la somma di tutte le principali eterodossie filosofiche”, una vera e propria opera di dissacrazione e svelamento dei
principali errori della filosofia e della cultura del suo tempo. In questo brano è la ragione ad essere presa di mira, ma
nell’analisi di Nietzsche le responsabilità del linguaggio sono rilevanti, al punto da fargli meritare l’epiteto di
“metafisica popolare”.
Stabiliamo finalmente al contrario in che diverso modo noi (- dico noi per cortesia ... ) consideriamo il problema
dell'errore e dell'apparenza. Una volta si prendeva la trasformazione, il cangiamento, il divenire in generale come
prova dell'apparenza, come indice che doveva esserci qualcosa a indurci in errore. Viceversa oggi, esattamente nella
misura in cui il pregiudizio della ragione ci costringe a stabilire unità, identità, durata, sostanza, causa, cosalità, essere,
ci vediamo in certo modo irretiti nell'errore, necessitati all'errore: per quanto si sia intimamente certi, sulla base di
una rigorosa verifica in noi stessi, che qui sta l'errore. E lo stesso di quel che accade nei movimenti delle grandi
costellazioni: nel caso di queste l'errore ha il costante patrocinio del nostro occhio, nel nostro caso invece ha quello
del nostro linguaggio. Il linguaggio, quanto alla sua origine, appartiene all'epoca della più rudimentale forma di
psicologia: noi entriamo in un grossolano feticismo se acquistiamo consapevolezza dei presupposti fondamentali della
metafisica del linguaggio, ossia, per esprimerci chiaramente, della ragione. Tale feticismo vede dappertutto uomini
che agiscono e azioni: crede alla volontà soprattutto come causa; crede all'«io», all'io come essere, all'io come
sostanza, e proietta la fede nell'io come sostanza in tutte le cose - soltanto in tal modo crea il concetto di «cosa» ... Il
pensiero introduce ovunque l'essere come causa, lo interpola in quanto tale; dal concepire l'«io» segue subito, come
derivato, il concetto di «essere» ... Al principio sta l'errore, grandemente funesto, che la volontà sia qualcosa di agente
-, che la volontà sia una facoltà ... Oggi sappiamo che essa è soltanto una parola ... Assai più tardi, in un mondo mille
volte più illuminato, la sicurezza, la soggettiva certezza nel maneggiare le categorie della ragione giunse
sorprendentemente alla coscienza dei filosofi: essi conclusero che queste non potevano avere un'origine empirica ma che anzi l'intera esperienza era in contraddizione con esse. Dove sta dunque la loro origine? - E in India come in
Grecia si è commesso lo stesso errore: «Dobbiamo già avere dimorato una volta in un mondo superiore ( - invece di
dire: in un mondo molto inferiore: ciò che sarebbe stata la verità), dobbiamo essere stati divini, giacché abbiamo la
ragione! » ... In realtà, nulla fino a oggi ha posseduto una più ingenua forza di persuasione che l'errore dell'essere,
come fu formulato, ad esempio, dagli Eleati: esso ha anzi a suo favore ogni parola, ogni frase che noi pronunciamo! Anche gli avversari degli Eleati soggiacquero alla seduzione del loro concetto dell'essere: tra gli altri Democrito,
quando escogitò il suo atomo ... La « ragione » nel linguaggio: ah, quale vecchia donnacola truffatrice! Temo che non
ci sbarazzeremo di Dio perché crediamo ancora alla grammatica ...
F. Nietzsche, il crepuscolo degli idoli, (1888) in Opere di Nietzsche, v.VI, t.III, pp. 72-73.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 13
5. La svolta linguistica nel Novecento
Il problema del linguaggio attraversa quasi tutte le principali correnti filosofiche del Novecento.
Filosofia della scienza, filosofia analitica, strutturalismo, ermeneutica, psicanalisi, per citare solo
alcuni settori di indagine, si concentrano sull’analisi del linguaggio con un’attenzione inedita. C’è
chi, come Richard Rorty (1931 -), ha parlato di "svolta linguistica" (linguistic turn) nella filosofia del
Novecento. Ma perché si sviluppa questo interesse e perché esso assume dimensioni così vaste?
Una risposta univoca è, ovviamente, impossibile, ma si possono avanzare alcune ipotesi.
1. Anzitutto nel nostro secolo prendono forma sempre più definita le scienze del linguaggio. Esse
sono la semantica, che permette l’interpretazione dei sistemi simbolici, la fonetica, cioè la scienza
dei suoni linguistici, la morfologia, lo studio delle forme linguistiche, la sintassi, cioè la disciplina
che studia la corretta combinazione di segni per produrre enunciati, la semiotica, cioè la teoria del
segno. Nei primi decenni del Novecento studiosi come Ferdinand de Saussure, Charles Sanders
Peirce (1839-1914) e Roman Jakobson (1896-1982), solo per citare i più noti, gettano le basi
teoriche che permettono uno studio scientifico del fenomeno linguistico.
2. Negli stessi anni, cioè all’inizio del secolo, matura una generale reazione alla tendenza
mentalistica di derivazione psicologista e neo-kantiana: da Gottlob Frege (1848-1925), a Bertand
Russell (1872-1970), a Ludwig Wittgenstein (1889-1951) prende il via uno studio del significato
inteso non più come analisi di un processo interiore, ma come indicazione delle condizioni di verità
(o falsità) degli enunciati. Il significato “esce dalla testa”, rendendo possibile analizzarlo in modo
nuovo.
3. Nel Novecento, poi, nascono o si sviluppano alcune correnti filosofiche fortemente
linguisticizzate, come la psicanalisi, l'ermeneutica, il neopositivismo: il loro “stile di indagine” e
l’agenda dei problemi affrontati saranno molto influenti per tutta la filosofia novecentesca.
Più in generale occorre ricordare che la cultura del XX secolo si sviluppa all’insegna della crisi, crisi
di valori, di risposte, di prospettive. In una cultura della crisi, in cui la verità sembra ancora più
sfuggente, è comprensibile che ci si ripieghi sulle condizioni della verità. L'involucro più esterno di
questa verità è, appunto, il linguaggio: si è accomunati nel modo di dire, anche se si è divisi sul
contenuto del detto.
4. Il linguaggio viene allora sempre più spesso considerato come un medium, nel senso latino del
termine: non solo, cioè, come strumento di comunicazione, ma anche come ambito, mondo,
ambiente in cui la comunicazione diventa possibile. L’attenzione al linguaggio mostra che un
accesso “immediato” all’essere o alla verità è impossibile. Nell’Ottocento il riferimento al
linguaggio serviva a illustrare il comune slancio verso il superamento della scissione, verso
l’Assoluto. Nel Novecento esso è piuttosto il segno di un’impossibilità, quella di abbracciare la
totalità dell'essere. Anche per questo le filosofie del linguaggio, pur nelle loro consistenti
differenze, portano ad una comune istanza anti-metafisica.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 14
5.1. La tesi Sapir-Whorf e il relativismo linguistico
Il grande sviluppo novecentesco dagli studi linguistici ha, evidentemente, comportato anche una
profonda diversificazione di approcci. Senza volerne rendere ragione qui, vale la pena ricordare
che proprio l’analisi linguistica ha portato ad un rinnovato interesse per quella integrazione tra
processi mentali e pratiche linguistiche da cui, almeno riferendoci a de Saussure, la linguistica
aveva preso le distanze. Punto di riferimento per questa nuova attenzione al rapporto tra pensiero
e linguaggio è la cosiddetta tesi Sapir-Whorf, dal nome dei due studiosi americani a cui si è soliti
riferirla.
Edward Sapir (1884-1939), antropologo e linguista, si riferisce spesso, nei suoi scritti, ad una
categorizzazione linguistica che diventa autonoma dall’esperienza, al punto da imporsi su di essa.
La realtà, egli sostiene, è in gran parte inconsciamente costruita sulle abitudini linguistiche del
gruppo. Ciò comporta che un cambiamento di lingua implichi un cambiamento di visione del
mondo. Con strumenti diversi e differente consapevolezza, riemerge qui la tesi di Karl Wilhelm von
Humboldt (1767-1835), secondo il quale la lingua costituisce una Weltanschauung, una visione del
mondo, da cui è possibile uscire solo per entrare nel cerchio di un’altra lingua.
L’allievo di Sapir, Benjamin Lee Whorf (1897-1941), studioso di lingue antiche americane, accentua
questa tesi giungendo a teorizzare la tesi del relativismo linguistico. Proprio lo sviluppo dell’analisi
linguistica, secondo Whorf, ha messo in luce che “ciascuna lingua non è soltanto uno strumento di
riproduzione per esprimere idee, ma […] dà forma alle idee, è il programma e la guida dell'attività
mentale dell'individuo, dell'analisi delle sue impressioni, della sintesi degli oggetti mentali di cui si
occupa” (Linguaggio, pensiero e realtà (1956), Boringhieri, Torino 1970, p. 169). Si inverte qui il
rapporto di causa-effetto tra esperienza e linguaggio: “Le categorie e i tipi che isoliamo dal mondo
dei fenomeni non vengono scoperti perché colpiscono ogni osservatore; ma, al contrario, il mondo
si presenta come un flusso caleidoscopico di impressioni che deve essere organizzato dalle nostre
menti, il che vuol dire che deve essere organizzato in larga misura dal sistema linguistico delle
nostre menti” (ibidem). Se la lingua struttura l’esperienza e il pensiero, allora una sensibile
variazione linguistica, per esempio la lingua degli indiani Hopi rispetto all’inglese, porta con sé una
consistente diversità concettuale. E’ questo il “principio di relatività, secondo cui differenti
osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fisici alla stessa immagine dell'universo, a meno che
i loro retroterra linguistici non siano simili, o non possano essere in qualche modo tarati” (ibidem,
p. 170). Whorf produce analisi molto ricche delle differenze categoriali presenti nelle lingue, per
esempio quella degli indiani Hopi confrontata con l’inglese o con le lingue di origine indoeuropea.
Strutture centrali, come quelle di tempo e o di azione, sono trattate con considerevoli diversità in
una lingua o in un’altra. Ma allora, è possibile tradurre in inglese la lingua Hopi? Per Whorf la
risposta è positiva e si basa su una generosa dose di buon senso. Ma non sempre, nella riflessione
filosofica, le soluzioni sono così accessibili.
5.2 Quine e l’esperimento della traduzione radicale
Un percorso simmetrico ma indipendente, seguito dalla riflessione filosofica circa il problema del
significato, porta un filosofo e logico come Willard van Orman Quine (1908-2001) a sostenere
l’impossibilità di distinguere una componente linguistica e una componente fattuale nell’analisi di
un enunciato. Come conseguenza di questo approccio, in Parola e oggetto (1960) Quine avanza
l’esperimento mentale di un linguista che, data una lingua a lui completamente sconosciuta,
parlata da una popolazione indigena con cui non ha avuto alcun contatto precedente, riceve
l’incarico di produrre un manuale di traduzione, dalla propria lingua a quella. Così, alla vista di un
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 15
coniglio che passa saltellando (questa è la situazione-stimolo), poiché l’indigeno pronuncia
“gavagai”, il linguista annota “coniglio” o “guarda, un coniglio”. Quando il linguista, in presenza di
una situazione-stimolo simile, sottopone all’indigeno l’enunciato “gavagai”, si aspetta di ottenerne
l’assenso o il dissenso. Nel primo caso l’ipotesi che “gavagai” significhi “coniglio” esce rafforzata.
Ma chi ci dice che gli oggetti cui il termine si applica siano proprio conigli, anziché semplici stadi, o
piccoli segmenti temporali di conigli? Quando il linguista passa alla conclusione che un gavagai è
un coniglio intero e perdurante, egli dà per scontato che l’indigeno sia abbastanza simile a noi da
disporre di un breve termine generale per conigli e di nessun breve termine generale per stadi o
parti di coniglio. Ipotizza, senza averne certezza, una somiglianza di schemi concettuali e di termini
che li rappresentano. Ma tale somiglianza non ha un fondamento certo: si limita a registrare un
comportamento favorevole – l’indigeno non smentisce l’associazione fatta dal linguista – ma
niente più di questo.
5.3 L’approccio analitico
Una diversa modalità di studio del linguaggio è quella che si suole contraddistinguere con “filosofia
analitica”. Essa rappresenta una concezione “per cui i problemi filosofici possono essere risolti (o
dissolti) riformando il linguaggio o ampliando la conoscenza del linguaggio” (R. Rorty, La svolta
linguistica (1967), Garzanti, Milano 1994, p. 29). Questo programma di ricerca si è sviluppato
inizialmente nell’università di Cambridge e poi a Oxford (da cui il nome di Cambridge-Oxford
Philosophy), per poi diffondersi in gran parte della filosofia anglosassone. Partendo da interessi di
tipo logico, ma anche etico, l’approccio analitico cerca nel linguaggio un terreno di indagine che
permette di affrontare problemi filosofici, di correggere fraintendimenti ed errori determinati da
un cattivo uso linguistico, in generale di elaborare una teoria del linguaggio e, in molti casi, anche
una connessa teoria cognitiva.
5.4 Wittgenstein e la filosofia come terapia linguistica
Alle spalle di questo approccio vi è la figura di Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Egli inaugura una
originale concezione tanto del linguaggio quanto della filosofia. Figlio di una ricchissima famiglia
viennese, studia ingegneria ma si interessa di logica e di fondamenti della matematica. Intelligenza
acutissima e personalità inquieta, affida la sua concezione della logica, del linguaggio e dell’etica
ad un breve testo, il Tractatus logico-philosphicus, che influenzerà moltissimo le discussioni del
Circolo di Vienna.
Fin dalle prime pagine Wittgenstein avverte che “la formulazione dei problemi filosofici si fonda
sul fraintendimento della logica del nostro linguaggio” (Tractatus logico-philosphicus (1921-1922),
Einaudi, Torino 1974, p. 3). Obiettivo del libro è tracciare un limite all’espressione dei pensieri,
studiando la forma logica del linguaggio, ma sapendo tuttavia che tale limite non può essere detto:
ciò significherebbe ammettere la possibilità di essere da entrambi i lati di tale limite. Invece, il
senso del libro è riassumibile così: “Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò, di cui non si può
parlare, si deve tacere” (ibid.). Il linguaggio, secondo Wittgenstein, può descrivere il mondo, ma
non le modalità con cui lo fa.
La struttura portante del linguaggio, secondo Wittgenstein, consiste nella proposizione. Essa è un
enunciato che rappresenta il sussistere o il non sussistere di stati di cose. Per questo può venire
detta vera o falsa. “Oggi è venerdì” è vera o falsa, a seconda della data in cui è espressa. Vi sono
proposizioni sempre vere (le tautologie, come “oggi è venerdì o non è venerdì”) o sempre false (le
contraddizioni, come “oggi è venerdì e non è venerdì”), ma ogni altra proposizione, se ha senso,
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 16
deve potersi dire vera o falsa, a seconda che essa descriva o no uno stato di cose. Il linguaggio è
quindi la totalità delle proposizioni (4.001) e la scienza è la totalità delle proposizioni vere (4.11).
L’uso corretto del linguaggio non è affatto scontato. Esso, infatti, “traveste i pensieri” (4.002),
soprattutto quando si fa filosofia: “Il più delle proposizioni e questioni che sono state scritte su
cose filosofiche è non falso, ma insensato (unsinnig). Perciò a questioni di questa specie non
possiamo affatto rispondere, ma possiamo solo stabilire la loro insensatezza” (4.003). E’ cioè
impossibile, per Wittgenstein, dire se “L’Assoluto esiste” è una proposizione vera o falsa: è
semplicemente insensata, perché non c’è un criterio per stabilire se descrive oppure no uno stato
di cose. Per questo i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo” (5.6)
Ma se la filosofia è un fraintendimento del linguaggio, essa non ha alcuna funzione? Al contrario, il
suo scopo è “la chiarificazione logica dei pensieri. La filosofia non è una dottrina, ma un’attività […]
Risultato della filosofia non sono “proposizioni filosofiche”, ma il chiarirsi di proposizioni” (4.112).
Come ci ricorda Wittgenstein, “non meraviglia che i problemi più profondi propriamente non siano
problemi (4.003).
Gli esponenti del Circolo di Vienna (Moritz Schlick(1882-1936), Otto Neurath (1882-1945), Hans
Hahn (1879-1934), Rudolf Carnap (1891-1970), per citare i più noti), impegnati com’erano a
determinare limiti e condizioni del discorso scientifico, trovarono in queste tesi una conferma del
loro atteggiamento antimetafisico. Per Schlick, il fondatore del circolo di Vienna, ” la filosofia non è
un sistema di conoscenze ma un sistema di atti; essa è infatti quell’attività attraverso la quale
viene stabilito e scoperto il senso delle proposizioni. Per mezzo della filosofia le proposizioni
vengono chiarificate, per mezzo della scienza vengono invece verificate” (Die Wende der
Philosophie, in Gesammelte Aufsätze, Vienna 1938, p. 36). Secondo Rudolph Carnap, tutte le
proposizioni della metafisica si rivelano, all’analisi logica, delle pseudo-proposizioni. E
precisamente in tali pseudo-proposizioni o compare una parola che erroneamente si ritiene abbia
un significato (Dio, Principio, Assoluto…), oppure termini che sono significanti ma che vengono
combinati in proposizioni che non hanno senso (“Il Nulla dipende dall’esistenza della negazione”).
L’analisi del linguaggio è quindi una terapia contro il suo cattivo uso: la filosofia deve proporsi non
come un sapere autonomo ma come attività terapeutica, che impedisca e curi i “crampi del
linguaggio” da cui derivano i falsi problemi della filosofia. L’orizzonte dell’analisi linguistica sta
disegnando un nuovo destino per la filosofia.
Nelle Ricerche filosofiche, pubblicate postume nel 1953, Wittgenstein si allontana da
un’impostazione prevalentemente logica del Tractatus, approdando ad una diversa concezione del
linguaggio, più attenta al contesto di enunciazione e all’uso che viene fatto delle parole e degli
enunciati. Partendo dalla riflessione su espressioni di uso comune e su forme di linguaggio non
strutturate ma funzionanti (per esempio fare un gestaccio a qualcuno), egli si sposta
progressivamente verso una concezione più aperta e liberalizzata, centrata sulla nozione di gioco
linguistico. Comandare e agire secondo il comando, descrivere un oggetto, costruirlo in base a un
progetto, riferire un avvenimento…, questi sono alcuni esempi di gioco linguistico.
Wittgenstein rimane fedele all’idea, presente già nel Tractatus, che parlare sia un’attività
governata da regole, ma tali regole, nelle Ricerche filosofiche, sono sempre più simili a quelle di un
gioco. Anche la teoria semantica ne esce cambiata: il significato di un termine è il suo uso nel
linguaggio (Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1974, § 43). Ciò vuol dire che per determinarlo
occorre capire le condizioni in cui un termine è utilizzato, il gioco in cui appare, la forma di vita in
cui lo è utilizzato.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 17
Da un’idea regolare e purificata del linguaggio si va verso un’immagine più realistica e variegata: “il
nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città: un dedalo di stradine e di piazze,
di case vecchie e nuove, e di case con parti aggiunte in tempi diversi; e il tutto circondato da una
rete di nuovi sobborghi con stradine diritte e regolari, e case uniformi” (ivi, § 18).
La svolta pragmatica della teoria dei giochi linguistici, oltre a rendere plurali le regole del rapporto
tra parole e cose, sposta l’attenzione dai linguaggi formalizzati al linguaggio ordinario.
Wittgenstein: i giochi linguistici
Le Ricerche filosofiche sono il testo a cui Wittgenstein lavorò fino alla morte, avvenuta nel 1951, senza tuttavia
giungere a vederlo concluso e pubblicato. Il contenuto del libro è anticipato dai due quaderni di appunti, il Libro blu e il
Libro marrone, relativi ai suoi corsi a Cambridge nel 1933-35. Determinante è la nuova concezione di linguaggio, non
più raffigurativo, come nel Tractatus, non più sistema, come nella Grammatica filosofica, ma inteso a partire dalla
nozione di gioco, cioè un sistema di regole variabile e contestuale, socialmente condiviso e quindi non arbitrario.
Ma quanti tipi di proposizioni ci sono? Per esempio: asserzione, domanda e ordine? Di tali tipi ne esistono
innumerevoli: innumerevoli tipi differenti d’impiego di tutto ciò che chiamiamo “segni”, “parole”, “proposizioni”. E
questa molteplicità non è qualcosa di fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi giuochi
linguistici, come potremmo dire, sorgono e altri invecchiano e vengono dimenticati. (Un’immagine approssimativa
potrebbero darcela i mutamenti della matematica.)
Qui la parola “giuoco linguistico” è destinata a mettere in evidenza il fatto che il parlare un linguaggio fa parte di
un’attività, o di una forma di vita.
Considera la molteplicità dei giuochi linguistici contenuti in questi (e in altri) esempi:
Comandare, e agire secondo il comando.
Descrivere un oggetto in base al suo aspetto o dimensioni.
Costruire un oggetto in base a una descrizione (disegno).
Riferire un avvenimento
Far congetture intorno all’avvenimento
Elaborare un’ipotesi e metterla alla prova.
Rappresentare i risultati di un esperimento mediante tabelle e diagrammi.
Inventare una storia; e leggerla.
Recitare in teatro.
Cantare in girotondo.
Sciogliere indovinelli.
Fare una battuta; raccontarla.
Risolvere un problema di aritmetica applicata.
Tradurre da una lingua in un’altra.
Chiedere, ringraziare, imprecare, salutare, pregare.
E’ interessante confrontare la molteplicità degli strumenti del linguaggio e dei loro modi d’impiego, la molteplicità dei
tipi di parole e di proposizioni, con quello che sulla struttura del linguaggio hanno detto i logici. (E anche l’autore del
Tractatus logico-philosophicus)
L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1953, trad. it. Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1968, § 23.
L’approccio ontologico
5.5 Heidegger e il linguaggio come dimora dell’Essere
Una prospettiva ancora diversa nell’analisi del linguaggio viene dalla tradizione ermeneutica,
legata ad autori come Martin Heidegger (1889-1976) e Hans Georg Gadamer.
Questa linea di riflessione prende le mosse, nel Novecento, dall’impostazione del problema
dell’essere che Heidegger delinea nelle pagine di Essere e Tempo (1927). Qui, nel quadro di una
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 18
articolata analisi delle strutture esistenziali, l’uomo, cioè l’Esserci (Dasein), appare come l’unico
ente che si pone il problema del senso dell’Essere, che si interroga cioè su che cosa significhi
“ente” ed “essere” e su che rapporto intercorra tra i due. Da tale analisi emerge una delle tesi
fondamentali di Heidegger, cioè che l’Essere, nella tradizione occidentale, dalla metafisica greca
fino a noi, viene pensato come cosa, ente, semplice-presenza. Questa analisi assume sempre più
importanza nelle opere di Heidegger, fino a diventarne il tema dominante: “Già sempre l’uomo si
attiene innanzitutto e solamente all’ente; e anche se, quando si rappresenta l’ente come ente, il
pensiero si riferisce in effetti all’Essere, in verità esso pensa sempre e solo l’ente come tale e mai
l’Essere come tale. La «questione dell’Essere» rimane sempre la questione dell’ente” (Lettera
sull’«umanismo» (1947), in Segnavia (1976), Adelphi, Milano 1987, p. 284).
Emerge così la tesi che accompagnerà Heidegger fino agli ultimi scritti, cioè una riflessione sul
darsi dell’Essere che coinvolge, in modo decisivo, il tema del linguaggio. Heidegger stesso
riconoscerà come un difetto fondamentale di Essere e Tempo l’aver trascurato il rapporto tra
linguaggio e essere. Ma perché tale rapporto è così decisivo?
Per Heidegger, a partire dalla filosofia classica, una millenaria esperienza ha travolto il linguaggio
nella sua autenticità, per privilegiarne solo un aspetto: la pura funzione di rimando alle cose.
Dietro questo travisamento si cela quello che per Heidegger è l'errore metafisico classico: il
dominio della semplice-presenza. Ma quale sarà il ruolo di un linguaggio che non venga
considerato nei termini della presenza?
Il linguaggio, per Heidegger, nella sua essenza non è né espressione né attività dell’uomo. Il
linguaggio parla (Die Sprache spricht). Esso non è uno strumento che l’uomo può prendere e
lasciare; non ne ha padronanza, perché non è l’uomo che parla il linguaggio, ma è il linguaggio che
parla l’uomo. Ciò avviene perché esso, in particolare nel dire poetico, preserva e mostra l’Essere,
non come qualcosa che si possegga, ma come qualcosa che si mostra e si sottrae. Da qui deriva
anche il ricorso, tutto heideggeriano, a profonde e talvolta spericolate etimologie, che illustrano
come, in un senso nascosto e quasi cancellato dall’uso, alcuni termini conservino la loro essenza
originaria, il rimando alla verità di ciò che indicano.
“Il linguaggio parla - scrive Heidegger-. Noi cerchiamo ora il parlare del linguaggio nella poesia. Ciò
che si cerca è, pertanto, racchiuso nella poeticità della parola” (In cammino verso il linguaggio
(1959), Mursia, Milano 1973, p. 33). Il linguaggio è la dimora dell’Essere e qui abita l’uomo. Ne
deriva un atteggiamento diverso da quello dominante nella metafisica classica, nella tecnica
moderna, in generale nella cultura contemporanea. L’uomo non parla per governare le cose
attraverso il linguaggio, né parla per realizzare un modello scientifico di verità, intesa come
corrispondenza tra soggetto e oggetto. Semmai è chiamato ad ascoltare e rispondere ad un
appello che l’Essere gli invia attraverso la parola dei poeti. Solo in questa apertura si dà una verità
autentica, perché la verità, seguendo l’etimologia della parola greca, è a-létheia, dis-velamento,
uscita dal nascondimento.
5.6 Gadamer: “l’essere che può venir compreso è linguaggio”
Hans Georg Gadamer (1900-2001) è l’autore che ha diffuso, articolato storicamente e rielaborato
teoreticamente le intuizioni fondamentali di Heidegger relativamente all’ermeneutica. L’idea per
cui ogni nostra comprensione muove da una pre-comprensione, presente in Essere e Tempo, viene
sviluppata e approfondita nel capolavoro del filosofo di Marburgo, Verità e Metodo (19601-19652).
L’ermeneutica contemporanea si precisa sullo sfondo dell’estetica, della storia, della filosofia greca
e tedesca, delle scienze dello spirito, ma soprattutto del linguaggio, che domina tutta la terza
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 19
parte dell’opera. Il linguaggio, per Gadamer, è il medium della comprensione, (Verità e Metodo
(1960), Bompiani, Milano 1990, p. 542), non nel senso dell’essere uno strumento, ma nel senso di
rappresentare l’ambito intrascendibile in cui si danno il pensiero e l’esperienza. “La lingua è
soprattutto nessuno strumento, nessun utensile, poiché è essenziale per lo strumento che noi ne
padroneggiamo l'uso e cioè che possiamo prenderlo in mano e lasciarlo quando non serve più […]..
Noi piuttosto siamo presi dalla lingua, che è propriamente nostra, in tutto il nostro sapere, in tutto
il sapere del mondo. Noi cresciamo, impariamo a conoscere il mondo, impariamo a conoscere gli
uomini e infine noi stessi, mentre impariamo a parlare. Imparare a parlare non significa: essere
introdotti alla raffigurazione del mondo a noi familiare e conosciuto nell'uso di uno strumento a
portata di mano, ma significa acquistare conoscenza e familiarità col mondo stesso, così come
esso ci incontra” (Ermeneutica e metodica universale, Marietti, Torino 1973, pp. 110-111). Nel
linguaggio si esprime la natura dialogica della comprensione, dell’intendere e dell’intendersi. Ma
si esprime anche l’azione della storia, la tradizione di testi che ci precedono e ci determinano, il
cammino di culture e uomini che hanno costituito un orizzonte di senso in cui ancora abitiamo.
Uscito dall’evocazione poetante di Heidegger, l’essere si determina come storia, discorso,
orizzonte di senso in cui le cose ci appaiono manifeste. Per questo, secondo Gadamer, “l’essere,
che può venir compreso, è linguaggio” (Verità e Metodo, p. 542). Non perché in esso l’essere trovi
un limite invalicabile, un condizionamento che non si riesce a superare. Al contrario, l’essere che
possiamo comprendere è linguaggio perché solo nel linguaggio si realizza l’esperienza umana della
comprensione, del sentirsi parte di un più vasto e precedente orizzonte.
6. Conclusioni
Che si indaghi l’origine e le strutture proprie del linguaggio, come nella linguistica, o che si ricerchi
il modo in cui il linguaggio ordinario plasma e talvolta confonde i nostri pensieri, come nella
filosofia analitica, o che si intenda il linguaggio come dimora dell’Essere, come nell’ermeneutica, in
ogni caso la svolta linguistica appare più un esproprio che una conquista.
L’uomo si trova sempre più in balia di questo medium in cui naviga ma anche, talvolta, naufraga.
Non per colpa solo del linguaggio, ovviamente. Semmai questa crisi del soggetto è una tendenza
generale del pensiero novecentesco, a cui la riflessione linguistica dà il suo contributo importante,
ma non unico.
Analogamente emerge una concezione di linguaggio come sistema strutturato, storicamente
determinato, pervasivo e condizionante, ma soprattutto intrascendibile.
La riflessione sul linguaggio crea anche le premesse per una migliore capacità di gestione della
differenza e di incontro tra culture diverse.
Ma, oltre a ciò, appare la consapevolezza che dalla riflessione sul linguaggio emerge una più
autentica visione dell’uomo e una più profonda concezione della verità.
Paolo Vidali – Filosofia del linguaggio – Corsi di cultura del “Quadri” - maggio 2011 – p. 20