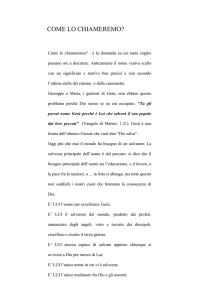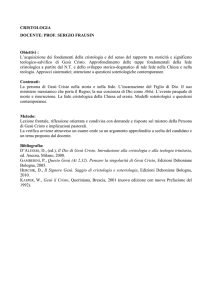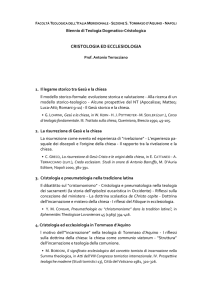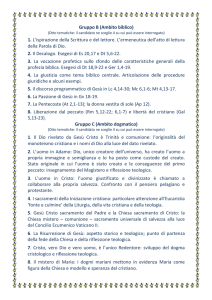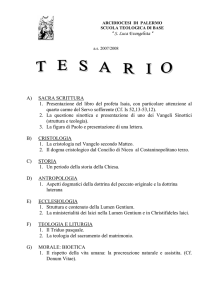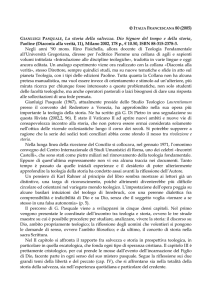Salvezza a norma di legge
Se, come ci dice Benedetto XVI, «all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione
etica» (Deus caritas est), allora è bene riflettere su una fede che si fa largo a colpi di
legalismo e moralismo.
di Danilo Castello
L’idea che missione significhi salvare le anime ed estendere la chiesa ha sempre goduto – e
continua tutt’oggi a godere -, se non di una piena approvazione almeno di una relativa tolleranza da
parte di molti. Questa visione teologica affonda le sue radici storiche in una provincia dell’impero
romano: il Nord Africa. Qui è nato un cristianesimo dalla fisionomia coriacea ed esclusivista.
Cartagine fu la patria di Tertulliano, probabilmente un uomo di legge, uno dei più influenti
pensatori cristiani di tutti i tempi, al quale può essere attribuita l’origine di questo potente tipo di
teologia. Le sue opere, pensate con mentalità giuridica, rappresentano una radicale romanizzazione
del messaggio cristiano.
Le caratteristiche di questa teologia s’individuano in una parola: diritto, il grande dono di Roma
all’Occidente. Negli scritti di Tertulliano, Dio è descritto come legislatore e giudice. Sotto l’influsso
di questa teologia, il “giorno della venuta del Signore”, sospirato dai primi cristiani nella loro
invocazione liturgica in lingua aramaica, “Maràna tha” (Signore, vieni”), si trasforma nel giorno
del giudizio. Nel Medioevo, questa visione troverà il suo inno corrispondente nel Dies irae, dies illa
(“giorno d’ira quel giorno”), che per secoli sarebbe risuonato nelle chiese cristiane.
Clima di rassegnazione, più che di gioiosa attesa. I più anziani tra noi sono cresciuti in questa
mentalità di paura, nel timore di essere “colti in fallo” dall’occhio di Dio, che tutto vede e tutto
scruta, pronto a punire là dove c’è colpa. Gesù viene raffigurato come il “nuovo Mosè” e il Vangelo
è la “nuova legge”.
Questa concezione della vita cristiana ha dominato per secoli la teologia scolastica medioevale e la
maggior parte della teologia cattolica. Dai tempi dell’imperatore Costantino fino a tutto il 19°
secolo la chiesa, nonostante le molte riforme e i molti cambiamenti nella società, ha assunto una
caratteristica ben definita. Molte delle pretese della chiesa ebbero la loro origine dal fatto che il
cristianesimo diventò religione di stato; dopo Costantino, la legislazione di Teodosio e Giustiniano
consolidò il sostituirsi della chiesa all’impero romano nella società.
CRISTO HA “PAGATO” PER TUTTI
All’interno di questo orientamento teologico non c’è posto per la domanda che inquieta alcuni
settori della teologia contemporanea della missione, e cioè se e fino a che punto la persona e l’opera
di Gesù siano l’unico modo in cui Dio offre la salvezza all’umanità.
Riguardo alla persona di Gesù, la tendenza è quella di focalizzare l’attenzione sulla sua realtà di
“Figlio eterno”, più che sul significato del Gesù storico e sulla rilevanza della sua vita e del suo
messaggio. Le implicazioni per la missione sono di vasta portata.
L’opera salvifica di Gesù viene pensata in termini legalistici. Tertulliano introdusse la parola
“soddisfazione” che nel diritto romano significava “fare ammenda” per non aver tenuto fede a un
obbligo, o addirittura impartire o ricevere una punizione. Ma fu Anselmo di Canterbury a sviluppare
questa dottrina nel modo che, nell’espressione teologica successiva, avrebbe raggiunto uno status
quasi normativo. Per Anselmo, che faceva teologia nel contesto del diritto germanico tradizionale,
la morte di Gesù in croce “rende soddisfazione” a Dio per l’offesa infinita commessa con la
disobbedienza di Adamo. La redenzione è stata conseguita – diceva San Bernardo di Chiaravalle –
attraverso il sangue e non solo attraverso la parola di Gesù. Neppure la risurrezione è tanto
importante quando questo momento di soddisfazione e di vittoria divina sul demonio.
Questa redenzione “oggettiva” è stata realizzata una volta per tutte sulla croce. La redenzione
“soggettiva”, invece, è compito di ogni singolo individuo e può avere luogo solo attraverso lo
sforzo d’imitare la vita di Cristo.
Nella discussione cristologica odierna, che ha luogo nel contesto del pluralismo delle religioni
mondiali, si distinguono comunemente tre posizioni: una cristologia esclusiva, che confessa Gesù
come unico salvatore; una cristologia inclusiva, che concepisce la grazia di Dio in Cristo come
implicitamente presente in altre vie religiose; una cristologia pluralista, che riconosce in Gesù
semplicemente “una” delle tante vie di salvezza.
Evidentemente, una scuola teologica dominata da un forte giudaismo si sente più a proprio agio
con la posizione esclusivista. Sebbene nella chiesa sia sempre esistita una vigorosa tradizione che
preferisce adottare una più modesta cristologia inclusiva, vi è sempre stata una forte tradizione
secondo cui, senza la fede esplicita in Cristo, non c’è speranza di salvezza. Tale, ad esempio, era la
tradizione che alimentò lo zelo missionario di Francesco Saverio e quello di innumerevoli
missionari dei secoli 18° e 19°. Secondo questa cristologia, obiettivo dell’opera missionaria era
“salvare le anime” e “impiantare la chiesa”, che avrebbe portato avanti l’opera di “salvare i poveri
pagani”.
Chi sottoscrive una concezione esclusivista del ruolo di Cristo nella storia della salvezza considera
futili o pericolosi gli attuali sforzi di dialogo interreligioso: futili, perché ritengono di non avere
nulla da imparare da tale conversazione e cooperazione; pericolosi, perché tali sforzi fanno violenza
all’imperativo della testimonianza biblica.
NESSUNA SALVEZZA FUORI DELLA CHIESA
La chiesa è l’unico agente – o la “via ordinaria” – della fede in Cristo. Il detto attribuito a
Cripriano – “Extra ecclesia nulla salus” – deve essere inteso in senso del tutto letterale. Nella forma
più estrema in cui lo espresse Bonifacio VIII, la salvezza è possibile solo a coloro che si
sottomettono all’autorità del Papa. La durezza di questa affermazione fu attenuata, e addirittura
negata, in documenti romani successivi. Nel Vaticano II la frase non è stata neppure usata.
Ciononostante, nell’enciclica Redemptoris missio (“la missione del Redentore”) del 1991, Giovanni
Paolo II ammonisce che «il dialogo deve essere condotto e attuato con la convinzione che la chiesa
è la via ordinaria di salvezza e che solo essa possiede la pienezza dei mezzi di salvezza» (RM 55).
Trattandosi di una ecclesiologia che ha una concezione istituzionale della chiesa (e le istituzioni
sono notoriamente lente a permettere o a promuovere il cambiamento), l’idea che altre culture – o
tempi nuovi – possano elaborare strutture differenti o migliorare quelle attuali è quasi
inammissibile. Nonostante l’esortazione a rispettare i costumi e gli usi locali, rivolta nel 1659 ai
missionari dell’appena istituita Propaganda Fide, la maggior parte dei missionari duplicarono le
strutture della chiesa europea, con la sua liturgia, la sua architettura ecclesiastica e spesso anche la
sua lingua.
Un terzo tratto dell’ecclesiologia di questo tipo di teologia – che qui è necessari citare – è il
rapporto della chiesa con il Regno di Dio. Per il modello istituzionale la chiesa s’identifica
fondamentalmente con il Regno. Durante il suo ministero terreno Gesù annunciò, servì e testimoniò
il Regno di Dio, ma questo ha trovato il suo compimento nell’istituzione della chiesa. Dunque, la
pienezza della salvezza offerta da Dio è rinvenibile soltanto dentro i confini della chiesa. Ciò che la
chiesa attende alla fine dei tempi è il completo insediamento di sé medesima in ogni luogo e la
conversione di tutti i popoli ai suoi ranghi. E qui tocchiamo la terza costante della missione:
l’escatologia.
IN ATTESA DEL GIUDIZIO DI DIO
L’escatologia viene articolata solitamente da due prospettive diverse: da una prospettiva, ci si
concentra sull’eschaton, cioè “il tempo finale” (escatologia generale); da un’altra, si riflette sulle
cosiddette “cose ultime”: morte, giudizio, inferno e paradiso. La prima prospettiva riguarda
l’umanità in generale, la seconda si riferisce al destino di ogni individuo.
I cristiani medioevali, in particolare, erano molto preoccupati degli interrogativi escatologici
riguardanti la morte, il giudizio, il paradiso, l’inferno e il purgatorio, ed è alla loro vivida
immaginazione, espressa nella sua forma migliore nella poesia e nella teologia tardo-medioevale di
Dante, che dobbiamo molte delle nostre immagini e gran parte del linguaggio dottrinale odierno. Ci
riferiamo al grande terrificante poema, adoperato sino alla riforma della liturgia cattolica degli anni
’60 del secolo scorso, rappresentato dalla sequenza della messa per i defunti. I cristiani sono stati
fortemente motivati dalle dottrine dell’escatologia individuale. Nella letteratura periodica e
devozionale esistono migliaia di libri, trattati e articoli che invitano gli uomini e le donne a dedicare
la propria vita a salvare la maggior parte dell’umanità dal fuoco dell’inferno e dalla punizione
eterna. Anche se i missionari non erano motivati dall’arcigna credenza del Dies irae, certamente
erano sospinti dall’idea di persone innocenti, e tuttavia “ignoranti”, che bruciavano nell’inferno solo
perché qualcuno non aveva condiviso con loro il messaggio di Gesù.
La forma mentis di questa teologia, impregnata di moralismo, vede gli esseri umani come irretiti
nel peccato e, dunque, se lasciati a se stessi, destinati alla dannazione eterna. È mediante l’opera
espiatrice, redentrice di Cristo, partecipabile solo nella chiesa, che le persone sono “liberate” e
messe in grado di vivere nei modi che garantiscono loro la vita eterna. La salvezza è qualcosa che si
acquisisce al di là della morte e al di fuori di questo mondo. In altre parole, non c’è nessuna
percezione che la salvezza, in quanto tale, includa un rinnovamento strutturale politico e cosmico.
Sotto l’influsso sempre più forte dell’idea di “soddisfazione vicaria” di Anselmo, in Occidente la
teologia giunse a concepire la salvezza come redenzione dell’anima individuale nell’aldilà:
redenzione che sarebbe entrata in vigore in occasione dell’apocalisse in miniatura, costituita dalla
morte del singolo credente.
QUALE ANTROPOLOGIA?
Se la concezione della salvezza è fondamentale per il modo di fare missione, anche la concezione
della natura dell’umanità è determinante nelle sue implicazioni. Accenno soltanto alle implicazioni
che derivano per la missione da un istinto teologico che ha come base antropologica l’ordinamento
gerarchico degli esseri umani, sullo sfondo della struttura giuridica della società romana. Quando
gli orizzonti del mondo si sono allargati, questa concezione gerarchica passò negli atteggiamenti di
superiorità del mondo occidentale verso gli altri popoli. Quando i missionari, permeati di questa
teologia, andavano ad annunciare il Vangelo, portavano con sé il sentimento della propria
superiorità e un atteggiamento paternalistico nei confronti degli altri cui erano stati mandati. Questo
diffuso e inconscio atteggiamento paternalistico e di superiorità ha mortificato e represso
enormemente lo sviluppo e la diffusione del Vangelo. Basta leggere le 82 pagine di appunti scritte
da padre Paolo Manna (1872-1952) durante un viaggio intorno al mondo, nel 1929, per visitare le
missioni dell’istituto di cui era superiore generale (per molti anni, lo scritto giacque inedito negli
archivi di Propaganda Fide, fino al 1997, quando fu pubblicato integralmente con il titolo
Osservazioni sul metodo moderno di evangelizzazione).
Questa gerarchia vigeva persino all’interno della chiesa. Graziano (fine 11° sec.-1150), nel suo
Decretum, scrisse che ci sono due generi di cristiani e sancì la superiorità del clero (“gli eletti da
Dio”) dai laici (la massa): «Esistono due specie di cristiani. La prima è votata all’ufficio divino; si
consacra alla contemplazione e alla preghiera e conviene che viva lontano dai rumori del mondo. Si
tratta dei chierici, che sono votati a Dio. In greco, infatti, kléros significa “sorte”; questi uomini
sono chiamati chierici perché sono eletti dalla sorte. Dio li ha scelti. Sono dei re perché dominano e
regnano sugli altri con le virtù. Il loro regno è di Dio, e questo è indicato da una corona sul capo.
(…) Altra specie di cristiani sono i laici. Laòs, infatti, significa “popolo”. A costoro è concesso
possedere beni temporali, ma soltanto per i bisogni necessari. Non vi è nulla di più miserevole che
spregiare Dio per il denaro. Sono autorizzati a contrarre matrimonio, coltivare la terra, dirimere
controversie, difendere la propria causa, e pagare le decime: possono così essere salvati, purché
evitino i vizi nel fare il bene».
Da un punto di vista culturale, questa impostazione teologica portava i missionari, a parte
significative eccezioni (le disposizioni di Papa Gregorio Magno per gli anglosassoni, la
dichiarazione di Propaganda Fide del 1659, gli esempi di De Nobili e Valignano in India e di
Matteo Ricci in Cina), ad adottare l’approccio della tabula rasa: la cultura locale doveva essere
accantonata.
TRE INSIDIE
Questa forma mentis, imbevuta di filosofia stoica e di categorie giuridiche romane, che
nell’arco di due millenni di cristianesimo ha fornito a milioni di cristiani la motivazione per
sopportare privazioni incredibili e rischiare la propria vita perché il mondo potesse credere ed essere
salvato, nasconde nel suo seno tre insidiosi atteggiamenti.
Legalismo – La spiritualità che anima questa corrente teologica è dominata da una eccessiva
attenzione all’osservanza esteriore, con tutte le conseguenze che ne possono derivare (in termini
anche di un celato fariseismo). Benedetto XVI nel suo Gesù di Nazareth (Rizzoli 2007) non esita a
qualificare questo cristianesimo come «di facciata». È un illusorio tentativo dell’uomo di cercare la
salvezza nell’osservanza della legge, nella disperata ricerca di sicurezze. La legge impersonale
viene come idolatrata per mettersi al sicuro. Siamo agli antipodi del Vangelo di Paolo, per il quale
ha lottato per tutta la vita, e non solo tra i Galati. Paolo ripete con forza che non c’è un altro
Vangelo.
L’umanesimo pelagiano di cui è impregnata questa visione teologica apre la strada a una
seconda insidia: il volontarismo, ovvero il prometeico sforzo di costruirsi la salvezza con le proprie
mani. Questo atteggiamento fa leva sulla forza della volontà. Sotto questa vernice di cristianesimo è
percepibile la concezione stoica della vita. Il cambiamento radicale di mentalità (metànoia) non è
ancora avvenuto. Non si può guardare a Cristo solo come a un “buon esempio” da imitare. Tutto
sommato, si ha l’impressione di non essere ancora entrati nella dinamica dell’amore. Facile,
pertanto, rimanere impigliati nelle reti di un tormentato moralismo, nella esasperata ricerca della
perfezione.
Moralismo – Albert Camus, nei suoi Taccuini, scrive «Bisogna incontrare l’amore, altrimenti è
lo strazio. La grandezza non viene da continui ripiegamenti su di sé, ma, a Dio piacendo, arriva
come una bella giornata». Se non si capisce questo, si lasciano sopravvivere tendenze
veterotestamentarie e farisaiche. E ciò è ben poco liberante e può condurre a un cristianesimo fatto
di pratiche esteriori, e a imporre agli altri pesi che nemmeno noi riusciamo a portare. Sarebbe la
versione cristiana di quel proselitismo che Gesù ha duramente condannato.