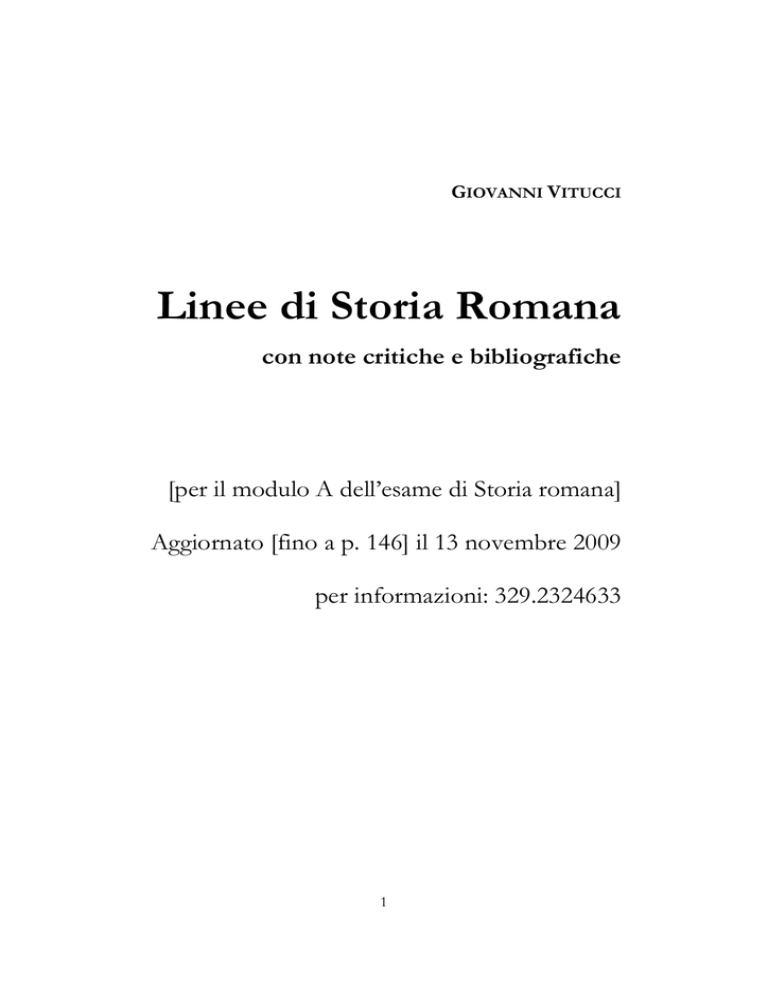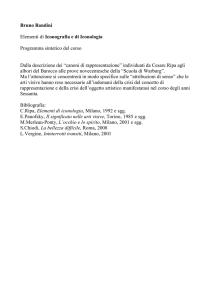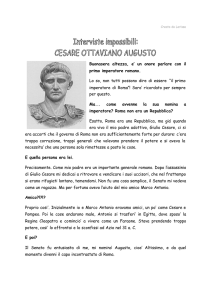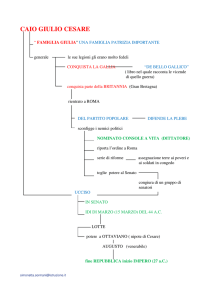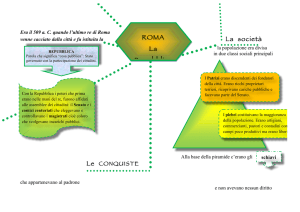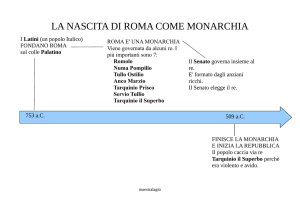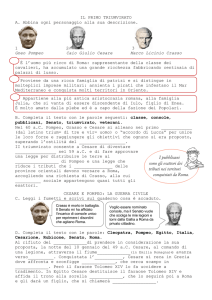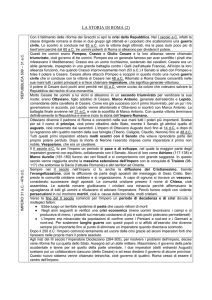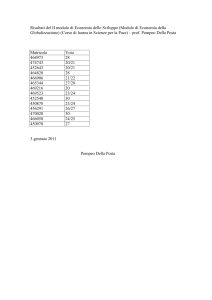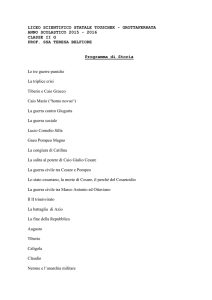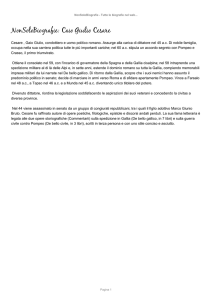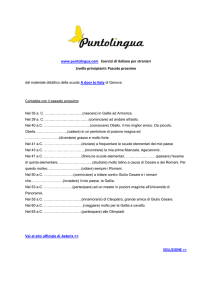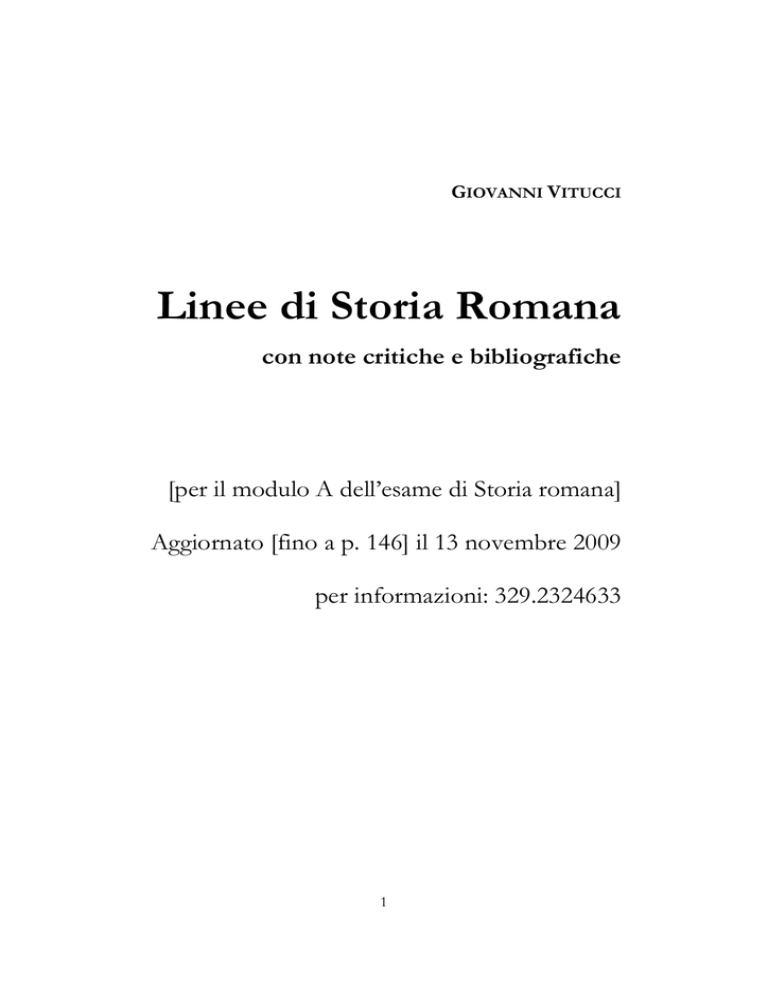
GIOVANNI VITUCCI
Linee di Storia Romana
con note critiche e bibliografiche
[per il modulo A dell’esame di Storia romana]
Aggiornato [fino a p. 146] il 13 novembre 2009
per informazioni: 329.2324633
1
SOMMARIO
I. Il Lazio e Roma. L’età regia
1. Le popolazioni dell’Italia preromana, 5.
2. Gli Etruschi, 6.
3. I Latini, 7.
4. La Roma primitiva e i suoi ordinamenti, 8.
5. Evoluzione dell’istituto regio e avvento della repubblica, 11.
II. La repubblica sotto il predominio dei patrizi
1. I primi rapporti politici con Cartagine e il ritorno degli Etruschi, 18.
2. Le città latine e Roma, 19.
3. Lotte contro i Sabini, gli Equi e i Volsci, 21.
4. Guerre con gli Etruschi, 22.
5. Colonie romane e colonie latine. Origini del ‘diritto latino’, 24.
6. Il predominio politico e religioso dei patrizi sopra i plebei, 25.
7. Ordinamenti del più antico stato repubblicano, 28.
8. Le rivendicazioni della plebe e i suoi primi successi, 30.
III. Dall'incendio gallico al primato nell'Italia centrale
1. Il disastro e la ricostruzione, 37.
2. I Sanniti e il loro primo conflitto con Roma, 40.
3. Insurrezione e scioglimento della lega latina, 41.
4. La seconda guerra sannitica, 44.
5. La terza guerra sannitica e l’ampliarsi della federazione romanoitalica, 46.
IV. Il regime nobiliare patrizio-plebeo. Il controllo dell'Italia
meridionale
1. Conclusione delle lotte fra plebe e patriziato, 50.
2
2. Introduzione della costituzione ‛serviana’, 52.
3. La nuova nobilitas patrizio-plebea, 55.
4. Taranto e Roma, 56.
5. Pirro in Italia, 58
6. Pirro in Sicilia e il definitivo fallimento della sua impresa, 61.
7. Importanza dell'espansione nell’Italia meridionale. Sviluppo
economico e progresso civile, 63.
V. Roma e Cartagine
1. Dall'amicizia al conflitto, 67.
2. Gli sviluppi della prima guerra punica, 69.
3. Conseguenze della guerra in Roma e in Cartagine, 70.
4. I Romani oltre l’Adriatico e nell'Italia settentrionale, 72.
5. Origini della seconda guerra punica, 74.
6. Dal Ticino a Canne, 76.
7. Da Canne al Metauro, 79.
8. Annibale e Scipione, 81.
VI. Militarismo e imperialismo. Dall'espansione in Oriente alla
distruzione di Cartagine
1. Il conflitto con la Macedonia e il protettorato sulla Grecia, 87.
2. Roma e l'impero siriaco, 89.
3. La dissoluzione della monarchia macedone e il predominio sulla
Grecia, 91.
4. L'assoggettamento della Macedonia e della Grecia, 93.
5. La penetrazione nell'Italia settentrionale e nella Spagna, 94.
6. La terza guerra punica, 96.
7. Trionfo del conservatorismo. Catone e Scipione, 98.
8. Squilibrio economico e società in fermento, 100.
9. Cultura greca e humanitas romana, 102.
VII. La crisi del regime nobiliare. Dai Gracchi alla guerra sociale
1. Ripercussioni interne delle grandi conquiste, 107.
2. Il tribunato di Tiberio Gracco, 108.
3. Dal programma conservatore di Tiberio a quello rivoluzionario di
Gaio Gracco, 111.
4. L’azione politica di Gaio Gracco, 112.
5. Reazione nobiliare e sopravvivenza delle istanze graccane, 114.
6. Giugurta e l’ascesa di Gaio Mario, 116.
7. I Cimbri e i Teutoni. La gloria di Mario, 120.
8. Inasprimento della lotta politica. Eclissi di Mario, 121.
9. L'agitazione degli Italici e la guerra sociale, 122.
VIII. Le guerre civili: Mario, Sulla, Pompeo
1. Il pronunciamento di Sulla, 127.
3
2. La sedizione di Cinna e la vendetta di Mario, 129.
3. Le imprese di Sulla in Oriente, 130.
4. Il ritorno di Sulla, 132.
5. Dittatura e riforme antidemocratiche di Sulla, 133.
6. Ripresa delle forze democratiche. Sertorio e la resistenza in Spagna,
135.
7. Mitridate, Spartaco e l’ascesa di Pompeo, 137.
8. Fine di Mitridate e potenza di Pompeo, 139.
IX. Il declino della repubblica e la monarchia di Cesare
1. Le ambizioni di Crasso e gl'inizi di Cesare, 144.
2. La congiura di Catilina e l’effimero trionfo di Cicerone, 146.
3. Dal ritorno di Pompeo al ‘primo triumvirato’, 148.
4. Le prime campagne di Cesare nelle Gallie, 150.
5. Torbidi in Roma. Rinnovamento dell’intesa fra i ‘triumviri, 152.
6. Conquista e romanizzazione delle Gallie, 153.
7. Fine di Crasso e inizio della lotta fra Cesare e Pompeo, 155.
8. Dal Rubicone alla morte di Pompeo, 158.
9. Il potere monarchico di Cesare e le idi di marzo, 161.
X. Conclusione delle guerre civili. Il principato augusteo
1. Dalla morte di Cesare al triumvirato di Lepido, Ottaviano e Antonio,
167.
2. Rotta degli anticesariani e rivalità fra i triumviri, 169.
3. Il duello conclusivo fra Ottaviano e Antonio, 172.
4. Ottaviano ‘Augusto’ e ‘principe’ dell'impero, 174.
5. Compromesso tra vecchio e nuovo regime nelle riforme augustee,
176.
6. Pacificazione e riordinamento dell’impero, 179.
7. La conservazione del principato nel problema della successione, 181.
XI. Consolidamento del regime imperiale. I Giulio-Claudi
1. La personalità e il programma di Tiberio, 189.
2. L'opposizione senatoria e il lungo ritiro di Tiberio, 190.
3. L'esperimento assolutistico di Caligola (37-41), 193.
4. L'avvento di Claudio e i primi sviluppi della burocrazia, 194.
5. Le altre realizzazioni di Claudio, 196.
6. Nerone e il consolidarsi dell’assolutismo, 199.
7. Dalla prima persecuzione cristiana alla fine di Nerone, 201.
XII. Dai Flavii agli Antonini. L'ascesa della borghesia italica e
provinciale
1. La svolta degli anni 68-69, 207.
2. Il principato ‘borghese’ di Vespasiano, 209.
3. Tito e Domiziano. L'impero sotto i Flavii, 211.
4. Nerva. Il principato ‘adottivo’, 215.
5. Traiano e la ripresa dell'espansione territoriale, 218.
6. Il nuovo corso di Adriano, 221.
7. Gli Antonini e la fine dell’impero liberale, 223.
4
XIII. La crisi del terzo secolo e il tramonto del principato
1. Evoluzione politica e declino economico, 232.
2. Mistica dell’assolutismo e trasformazione culturale, 234.
3. La dinastia dei Severi, 236.
4. Il periodo della ‘anarchia militare’, 240.
5. La ripresa sotto gli imperatori ‘illirici’, 243.
XIV. Il dominato. Da Diocleziano alla fine dell'impero d'Occidente
1. Diocleziano e il nuovo volto dell’impero, 251.
2. Fallimento della tetrarchia. Costantino e l’impero cristiano, 255.
3. I discendenti di Costantino, 259.
4. I barbari nei confini e la bipartizione dell'impero, 260.
5. L'impero d'Oriente e la fine dell'impero d'Occidente. I regni romanobarbarici, 262.
5
I
Il Lazio e Roma. L’età regia.
1. Le popolazioni dell’Italia preromana. - Uno degli aspetti
più interessanti della storia di Roma antica è l’unificazione
politica e civile dell’Italia, unificazione che in vario grado e
in varie guise si estese ai paesi gravitanti intorno al bacino
del Mediterraneo. Sarà quindi opportuno gettare anzitutto
uno sguardo d’insieme sulle varie popolazioni che
abitavano la Penisola quando ebbe inizio l’ascesa di Roma.
Il panorama che esse presentano, com’è noto, fu il risultato
di un lungo processo di sovrapposizione a genti
preesistenti di nuove genti venute di fuori, in possesso di
costumi e di lingua talora diversissimi (basti pensare che
alcuni appartenevano agli “Indoeuropei”, come i Latini, e
altri no, come gli Etruschi); pertanto il problema
dell’etnogenesi dell’Italia, sia per la scarsezza delle
testimonianze letterarie, sia per la relativa incertezza dei
dati forniti dalla moderna indagine archeologica e
linguistica, offre tuttora largo campo a ipotesi e
ricostruzioni non poco contrastanti. Oltre l’arrivo delle
genti già menzionate (quelle “indoeuropee” in scaglioni
successivi: i Latino-Falisci e i Siculi, gli Umbro-OscoSabelli, gli Illiri cui appartenevano da un lato i Veneti,
dall’altro gli Iapigi, che poi dettero il nome all’Apulia), si
ebbe anche la colonizzazione greca della Magna Grecia e
più tardi, dal principio del IV sec., l’immigrazione di tribù
celtiche, sì che alla fine ne risultò, come si diceva, un
quadro etnografico assai vario, che si può delineare nel
6
modo seguente. Nell’Italia settentrionale ad occidente i
Liguri e ad oriente i Veneti, tra cui vennero poi a incunearsi
i Galli riducendo progressivamente l’area occupata dagli
Etruschi. Nell’Italia centrale, oltre agli Etruschi (che nel
VII-VI sec. arrivarono anche in Campania), gli Umbri (alto
Tevere), i Sabini (Terni e Rieti), i Picenti (sull’Adriatico), i
Latini, gli Equi, i Volsci e gli Ernici (nell’od. Lazio); i Marsi,
i Peligni, i Vestini e i Marrucini (nell’od. Abruzzo).
Nell’Italia meridionale: i Campani, i Sanniti, i Lucani, i
Bruzi, gli Iapigi, i coloni greci.
2. Gli Etruschi. - Fra tutte queste genti
(prescindendo, naturalmente, dai Latini) particolare
importanza per la funzione che svolsero nella storia e nella
civiltà dell’Italia antica ebbero gli Etruschi.
È appena il caso di accennare qui al problema delle
loro origini, uno dei più dibattuti dalla moderna
storiografia, nella quale oggi, sull’opinione che essi siano
scesi in Italia attraverso le Alpi, prevale quella della
provenienza orientale, in accordo con la tradizione antica
raccolta, per esempio, da Erodoto (I 94).
Dal punto di vista politico gli Etruschi (come noi li
chiamiamo dal latino Etrusci; i Greci li chiamarono Tirreni,
, mentre essi stessi si denominavano
Rasèna) non riuscirono a realizzare una vera unità
nazionale. Il massimo organismo politico da loro creato fu
l’unione di dodici città-stati in una lega che aveva il centro
nel santuario della dea Voltumna presso Bolsena; ma, con
ogni probabilità, si trattava di una federazione di carattere
religioso che non giunse mai a cementare stabilmente le
forze dei collegati. Anche pensando a tale disunione si
spiega come gli Etruschi, dopo aver esteso il loro dominio
da Mantova, Adria e Spina fino alla Campania (compresa
Roma), dopo aver signoreggiato sul mare che porta ancora
7
il loro nome, cominciarono a declinare sotto i colpi dei
Greci d’occidente, dei Latini, dei Galli e infine dei Romani,
che s’imposero ad essi sul principio del III sec. a.C. Quanto
agli ordinamenti interni delle città étrusche, queste ebbero
dapprima un regime monarchico; più tardi, con un
mutamento costituzionale che quasi ovunque precorse
quello verificatosi a Roma, esse si vennero trasformando in
repubbliche nobiliari rette da magistrati annui (v. appresso).
3. I Latini. - Ad un certo momento dell’antica
riflessione (pseudo)storica di carattere erudito si fece
derivare il nome dei Latini da quello dal loro progenitore
Latinus; più tardi, questi venne concepito come un re
piuttosto che come un progenitore, e si pose quindi il
problema della denominazione dei Latini prima
dell’avvento del re Latino, problema che fu risolto con la
coniazione del nome di Aborigines. Indizio, questo nome, di
una convinzione di autoctonia (inesatta, peraltro), mentre
quello di Latini con ogni probabilità nacque per indicare gli
“abitatori della pianura” cioè del Latium. Questo originario
“territorio pianeggiante”, allargato poi con quello degli
Equi, degli Ernici, dei Rutuli, dei Volsci, e con quello delle
colonie latine che si presero a fondare dal V sec., giunse ad
estendersi dal Tevere (oltre il quale era l’Etruria) a Fondi,
confinando ad est con i Sabini e i Marsi. All’antico nome di
Latium si aggiunse più tardi la qualifica di vetus (Latium vetus,
o anche antiquum) allorché, dalla seconda metà del IV sec.
a.C., la denominazione di Lazio fu ancora estesa a sud di
Fondi fin oltre il Garigliano, e questo territorio costituì il
Latium novum o adiectum. Gli antichissimi Latini, appunto
perché abitatori di una piana costituente una naturale unità
geografica, realizzarono assai presto lo stabilimento di
reciproci legami fra i numerosi piccoli popoli in cui erano
organizzati; e, per prima cosa, comuni pratiche cultuali
8
riunirono intorno a un centro sacrale alcuni di quei populi.
Ne sorsero diverse leghe religiose, fra cui la più importante
fu quella che nel VII sec. giunse a riunire intorno ad Alba
Longa una cinquantina di stati (probabilmente la totalità di
quelli allora esistenti nel Lazio), partecipanti ogni anno alla
solennità detta Latiar o Feriae Latinae, che si celebrava sul
monte Albano in onore di Iuppiter Latiaris. Al di fuori di
queste vanno considerate le piccole comunità di Antemnae,
Caenina, Crustumerium, Politorium, Ficana, Tellene, Collatia,
Corniculum, Cameria, Ameriola, Medullia, situate nelle
vicinanze di Roma (nella zona compresa tra l’Aniene e il
Tevere che separa Roma dalla Sabina) e alle quali Roma si
sovrappose nella prima età regia. Intorno alla metà del VII
sec., con la distruzione di Alba Longa ad opera di Tullo
Ostilio, la direzione della lega di Iuppiter Latiaris passò nelle
mari dei Romani (e vi rimase nei secoli, esplicandosi però
fin dall’inizio più che altro nell’organizzazione delle Feriae
Latinae, cioè senza pervenire a tradursi in un’azione politica
di grande rilievo). Del resto, alle mire egemoniche dei
Romani le città latine risposero con lo stringere altri legami
di alleanza, e fra questi nuovi organismi federali salì poi a
grande importanza una lega avente il centro sacrale nel
santuario di Diana ad Aricia (v. appresso). Una idea della
posizione raggiunta da Roma nel Lazio verso la fine del VI
sec. è possibile ricavarla dal testo di Polibio (III 22) relativo
al primo trattato fra Roma e Cartagine (v. appresso).
4. La Roma primitiva e i suoi ordinamenti. - La
storiografia antica, salvo qualche divergenza, datò la nascita
di Roma (concepita in termini di fondazione con rituale
etrusco, o di insediamento di elementi greci) intorno alla
metà dell’VIII sec.; al primo anno dell’ottava olimpiade
(corrispondente al nostro 748/7 a.C.) l’aveva fissata Fabio
Pittore, il primo annalista (frgm. 3 Jacoby, FGrHist III C, p.
9
850), ma poi sulla sua data prevalse quella del terzo anno
della sesta olimpiade, equivalente al nostro 754/3 a.C.,
computata da Varrone (èra varroniana). A determinare
queste date d’intorno alla metà del sec. VIII gli antichi
autori giunsero sommando all’anno in cui dai fasti
consolari risultava iniziata la repubblica (anno
corrispondente al nostro 509 a.C.) il numero di circa 245
anni, quanti ne risultavano attribuendo ad ognuno dei sette
re un periodo di regno della durata media di 35 anni, ossia
all’incirca lo spazio di una generazione. Un procedimento
più o meno plausibile, ma fondamentalmente arbitrario, e i
suoi risultati non si accordano col dato dello scavo
archeologico, che qualche decennio fa ha messo in luce
resti di capanne del IX sec. sul Palatino, dalla parte del
Cermalo. Questa zona, che anche la tradizione indicava
come quella su cui Romolo avrebbe fondato Roma (e che
di fatto, per la sua posizione dominante sul Tevere nel
punto in cui l’isola Tiberina ne facilitava l’attraversamento,
si presentava come una delle più idonee per un
insediamento), fu dunque stabilmente abitata almeno dal
IX sec. a.C. Naturalmente, altra cosa dal cominciare dei
primi insediamenti stabili, di non precisabile datazione, è
l’origine di una vera e propria comunità organizzata,
costituitasi dal sinecismo del nucleo impiantato sul Palatino
con quello del Campidoglio, del Quirinale e via via degli
altri colli.
In questa primitiva comunità romana i più antichi
ordinamenti politici li troviamo imperniati intorno alla
figura di un rex, il quale ripeteva la sua autorità, politica e
religiosa insieme, dalla designazione del populus. Il popolo,
in una certa fase di sviluppo degli ordinamenti statali
ancora in embrione, si articolò in tribus e curiae,
raggruppamenti a base familiare e gentilizia nei quali si
coordinava la vita della comunità e del singolo in ogni atto
10
che avesse rilevanza giuridica: nella tradizione è allo stesso
Romolo, il mitico fondatore della città, che viene attribuita
la creazione sia delle tre tribù gentilizie dei Ramnes, Tities e
Luceres, sia delle trenta curie, dieci per ogni tribù. In origine
l’ordinamento a base gentilizia esprimeva e tutelava
gl’interessi della classe nobiliare che deteneva il potere; con
lo sviluppo dell’organizzazione statale le curie si vennero
poi trasformando in organi di governo, e le loro
competenze passarono all’assemblea generale delle trenta
curie, i comitia curiata. Questi divennero la principale
assemblea civile del popolo romano, con il potere anche di
eleggere il rex.
Oltre ai comizi curiati, che si radunavano alle pendici
del Campidoglio nell’angolo settentrionale del Foro,
esistevano i comitia centuriata, cioè l’assemblea del popolo in
armi diviso per centurie. Queste centurie, composte di
cento uomini, erano le unità base della fanteria, e in esse si
articolava la legio (= leva) formata complessivamente di
3.000 fanti e 300 cavalieri forniti da ciascuna delle 3 tribù.
Tanto i comizi curiati quanto i centuriati si
adunavano per convocazione del rex, e di fronte a lui erano
privi di ogni iniziativa: un sistema che manifestamente
riproduceva i modi di una ferrea disciplina militare e che
poi si perpetuò come un costume caratteristico delle
assemblee politiche romane. Gli elementi più cospicui del
populus si acconciarono a questo tipo di assemblea senza
libertà di parola perché potevano far sentire la loro voce
nel senatus. Ancora lo stesso Romolo, secondo la tradizione,
avrebbe istituito quest’organo consultivo del rex; esso era
formato dagli elementi più rappresentativi del patriziato,
che era in posizione di superiorità rispetto alla massa dei
plebei, e anche questa distinzione del popolo in patrizi e
plebei sarebbe stata opera di Romolo. In realtà, in una
società a base prettamente agricola dove sussisteva la
11
proprietà terriera, era naturale che assai presto si formasse
da una parte un certo numero di famiglie più ricche (che a
poco a poco si costituirono in un’aristocrazia fondiaria) e
dall’altra la moltitudine dei meno ricchi fino alla indigenza
(plebs è da confrontare col greco pléthos): si diversificarono
così i patrizi e i plebei, questi ultimi normalmente in
rapporto di dipendenza verso i primi come clientes verso il
patronus. Le cose, naturalmente, cambiarono quando si
presentarono condizioni industriali e commerciali
favorevoli a nuove e diverse ricchezze, e la vecchia
aristocrazia fondiaria, per quanto organizzata a difesa dei
suoi privilegi, dovette subire la concorrenza di famiglie
plebee che si affacciavano in primo piano nella vita politica
e sociale.
5. Evoluzione dell’istituto regio e avvento della repubblica. Come su Romolo, così sugli altri re di Roma la tradizione ci
ha conservato racconti relativi a opere di pace (ordinamenti
religiosi e giuridici, lavori pubblici, ecc.) e a imprese di
guerra contro le comunità vicine; tutti racconti sui quali è
legittimo esercitare punto per punto il vaglio della critica,
ma arbitrario giungere a conclusioni globalmente distruttive
(come quella, p. es., di non credere all’esistenza di un
periodo monarchico in Roma). Se ne farà qualche cenno
più avanti; qui conviene piuttosto soffermarsi sulle
caratteristiche dell’istituto regio dei Latini. A tal fine
bisogna tener conto della “comune nazionalità italica”
(come l’ha chiamata G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I, p.
170) “dei Siculi e dei Latini”. Perciò è possibile il confronto
tra istituto regio dei Latini e istituto regio dei Siculi (v. S.
MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano, p. 28
sgg.). Infatti nel Lazio antico, e particolarmente a Roma, il
rex oltre le funzioni di comando sopra ricordate ha anche
funzioni sacrali: «Egli è il capo dello stato romano arcaico,
12
e l’esistenza di un’età regia in Roma è confermata (oltre che
dalla tradizione sui sette re di Roma) dall’istituto del
l’interrex, dall’esistenza (in età repubblicana) di un rex
sacrorum e di una regia, e da molti altri indizi, tra cui quello
del cippo del Foro». Anche presso i Siculi si trova che il re,
detto rhesós, ha caratteri sacrali. Un frammento di Epicarmo
mostra che a questo commediografo greco il rhesós appare
un capo veramente strano: un capo che sovrintende agli
oracoli. A noi moderni il rhesós siculo «deve apparire un
rudimento dell’arcaico stato siculo, conservatosi ancora al
tempo di Epicarmo, vale a dire agl’inizi del 5° secolo. Il re
dei Siculi (rhesós) è rex e augur... In epoca storica, il rex
appare a Roma come sacerdote, rex sacrorum: il sacerdozio
del rex sacrorum può dare un’immagine di quel contenuto
sacrale originario, che nell’istituto della regalità romana
dovette assumere un’importanza notevole, accanto al
contenuto militare e giusdicente».
Da questa regalità primitiva si passò ad una nuova
concezione del potere, e a una nuova prassi nel suo
esercizio, che s’inquadra nell’evoluzione costituzionale delle
città laziali come viene chiarita da un fregio architettonico
di Velletri. I rilievi di questo fregio si riferiscono (S.
MAZZARINO, op. cit., p. 58 sgg.) «a una scena di vita
pubblica, e non già a figurazione di dèi. Essi vanno datati
alla seconda metà del 6° secolo, e piuttosto nei primi che
negli ultimi decenni (all’incirca 550-525 a.C.) e mostrano
che in questo periodo esisteva già una collegialità
magistratuale». In conclusione (p. 76) «il rilievo di Velletri
ci presenta uno stato con magistrature collegiali. La
collegialità esisteva dunque nello stato da cui proviene la
matrice di quel rilievo già nella seconda metà del 6° secolo.
Roma non poté essere estranea a questa innovazione».
Il problema del modo in cui nelle città etrusco-laziali
si passò dalla monarchia alla collegialità del potere si pone
13
nel modo seguente. Nella costituzione romana c’è un
istituto con caratteristica “collegialità disuguale”: la
dittatura. Infatti il dictator nomina un suo “collega
subordinato”: il magister equitum. D’altra parte, in alcune
città del Lazio (Aricia, Nomento, Lanuvio) il dittatore è
ordinario (non già straordinario, come il romano) e
annuale. Connettendo i due dati, è facile pensare che dalla
monarchia alla repubblica il passaggio avvenisse, in Roma,
attraverso una magistratura ordinaria e annuale, e che
questa fosse, come in quelle città latine, la dittatura. Com’è
noto il De Sanctis (op. cit., I p. 393) cercò di spiegare quel
passaggio con la seguente teoria: «I consoli in età storica
erano due. La tradizione aggiunge che nel 366 si diede ad
essi un terzo collega col titolo di pretore, ossia col titolo
stesso che allora i consoli portavano... Non è chi non veda
quanto questa tradizione sull’origine della pretura sia poco
plausibile... È lecito congetturare che fin dall’origine i
pretori fossero tre... In tal guisa si spiega come solo i due
primi divenissero gli eponimi, e come invece coloro che
occupavano il terzo posto si prendessero a registrare solo
più tardi, quando si cominciò a tener nota anche dei
magistrati non eponimi ... Tale ipotesi rende ragione della
dualità, così singolare in un collegio di magistrati supremi
quali erano i consoli romani ... Il numero di tre ha poi facile
spiegazione nel numero delle tribù. I pretori furono, come
è da credere, in origine i comandanti dei Tiziensi,
Ramnensi e Luceri, subordinati dapprima al re, poi,
declinando l’autorità regia, a lui non sottoposti [...]; divenuti
comandanti supremi dell’esercito e poi capi dello Stato, le
loro attribuzioni non erano più compatibili col comando
dei reggimenti delle tribù».
Tale ricostruzione del De Sanctis parte da un
atteggiamento di diffidenza verso molti dati della
tradizione, diffidenza che, se pur temperata rispetto a
14
precedenti posizioni critiche, appare oggi sempre più da
circoscrivere. «La tradizione sul periodo regio è assai meno
priva di valore di quanto non si credeva un tempo; oggi un
atteggiamento del tutto negativo ed ipercritico sarebbe
ingiustificato. Già i nomi dei primi re, ed alcuni elementi
tradizionali ad essi relativi, non vanno soggetti a dubbi: a
prescindere da Romulus, nessuno più dubita o dovrebbe
dubitare che di Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco
Marcio i nomi sono autentici, essendo impossibile che essi
venissero inventati in epoca in cui nessuno avrebbe avuto
interesse a inventarli; ed anche le imprese ad essi attribuite
rispondono, con varie amplificazioni e confusioni e
reduplicazioni, a verità (p. es., la distruzione di Alba Longa
per opera di Tullo Ostilio). Per il periodo più recente, la
tradizione dà altresì non solo nomi che non vanno soggetti
a dubbi, quando parla dei due Tarquinii e fra essi pone
Servio Tullio, ma anche attribuisce a questi imprese che
certo a quel periodo vanno attribuite». Così il Mazzarino
(op. cit. p. 182 sgg.), che sulla base di queste premesse ha
collegato la tradizione romana con quella etrusca, nota dai
dipinti della tomba François di Vulci. In tali dipinti il
personaggio indicato col nome di MACSTRNA è l’autore
principale della rivoluzione “democratica” che pose fine al
governo di Cneve Tarchu[nies] rumach (= Cnaeus Tarquinius
Romanus), e macstrna è il rendimento etrusco di magister,
termine che nella formula magister populi equivaleva, in
Roma, a dictator.
La fine della dinastia degli Etruschi in Roma fu uno
degli ultimi episodi del declino della loro potenza in
Campania e nel Lazio, sanzionato dalla sconfitta subita
presso Aricia nel 524 ad opera dei Cumani uniti ai
confederati Latini.
15
Sull’etnografia dell’Italia preromana, S. PUGLISI, La civiltà appenninica.
Origini delle comunità pastorali in Italia, Firenze 1959; M. PALLOTTINO, Sulla
cronologia dell’età del bronzo e dell’età del ferro in Italia, in «Studi Etruschi» XXVIII
(1960), p. 11 sgg.: ID., Le origini storiche dei popoli italici, in «Relazioni del X
Congresso Intern. di Scienze Storiche, Roma 1955», II, p. 3 sgg.
Sulla provenienza degli Etruschi dall’Oltralpe, G. DE SANCTIS, Storia dei
Romani, I, Torino, 1907, p. 125 sgg.; L. PARETI, Storia di Roma e del mondo romano,
I, Torino 1952, p. 110 sgg.; sulla provenienza orientale, fra gli altri, A.
PIGANIOL, Les Etrusques peuple d’Orient, in «Cah. hist. mond.» I (1953), p. 328
sgg. In generale, cfr. M. PALLOTTINO, Etruscologia, 5a ed. Milano 1953.
Su Latini e Aborigeni, G. DE SANCTIS, op. cit., I, p. 170 sgg.;
sull’estendersi del Latium, G. VITUCCI in «Dizionario epigrafico di antichità
romane fondato da E. De Ruggiero», IV, p. 430 sg. Alcuni nomi dei populi che
partecipavano alle celebrazioni annuali in onore di Iuppiter Latiaris li
conosciamo attraverso un elenco che ci è stato trasmesso da Plinio (Nat. hist.
III 69). Tale elenco riguardava le comunità che in seguito avevano cessato di
esistere, e fra queste ne compaiono due che destano uno speciale interesse. Si
tratta dei Querquetulani e dei Velienses. Tacito (Ann. IV 65) ricorda che
anticamente il Celio si chiamava Querquetulanus, mentre i Velienses sono
evidentemente gli abitanti del Velia, il colle che sorgeva fra il Palatino e
l’Esquilino. Pertanto in quell’elenco si conserva traccia di un tempo in cui
esistevano due comunità a sé stanti, quella del Celio e quella del Velia,
comunità ben distinte da quella di Roma, la quale probabilmente ancora non si
era costituita dal sinecismo degl’insediamenti sparsi sui vari colli (cfr. S.
MAZZARINO, Il pensiero storico classico, I, Bari 1966, p. 193 sg.). A risultati
notevolmente nuovi, ma poco convincenti, è arrivato G. GJERSTAD (Legends
and facts of early Roman history, Lund 1962) attraverso un’analisi dei dati della
tradizione e il loro raffronto con gli elementi che si ricavano dalla esplorazione
archeologica; in conclusione, l’inizio della storia di Roma dovrebbe essere
posticipato di quasi due secoli.
Il testo del primo trattato romano-cartaginese viene così riferito in
POLYB. III 22: «Fu dunque stipulato il primo trattato fra Romani e Cartaginesi
al tempo di Lucio Giunio Bruto e di Marco Orazio, i primi che furono creati
consoli dopo l’abolizione della monarchia, dai quali fu anche consacrato il
tempio di Giove Capitolino. Questi fatti sono di ventotto anni anteriori al
passaggio in Grecia di Serse. Il quale (trattato) noi abbiamo trascritto qui di
seguito dopo averlo interpretato con la massima precisione possibile. Tale
infatti anche presso i Romani è la differenza fra la lingua attuale e quella antica,
che a stento anche i più esperti sono riusciti a comprenderne alcune
espressioni. Il trattato suona press’a poco così: Alle seguenti condizioni sia
amicizia tra i Romani e gli alleati dei Romani (da un lato) e i Cartaginesi e gli
alleati dei Cartaginesi (dall’altro); non navighino i Romani né gli alleati dei
Romani oltre il promontorio Bello, se non costretti da una tempesta o da
nemici, e se qualcuno vi fosse trasportato per forza, non gli sia lecito né di fare
compere né di prendere se non quanto sia necessario a riparare la nave e alle
16
sacre cerimonie, ed entro cinque giorni riparta. Quelli che arrivano per ragioni
di commercio non possano concludere alcun affare se non con l’intervento di
un banditore o di uno scriba. Delle cose che in presenza di costoro siano
vendute, tanto in Africa quanto in Sardegna, sotto pubblica garanzia il prezzo
sia dovuto al venditore. Se qualcuno dei Romani giunga in Sicilia, nella zona
che dominano i Cartaginesi, abbia completa uguaglianza di diritti. I Cartaginesi
non rechino danno al popolo di Ardea, di Anzio, di Laurento, di Circei, di
Terracina, né ad alcun altro popolo dei Latini quanti (siano) soggetti (ai
Romani); se alcuni non sono soggetti, si astengano dalle (loro) città, e se poi
(ne) dovessero prendere (qualcuna), la consegnino intatta ai Romani. Non
costruiscano una fortezza nel Lazio. Se entrano nel territorio (del Lazio) come
nemici, non vi dovranno pernottare» (Circa questo trattato, vedi il capitolo
seguente).
Sulla data calcolata da Fabio Pittore per la nascita di Roma, e su altri
problemi connessi con gl’inizi della storiografia romana, G. VITUCCI, in
«Helikon», 1966, p. 401 sgg.
Circa i fasti consolari (espressione che significa “elenco di consoli”) si
ricordi l’importanza che tale elenco ebbe nell’antico mondo romano per
individuare i singoli anni, e ciò sia in generale per i bisogni della vita pratica, sia
poi nell’uso storiografico per indicare la cronologia dei fatti. Nella lista i vari
anni si distinguevano dal nome dei magistrati eponimi, e questi furono per lo
più i consoli (donde il nome di fasti consolari) salvo il periodo in cui si ebbero i
decemviri consulari imperio legibus scribundis e poi i tribuni militum consulari potestate (v.
appresso). Considerata l’importanza dei fasti consolari per l’ordinato
svolgimento della vita civile, è da ritenere che se ne cominciasse la registrazione
non molto dopo l’inizio della repubblica, il che rappresenta un importante
elemento a favore della genuinità della lista anche nella sua parte più antica,
mentre una tendenza ipercritica vedrebbe in tale parte il prodotto di un
posteriore lavorio di interpolazioni. Su ciò v. K.J. BELOCH, Römische Geschichte,
Berlin 1926, p. 1 sgg.
I fasti consolari ci sono giunti in una duplice redazione; una proviene
soprattutto dalle fonti annalistiche (Diodoro Siculo, Livio, Dionisio di
Alicarnasso, che nel loro racconto distinguono appunto il succedersi degli anni
menzionandone gli eponimi), l’altra da fonti cronografiche quali il “Cronografo
del 354”, i “Fasti Idaciani” e il “Chronicon Paschale”. A tali fonti
cronografiche se ne deve aggiungere una quarta, che fu redatta non come opera
letteraria, ma per essere incisa sull’arco di Augusto nel Foro Romano. Di
questa lista, che elencava gli eponimi dall’inizio dell’età repubblicana al 13 d.C.,
molti frammenti furono trovati e ricomposti, col concorso di Michelangelo, nel
Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, donde la loro denominazione di Fasti
Capitolini. Una recente edizione di essi (e degli altri fasti superstiti) è stata curata
da A. Degrassi nel vol. XIII delle Inscriptiones Italiae.
Le varie liste a noi in tal modo pervenute sono identiche a cominciare
dal 280 a.C. in poi, mentre per la parte anteriore esse presentano varie
discrepanze, fra cui sono da ricordare almeno due. Livio (VI 35, 10) registra un
17
periodo di cinque anni, dal 375 al 371, in cui a causa della violenza dei contrasti
fra plebe e patriziato si sarebbe verificata una solitudo magistratuum, cioè
sarebbero stati eletti solo tribuni e edili della plebe (Licinius Sextiusque tribuni
plebis refecti nullos curules magistratus creari passi sunt; eaque solitudo magistratuum et
plebe reficiente duos tribunos et iis comitia tribunorum militum tollentibus per quinquennium
urbem tenuit); tale periodo invece si riduce a quattro anni in Eutropio (II 3:
Verum dignitas tribunorum militarium non diu perseveravit. Nam post aliquantum nullos
placuit fieri et quadriennium in urbe ita fluxit, ut potestates ibi maiores non essent), e così
pure in Zonara (VII 24) e nei “Fasti Idaciani”, mentre diventa di un solo anno
in Diodoro (XV 75, 1: Nell’anno in cui ad Atene fu arconte Polizelo, si verificò
a Roma, a causa di certi contrasti fra i cittadini, una “anarchia”).
L’altra particolarità da notare sono i quattro cosiddetti “anni
dittatoriali”, registrati unicamente dai Fasti Capitolini, secondo i quali nel 333,
324, 309 e 301 il governo della repubblica sarebbe stato per tutto l’anno nelle
mani di un dittatore, che ne sarebbe pertanto divenuto l’eponimo.
Solitudo magistratuum e anni “dittatoriali”, inammissibili come realtà
storica, si rivelano espedienti intesi ad allungare la lista ed escogitati quando ci
si accorse che il numero dei collegi di eponimi era inferiore a quello degli anni.
Sui più antichi ordinamenti di Roma, A. FERRABINO, L’Italia romana,
Milano 1934, p. 18 sgg.; L. PARETI, op. cit., I, p. 237 sgg.; P. DE FRANCISCI, La
comunità sociale e politica romana primitiva, in «Relazioni del X Congresso», cit., II,
p. 63 sgg.
18
II
La repubblica sotto il predominio dei patrizi.
1. I primi rapporti politici con Cartagine e il ritorno degli
Etruschi. - Uno dei primi atti a noi noti del governo
repubblicano fu la conclusione di un trattato di amicizia e
di commercio con i Cartaginesi (l’implacabile rivalità tra
Roma e Cartagine era ancora di là da venire!). Ce ne dà
notizia Polibio (III 22), il quale, come s’è visto, afferma che
l’accordo fu stipulato “essendo consoli L. Giunio Bruto e
Marco Orazio” (primo anno della repubblica [509 a.C.]) e
aggiunge che il documento, inciso su tavole di bronzo, era
ai suoi tempi conservato presso il tempio di Giove sul
Campidoglio. Cartagine, fondata alcuni secoli prima da
coloni fenici provenienti da Tiro, aveva acquistato sempre
maggior potenza fino a diventare il centro politico e
commerciale di un vasto impero. Nella seconda metà del
VI secolo i Cartaginesi avevano vittoriosamente conteso
con Marsiglia, colonia greca fondata dai Focesi, per il
predominio commerciale nel Mediterraneo occidentale, e in
questa lotta avevano avuto l’appoggio degli Etruschi. Da
tale momento presero l’avvio i rapporti amichevoli fra
Cartaginesi e Romani, la cui politica si svolgeva allora sotto
l’influenza etrusca, e pare che proprio per confermare
quelle buone relazioni dopo il mutamento di regime
avvenuto in Roma venisse stipulato il trattato di cui ci parla
Polibio. Ora è da considerare che in questo trattato i
Romani si atteggiano a protettori di varie città dell’interno e
della costa fino alla lontana Terracina, ma poiché tale
protettorato non corrispondeva affatto alla reale situazione
politica, se ne deve ricavare che in quel momento il
19
governo di Roma nutriva aperte pretese al predominio su
quei popoli del Lazio e, per intanto, le faceva valere nei
confronti di Cartagine.
Però a così rosee speranze i tempi erano poco
propizi: i Latini, in realtà, erano tutt’altro che pronti a
riconoscere la supremazia di Roma e, per di più, la città
dové presto affrontare il ritorno offensivo degli Etruschi.
Secondo la tradizione vulgata, Tarquinio aveva spinto
Porsenna, il re di Chiusi, a costringere con la forza i
Romani a rimetterlo sul trono, e n’era nata una guerra
terribile. Se essa non era terminata col disastro, il merito
era stato tutto degli atti di eroismo compiuti dal fiero
Muzio Scevola, dal fortissimo Orazio Coclite, dall’intrepida
Clelia, che riempirono di ammirazione il re etrusco
inducendolo a togliere il blocco della città e a concedere
onorevoli condizioni di pace, mentre Tarquinio veniva
abbandonato al suo destino. In realtà le cose andarono
assai diversamente; accadde, cioè, che Roma fu vinta dagli
Etruschi e costretta ad accettare le più dure imposizioni, fra
cui quella di rinunziare a tutti gli armamenti. La città era
alla mercé dei vincitori, e fu in grazia del colpo subìto dalla
potenza etrusca nella battaglia di Aricia se l’impresa di
Porsenna nel Lazio e la nuova sottomissione di Roma si
risolse in un fatto passeggero.
2. Le città latine e Roma - I Latini che, sia pure
indirettamente, avevano impedito che in Roma
s’instaurasse nuovamente la dominazione degli Etruschi,
erano uniti in una lega che stringeva intorno a Tuscolo (a 5
km dall’odierna Frascati) alcune importanti città, site per lo
più sui Colli Albani, e aveva come centro sacrale il
santuario di Diana nel territorio di Aricia. Come s’è detto,
essa rappresentava, dopo la distruzione di Alba Longa e il
declino dell’antica lega di Iuppiter Latiaris, uno degli
20
organismi più importanti del Lazio, cui Roma, già negli
ultimi tempi della monarchia, aveva cercato di
contrapporre un’altra lega da essa diretta, quella che aveva
il centro nel tempio di Diana sull’Aventino.
Noi non sappiamo in quali precise circostanze, vari
anni dopo, avvampò la guerra fra Roma e la lega capeggiata
da Tuscolo, ma si può ragionevolmente dubitare che i
Romani riportassero nella battaglia del Lago Regillo (oggi
prosciugato, nelle vicinanze di Frascati) quello strepitoso
successo di cui parlò più tardi la “storia ufficiale”, poiché
sembra che a spingere i contendenti a venire a un accordo
fosse la minacciosa avanzata nel Lazio di popoli vicini.
Unico punto fermo - ma anche qui non mancano motivi di
varie incertezze - è che la guerra si concluse a favore dei
Romani intorno al 493 con un trattato che vien detto foedus
Cassianum da Spurio Cassio, il console che lo stipulò.
In forza di questo trattato, il cui testo poteva ancora
leggersi a Roma alcuni secoli dopo, cioè al tempo di
Cicerone, si stabilivano non solo accordi di pace e di
alleanza, ma anche si regolavano gli scambievoli rapporti,
in materia di commercio, tra i cittadini di Roma e quelli
delle diverse città latine. Un particolare, quest’ultimo, assai
importante perché rappresentava il primo passo di quel
lungo processo di assimilamento che avrebbe portato
all’unificazione dei Latini nel nome di Roma. Il trattato era
stato concluso a parità di condizioni, vale a dire che in quel
momento la potenza romana era riconosciuta uguale a
quella di tutti i Latini uniti insieme, ma un sì grande
successo non fu ritenuto sufficiente dalla “storia ufficiale”,
che più tardi parlò addirittura di una supremazia instaurata
allora da Roma sul Lazio. In realtà, tale supremazia Roma
l’acquistò non al principio, ma alla fine del V sec. a.C., cioè
dopo aver validamente concorso alla difesa delle città latine
maggiormente esposte alla marea dei popoli confinanti che
21
minacciava di sommergerle. Nel corso del V secolo, infatti,
a più riprese Roma dovette scendere in campo non
soltanto contro la ricorrente pressione degli Etruschi sui
confini settentrionali, ma anche contro i Sabini, gli Equi e i
Volsci che premevano sul Lazio spostandosi dalle loro sedi
montane (a un dipresso nell’odierno Abruzzo occidentale)
in direzione delle terre più fertili verso il mare. L’alleanza
tra Romani e Latini, stretta sotto la spinta dei comuni
pericoli, stava per subire la prova del fuoco.
3. Lotte contro i Sabini, gli Equi, i Volsci. - Anche lo
sviluppo di questi lontani avvenimenti subì la consueta
deformazione nel racconto degli storici romani, ma non al
punto che non possiamo farcene un’idea sia pure sommaria
e, soprattutto, constatare che per fortuna delle città latine
mancò una vera intesa fra i loro aggressori. Per quanto
riguarda la stessa Roma, il pericolo più grave fu
rappresentato ad un certo momento dai Sabini che, dopo
una serie di incursioni verso il sud fino all’Aniene,
riuscirono nel 460 a penetrare nella città e ad occupare la
roccaforte del Campidoglio! La riscossa però fu immediata,
grazie anche - come pare - all’aiuto dei Tuscolani, e dopo
non molti anni, nel 449, una nuova vittoria allontanava per
sempre da Roma la loro minaccia.
Quanto agli Equi, essi, dopo aver sommerso, oppure
attirato dalla loro parte, Praeneste (Palestrina) e aver
occupato altri centri latini minori (tra cui Labici, forse
l’odierna Monte Compatri), giunsero ad accamparsi sul
monte Algido (Maschio dell’Ariano) fra i Colli Albani, a
pochi chilometri da Tuscolo. E fu appunto sui Tuscolani
che maggiormente gravò il compito di fermare gli Equi,
anche se più tardi gli storici romani esaltarono il contributo
delle armi romane, specie con la vittoria riportata nel 458
dal dittatore Cincinnato.
22
Del resto un notevole apporto alla causa comune fu
dato anche dagli Ernici, un popolo stanziato a sud degli
Equi e pertanto ugualmente soggetto alla loro pressione.
Gli Ernici costituivano anch’essi una lega che si raccoglieva
intorno ad Anagnia (altri centri più importanti: Ferentinum,
od. Ferentino; Aletrium, od. Alatri; Verulae, od. Veroli), e fin
dal 486 furono accolti a parità di condizioni nell’alleanza
che univa Romani e Latini e che si trasformò allora in
alleanza fra Romani, lega latina e lega ernica.
Solo verso la fine del secolo i tre collegati riuscirono a
bloccare la spinta espansionistica degli Equi, costringendoli
a ritirarsi dalle posizioni che avevano guadagnato nel Lazio.
Ancora più duro fu lo scontro contro i Volsci che,
aprendosi un varco fra gli Aurunci e i Latini, all’inizio del V
secolo dilagarono nell’agro Pontino occupando la regione
costiera da Terracina (che essi chiamarono Anxur) fin oltre
Anzio, e spingendosi nell’interno fino a Velletri. Come
capisaldi per contenere la loro avanzata, furono fondate
(intorno al 492) le colonie di Norba (Norma) e Signia
(Segni); quindi si combatté una serie di lotte asprissime nel
cui racconto venne intessuta, fra l’altro, la storia di Cn.
Marcio Coriolano, il condottiero ribelle che, costretto in
esilio, si sarebbe posto a capo dei Volsci guidandoli di
vittoria in vittoria da Circei fino a poche miglia da Roma.
La spinta volsca verso il nord lungo il litorale per poco non
culminò nella caduta di Ardea: la città fu rafforzata con
l’invio di coloni diventando anch’essa colonia latina (439).
La presa di Anxur nel 406 e il successivo trapianto di coloni
a Velletri nel 404 e a Circei nel 393 segnano le ultime tappe
della sottomissione dei Volsci, anche se continuò a
verificarsi qualche tentativo di ribellione.
4. Guerre con gli Etruschi. - A nord più diretto interesse
ebbe per Roma la lotta contro gli Etruschi meridionali,
23
soprattutto quelli di Veio, una popolosa e ricca città che
sorgeva a circa una ventina di chilometri sulle rive del
Cremera, piccolo affluente del Tevere. Verso l’inizio del V
secolo, mentre urgeva sul Lazio la minaccia dei Volsci e
degli Equi, i Veienti fecero ripetute scorrerie entro il
territorio romano e riportarono anche grossi successi,
come quello dell’anno 477 in cui restarono sul campo quasi
tutti i membri della nobile gens dei Fabi (si sarebbe salvato
solo un giovanetto, destinato ad avere tra i suoi discendenti
il grande Temporeggiatore). Fu un grave colpo per i
Romani, di cui la “storia ufficiale” non poté cancellare il
ricordo, ma solo abbellirlo con i colori della leggenda. Però
alcuni decenni dopo, fermati gli Equi e i Volsci, la
situazione si capovolse e fu Roma a prendere l’iniziativa
delle ostilità. Dapprima, nel 426, venne distrutta Fidene
(presso Castel Giubileo); poi fu la volta di Veio, espugnata
nel 396 dopo un assedio di dieci anni.
Molti dei particolari che gli storici romani
raccontarono su questa guerra debbono ritenersi
leggendari, a cominciare dallo stesso assedio la cui durata
sembra richiamare quella dell’epico assedio di Troia: in
maniera particolare fu ingigantita la figura di Marco Furio
Camillo, il capitano che condusse a termine l’ardua
impresa. Tuttavia è certo che i Romani avevano riportato
sui vicini Etruschi un successo di prim’ordine. Infatti, delle
città che avevano dato aiuto a Veio, le minori furono
anch’esse conquistate, come Capena, Sutrium (Sutri) e Nepet
(Nepi), mentre con quella assai importante di Falerii (Civita
Castellana), il principale centro del popolo dei Falisci, fu
concordata una tregua. Di questa in realtà si trattò, più che
di una pace, anche se poi gli storici romani favoleggiarono
che i Falisci si sarebbero addirittura sottomessi a Camillo
ammirati per il suo rifiuto di impadronirsi della città col
tradimento. Egli avrebbe infatti respinto la proposta di un
24
maestro di scuola, il quale gli aveva offerto di consegnargli i
suoi discepoli, tra cui erano i figli dei maggiorenti falisci.
Dei paesi così conquistati, quelli di Veio e Capena,
come già quello di Fidene, entrarono a far parte del
territorio propriamente romano, mentre Sutri e Nepi, con
l’invio di un certo numero di coloni, furono trasformate in
colonie latine, al pari di quanto già era stato fatto per
Norba, Signia, Ardea e Circei.
5. Colonie romane e colonie latine. Origini del “diritto latino”.
- Riguardo alle suddette (e, via via, alle future) colonie
latine si deve notare come esse si distinguessero nettamente
dalle colonie romane. Le colonie romane nacquero con una
funzione essenzialmente militare, e furono impiantate per
lo più sulla costa a difesa dagli attacchi provenienti dal
mare. Erano costituite da poche centinaia di cittadini
romani, che tali restavano nella loro nuova sede, anche se
praticamente, per la lontananza da Roma, non potevano
più esercitare i loro diritti di cittadinanza.
Le colonie latine, invece, ebbero importanza per
Roma non solo dal punto di vista militare, per la posizione
strategica in cui sorgevano, ma anche - e sempre più - dal
punto di vista economico e sociale come sfogo
all’emigrazione dei più bisognosi. Esse erano costituite con
l’invio di coloni provenienti sia da Roma, sia dalle città
degli alleati Latini ed Ernici, e diventavano altrettante
comunità latine comprese nella lega latina; pertanto quei
Romani che vi erano inviati come coloni cessavano di
essere cives Romani e diventavano cittadini della nuova
comunità latina. Ma se, in tal modo, Roma perdeva un
certo numero di cittadini nel tempo stesso che si ingrandiva
la lega delle città latine, questi svantaggi erano compensati
dalla presenza, nelle nuove comunità latine, di elementi in
genere favorevoli alla politica romana.
25
Di grandissima importanza fu poi che, per evitare che
rimanesse troncato ogni rapporto fra tali coloni ex-Romani
e la loro patria d’origine, si venne sviluppando il così detto
“diritto latino” in forza del quale furono a quelli concessi
alcuni privilegi come la facoltà di sposarsi in Roma (ius
conubii) e di riacquistare la cittadinanza romana col semplice
trasferimento del domicilio in Roma (ius migrandi). Più tardi
questi privilegi furono estesi indistintamente a tutti i Latini,
onde costoro godettero di una posizione privilegiata
rispetto agli altri popoli con cui Roma strinse via via
rapporti di alleanza.
A proposito dei quali si deve ricordare che
l’espansione dello Stato romano ben presto si sviluppò a
preferenza attraverso la forma federativa. Quando cioè
Roma affermò la sua supremazia sui popoli vicini, solo in
piccola parte li assoggettò immediatamente al suo diretto
controllo incorporandoli nel territorio dello Stato; ai più,
invece, conservò la loro autonomia legandoli però a sé con
un patto di alleanza (foedus), trasformandoli cioè in foederati
con particolari diritti e doveri. Tra questi alleati i Latini
ebbero, come dicevamo, una posizione di privilegio.
L’affermarsi di Roma in Italia, pertanto, sarà per lungo
tempo segnato non tanto dall’ampliarsi del suo territorio che fu piuttosto lento - quanto dall’allargarsi della cerchia
dei suoi foederati.
6. Predominio politico e religioso dei patrizi sopra i plebei. La riluttanza verso il troppo rapido dilatarsi dello Stato era
uno degli aspetti della tendenza eminentemente
conservatrice della classe che reggeva il timone della
repubblica. Un’eccessiva espansione territoriale avrebbe
comportato un moltiplicarsi dei problemi di governo e
rappresentato, quindi, una grave incognita per il
predominio del patriziato, predominio che la parte più
26
numerosa del popolo romano, cioè la plebe, era sempre
meno disposta a subire. Difatti per tutto il V secolo si
agitarono in Roma contrasti talvolta più aspri delle guerre
combattute senza posa contro i Volsci o gli Equi o gli
Etruschi.
I plebei, che avevano dovuto condividere gli sforzi e i
sacrifici imposti dalla politica dei patres, aspiravano ad
acquistare nel governo della repubblica un peso maggiore
di quello, assai scarso, che avevano. E la plebe non era
costituita soltanto dal popolo minuto, ma ne facevano
parte anche elementi cospicui per capacità d’ingegno e di
lavoro, i quali però, appunto perché estranei alla cerchia
delle grandi famiglie nobiliari, erano esclusi dalla carriera
politica: una condizione, questa, tanto più inaccettabile se si
pensa che (come mostra la parte iniziale dei fasti consolari)
all’inizio della repubblica uomini della plebe avevano
raggiunto, col consolato, il più alto fastigio nella direzione
dello Stato. Da tale direzione, peraltro, essi erano stati a
poco a poco allontanati ad opera dei patrizi, che vennero
monopolizzando l’esercizio del potere fino a costituirsi in
casta chiusa.
Però se la lotta fra patrizi e plebei conobbe episodi
veramente drammatici, essa non mise mai in pericolo le
sorti della repubblica: opportune concessioni da parte dei
patrizi e consapevole rispetto dei principi tradizionali (mos
maiorum) da parte dei plebei consentirono di mantenere una
concordia capace di assicurare col tempo non solo le
maggiori fortune, ma anche un ordinato progresso morale
e civile.
Nel mondo antico religione e politica si sono sempre
e variamente mescolate; soprattutto in Roma, dove tale
confusione fu favorita dal carattere stesso della religione
romana. Sorta, come presso le altre genti d’Italia, da
un’ingenua venerazione per le immense forze e i grandiosi
27
fenomeni della natura (Iuppiter è in origine il dio del cielo
luminoso; Iuppiter Fulgur propriamente non è che il diofulmine) commista a forme primitive di totemismo (si
pensi al culto di Iuppiter Lapis, una pietra conservata sul
Campidoglio) e di animismo (credenza nell’azione buona o
cattiva degli “spiriti”), la religione romana conservò la sua
arcaica rozzezza anche quando, per influsso della civiltà
ellenica, si fuse col paganesimo greco. Alcune divinità si
elevarono allora al livello delle più evolute concezioni dei
Greci (onde Iuppiter fu identificato col maestoso Zeus
dell’Olimpo, Iuno con Hera, Minerva con Athena, ecc.), altre
subirono una completa trasformazione della loro essenza
(come Venere, in origine custode degli orti, che fu poi
assimilata ad Afrodite e divenne la dea dell’amore con tutti
i relativi attributi), ma questo processo di fusione non valse
ad incrinare la vetusta compagine religiosa dello spirito
romano. In essa non un anelito di elevazione spirituale, ma
solo l’ansia di propiziare all’individuo, alla famiglia, e
soprattutto allo Stato l’aiuto degli dei, concepiti come
dispensatori di bene o di male a chi li onorasse nelle forme
dovute oppure no. Inoltre, mancando del fondamento di
una vera e propria speculazione teologica, il politeismo
romano fu sempre aperto ad accogliere da ogni parte
nuove divinità e nuovi riti, ma ciò solo nella fiducia che
anche questi potessero contribuire alla prosperità di tutti e
di ciascuno, sì che in fondo la religione dei Romani restò
ancorata alle sue rozze caratteristiche originarie e
soprattutto alla sua peculiare concezione utilitaria.
Ma perché lo Stato prosperasse bisognava assicurare
che ogni atto importante della vita pubblica si svolgesse
secondo la volontà degli dei. Di questo i soli patrizi
pretesero di essere capaci, in quanto essi soltanto “avevano
gli auspici”, cioè erano in grado di far sì che l’azione del
popolo corrispondesse al volere divino rettamente indagato
28
e interpretato con l’ausilio degli àuguri (che vennero
acquistando un’influenza sempre maggiore sui pubblici
affari). Per questa via si arrivò a non ammettere i
matrimoni misti fra patrizi e plebei, e così il patriziato finì
per formare una casta chiusa, esercitando quanto più
possibile in esclusiva l’imperium inerente alla suprema
magistratura della repubblica, il consolato.
7. Ordinamenti del più antico stato repubblicano. - I due
consoli avevano la direzione dello Stato in quanto erano
nello stesso tempo la più alta autorità civile, i giudici di
grado più elevato e i supremi comandanti delle forze
armate (quest’ultima attribuzione si rifletteva nella
denominazione che essi ebbero prima di chiamarsi consules,
quella cioè di praetores, da prae ire = marciare alla testa).
Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie i consoli
ebbero ben presto l’ausilio dei quaestores; per il resto essi
potevano avvalersi, come una volta avevano fatto i re, del
consiglio dei senatori, anche essi provenienti dalle famiglie
più ragguardevoli. Non avevano però l’obbligo di
sottostare ai loro pareri (senatusconsulta), anzi il senato non
poteva nemmeno adunarsi se non dietro convocazione dei
consoli, che ne presiedevano le sedute e ne dirigevano i
lavori. Tuttavia questa prevalenza dei consoli sui senatori
tendeva a diventare più formale che sostanziale, e sta di
fatto che per tutta l’età repubblicana il senato rimase il
principale organo di governo attraverso il quale si
attuavano i disegni politici della classe che deteneva il
potere. I maggiori esponenti delle casate nobili erano
sempre presenti in senato a difendere i propri interessi con
tutto il peso della loro autorità, mentre i consoli, che del
resto provenivano di massima da quella stessa nobiltà, non
duravano in carica che un solo anno, salvo il caso di
qualche rielezione. Poteva dirsi, quindi, che i consoli
29
passavano ma il senato restava. Inoltre i consoli, per effetto
della loro “collegialità uguale”, se fossero stati in
disaccordo potevano intralciarsi a vicenda con il diritto di
veto (ius intercessionis): in tal caso i loro contrasti non
potevano risolversi che seguendo i consigli del senato, i
quali anche per questa via divennero per i consoli sempre
più vincolanti. Nello stesso tempo questa collegialità, al
pari dell’annualità della carica, impediva che qualcuno,
attraverso il consolato, potesse costituirsi uno stabile
potere personale.
Del resto, anche sulle assemblee popolari il senato
faceva sentire il peso della sua volontà.
Il popolo, cioè l’insieme dei patrizi e dei plebei,
appunto perché composto di cittadini e non di sudditi, era
chiamato a collaborare ad alcuni atti fondamentali nella vita
dello Stato, per esempio l’emanazione delle leggi o la
nomina dei magistrati. Le deliberazioni al riguardo il
popolo le prendeva alcune radunato nei comizi curiati
(assemblea “civile” del popolo suddiviso in curie), altre nei
comizi centuriati (assemblea “militare” del popolo
suddiviso in centurie). Ora, a parte il fatto che in queste
assemblee i patrizi, forti della loro organizzazione e della
loro potenza, avevano facilmente ragione dei più numerosi
plebei, il senato poteva far sentire la sua autorità, sia
direttamente, negando la prescritta approvazione ad alcuni
deliberati, sia indirettamente, esercitando la sua influenza
sui consoli che presiedevano le assemblee popolari. I
comizi romani, infatti, avevano ancora in quest’epoca e
conservarono nei secoli quella fisionomia particolare cui già
si è accennato: essi si adunavano solo quando li convocava
il magistrato, e di fronte a lui osservavano una disciplina
assoluta. Praticamente, non v’era luogo a discussioni; chi
parlava era il magistrato che esponeva le sue proposte, e il
30
popolo non poteva che esprimere il suo voto, favorevole o
contrario.
Il senato, infine, non mancava di far sentire la sua
influenza nemmeno quando, per assicurare l’unità di
comando necessaria nei momenti di maggior pericolo per
lo Stato, sia per la gravità dei contrasti interni sia per la
minaccia di nemici esterni, procedeva alla nomina di un
dictator, che ora si era trasformato da magistrato ordinario e
annuo in magistrato straordinario. Questi aveva poteri
assoluti, ma la sua carica non poteva durare oltre sei mesi;
inoltre egli veniva nominato da uno dei consoli, i quali come s’è visto - in generale agivano d’intesa col senato.
8. Le rivendicazioni della plebe e i suoi primi successi. - Tali,
per sommi capi, erano gli ordinamenti che permettevano ai
patres di esercitare il predominio da essi acquistato nei primi
decenni del V secolo sopra i plebei; ma questi, una volta
imboccata la via delle rivendicazioni, seppero trarre grande
vantaggio da una recente innovazione amministrativa:
l’istituzione delle tribù territoriali.
Erano queste qualcosa di totalmente diverso dalle
antiche tribù gentilizie dei Ramnes, Tities e Luceres, le quali
all’inizio, prima di trasformarsi in organi governativi, erano
state raggruppamenti familiari consociatisi per assicurare
quella difesa delle persone e dei beni a cui lo Stato, ancora
in embrione, non provvedeva. Le tribù territoriali, che
sembrano istituite appunto verso il principio del V secolo,
erano invece circoscrizioni create con lo scopo di
migliorare l’andamento delle operazioni di leva e della
riscossione del tributo. Ogni cittadino doveva essere
iscritto in uno di questi distretti, e pertanto tutto il
territorio dello Stato fu inizialmente diviso in quattro tribù
“urbane”, ove erano iscritti i cittadini domiciliati in Roma,
e sedici tribù “rustiche” (queste ultime, allargandosi il
31
territorio per effetto delle successive conquiste, raggiunsero
poi il numero di trentuno).
Di tale organizzazione i plebei si valsero per tenere
adunanze (concilia plebis tributa) e ivi coordinare i loro
attacchi ai privilegi nobiliari; quindi cominciarono coll’usare
l’arma delle secessioni, cioè con una sorta di resistenza
passiva, rifiutandosi di continuare ad adempiere agli
obblighi del cittadino. La prima secessione viene ricordata
per il 494, quando la plebe si ritirò sul Monte Sacro; essa si
lasciò indurre a più miti consigli - si raccontò poi - dal
famoso apologo di Menenio Agrippa, ma è un fatto che
proprio allora ottenne uno dei più grandi successi, quello di
darsi dei capi riconosciuti. Nacquero così i tribuni della
plebe che in origine, prima di diventare anch’essi veri e
propri magistrati, non furono se non dei capipopolo
rivoluzionari, che il governo patrizio dovette acconciarsi a
tollerare nella loro azione spesso violenta. Sotto la loro
guida la plebe percorse la lunga strada delle sue
rivendicazioni, che erano di natura diversa.
Una delle esigenze che i plebei più largamente
sentivano era quella di strappare al patriziato il monopolio
dell’amministrazione della giustizia. Della legge erano
depositari esclusivamente i nobili, che se la tramandavano
oralmente ed avevano essi soli la facoltà di applicarla: nel
451 e nel 450 la plebe ottenne che, invece dei consoli, a
capo dello Stato fossero nominati alcuni magistrati
straordinari, i decemviri consulari imperio legibus scribundis, e
questi approntarono un codice scritto di leggi civili e
penali. Furono le famose Dodici Tavole che, col sancire
l’uguaglianza di tutti gli uomini liberi di fronte alle leggi
civili e col porre a fondamento dello Stato la legge
approvata dal popolo e nell’interesse del popolo, dovevano
diventare fons omnis publici privatique iuris in un senso ancora
più ampio di quello che Tito Livio (III 34, 6) dava a questa
32
espressione, e cioè il germe da cui si sviluppò il diritto
ancora oggi vigente presso tanti popoli.
Pochi anni dopo, nel 445, con una legge proposta dal
tribuno C. Canuleio (lex Canuleia), veniva abolito il divieto
di matrimonio fra patrizi e plebei, divieto che, osservato
per un certo tempo soltanto in forza della consuetudine,
era già stato imposto con una legge delle XII Tavole. I
plebei, ormai, potevano battersi per raggiungere di nuovo il
consolato, e nel 444 addivennero a un compromesso. Negli
anni successivi a capo della repubblica si sarebbero potuti
eleggere i soliti due consoli, provenienti dal patriziato,
oppure un certo numero di cittadini che avevano ricoperto
o tuttora ricoprivano la carica di tribuni militari (cioè di
ufficiali superiori nella legione) e che perciò vennero
denominati tribuni militum consulari potestate: in seno a
costoro potevano essere eletti anche dei plebei. Per effetto
di tale compromesso nel corso di vari anni non si
susseguirono più coppie di consoli, ma collegi di tribuni
militum consulari potestate composti da un numero variabile di
membri (tre, quattro, sei, otto); solo nel secolo successivo il
consolato fu stabilmente restaurato, quando si concordò
che uno dei due posti di console spettava alla plebe.
Naturalmente, i patrizi cercarono di resistere come
potettero e fra l’altro, quando furono costretti ad accettare
l’eventualità di tornare a dividere con i plebei la più alta
carica dello Stato, essi la svuotarono di alcune attribuzioni
assegnandole ad una nuova magistratura esclusivamente
patrizia, la censura (a. 443).
I due censori, che si elessero ogni cinque anni (lustro
è da lustrum, il sacrificio di purificazione per il popolo con
cui i censori concludevano i loro lavori), dovevano in
primo luogo tenere aggiornata sia la lista dei cittadini, cioè
di quelli che potevano godere i diritti di cittadinanza, sia la
lista dei senatori, magari cacciandone gl’indegni. Poiché
33
tutto questo comportava anche una sorveglianza sulla
condotta pubblica e privata di ognuno, i censori ben presto
acquistarono un’influenza grandissima.
Secondo gli storici antichi, nel corso del lo stesso V
secolo la plebe avrebbe strappato anche una specie di
diritto di emanare leggi, cioè avrebbe imposto che si
riconoscessero come valide le deliberazioni prese nei suoi
concilia, ma questa conquista in realtà avvenne più tardi.
Comunque, i plebei avevano gia fatto parecchi passi verso
la rivendicazione dell’antica uguaglianza; grazie anche
all’apporto delle loro fresche energie sembrava aprirsi,
dopo la presa di Veio, un periodo di maggiore sicurezza e
prosperità, quando su Roma si abbatté il flagello
dell’invasione gallica.
Con la datazione indicata da Polibio per il più antico trattato romanocartaginese (vedi il capitolo precedente) è in contrasto la tradizione confluita in
Livio, ove di un simile foedus si parla per la prima volta solo sotto l’anno 348
(VIII 27, 2: cum Carthaginiensibus legatis Romae foedus ictum, cum amicitiam ac
societatem petentes venissent); di qui un dibattuto problema, soprattutto, ma non
soltanto, cronologico, su cui cfr. S. MAZZARINO, Introduzione alle guerre puniche,
Catania 1947.
Circa l’assoggettamento di Roma ad opera di Porsenna, cfr. TAC., Hist.
III 72: Id facinus (l’incendio del Campidoglio alla fine del 69 d.C.) post conditam
urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi Romani accidit ... sedem Iovis
Optimi Maximi auspicato a maioribus pignus imperii conditam, quam non Porsenna dedita
urbe neque Galli capta temerare potuissent, furore principum exscindi. Si veda anche
PLIN., Nat. Hist. XXXIV 139: In foedere quod expulsis regibus populo Romano dedit
Porsina, nominatim comprehensum invenimus ne ferro nisi in agri cultu uteretur.
Sulla battaglia del lago Regillo v. L. PARETI in “Studi romani” VII
(1959) p. 18 sgg. L’accenno alla “storia ufficiale” vuole richiamare l’attenzione
su uno dei caratteri più salienti della tradizione storica romana. Si tratta in
breve di questo: quando i Romani cominciarono a scrivere la storia più antica
della loro città, questa si era innalzata al rango di potenza mediterranea. Gli
umili inizi, il travaglio affannoso delle guerre continue, con battaglie spesso
vinte, ma talora anche perdute, parvero a quegli scrittori come una macchia per
la presente grandezza della patria, ed essi si studiarono di cancellarla alterando
la verità con vari espedienti. In seguito vi furono storici che su quegli stessi fatti
diedero racconti inquinati da altri elementi, per esempio dal gusto per le
amplificazioni o invenzioni retoriche. In conclusione, quando ancora più tardi
34
quelle narrazioni furono riprese da storici la cui opera si è conservata fino a noi
(come Livio), si era formata e ancor più si venne consolidando una specie di
versione ufficiale spesso poco rispettosa della verità dei fatti e, quindi, più che
mai da sottoporre al vaglio di un’attenta critica.
Sul foedus Cassianum (le cui clausole sono in parte riferite da DIONYS.
HALIC., VI 95, 2) cfr. CIC., Pro Balbo 23, 53: cum Latinis omnibus foedus esse ictum
Sp. Cassio Postumo Cominio consulibus quis ignorat? Quod quidem nuper in columna
ahenea meminimus post rostra incisum et perscriptum fuisse. Cfr. anche LIV. II 33, 9: nisi
foedus cura Latinis columna aenea insculptum monumento esset ab Sp. Cassio uno, quia
collega afuerat, ictum, Postumum Cominium bellum gessisse cum Volscis memoria cessisset.
Sui rapporti instaurati dal foedus fra la lega latina e i Romani sono da tener
presente due testi. Uno è un lemma di Festo (p. 276 LINDSAY) contenente un
frammento di Cincio (antiquario del I sec., da non confondere con l’annalista
Cincio Alimento) ove si parla di Romani che, in veste di praetores (lo stesso
titolo che precedette quello di consules), si recavano ad assumere il comando
dell’esercito federale: Praetor ad portam nunc salutatur is qui in provinciam pro praetore
aut pro consule exit; cuius rei morem ait fuisse Cincius in libro de consulum potestate talem
“Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem; Alba deinde diruta usque ad P. Decium
Murem consulem (cioè all’anno 340) populos Latinos ad caput Ferentinae, quod est sub
monte Albano, consulere solitos, et imperium communi consilio administrare; itaque quo
anno Romanos imperatores ad exercitum mittere oporteret iussu nominis Latini, complures
nostros in Capitolio a sole oriente auspicis operam dare solitos. Ubi aves addixissent, militem
illum, qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addixerant, praetorem salutare
solitum, qui eam provinciam optineret praetoris nomine. La lega di città latine, che
Cincio ricordava come avente il suo centro alla fonte Ferentina, è quella stessa
che troviamo menzionata in un frammento (58 PETER) delle Origines di Catone,
ove si riporta il testo di una dedica fatta per conto della lega dal comandante
militare dei confederati: lucum [***] Dianium in nemore Aricino Egerius Baebius
Tusculanus dedicavit dictator Latinus; hi populi communiter: Tusculanus, Aricinus,
Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutulus. All’atto della
dedica era un tusculano che, col titolo di dictator Latinus, comandava l’esercito
della lega latina, della quale vengono nominati come membri gli stati-città di
Tusculum, Aricia, Lanuvium, Lavinium, Cora, Tibur, Pometia, Ardea.
Sull’ampliarsi della dominazione romana nella Penisola, sempre
d’importanza fondamentale K.J. BELOCH, Der italische Bund unter Roms
Hegemonie, Leipzig 1880 (rielaborato nella già citata Römische Geschichte). Del
medesimo autore è ancora da tener presente, sulle condizioni sociali ed
economiche della popolazione di Roma nei primi secoli della repubblica, Die
Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig 1886; in particolare, per la società
romana nel V sec., v. A. PIGANIOL, La conquête romaine, 2a ed., Paris 1930, p. 95
sgg.
Illuminante sul carattere della religiosità romana la classificazione fatta
da Varrone (a noi nota attraverso AUGUSTIN., De civ. dei VI 3) fra dii certi, dii
incerti e dii praecipui atque selecti. Sulle pratiche cultuali nell’antica Roma è da
vedere, in generale, G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, 2a ed., München
35
1912, sostituito ora, nello “Handbuch der Altertumswissenschaft” fondato da
I. MÜLLER, dall’opera di K. LATTE, Römische Religionsgeschichte, München 1960; v.
anche P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, I, Torino 1960.
Sugli ordinamenti dello Stato romano, dalle origini al basso impero,
fondamentale TH. MOMMSEN, Das römische Staatsrecht, voll. I-III, Leipzig 1887
sgg. (sostanziali integrazioni di quest’opera, per quanto riguarda l’età imperiale,
sono rappresentati da due contributi di A. ALFÖLDI: Die Ausgestaltung des
monarchischen zeremonielles am römischen Kaiserhofe, in “Mitteilungen d. deutsch.
Arch. Inst.”, Röm. Abt., 1934, e Insignien und Tracht der römischen Kaiser, ibid.,
1935). Il Mommsen, peraltro, nell’indagare gli sviluppi degli ordinamenti statali
di Roma, li considerò come originati da una genuina creazione dei Romani,
cioè come affatto isolati da analoghi sviluppi verificatisi presso altri popoli
italici, i quali si sarebbero poi limitati, volenti o nolenti, ad adottare e adattare
gli schemi di governo elaborati dai Romani. Contro questa teoria già formulò
valide riserve A. ROSENBERG (Der Staat der alten Italiker, Berlin 1913);
sull’esistenza di una comune cultura italica e di un corrispondente comune
travaglio costituzionale che condizionò l’origine delle istituzioni romanoitaliche, v. S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano, sopra citato. Le
lacinie superstiti della legislazione decemvirale presso S. RICCOBONO, Fontes
iuris Romani anteiustiniani, I, Leges, 2a ed., Firenze 1941, p. 21 sgg.
36
37
III
Dall’incendio gallico al primato nell’Italia centrale.
1. Il disastro e la ricostruzione. - Col nome di Galli i
Romani chiamarono quelle popolazioni di stirpe celtica
che, muovendo nel primo millennio dalla Germania
meridionale, sciamarono nelle terre dell’Europa
occidentale. Nell’Italia settentrionale essi si affacciarono,
pare, all’inizio del IV secolo ed ebbero presto ragione delle
resistenze opposte dai Liguri e dagli Etruschi, cui
strapparono successivamente Melpum (che chiamarono
Mediolanum, Milano) e Felsina (Bologna).
Un’orda di questi Galli, con a capo Brenno, si spinse
attraverso l’Etruria interna e nel 390 (secondo Livio V 41
sgg.; 386 secondo la migliore cronologia di Polibio I 6, 1-2)
travolse sul fiume Allia, piccolo affluente del Tevere, lo
schieramento difensivo dei Romani e dei loro alleati.
Nessun altro ostacolo si frapponeva sulla via verso la vicina
Roma, che fu presa e messa a ferro e fuoco. Solo dopo vari
mesi i Romani riuscirono a fare allontanare i barbari dalla
città, e non per l’eroica riscossa di Camillo - come più tardi
si raccontò - ma pagando una forte somma di riscatto; del
resto gli invasori non erano mossi dal desiderio di
conquiste territoriali, ma solo dalla cupidigia di far bottino.
Gli storici romani, per attenuare le proporzioni del
disastro, raccontarono anche che si ebbe un’immediata
ripresa in ogni campo, tanto che un solo anno sarebbe
bastato a ricostruire la città, ma il vero è che il contraccolpo
subito dalla potenza romana fu assai duro: Volsci ed Equi
ripresero i loro attacchi mentre veniva meno l’aiuto dei
Latini e degli Ernici, che avevano colto il destro per
38
sottrarsi agli obblighi del trattato che li legava a Roma. Un
compenso a questo pericoloso isolamento i Romani lo
trovarono in una salda unione con la potente città etrusca
di Cere (oggi Cerveteri) che, situata presso la costa
tirrenica, non era stata toccata dalle devastazioni dei Galli.
A Cere erano stati posti in salvo e avevano trovato
ospitalità i patrii Penati e le Vestali: in cambio di questo
beneficio, che attraverso la continuità dei culti cittadini
aveva assicurato la sopravvivenza del la loro patria, i
Romani offrirono ai Cèriti la civitas sine suffragio (= senza
diritto di voto), una specie di cittadinanza onoraria che
cementava i vincoli fra i due popoli facendoli hospites gli uni
degli altri.
Forti di questa intesa, i Romani potettero
intraprendere quel trentennio di lotte che li portarono a
restaurare il loro prestigio nel Lazio. Contro i Volsci il
conflitto si protrasse con alterne vicende sino alla definitiva
occupazione della pianura pontina, che nel 358 entrò a far
parte del territorio dello Stato. Ugualmente fortunata fu la
lotta contro gli Equi collegati con Preneste, lotta nella quale
Roma fu largamente aiutata dai Tuscolani, i più esposti alla
minaccia degli Equi. Nello stesso anno 358, che aveva visto
chiudersi il duello con i Volsci, riusciva a Roma di
riannodare le fila della sua triplice alleanza rinnovando gli
antichi legami con gli Ernici e con le città della lega latina.
Dopo essere in tal modo risalita dal baratro in cui l’aveva
precipitata l’invasione dei Galli, Roma imboccò una nuova
politica che portò alla fine della stretta intesa con i Ceriti e,
in generale, della collaborazione con gli Etruschi.
Causa di questa rottura fu il prevalere della reazione
conservatrice su quei circoli democratizzanti di tendenza
filo-etrusca che sotto la guida del tribuno Licinio Stolone
avevano vigorosamente patrocinato le rivendicazioni della
plebe e, come vedremo, erano riusciti a restaurare
39
l’eleggibilità dei plebei al consolato, Questo dà ragione del
carattere di spietata ferocia che assunse il rinnovato cozzo
dei Romani con gli Etruschi, soprattutto con i Tarquiniesi
ed i Falisci. Così nel 358, dopo uno scontro sfortunato,
alcune centinaia di prigionieri romani furono trascinati a
Tarquinia e passati per le armi; quattro anni appresso,
quando la guerra prese una piega favorevole ai Romani,
questi si vendicarono infliggendo il medesimo trattamento
ad un numero ancor maggiore di Tarquiniesi presi in
battaglia. Nel 353 si pattuì con i Ceriti una tregua per la
durata di cento anni e infine nel 351 fu conclusa la pace
con i Tarquiniesi e i Falisci.
Ma queste lotte così aspre ed impegnative sui confini
settentrionali avevano deteriorato le posizioni romane,
ancora in via di consolidamento, nel settore meridionale,
cioè di fronte alle città latine. Ce lo mostra, fra l’altro, una
clausola contenuta in un nuovo trattato che nel 348 Roma
concluse con Cartagine allo scopo di confermare l’antica
amicizia e di delimitare le rispettive sfere d’influenza nella
navigazione e nel commercio. “Se i Cartaginesi”, riferisce
Polibio, “avessero preso nel Lazio qualche città non
soggetta ai Romani, essi potevano tenere il bottino e i
prigionieri salvo a consegnare la città ai Romani”. Una
clausola, questa, assai diversa da quella sancita nel
precedente trattato un secolo e mezzo avanti, quando si era
convenuto l’obbligo per i Cartaginesi di astenersi
dall’attaccare le città del Lazio e, se ne avessero presa
qualcuna, di consegnarla intatta ai Romani. Nel 348,
dunque, Roma sembra non solo prevedere attacchi dei
Cartaginesi contro le città latine con lei non collegate, ma
anche incoraggiare tali attacchi stabilendo i vantaggi che ne
potevano derivare all’aggressore. Evidentemente era un
modo di far pressione sui Latini, le cui relazioni coi
Romani si erano nuovamente guastate.
40
Allo stesso fine, in fondo, pare fosse stato concluso
qualche anno prima, nel 354, un trattato di alleanza con i
Sanniti.
2. I Sanniti e il loro primo conflitto con Roma. - I Sanniti
erano una popolazione dì stirpe sabellica, stanziata
sull’Appennino meridionale, che al principio del V sec.
avevano cominciato a spostarsi verso il sud provocando,
fra l’altro, la calata dei Volsci nella pianura pontina.
Favorite dal declino della potenza etrusca, le tribù
sannitiche più meridionali sboccarono nella Campania ove
si sovrapposero agli Ausoni, dei quali peraltro assorbirono
la superiore civiltà, formatasi al contatto con gli Etruschi e
con i Greci della Magna Grecia. Questi invasori, che i
Greci chiamarono Obikòi e i Latini Opsci oppure Osci, si
radicarono saldamente nelle nuove sedi organizzandosi in
tre leghe, con al centro rispettivamente Nuceria (od.
Nocera), Nola e Capua (od. Santa Maria Capua Vetere).
Quest’ultima, la lega dei Campani, era la più importante per
estensione e potenza, tanto che Capua divenne una delle
prime città d’Italia. Il diverso grado di civiltà e i
contrastanti interessi causarono una frattura fra gli Osci e le
più arretrate tribù sabelliche rimaste sui monti, ossia le
tribù (da nord a sud) dei Caraceni, dei Pentri, degli Irpini,
dei Caudini, che i Romani chiamarono col nome
complessivo di Samnites. Intorno alla metà del IV secolo i
Sanniti costituivano una compagine politica organizzata su
basi federali (meddix si chiamava il capo di ogni tribù,
meddix tuticus il capo di tutta la federazione), che si
estendeva dal versante adriatico a quello tirrenico, ove
premeva sulle fertili terre tenute dagli Osci.
L’accordo del 354 implicava da parte dei Romani
l’accettazione della politica espansionistica dei rudi e
bellicosi montanari dei Sannio verso la Campania, e se
41
Roma dovette per il momento acconciarvisi fu per
costituire una minaccia alle spalle dei Latini recalcitranti, e
anche per impedire che eventualmente i Sanniti si
intendessero con gli stessi Latini. Ma non si era trattato che
di un’occasionale convergenza d’interessi, e difatti, appena i
Sanniti tentarono di realizzare le loro mire sulla Campania,
trovarono la più energica opposizione proprio nei Romani.
La loro prima mossa fu in direzione di Teano, uno
dei centri del piccolo popolo dei Sidicini. Questi si
rivolsero per aiuti alla lega campana e a sua volta Capua,
facendosi accogliere in seno alla federazione romano-latina,
si assicurò l’appoggio romano. Scoppiava cosi, nel 343, la
prima guerra sannitica, che ebbe come scontri principali
una battaglia al Monte Gauro (nei Campi Flegrei) e una
presso Suessula (non lungi dall’odierna Cancello, in prov.
di Caserta) Gli storici antichi parlarono anche di una terza
battaglia che si sarebbe combattuta a Saticula (Sant’Agata
dei Goti), ma sembra poco credibile che l’esercito romano
si spingesse così addentro nel Sannio. Comunque, il duello
si era risolto in un trionfo della superiore organizzazione
militare dei Romani, sì che i Sanniti s’indussero a chiedere
pace.
Contemporaneamente si acuivano i vecchi dissidi fra i
Romani e i loro alleati, e mentre i primi, in vista di
eventuali complicazioni nel Lazio, concedevano ai Sanniti
miti condizioni, lasciando loro mano libera contro i Sidicini
di Teano, i Latini non solo deliberavano di continuare da
soli la lotta contro i Sanniti, ma scendevano in guerra
aperta contro Roma, decisi ad abbatterne la supremazia.
3. Insurrezione e scioglimento della lega latina - Verificatosi
un totale rovesciamento di posizioni, dalla parte dei Latini
si schierarono i Campani, scontenti della pace concessa ai
Sanniti, e invece questi ultimi si accordarono con i Romani.
42
Per effetto di tale accordo un esercito comandato dai
consoli Tito Manlio Torquato e Publio Decio Mure (340) si
portò in Campania passando non per l’infido territorio del
Lazio, ma addentrandosi nel paese dei Marsi e dei Peligni
per poi scendere attraverso il Sannio a congiungersi con
l’esercito sannita. Lo scontro si ebbe presso la località di
Veseris non lontano dal Vesuvio, e la vittoria fu assicurata si raccontò poi - dai patriottismo del console Decio Mure,
che fece getto della propria vita per assicurare il trionfo
delle armi romane. La lotta continuò ancora per due anni e
solo nel 338 i Latini, a cui si erano uniti anche i Volsci di
Anzio, furono definitivamente piegati con due battaglie
combattute nel cuore del loro territorio.
Le condizioni di pace dettate alle città latine dopo la
loro completa disfatta danno la misura della lungimiranza
della classe politica che reggeva le sorti della repubblica
romana. I Latini avevano violato il patto di alleanza e,
come fedifraghi, avrebbero potuto attendersi le più dure
imposizioni; ottennero, invece, un trattamento tale che da
quel momento in poi formarono un blocco unico con
Roma. Naturalmente la loro lega, dopo un secolo e mezzo
di vita, dovette sciogliersi, sì che nel Lazio non sopravvisse
che l’antichissima lega religiosa per la celebrazione delle
Feriae Latinae in onore di Giove Laziare. Le varie città
ebbero, quindi, una sorte diversa a seconda che per
ciascuna parve più opportuna. I centri più importanti della
disciolta lega e più vicini a Roma come Lanuvio, Aricia,
Nomento, Pedo furono trasformati in comuni romani, vale
a dire che i loro abitanti cessarono di essere Lanuvini,
Aricini etc., e diventarono Romani, con tutti i relativi diritti
e doveri, mentre il loro territorio veniva unito a quello
dello stato romano rendendolo più ampio e compatto. Le
altre città latine, come Tivoli, Preneste, Cora e tutte quelle
che a suo tempo erano nate come colonie latine,
43
mantennero la loro fisionomia di comuni Latini
formalmente indipendenti, salvo il divieto di unirsi fra loro
in nuove leghe e l’abolizione del vicendevole diritto di
conubium (cioè di contrarre matrimoni “misti”
giuridicamente validi) e di commercium (cioè di stipulare fra
loro atti di compravendita giuridicamente validi). Ciascuna
dovette sottoscrivere con Roma un singolo trattato di
alleanza, che sanciva i vantaggi e gli obblighi dei suoi
cittadini rispetto ai Romani: fra gli obblighi in primo luogo
quello di concorrere con un contingente militare alle guerre
di Roma, tra i vantaggi quello di poter acquistare, volendo,
la cittadinanza romana col semplice trasferimento del
domicilio in Roma. Un privilegio di non poca importanza,
quest’ultimo, che rendeva possibile ai personaggi più
cospicui delle città latine di stabilirsi in Roma e di
affermarsi, attraverso la partecipazione alla vita pubblica, in
seno alla classe di governo.
Anche per i Campani, che come i Volsci Anziati
erano stati a fianco dei Latini ribelli, ma che bisognava
tutelare dalle mire espansionistiche dei Sanniti cui
restavano esposti, le condizioni di pace non furono
punitive, bensì intese ad assicurare lo sviluppo di
amichevoli rapporti; pertanto, come ad Anzio, fu conferita
la civitas sine suffragio a Capua, a Cuma, a Suessula, nonché a
Fundi (Fondi) e Formiae (Formia) che si trovavano in
posizione dominante sulla via, ormai d’interesse vitale, che
menava dal Lazio alla Campania. Assai duro fu invece il
trattamento inflitto alla volsca Velletri, ove l’aristocrazia
ribelle fu sbandita e spogliata delle sue terre, che vennero
assegnate a cittadini romani.
Quanto agli Ernici, che a differenza dei Latini non
erano venuti meno al rispetto del trattato di alleanza, essi
restarono nell’antica condizione di foederati.
44
4. La seconda guerra sannitica. - L’intervento romano in
Campania, se aveva creato i lontani presupposti per
un’espansione verso quelle contrade, doveva portare, per la
stessa ragione, ad un nuovo e più aspro conflitto coi
Sanniti. Gli insuccessi della guerra del 343 non potevano
bastare a distogliere le mire di costoro da quelle terre
naturalmente ubertose e fecondate dal lavoro di una
popolazione industriosa e civile. Consapevoli di questo, i
Romani si preoccuparono assai presto di consolidare la
loro posizione, badando soprattutto ad assicurarsi con
nuove alleanze il controllo delle vie naturali di
comunicazione con la Campania.
Da parte loro, i Sanniti avevano esteso la loro
ingerenza in Campania stringendo accordi con la lega osca
di Nola e con la città greca di Napoli, dove ad un certo
punto introdussero anche un loro presidio. Ma questa
intesa con i Sanniti sembra che in Napoli fosse sostenuta
dal partito popolare e invece osteggiata dagli aristocratici i
quali, quando nel 327 i Romani decisero di intervenire
militarmente, intavolarono con loro lunghe trattative che si
conclusero con la stipulazione di un accordo. Era un gran
successo per la politica romana aver attirato nel sistema
delle sue alleanze una delle principali città della Magna
Grecia, ma nello stesso tempo si dava luogo ad un nuovo, e
questa volta assai più duro, conflitto col Sannio.
Piuttosto oscuri rimangono gli sviluppi di questa
seconda guerra sannitica, anche perché gli storici romani
che più tardi la narrarono ne alterarono il racconto,
sforzandosi di ingrandire le vittorie e, soprattutto, di
mettere in ombra gl’insuccessi. Ma è certo che le prime
battute culminarono in una disfatta per i Romani, che
avevano cercato audacemente di colpire la potenza nemica
nel cuore del suo territorio. Nel 321, mentre le legioni, al
comando dei due consoli s’inoltravano nello gole verso
45
Benevento, in vicinanza di Caudium caddero in
un’imboscata e furono costrette ad arrendersi e passare
sotto il giogo (Forche Caudine). Di questo grosso successo
i Sanniti non seppero approfittare e pertanto l’iniziativa
restò ai Romani, i quali, anziché ritentare la prova
dell’attacco diretto, intrapresero un’abile politica per
accerchiare i nemici. Si assicurarono infatti l’amicizia dei
popoli stanziati sull’Appennino a nord dei Sanniti (i Marsi, i
Peligni, i Marrucini, i Frentani) e strinsero alleanza con
alcune città dell’Apulia che si sentivano minacciate dalla
pressione sannitica.
A questo punto i Sanniti si mossero per spezzare
l’accerchiamento e, sboccati nella pianura laziale, giunsero
anche a minacciare da vicino la stessa Roma, che però
riuscì a contenere la loro offensiva e a presidiare con nuove
colonie le vie d’accesso dal Sannio verso il Lazio e la
Campania. In questa regione i Romani condussero
energiche operazioni non solo per via di terra (e a questo
scopo fu costruita la prima grande arteria stradale
d’Europa, la via Appia, con la quale nel corso della sua
censura cominciata nel 312 Appio Claudio il Cieco
congiunse Roma con Capua), ma anche per via di mare,
creando un corpo di fanteria da sbarco che agli ordini dei
duoviri navales, istituiti nel 311, operò sulle spiagge di
Pompei.
Nonostante qualche complicazione in Etruria, e
malgrado la defezione degli Ernici che vennero presto
domati, la guerra si avviava ad un epilogo favorevole per i
Romani, che nel 305 avanzarono ben addentro nel
territorio dei nemici costringendoli a chiedere pace. Questa
fu stipulata nel 304, e mentre il Sannio restava
sostanzialmente intatto (per il momento non era nemmeno
da pensare ad una diretta dominazione), il territorio
romano risultava ingrandito dal territorio degli ex alleati
46
Ernici che nel 306 si erano ribellati. Si trattava di Anagnia,
Aletrium e Frusino (Frosinone), i cui abitanti vennero puniti
con l’incorporazione nello Stato romano in qualità di cives
sine suffragio. Infatti a partire da questo momento) la civitas
sine suffragio non rappresentò più una forma di cittadinanza
onoraria, come era stata al tempo in cui fu data ai Cèriti;
ormai le città cui essa era stata estesa cessavano di essere
comunità autonome per divenire municipi romani, e
municipes diventavano i loro abitanti perché, trasformati in
cives sine suffragio non erano più, per es., Anagnini, Frusinati
ecc., ma cittadini romani di una categoria inferiore.
L’inferiorità consisteva nel dover adempiere agli obblighi
che incombevano sugli altri cittadini romani (municipes è da
munia capere) senza poter godere dei diritti politici
(simboleggiati dal suffragium o voto).
5.
La terza guerra sannitica e l’ampliarsi della
federazione romano-italica. - Appena sei anni durò l’intervallo
fra la seconda e la terza guerra sannitica. Quella del 304,
piuttosto che una pace, era stata una tregua, e i Romani ne
approfittarono per colpire e debellare definitivamente gli
Equi, che avevano ripreso le armi, e occuparne buona parte
del territorio ove furono fondate le colonie di Alba Fucens
(nel 303: Liv. X 1, 1) e di Carsioli (nel 302 o nel 298: Liv. X
3, 2; 13, 1. Vell. Pat. I 14). Nel frattempo grosse nuvole
tornavano ad addensarsi sull’orizzonte, e mentre Roma era
costretta ad impegnarsi contro i Sabini e gli Umbri, dovette
nuovamente affrontare l’urto dei Sanniti, coalizzati questa
volta con gli Etruschi e i Galli Sènoni (stanziati nelle
odierne Marche). Sulle prime, grazie alla posizione
geografica centrale che separava i nemici del nord da quelli
del sud, fu piuttosto agevole ai Romani di controllarne le
mosse; ma quando un grosso esercito sannita, passando
attraverso il territorio dei Peligni e dei Sabini, riuscì a
47
congiungersi nell’Umbria con le forze degli altri coalizzati,
il pericolo divenne mortale. Lo scontro decisivo, che
avvenne nel 295 presso Sentinum (non lungi da
Sassoferrato), giustamente fu definito “battaglia delle
nazioni”: dal suo esito, infatti, doveva dipendere se la
penisola aveva ancora da restar divisa fra popolazioni di
stirpe e civiltà diverse oppure avviarsi alla completa unità
nazionale e statale sotto l’impero di Roma. La grande
vittoria, che costò gravi perdite e la morte di un console
(Publio Decio Mure - si raccontò - come già suo padre
nella guerra contro i Latini del 340, avrebbe consacrato la
vita agli dei inferi), scongiurò per i Romani il pericolo di
rimanere schiacciati dalla coalizione avversaria, ma per
concludere il conflitto occorsero ancora altri cinque anni di
guerra. Al termine dei quali, nel 290, la potenza romana
risultava notevolmente accresciuta. Il Sannio rimase
indipendente, ma vincolato da un foedus e ancor più di
prima controllato da nuove colonie come Minturnae e
Sinuessa (presso Mondragone), fondate sul versante
tirrenico, e Venusia (in Apulia, od. Venosa), che con i suoi
20 mila coloni rappresentava per i Sanniti una formidabile
minaccia alle spalle. Parecchie città degli Etruschi, come
Volsinii (Bolsena), Arezzo, Perugia e Chiusi dovettero
entrare nell’alleanza romana, e così pure varie città degli
Umbri, fra cui alcune (Spoleto, Foligno), per la loro
posizione geografica dominante, furono direttamente
occupate dai Romani.
Ugualmente in diretto possesso dei Romani caddero
l’ampio territorio dei Sabini e il Piceno, e poco dopo
venivano strappate ai Galli Senoni le loro terre
sull’Adriatico, ove più tardi furono fondate le colonie di
Sena Gallica (Senigallia) e Arìminum (Rimini). In tal modo
Roma aveva fatto della confederazione romano-italica una
delle principali potenze del Mediterraneo: il territorio della
48
repubblica si aggirava sui 20 mila kmq con una
popolazione di circa un milione di cives Romani, mentre a un
paio di milioni assommavano i foederati distribuiti su un
territorio di 60 mila kmq.
Sull’invasione gallica della Penisola v., p. es., A. GRENIER, Les Gaulois,
Paris 1923; sulla questione relativa all’itinerario seguito dall’orda che giunse a
occupare Roma, G. VITUCCI, Problemi di storia e archeologia dell’Umbria, Perugia
1964, p. 291 sgg. Sullo scontro al fiume Allia (come poi, in genere, su tutte le
battaglie combattute da Greci e da Romani) sono da vedere gli Antike
Schlachtfelder di J. KROMAYER e G. VEITH, voll. 4, Berlin 1903-1931, corredati
dallo Schlachten Atlas (ai medesimi autori si deve la trattazione sulle antichità
militari nello Handbuch del MÜLLER, con il titolo: Heerwesen und Kriegführung der
Griechen und Römer, München 1928). Sulle relazioni fra Roma e Cere, M. SORDI,
I rapporti romano-ceriti e l’origine della civitas sine suffragio, Roma 1960.
Accennando al secondo trattato romano-cartaginese, Polibio (III, 24, 1-6) non
ne riferisce la data; tra le varie opinioni dei moderni è preferibile quella che lo
colloca nel 348, al quale anno Livio registra per la prima volta un foedus fra
Roma e Cartagine: cfr. S. MAZZARINO, op. cit. sopra, p. 45.
Il racconto della I guerra sannitica spec. in LIV., VII 29 e VIII 2
(qualche cenno anche in CIC., De divinatione I 24, 51; DIONYS. XV, 3, 2;
APPIAN., Samn. 1, e altri). Invece Diodoro ne tace completamente, dal che
alcuni critici hanno voluto ricavare che si tratterebbe soltanto di una
falsificazione dell’annalistica (vedi per esempio F. E. ADCOCK, in “Cambridge
Ancient History”, vol. VII, p. 588).
Sulla devotio del console Publio Decio Mure, sospetta alla critica perché
la cosa si ripete per Publio Decio Mure figlio (cos. 295) alla battaglia di
Sentinum, e per Publio Decio Mure nipote (cos. 279) alla battaglia di Ascoli
contro Pirro, è interessante la formula riportata da LIV., VIII 9, 6-9: Iane,
Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, divi Novensiles, di Indigetes, divi quorum est
potestas nostrorum hostiumque, diique Manes, vos precor veneror veniam peto feroque, uti
populo Romano Quiritium vim victoriamque prosperetis hostesque populi Romani Quiritium
terrore, formidine morteque adficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ita pro re publica Quiritium,
exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium legiones auxiliaque hostium mecum
deis Manibus Tellurique devoveo.
Le condizioni di pace alla fine del bellum Latinum sono riportate in
particolare da Livio (VIII 14: Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita cum eo, ut
aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Romano
esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure, quo Lanuvini, in civitatem accepti.
Tusculanis servata civitas, quam habebant, crimenque rebellionis a publica fraude in paucos
auctores versum. In Veliternos, veteres cives Romanos, quod totiens rebellassent, graviter
saevitum et muri deiecti, et senatus inde abductus, iussique trans Tiberim habitari, ut eius,
qui cis Tiberim deprehensus esset, usque mille pondo assium clarigatio esset nec prius quam
aere persoluto is, qui cepisset, extra vincula captum haberet. In agrum senatorum coloni
49
missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt. Et Antium nova
colonia missa cum eo, ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni vellent; naves inde
longae abactae, interdictumque mari Antiati populo est, et civitas data. Tiburtes
Praenestinique agro multati ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se
ademerunt. Campanis, equitum honoris causa, quod cum Latinis rebellare noluissent,
Fundanisque et Formianis, quod per finis eorum tuta pacataque semper fuisset via, civitas
sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque, cuius Capuam,
esse placuit. Naves Antiatium partim in navalia Romae subductae partim incensae,
rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornari placuit, rostraque id templum
appellatum). A questo proposito cfr. H. RUDOLPH, Stadt und Staat im römischen
Italien, Leipzig 1935; J. GÖHLER, Rom und Italien, Breslau 1939, con le
osservazioni di S. MAZZARINO, Dalla monarchia allo stato repubblicano, cit., p. 159
sgg. e G. VITUCCI, Latium, in “Dizionario Epigrafico di Antichità Romane
fondato da E. De Ruggiero”, vol. IV (1947) p. 433 sgg.
L’ubicazione di Caudium (Forche Caudine) si è in vario modo tentato di
determinarla con riferimento alle moderne località di Arienzo, Arpaia,
Montesarchio, S. Agata de’ Goti, Moiano; cfr. L. PARETI, Storia di Roma, I, p.
690 sgg. Sulle operazioni della III guerra sannitica nell’anno 298, oltre al
racconto di Livio (X 11-13) ci è pervenuto un breve resoconto nell’epitaffio di
Publio Cornelio Scipione Barbato, che condusse quelle operazioni in qualità di
console (C.I.L. I2 6, 7). Le due versioni sono discrepanti, ma non in maniera
inconciliabile, risalendo quella di Livio alla tradizione annalistica, quella
dell’epitaffio alle memorie gentilizie degli Scipioni. Un recente lavoro d’insieme
sullo incontro del mondo sannitico col mondo romano è quello di E. T.
SALMON, Samnium and the Samnites, Cambridge 1967.
Sull’ampliarsi del dominio romano nell’Italia centrale, G. DE SANCTIS,
Storia dei Romani, II, Torino l901 p. 348 sgg.; K. J. BELOCH, Römische Geschichte,
cit., p. 392 sgg.; A. FERRABINO, Nuova storia di Roma, I, Roma 1959, p. 265 sgg.
50
IV
Il regime nobiliare patrizio-plebeo. Il controllo
dell’Italia meridionale.
1. Conclusione delle lotte fra plebe e patriziato. - Nei
cent’anni, circa, che dal disastro dell’occupazione gallica
videro l’ascesa di Roma fino alla conquista del primato
nell’Italia centrale, veniva anche a compimento quel lungo
ciclo di lotte che portarono i plebei a conquistare nella vita
pubblica quella parità rispetto ai patrizi che avevano avuto
all’inizio della repubblica. Già si è accennato che dopo
l’invasione gallica ebbe per qualche tempo la prevalenza in
Roma una corrente politica di tendenze democratiche;
questa, al termine di una serie di contrasti, riuscì a fare
approvare nel 367 un gruppo di leggi, dette Liciniae Sextiae
dal nome dei due tribuni che fin dal 376 le avrebbero
proposte e per dieci anni tenacemente propugnate: Gaio
Licinio Stolone e Lucio Sestio Laterano. Per effetto di
queste leggi i plebei, anzitutto, si liberavano della loro
inferiorità “religiosa” ottenendo l’ammissione nel
sacerdozio dei decemviri sacris faciundis, e quindi potevano
essere eletti consoli.
Ma i patrizi, nel momento stesso in cui erano costretti
a condividere con la plebe la suprema magistratura dello
Stato, la svuotarono delle sue funzioni giudiziarie; cioè,
mentre fino allora l’amministrazione della giustizia era stata
di competenza dei due consoli, a partire dal 366 fu invece
affidata a un nuovo magistrato, il pretore, da eleggere
esclusivamente fra i patrizi. La plebe accettò
l’accomodamento confidando di non doverlo subire a
51
lungo, e difatti nel 337 fu eletto il primo pretore plebeo
nella persona di Quinto Publilio Filone. Del resto, già
prima era riuscito ai plebei di dare la scalata alle altre
magistrature più importanti, che si chiamavano
magistrature “curuli” dallo speciale scanno usato dai
magistrati, la sella curulis: così nel 356 fu nominato il primo
dittatore plebeo, Gaio Marcio Rutilo, che poi nel 351 fu
anche il primo plebeo a rivestire la censura. Ancora, nel
366 insieme con la pretura era stata istituita (e come
contrapposta ai due edili plebei, che erano gli aiutanti dei
tribuni della plebe) la edilità curule, con l’incarico di curare
la celebrazione dei ludi e di sorvegliare le strade e i mercati.
Tali funzioni avrebbero dovuto essere riservate a due
patrizi, ma ben presto si stabilì che un anno sì e uno no
anche i plebei potevano essere eletti edili curuli.
Mentre in questo modo gli uomini più eminenti della
plebe spezzavano le barriere che così a lungo li avevano
tenuti in uno stato d’inferiorità rispetto ai concittadini
patrizi, essi si adoperarono anche per migliorare le
condizioni economiche dei plebei appartenenti agli strati
inferiori della cittadinanza. Di tale problema sembra si
occupasse particolarmente una delle leggi Liciniae Sextiae (o,
più precisamente, una lex Licinia, cioè proposta dal solo
Gaio Licinio Stolone), la quale avrebbe introdotto una
nuova regolamentazione nel godimento dell’ager publicus.
Questo era costituito dai terreni che Roma aveva
confiscato ai nemici vinti; di essi era proprietario lo Stato,
che in buona parte li cedeva in uso ai cittadini che
volessero sfruttarli dietro la corresponsione di una modesta
percentuale sul reddito. Fino a quel momento a godere di
tali terreni (in una certa misura che andò aumentando a
mano a mano che con le nuove conquiste si ampliava l’agro
pubblico) lo Stato aveva ammesso esclusivamente i patrizi,
i quali del resto erano all’inizio i soli che potessero disporre
52
dei capitali necessari per sfruttarli. Si era così venuta a
costituire, sul piano economico, un’altra forma di
privilegio, ma con la legge Licinia i plebei l’abolirono
riuscendo a strappare ai patrizi il diritto di essere ammessi,
alla pari con loro, al godimento dell’agro pubblico.
È incerto se nel vittorioso corso di tali rivendicazioni si
sia provveduto anche ad alleviare la condizione dei plebei
oppressi dai debiti; comunque, a quest’ultimo proposito un
gran passo avanti si fece con la legge Petelia, che abolì
definitivamente l’imprigionamento per debiti e che fu fatta
approvare secondo Livio (VIII 28) dal console Gaio
Petelio Libone nel 326, secondo Varrone (De l. Lat. VII
105) da un omonimo figlio del precedente, dittatore nel
313. Invece fino allora il ricco aveva potuto tenere in
catene - e anche vendere come schiavo - il concittadino che
non riusciva a restituirgli il prestito ricevuto.
Procedendo sulla via delle rivendicazioni, i plebei si
sforzarono anche di accrescere l’importanza della propria
assemblea e quella delle relative deliberazioni, i plebiscita.
Questi dapprincipio non avevano avuto alcun valore
giuridico, e solo con la minaccia di far ricorso alla violenza
la plebe li aveva fatti rispettare. Ora bisognava costringere i
patrizi a riconoscerne la piena validità, e a questo si venne,
forse, già nel 339 durante la dittatura del plebeo Publilio
Filone; è certo, ad ogni modo, che l’efficacia dei plebisciti
fu definitivamente sanzionata nel 287 da una legge
proposta dal dittatore Quinto Ortensio.
2. Introduzione della costituzione “serviana”. - L’assemblea
della plebe si avviava in tal modo ad affermarsi come
organo più importante per l’espressione della sovranità
popolare e, probabilmente, proprio per impedire una simile
eventualità il governo nobiliare, intorno al 360, attuò quella
53
riforma per cui furono i comizi centuriati che,
trasformandosi da adunanze dei soli cittadini sotto le armi
in assemblee generali di tutti i cittadini, diventarono i
principali comizi del popolo romano. Si tratta,
precisamente, di quegli ordinamenti che gli storici antichi
attribuirono al re Servio Tullio, anticipando di circa due
secoli un’istituzione che invece, per un complesso di
ragioni, deve essere collocata nella prima metà del IV sec.
Secondo il nuovo ordinamento i cittadini furono
ripartiti in classi e centurie. Le classi erano cinque, e a
ciascuna di esse si veniva assegnati a seconda dell’entità
delle sostanze di cui si era forniti; non tutti i cittadini, però,
furono compresi nelle cinque classi, perché da una parte ne
rimasero fuori quelli più ricchi, dall’altra i nullatenenti.
Livio (I 43) attribuisce a Servio Tullio la nota scala dei
censi (almeno 100. 000 assi per la I classe, 75. 000 per la II,
50.000 per la III, 25.000 per la IV, 11.000 per la V), ma si
tratta di cifre valevoli evidentemente per un’età assai più
tarda, forse non anteriore alla guerra annibalica.
Le centurie erano 193, delle quali 170 furono costituite
dai cittadini delle cinque classi, e cioè 80 dalla I classe, 20
dalla II, 20 dalla III, 20 dalla IV e 30 dalla V. In ogni classe
le centurie erano formate una metà dagli iuniores (cittadini
fra i 17 e 45 anni) e una metà dai seniores (cittadini fra i 46 e
60 anni). Le rimanenti centurie vennero costituite da coloro
che erano fuori delle classi, e precisamente 18 dai più ricchi
(le centurie dei cavalieri) e 5 dai più poveri (detti proletarii o
capite censi).
Una simile ripartizione della massa dei cittadini in
centurie rispondeva insieme ai bisogni della pace e della
guerra, e pertanto il nome di centuria indicava
contemporaneamente
l’unità
fondamentale
sia
dell’organizzazione civile sia di quella militare. Sul campo di
battaglia una centuria era formata inizialmente, come dice il
54
nome, da 100 combattenti, e questi venivano reclutati in
seno alla corrispondente centuria del comizio che,
naturalmente, doveva comprendere parecchi cittadini di più
per poterne fornire 100 idonei al servizio di guerra. Di
norma il reclutamento veniva fatto tra gli iuniores (i seniores
costituivano una specie di riserva), e pertanto i cittadini
della I classe dovevano fornire 4000 fanti (40 centurie di
iuniores), quelli della II, III e IV 1000 ciascuna (cioè, ognuna
10 centurie dei suoi iuniores), quelli della V 1500 (15
centurie di iuniores): in totale 8500 uomini, quanti press’a
poco costituivano gli effettivi delle due legioni in cui si
articolava l’esercito romano verso la metà del IV secolo.
Ogni legione aveva infatti 4200 fanti, dei quali 3000 di
pesante armatura (con corazza, elmo di bronzo e grosso
scudo rettangolare) e 1200 armati alla leggera (con elmetto
di cuoio e piccolo scudo rotondo); e poiché l’armamento e
l’equipaggiamento erano a carico di ciascun combattente, la
fanteria pesante era formata dai cittadini delle prime tre
classi, che avevano maggiori possibilità, quella leggera dai
cittadini delle ultime due. Le 18 centurie dei cittadini più
ricchi dovevano poi fornire 600 uomini, con proprie
cavalcature, equipaggiati per il combattimento a cavallo
(300 per ogni legione), mentre le 5 centurie dei più poveri
davano uomini sprovvisti di armi che nell’esercito venivano
addetti a servizi vari.
Da tutto questo è evidente che gli obblighi più
gravosi, in primo luogo quello del servizio militare in
guerra, pesavano sui cittadini più ricchi, soprattutto quelli
delle 18 centurie equestri e della I classe, ma nello stesso
tempo il nuovo ordinamento attribuiva a costoro il
predominio nel governo della repubblica. Infatti il corpo
dei cittadini ripartito nelle 193 centurie, quando si radunava
nei comizi centuriati che fungevano ora anche da principale
assemblea popolare per l’approvazione delle leggi e
55
l’elezione dei magistrati, dava il suo voto centuria per
centuria. Ciò vuol dire che i voti dei singoli cittadini non si
sommavano globalmente, ma solo nell’ambito delle
rispettive centurie per determinare la volontà di ciascuna
centuria, e quindi i voti risultavano complessivamente in
numero di 193. Ora, poiché i cittadini più ricchi, quelli che
militavano a cavallo, avevano a disposizione 18 voti
(corrispondenti alle loro 18 centurie), e 80 ne avevano i
cittadini della I classe, è chiaro che costoro, se erano
concordi, con i loro 98 voti raggiungevano la maggioranza
sul totale dei 193 voti disponibili e, quindi, avevano un
peso determinante per decidere se, per esempio, quella tale
legge doveva essere approvata o respinta, oppure se alle
magistrature superiori, a cominciare dal consolato, doveva
essere eletto un candidato piuttosto che un altro.
3. La nuova nobilitas patrizio-plebea. - Si capisce che un
ordinamento di tal genere, commisurando al censo i diritti
e i doveri di ciascuno, seppure non ignorava gli strati più
umili della cittadinanza, era fatto apposta per tutelare
gl’interessi della ricca nobiltà che teneva le redini del
potere. Abbiamo detto nobiltà e non patriziato perché dal
momento in cui, dopo le leggi Licinie Sestie, anche gli
esponenti della plebe tornarono a raggiungere le più alte
magistrature dello Stato, si venne costituendo in Roma una
nuova classe di governo che fu formata insieme di patrizi e
di plebei, la cosiddetta nobilitas patrizio-plebea.
Naturalmente, sulle prime non furono molti i plebei
che, attraverso la gestione delle più alte magistrature curuli,
riuscirono a penetrare nelle file di questa nuova nobilitas:
homines novi vennero chiamati costoro con un certo
dispregio, e le antiche famiglie patrizie, collegate da vecchi
e nuovi vincoli d’interesse e di sangue, poterono battere
ancora a lungo la loro concorrenza. Per imporsi nella vita
56
politica, e anzitutto per assicurarsi il favore dei comizi,
occorreva non solo prestigio personale, ma anche una
grande ricchezza (i magistrati non avevano stipendio); ma
poiché l’economia romana conservava un carattere
eminentemente agricolo, la ricchezza continuò a restare
accentrata in prevalenza nelle mani dei patrizi, grandi
proprietari di terre. Tuttavia non pochi plebei
accumularono ingenti sostanze con l’esercizio dell’industria
e soprattutto del commercio che proprio in quest’epoca,
con l’allargarsi dell’orizzonte politico, ebbe notevole
incremento, come mostra il contemporaneo sviluppo della
circolazione monetaria.
Ad ogni modo i componenti plebei della nuova
nobilitas, se pure per vario tempo rimasero una minoranza e
anche se, chiuso il ciclo delle grandi rivendicazioni, furono
in genere portati ad allinearsi sulle posizioni conservatrici
del patriziato, non mancarono di far sentire la loro
influenza nel modificare le tradizionali direttive della
politica. Ma a questo proposito conviene osservare che
anche qualche elemento del patriziato attuò una politica in
certa misura democratica, sia pure soprattutto nell’intento
di cattivarsi il favore delle masse popolari. Ciò vale
specialmente per Appio Claudio il Cieco il quale fra l’altro,
nel corso della sua famosa censura cominciata nel 312,
nominò senatori alcuni cittadini di umili origini, tra cui
anche figli di liberti (cioè di ex schiavi).
Simili provvedimenti causarono, com’era naturale,
forti reazioni, ma ormai si trattava di diversità di tendenze e
di metodi più che di radicali contrasti, e sotto la guida del
governo patrizio-plebeo la repubblica si avviò decisamente
a primeggiare fra i paesi del Mediterraneo.
4. Taranto e Roma. - Già nel corso della seconda, e poi
della terza guerra sannitica, i Romani avevano avuto
57
occasione d’intervenire, con le armi o con le arti della
diplomazia, nelle regioni più meridionali della Penisola,
dove le rudi popolazioni indigene dell’interno premevano
sulle città della Magna Grecia. Dopo che Napoli, rimasta
come un’isola greca nella Campania sommersa dagli Osci,
era stata incorporata nel sistema federale romano, e mentre
si accentuava il declino delle altre colonie greche sotto la
spinta dei bellicosi Lucani, il principale baluardo della
grecità nell’Italia meridionale era diventata Taranto, florida
per gl’intensi traffici del suo porto in felice posizione tra
l’Oriente e l’Occidente.
Per parare la minaccia dei barbari confinanti, già prima
la città aveva dovuto chiedere aiuto ai Greci della
madrepatria, e i suoi appelli erano stati accolti per ultimo
dal re di Sparta Cleonimo (Taranto era stata fondata
nell’VIII sec. da coloni spartani). Cleonimo era sbarcato in
Italia nel 303, ma le sue imprese erano rimaste senza
conseguenze durature anche perché egli si era ben presto
guastato con i Tarentini, nei quali aveva suscitato il timore
di essere venuto nella Magna Grecia più come
conquistatore che come liberatore.
Nella sua spedizione, Cleonimo si era trovato a
fronteggiare anche i Romani, che si erano legati con i
Lucani per completare l’accerchiamento del Sannio, e
quando il re spartano, rotto l’accordo con Taranto, se ne
partì senza aver nulla concluso, i Tarentini stipularono con
i Romani un trattato nel quale si delimitavano le rispettive
zone d’influenza. I Romani, impegnandosi a non navigare
nel golfo di Taranto, riconoscevano in quella zona la
supremazia dei Tarentini, ma nello stesso tempo si
vedevano riconosciuto il diritto di intervenire in tutto il
resto della Italia meridionale.
Questo intervento ebbe luogo nel 282, quando i
Romani stabilirono di accordare il loro aiuto agli abitanti
58
della colonia greca di Turi che, incalzati dai Lucani,
avevano preferito rivolgersi a loro piuttosto che ai
Tarentini, da cui li dividevano vecchie rivalità. Le
operazioni furono condotte energicamente dal console C.
Fabricio, e poiché la guerra si era allargata ai Sanniti e ai
Bruzi, i Romani non si limitarono a liberare Turi, ma
provvidero ad occupare opportune posizioni strategiche
introducendo guarnigioni, oltre che in Turi, anche in Locri
e in Reggio. In tal modo l’iniziativa dei Turini aveva avuto
sviluppi assai pregiudizievoli per gli interessi dei Tarentini;
questi avevano ogni ragione di essere preoccupati delle
mosse dei Romani, e quando in violazione del recente
trattato, una flottiglia romana fece la sua apparizione nel
golfo, vi fu un vero scoppio di furore guerresco. La
flottiglia fu in parte affondata o catturata, in parte costretta
a fuggire, e pochi mesi dopo la città di Turi veniva
espugnata e saccheggiata.
Fallite le trattative che i Romani avevano intavolato
per non estendere ulteriormente il conflitto già in atto
contro Sanniti, Lucani e Bruzi, fu dichiarata la guerra e nel
281 il console Lucio Emilio Barbula si affrettò a portare
direttamente la minaccia sulla città nemica. Intercorsero
altri negoziati, appoggiati in Taranto da quelli che
inclinavano ad un accordo con Roma, ma non
approdarono a nulla; ebbero invece successo le trattative
dei Tarentini per assicurarsi l’intervento di Pirro, re
dell’Epiro.
5. Pirro in Italia. - Pirro era allora nel fiore degli anni e
delle speranze. Ancora giovinetto aveva regnato per
qualche anno sull’Epiro (corrispondente all’incirca
all’odierna Albania): poi ne era stato espulso, ma l’aveva
recuperato con l’aiuto di Tolemeo Sotere re di Egitto.
59
Le sollecitazioni dei Tarentini trovarono presso di lui
facile accoglienza. A convincerlo della opportunità di una
spedizione oltre il mare fu forse il timore di vedere i
Romani prendere possesso della altra sponda
dell’Adriatico, dirimpetto ai suoi domini, oppure il disegno
più vasto di cogliere quell’occasione per riprendere l’opera
del suocero Agatocle (tiranno di Siracusa dal 316 al 289) in
difesa dei Greci d’occidente contro il minaccioso
espansionismo di Cartagine. L’intervento per allontanare i
Romani dal centro più importante della Magna Grecia
poteva essere, per il re epirota, un’operazione di secondaria
importanza, e cioè la premessa per una più vasta azione
intesa ad unire in un grande stato i Greci di Italia (Italioti) e
di Sicilia (Sicelioti).
Si trattava, però, di un piano fondato su una
conoscenza assai imprecisa della forza di Roma, né
dobbiamo stupircene perché in effetti, fino a quel
momento, nel mondo greco risonante ancora delle
clamorose imprese di Alessandro Magno e dei suoi
successori, Roma non poteva venir considerata che una
potenza di rango inferiore. A questo errore di valutazione
se ne accompagnò un altro non meno grave, vale a dire
l’illusione che le città greche d’occidente, superando il loro
tradizionale spirito di particolarismo, avrebbero saputo
accantonare le secolari rivalità e, insieme, rinunciare a una
parte della loro autonomia: premesse entrambe
indispensabili perché potessero entrare a far parte di uno
stato unitario. Il fallimento dell’impresa era dunque segnato
in partenza; il grande talento di condottiero, un esercito
addestrato alle tecniche dell’arte militare greca - che era
allora più progredita di quella romana - consentirono a
Pirro di vincere varie battaglie, non di riportare il successo
finale.
60
Sbarcato nella primavera del 280 con circa 25.000
uomini e alcune decine di elefanti, il re epirota si scontrò
con i Romani in una località sita tra le città di Eraclea e
Pandosia (nell’odierna provincia di Matera). Pirro si era
attestato dietro il fiume Siris (odierno Sinni), ma i Romani
animosamente superarono l’ostacolo e diedero inizio al
combattimento. Era la prima volta che essi si trovavano a
fronteggia re l’urto degli elefanti - i “buoi (nel senso di
bestioni) Lucani”, come allora li chiamarono - e lo scontro
si risolse in un grave disastro. Deciso a sfruttare il successo,
Pirro risalì attraverso la Campania e si spinse nel Lazio fino
ad Anagni, ma la sua speranza di provocare una
sollevazione generale contro Roma andò presto delusa e
per il momento non gli rimase che rientrare a Taranto.
L’anno dopo (279) il re iniziò la campagna in direzione
dell’Apulia, ove i Romani inviarono le loro 4 legioni e i
contingenti alleati agli ordini di entrambi i consoli. Lo
scontro avvenne nel territorio di Ascoli (oggi Ascoli
Satriano, in prov. di Foggia) e ancora una volta Pirro ebbe
la meglio grazie ai suoi elefanti. Sul terreno restavano più di
seimila morti, fra cui il console Publio Decio Mure, che
secondo il racconto degli storici romani aveva
volontariamente sacrificato la vita come già a suo tempo
avevano fatto l’avo nella guerra latina (a. 340) e il padre
nella battaglia di Sentinum (a. 295).
Se anche non si era trattato di una vittoria decisiva
(tant’è vero che più tardi qualche storico poté addirittura
parlare di un successo romano), tuttavia il senato di Roma
deliberò di intraprendere sondaggi per arrivare ad un
accordo e nello stesso anno 279 ne affidò l’incarico a Gaio
Fabricio. Un simile passo destò le preoccupazioni dei
Cartaginesi; questi avevano tutto l’interesse che Pirro
continuasse ad essere impegnato in Italia (e quindi
impedito di rivolgersi alla Sicilia, dove richiedevano il suo
61
intervento sia i Siracusani sia gli Agrigentini, allora in lotta
fra loro), e pertanto si affrettarono a inviare alle foci del
Tevere una flotta agli ordini del generale Magone,
incaricato di offrire alleanza e aiuti. Ma l’offerta non venne
accettata: in quel momento avevano la prevalenza in Roma
i pacifisti che rappresentavano gl’interessi della nobilitas
plebea, ricca non tanto per i grandi possedimenti terrieri
(come i patrizi), quanto per le imprese commerciali. In
fondo la pace con Pirro, che non aveva affatto ottenuto un
successo decisivo, avrebbe comportato soltanto l’obbligo
di rispettare l’indipendenza della Magna Grecia. Ora ai
pacifisti di parte democratica la rinuncia ad ogni mira
sull’Italia meridionale spiaceva meno che un nuovo
accordo con Cartagine, la quale nei suoi precedenti trattati
aveva sempre badato a limitare lo sviluppo del commercio
romano nel Mediterraneo.
6. Pirro in Sicilia e il definitivo fallimento della sua impresa. Ben presto però la situazione generale subì un vero e
proprio capovolgimento. Pirro aveva esitato per vari mesi a
sottoscrivere la pace offerta dai Romani perché, se anche
questa gli riconosceva la figura del vincitore, non gli dava
però alcun vantaggio concreto. Una volta ottenuto dai
Romani l’impegno a rispettare la libertà della Magna
Grecia, egli avrebbe dovuto lasciar l’Italia, e quindi o
tornare in Epiro o passare in Sicilia, ma non - come
desiderava - in veste di liberatore dei Sicelioti dal dominio
cartaginese.
Infatti il suo appoggio era stato sollecitato, come s’è
visto, sia dagli Agrigentini sia dai Siracusani, e accettando di
soccorrere gli uni o gli altri egli avrebbe immeschinito la
sua azione mescolandosi nei soliti contrasti che dividevano
le città greche.
62
Però alcuni mesi dopo in Sicilia le cose mutarono:
nella primavera del 278 i Cartaginesi, preoccupati che il re
finisse col decidersi a passare nell’isola, presero l’iniziativa
delle operazioni e strinsero d’assedio Siracusa. Ma questo
era proprio ciò che Pirro voleva per poter scendere in
campo come paladino dell’indipendenza dei Sicelioti, e di
fatto poco dopo egli salpava da Taranto alla volta della
Sicilia. La sua mossa provocò naturalmente una svolta nella
politica romana: si giudicò troppo grave il pericolo che egli
riuscisse a raccogliere sotto la sua bandiera le forze greche
dell’isola per poi tornare a riprendere il duello interrotto, e
allora in senato prevalse il parere dei bellicisti, sostenuto in
particolare con un famoso discorso da Appio Claudio il
Cieco. Vennero troncate le trattative con Pirro, che dopo
averle trascinate così in lungo desiderava ora concluderle
per non lasciarsi la guerra alle spalle, e insieme furono
accettate le offerte dei Cartaginesi con i quali si concluse un
nuovo trattato.
Sbarcato in Sicilia nell’estate del 278 con la metà
dell’esercito (l’altra metà era rimasta a difesa di Taranto),
Pirro riuscì facilmente a liberare Siracusa dal blocco
cartaginese e vi fece un ingresso trionfale. Il suo arrivo
suscitò un’ondata di entusiasmo, e mentre veniva
proclamato “egémone e re della Sicilia” egli si diede a
raccogliere rinforzi da ogni parte. Nella primavera del 277
intraprese una campagna che lo portò in breve a liberare
tutta la Sicilia tranne la fortezza di Lilibeo (od. Marsala)
sulla punta occidentale dell’isola, dove però s’imbatté in
una resistenza così accanita che quando i Cartaginesi gli
offrirono di trattare la pace egli si mostrò incline ad un
accordo. Ma questo suscitò la più violenta reazione nei
Sicelioti, i quali ben sapevano che non sarebbero mai stati
sicuri se i Cartaginesi non avessero sgombrato anche
quell’estremo lembo dell’isola, e Pirro dovette riprendere le
63
operazioni contro Lilibeo finché, dopo qualche mese di
inutile logoramento, fu chiaro che l’impresa non sarebbe
riuscita.
Ciò produsse nei Greci un grande sconforto e
accrebbe il loro malcontento per i gravi sacrifici di sangue e
di denaro cui Pirro li aveva duramente assoggettati.
L’entusiastica adesione di qualche anno prima si venne
mutando in aperta ostilità, e nell’autunno del 276 al re non
restava di meglio che tornarsene in Italia, dove, più che i
Tarentini, lo invocavano i Sanniti, i Lucani e i Bruzi ridotti
a mal partito dai Romani. Infatti questi avevano continuato
la guerra riportando alcuni buoni successi, e Pirro dové
prepararsi con tutto l’impegno a ristabilire la situazione.
Lo scontro decisivo ebbe luogo nella primavera del
275, (forse in Lucania piuttosto che presso Benevento), e
seppure non si trattò di una vera e propria vittoria dei
Romani, il risultato fu ugualmente positivo perché in
effetti, dopo quella battaglia, Pirro si decise ad
abbandonare la partita e a tornarsene in Epiro per rituffarsi
nelle lotte di predominio dei sovrani ellenistici. È vero che
egli lasciava in Taranto un presidio agli ordini del figlio
Eleno, con la evidente speranza di poter riprendere il
duello in tempi migliori, ma poi fu costretto a richiamare il
figlio suggellando così la fine della sua troppo audace
avventura.
7. Importanza dell’espansione nell’Italia meridionale. Sviluppo
economico e progresso civile. - Nel 272 Taranto ottenne “pace e
libertà”, cioè non fu assoggettata, ma dovette entrare a far
parte della confederazione romano-italica obbligandosi per
di più ad ospitare una guarnigione; anche Bruzi e Lucani
ottennero un trattato di alleanza, mentre ai Sanniti fu tolta
buona parte del territorio, ove la stessa Benevento nel 268
diventò una colonia latina. L’anno dopo entravano nella
64
confederazione anche i Salentini, con l’importante porto di
Brindisi, e così tutta l’Italia meridionale veniva inquadrata
nel sistema dello Stato romano. Si trattava di un organismo
composito, popolato di cives optimo iure (tra cui i coloni delle
coloniae Romanae) e di cives sine suffragio (i municipi), di alleati
Latini (tra cui i coloni delle coloniae Latinae) e di alleati Italici
(in senso lato): tutta una varietà di condizioni
corrispondenti ad una varietà d’interessi che, appunto
perché singolarmente tenuti in considerazione da Roma,
cementavano intorno ad essa genti di origine, lingua e
costumi diversi. In seno a questo organismo unitario
divenne più rapida e agevole ogni sorta di scambi, dagli
economici ai culturali, e questo non a beneficio dei soli
Romani. Così, per esempio, se proprio in quest’epoca
Roma prese a far concorrenza alle città italiote nelle diverse
aree commerciali e adeguò la sua moneta ad una più larga
rete di scambio, sicché il denarius soppiantò poi le monete
di Taranto, di Reggio, di Napoli ecc., è anche vero che di lì
a non molto, sulla scia delle armi romane,
all’intraprendenza degli Italioti si sarebbero aperti i più
grandi mercati dell’Oriente.
Ma l’annessione dell’Italia greca fu soprattutto ricca
di conseguenze per il progresso della civiltà. La pace di
Roma, infatti, non solo impedì che venissero sommersi dai
popoli confinanti (e poi dai Cartaginesi) gli istituti civili e
religiosi, i costumi e la lingua dei Greci d’Occidente, ma
permise che essi continuassero ad evolversi e a irradiare la
loro influenza. E furono proprio di origine italiota quegli
ingegni che alla letteratura e all’arte di Roma fecero
muovere i primi passi sulla lunga via che portò al formarsi
di quel comune patrimonio culturale greco-romano
destinato a divenire uno dei pilastri della moderna civiltà.
65
Il resoconto più ampio sul compromesso costituzionale del 367 (leggi
Liciniae Sextiae) presso Livio, VI, 35, 4 seg.: creatique tribuni C. Licinius et L.
Sextius promulgavere leges omnes adversus opes patriciorum et pro commodis plebis: unam de
aere alieno, ut deducto eo capite, quod usuris pernumeratum esset, id quod superesset triennio
aequis portionibus persolveretur; alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta iugera
agri possideret; tertiam, ne tribunorum militum comitia fierent, consulumque utique alter ex
plebe crearetur: cuncta ingentia, et quae sine certamine maximo obtineri non possent. Per le
questioni relative al godimento delle terre demaniali, L. ZANCAN, Ager
publicus. Ricerche di storia e di diritto romano, Padova 1935.
Sulla data più probabile dell’introduzione degli ordinamenti centuriati,
attribuiti dalla tradizione a Servio Tullio, cfr. G. GIANNELLI, Origini e sviluppi
dell’ordinamento centuriato, in “Atene e Roma” XV (1935) p. 229 sgg.; ID. in
GIANNELLI-MAZZARINO, Trattato di Storia Romana, I, p. 180 sg. Sui riflessi
militari dei nuovi ordinamenti, v. J. KROMAYER - G. VEITH, Heerwesen und
Kriegführung, cit., p. 255 sgg. A proposito della scala dei censi, attribuita nelle
fonti al VI secolo (Servio Tullio) mentre, come sopra s’è detto, va piuttosto
riferita alla fine del III sec., è da ricordare che la prima fusione dell’aes grave,
cioè l’emissione degli assi librali (la prima vera e propria moneta romana) ebbe
luogo intorno alla metà del IV sec. Circa un secolo dopo (nel 269 secondo
PLIN., Nat. hist. XXXIII 44) cominciò la coniazione della moneta argentea:
denarius (10 assi), quinarius (5 assi), sestertius (2 assi e mezzo) del peso
rispettivamente di grammi 4,55; 2,27; 1,13. Per quanto riguarda la validità del
dato cronologico conservato dalla tradizione letteraria, si deve ricordare che
essa è stata sostenuta dai numismatici della scuola italiana, mentre è stata
revocata in dubbio da parecchi studiosi stranieri, soprattutto dall’inglese H.
MATTINGLY, secondo cui la coniazione del denarius sarebbe cominciata nel II
sec. a.C. Ma a confermare la bontà della data tradizionale è ora sopravvenuto il
dato obiettivo di recenti scavi, da cui risulta che il denarius circolava già nel III
sec. a.C. Cfr. L. BREGLIA, I rinvenimenti monetarii di Morgantina ecc. in “Ann. Ist.
It. di Num.” IX -XI (1966) p. 304 sgg.; S. CONSOLO LANGHER, Ricerche di
numismatica, Messina 1967, p. 169 sgg. T. V. BUTTREY e H. B. MATTINGLY in
«Atti Congr. intern. numism.” Roma 1965, p. 261 sgg. Sulla classe di governo
nobiliare, e sui legami intercorrenti fra i vari gruppi, resta esemplare (a parte
qualche riserva) l’opera di F. MÜNZER, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien,
Stuttgart 1920. Sull’intervento di Roma nelle regioni più meridionali della
Penisola, e particolarmente sulle sue relazioni con i Tarentini, v. P.
WUILLEUMIER, Tarente dès origines à la conquête romaine, Paris 1939. Lo sbarco in
Italia di Pirro, e l’importanza dell’azione militare e politica da lui intrapresa
attirarono l’attenzione di storici greci contemporanei di grande valore, come
Ieronimo di Cardia e Timeo; ma delle loro trattazioni (perdute) ben poco è
passato nei racconti giunti fino a noi, tutti più o meno inquinati dalle consuete
deformazioni dell’annalistica, compresa anche la plutarchea Vita di Pirro.
Un’idea del racconto liviano (scomparso con la perdita della II decade,
che riferiva gli avvenimenti dal 292 al 218) l’abbiamo, oltre che dalle periochae
(libri XII-XV), dagli epitomatori Floro, Eutropio e Orosio. L’incertezza della
66
tradizione si riflette, naturalmente, nella discordanza delle ricostruzioni
moderne e ha dato alimento a una vasta bibliografia, anche perché qui si tratta
di uno dei capitoli più attraenti della storia greco-ellenistica (e, come tale, svolto
con la solita maestria da K. J. BELOCH anche nel vol. IV della sua Griechische
Geschichte). Tra gli scritti più recenti sull’argomento si ricorderà quello di P.
LEVÉQUE, Pyrrhos, Paris 1957. Sull’inserirsi delle poleis d’Italia negli schemi di
governo romani, v. F. SARTORI, Il declino della Magna Grecia: libertà italiota e
civitas romana, in “Riv. Storica Ital.” LXXII (1960) p. 5 sgg.
67
V
Roma e Cartagine.
1. Dall’amicizia al conflitto. - Come s’è visto, le relazioni
ufficiali fra la repubblica dei Romani e quella dei
Cartaginesi datavano da tempi assai antichi. Una serie di
trattati aveva a più riprese ribadito la vecchia amicizia fra i
due Stati, e l’assenza di qualsiasi motivo per un sostanziale
contrasto aveva fatto sì che nulla venisse a turbare l’intesa.
Le cose improvvisamente mutarono quando i
Romani, estendendo il loro predominio sull’Italia meridionale, si affacciarono sullo stretto di Messina. Ormai la
lotta secolare di Cartagine contro i Sicelioti per assoggettare
tutta l’isola non poteva lasciarli indifferenti: se i Cartaginesi
si fossero insediati da dominatori anche nella parte
orientale della Sicilia, avrebbero costituito una grave
minaccia per gli interessi romani da poco affermati
nell’estremità meridionale della Penisola. E in realtà alla
grande floridezza economica di Cartagine continuava ad
accompagnarsi quella politica espansionistica in virtù della
quale la città era divenuta la capitale di un grande impero
che accentrava, in qualità di alleati o di sudditi, gli abitanti
delle altre colonie fenicie del Mediterraneo (i Libiofenici) e
le popolazioni del retroterra africano (dalle colonne
d’Ercole alle Sirti) della Spagna meridionale, della Sicilia
occidentale, della Sardegna, della Corsica. Il governo era
nelle mani dei ricchi proprietari terrieri e, soprattutto, degli
elementi più cospicui del mondo degli affari; erano
appunto questi che, alla ricerca di nuove aree per
l’espansione dei loro traffici, imprimevano alla politica
68
cartaginese quel vigoroso dinamismo che ad un certo
punto preoccupò il governo di Roma e finì per trasformare
la vecchia amicizia in mortale rivalità.
L’immane conflitto, che caratterizzò più di un secolo
di storia (l’età delle guerre puniche), ebbe modeste origini.
V’erano in Sicilia alcune migliaia di mercenari campani (i
Mamertini, così detti dal nome del dio Mamerte,
l’equivalente osco del Marte latino); a suo tempo questi
erano stati al soldo di Agatocle, tiranno di Siracusa, e dopo
la morte di costui, mentre stavano tornando in patria, si
erano impadroniti con un colpo di mano della città di
Messina (a. 283). Pirro li aveva più volte battuti, ma senza
riuscire ad eliminarli; dopo la sua partenza i Mamertini
avevano ripreso le loro incursioni brigantesche nel vicino
territorio di Siracusa finché, nel 265, subirono una grave
sconfitta ad opera del duce siracusano Gerone, che ottenne
allora dai concittadini, in ricompensa, il titolo di re.
Assediati in Messina, i Mamertini decisero di chiedere aiuto
ai Cartaginesi, che inviarono un corpo a presidiare la rocca
della città mentre Gerone si ritirava. Ma poco dopo, poiché
le truppe cartaginesi di occupazione erano viste sempre più
di malocchio, i Mamertini deliberarono di invitare i Romani
a prendere possesso della città.
Accogliendo l’invito, il senato di Roma mostrò di
essere disposto ad affrontare i rischi che esso comportava,
e questo spiega l’azione decisa di Appio Claudio (cons.
264), che, nonostante la vigilanza della flotta cartaginese,
riuscì a far passare al di là dello Stretto un buon
contingente del suo esercito e costrinse il presidio punico a
sgombrare la cittadella di Messina. Preoccupato per
l’energico intervento romano, Gerone s’indusse ad unirsi
coi Cartaginesi, e i due alleati assediarono Messina, ove nel
frattempo era entrato il console col resto dei suoi uomini.
Appio Claudio non solo si liberò dal blocco, ma costrinse
69
gli avversari a ritirarsi verso le loro basi; l’anno appresso il
console Marco Valerio Massimo (detto poi Messalla da
Messana, cioè Messina) obbligava Gerone a passare dalla
parte dei Romani.
2. Gli sviluppi della prima guerra punica. - Con l’appoggio
di Gerone, che rimase poi fedele alleato fino alla morte, i
Romani avrebbero potuto in tempo relativamente breve
piegare i Cartaginesi ad un accordo; invece la guerra si
trascinò con alterne vicende per oltre vent’anni. Questo
dipese soprattutto dal sistema di cambiare ogni anno i
generali sul campo, cioè i consoli, con evidente pregiudizio
della necessaria continuità nell’azione di comando, e non
certo da difetto di energia nel senato. Basta pensare alla
rapidità con la quale, una volta compreso che bisognava
tagliare la linea dei rifornimenti con cui Cartagine
alimentava la guerra in Sicilia, si provvide alla costruzione
di una flotta da guerra, e quindi a trasformare anche in potenza marittima quella che fino allora era stata solo una
potenza terrestre. Con questa flotta il console Gaio Duilio
riportò nel 260 la famosa vittoria di Milazzo, sopperendo
alla scarsa esperienza con l’ingegnosa trovata dei corvi (una
specie di ponti levatoi) mediante i quali le sue navi
agganciarono quelle nemiche e permisero ai legionari
imbarcati di combattere come in terraferma.
Questa vittoria fu la premessa indispensabile per il
coraggioso tentativo, fatto qualche anno dopo, di chiudere
la partita portando la guerra direttamente contro Cartagine.
Nel 256, sbaragliato al capo Ecnòmo la flotta nemica che
tentava di sbarrare il passo, il corpo di spedizione agli
ordini dei consoli Marco Attilio Regolo e Lucio Manlio
Vulsone sbarcò in Africa presso Clupea e vi organizzò le
sue basi. Poi, mentre una metà dell’esercito col console
Vulsone tornava a svernare in Italia, Attilio Regolo avanzò
70
in direzione di Cartagine e, sconfitto un esercito nemico,
s’impadronì di Tunes (Tunisi) ove pose i quartieri d’inverno.
Nella primavera dell’anno successivo i Cartaginesi
offrirono nuovamente battaglia, e Attilio Regolo, che pure
avrebbe potuto attendere il prossimo arrivo dei rinforzi,
baldanzosamente accettò subendo però questa volta un
grave rovescio e cadendo egli stesso prigioniero. Ai nuovi
consoli, che approdarono poco dopo a Clupea, non restò
che raccogliere i pochi superstiti e riprendere il viaggio di
ritorno, durante il quale subirono gravissime perdite per
una tempesta. Tra parentesi, è da notare che le prime flotte
romane soffrirono i danni maggiori non dall’agguerrita
marina avversaria, ma dalle tempeste da cui gli improvvisati
ammiragli si lasciarono più volte sorprendere.
Abbandonata l’idea dell’attacco diretto a Cartagine, i
Romani ripresero la guerra in Sicilia, dove s’impadronirono
di Panormo (Palermo) e strinsero d’assedio Lilibeo, senza
però riuscire ad espugnarla. Nel 247, fallito un tentativo per
raggiungere un accordo (a perorare la pace i Cartaginesi
avrebbero mandato lo stesso Attilio Regolo, che invece
incitò il senato a non cedere e a rinviarlo a Cartagine, pur
sa pendo che avrebbe pagato con la vita il suo
comportamento: ma questa pare più leggenda che storia),
arrivò in Sicilia un nuovo esercito con a capo un duce
geniale, Amilcare Barca. Questi, aggrappatosi alle estreme
posizioni nella Sicilia occidentale, riuscì a tenere in scacco
per vari anni i nemici, e solo quando la vittoria navale
romana alle isole Egadi (241) gli tagliò l’afflusso dei
rifornimenti si decise a chiedere pace. L’ottenne a patto che
Cartagine sgombrasse definitivamente la Sicilia, restituisse i
prigionieri e pagasse in venti anni una forte indennità.
3. Conseguenze della guerra in Roma e in Cartagine. - I
Romani, che erano sbarcati in Sicilia solo per impedire che
71
Messina cadesse nelle mani dei Cartaginesi, si trovarono
alla fine padroni di tutta l’isola tranne il piccolo regno
siracusano dell’alleato Gerone, destinato peraltro a
diventare il primo di una lunga serie di stati vassalli. Ma più
importa osservare che nel resto della Sicilia venne per la
prima volta applicata una nuova forma di dominio diretto
che era stata estranea al processo di unificazione dell’Italia,
unificazione attuata mediante la concessione della
cittadinanza romana o di trattati di alleanza. In Sicilia i
Romani avevano conosciuto un sistema di governo che
sovrapponeva nettamente dominatori a dominati, ed essi lo
applicarono pressoché integralmente con l’istituzione della
“provincia”, cioè di un territorio assoggettato e sottoposto
al governo di un pretore romano, i cui abitanti (i
provinciali) dovevano corrispondere ai dominatori la
decima sui prodotti del suolo. Era il primo passo verso la
creazione dell’impero, cui seguì poco dopo la riduzione a
provincia della Sardegna e della Corsica (227), che i
Romani avevano strappato nel 238 ai Cartaginesi
approfittando delle difficoltà che questi avevano incontrato
a stipendiare le loro guarnigioni di mercenari.
Ma per Cartagine, che conservava pressoché intatte le
basi della sua potenza, si era trattato più che altro della
perdita di un’area nella quale da secoli esercitava il
monopolio (o quasi) del commercio marittimo. Pertanto il
contraccolpo della sconfitta fu risentito soprattutto dal
partito dei grossi affaristi (capeggiato dalla famiglia dei
Barca); su questo prese il sopravvento il partito dei grandi
proprietari terrieri, il cui programma era di indirizzare la
politica cartaginese, più che alla espansione marittima e
coloniale, alla formazione di un grande impero nell’Africa
settentrionale. Ma di lì a poco riacquistò la prevalenza il
dinamico partito avversario e questo fu il preludio, sia pure
lontano, alla ripresa della guerra.
72
In Roma, invece, la vittoria consolidò il potere della
oligarchia patrizio-plebea, la quale tuttavia non mancò di
corrispondere in certa misura alle aspettative dei ceti
inferiori della cittadinanza, che avevano sopportato tanti
sacrifici di sangue e di denaro. Venne infatti attuata una
riforma in senso più democratico dei comizi centuriati
stabilendo un collegamento tra le 193 centurie e le 35 tribù
con un sistema che rimane piuttosto oscuro, ma che certo
ebbe l’effetto di far partecipare alla direzione della cosa
pubblica un certo numero di cittadini che fino a quel
momento ne erano rimasti esclusi.
Meno propensa la classe di governo si mostrò ad
accogliere le aspirazioni dei cittadini più poveri sui latifondi
demaniali. Sarebbe stato nei voti di costoro che grosse
porzioni di agro pubblico venissero trasformate in
territorio dello Stato e distribuite, in modo che i coloni che
vi si trasferissero come assegnatari di un appezzamento
potessero conservare i loro diritti di cittadini romani. Ma
questo avrebbe portato ad un ampliamento del territorio
statale contrario alle istanze dell’oligarchia dominante che,
preoccupata di conservare l’equilibrio costituzionale,
preferiva indirizzare l’emigrazione dei cittadini desiderosi di
lavorare un terreno di proprietà verso la costituzione di
nuove colonie latine, cioè di comunità estranee allo Stato e
solo vincolate dagli obblighi del foedus. Tuttavia nel 232 il
tribuno della plebe Gaio Flaminio riuscì a far approvare
una legge per la distribuzione in piccoli lotti dell’agro
gallico e piceno (e una decina di anni dopo congiunse a
Roma questo territorio con la grande via Flaminia che
arrivava fino a Rimini).
4. I Romani oltre l’Adriatico e nell’Italia settentrionale. Nello stesso torno di tempo si ebbero i primi scontri con i
Liguri, cui fu tolto il porto di Pisa, importante per le
73
comunicazioni con la Corsica, mentre nel basso Adriatico
si dovette intervenire qualche anno dopo per mettere fine
alle scorrerie dei pirati illirici che danneggiavano i traffici
delle città alleate con i paesi dell’Egeo. Nel 229 una
poderosa flotta approdò ad Apollonia (al di là del Canale
d’Otranto, dirimpetto a Brindisi), e costrinse Teuta, la
regina degli Illiri, ad assoggettarsi a dure condizioni di pace,
né in questo si esaurì l’azione dei Romani perché essi si
costituirono degli stabili interessi sull’altra sponda
dell’Adriatico legandosi in alleanza con varie città e con i
popoli dei Partini e degli Atintani.
Qualche tempo dopo si profilò una nuova minaccia
da parte dei Galli dell’Italia settentrionale, che per un
momento si temette potessero rinnovare i nefasti
dell’indimenticabile presa di Roma. Appoggiati da alcune
tribù transalpine nell’anno 225 i Lingoni, i Taurisci,
gl’Insubri e i Boi riunirono le loro forze, circa 70.000 fra
fanti e cavalieri e, valicato l’Appennino, discesero
attraverso l’Etruria fra ruberie e devastazioni. I Romani,
che nella gravità dell’ora avevano predisposto il necessario
per la mobilitazione generale (col recensus armatorum di cui
parla Polibio, II 24 attingendo a Fabio Pittore)
affrontarono gli invasori presso Telamone (in provincia di
Grosseto) e li annientarono in una battaglia nella quale
cadde il console Gaio Attilio Regolo, figlio di colui che per
primo aveva guidato le legioni in Africa.
La grande paura era svanita, ma bisognava assicurarsi
per il futuro: i Boi vennero assoggettati nel 224 e l’anno
dopo si portavano le armi oltre il Po nel territorio degli
Insubri, la cui capitale, Mediolanum (l’odierna Milano), fu
presa nel 222. Sulle terre a loro confiscate venivano
fondate nel 218 le colonie latine di Piacenza e Cremona,
col che Roma metteva saldamente piede nella Gallia
Cisalpina. Fuori della sua orbita restavano ad occidente le
74
tribù liguri e celtiche stanziate nell’odierna Liguria e
Piemonte, mentre a est si stringevano coi Veneti rapporti di
salda amicizia.
Oltre l’Adriatico la ripresa della pirateria illirica
rendeva necessario nel 219 un nuovo intervento con forze
navali, che costringeva alla fuga il dinasta Demetrio di Faro
(odierna isola di Lesina); poi le operazioni in questo settore
si arrestarono perché ormai premeva nuovamente la
minaccia cartaginese.
5. Origini della seconda guerra punica. - In Cartagine,
dopo una breve eclissi alla fine disastrosa della guerra,
erano tornati in auge i fautori della politica d’imperialismo
coloniale. A compensare la perdita della Sicilia, della
Sardegna e della Corsica, costoro si prefissero la conquista
della Spagna, che fu intrapresa nel 237 sotto il comando di
Amilcare Barca. Con una serie di fortunate campagne
questi risalì da Cadice ad Alicante, e quando, nel 229, cadde
in una imboscata, ebbe un degno continuatore della sua
opera nel genero Asdrubale, che ampliò la conquista fino al
fiume Ebro. Queste vittoriose operazioni, nel corso delle
quali, fra l’altro, Cartagine si era venuta costituendo un
esercito numeroso e agguerrito, non potevano non
preoccupare i Romani che, dopo aver fatto un primo passo
nel 231 presso Amilcare, intervennero decisamente nel 226
costringendo Asdrubale all’impegno di non spingersi con
mire ostili a nord del fiume Ebro. Il governo cartaginese
ratificò l’accordo, e con questo mostrò di approvare la
cauta politica di Asdrubale; ma le cose cambiarono quando
a costui, nel 221, successe nel comando il cognato
Annibale, figlio di Amilcare.
Annibale non aveva allora che ventisei anni, ma sin
da ragazzo si era temprato sui campi di battaglia di Spagna
alla scuola del padre e del cognato. Era dotato di un talento
75
militare straordinario, posto al servizio di un’idea quasi
fanatica di riscossa antiromana, e dopo aver condotto a
termine nel 220 la sottomissione delle tribù iberiche del
bacino del Tago, l’anno appresso con un evidente pretesto
portò il suo attacco contro la città di Sagunto che era
alleata dei Romani. Sagunto era a sud dell’Ebro, dunque in
una regione non inibita all’espansione cartaginese dall’accordo del 226, ma i Romani per ragioni di prestigio
imposero ad Annibale di togliere l’assedio. Non ottennero
che un rifiuto, e sulla fine dell’autunno 219 Annibale
espugnò la città senza preoccuparsi di provocare con
questo lo scoppio di una nuova guerra con Roma. Anzi, era
proprio ciò che per tanti anni aveva desiderato.
Nella primavera del 218 i Romani inviarono uno dei
consoli, Tiberio Sempronio Longo, in Sicilia a preparare
uno sbarco in Africa, l’altro, Publio Cornelio Scipione,
nella Cisalpina come per passare nella Spagna; ma non si
fece nessuna delle due cose, lasciando l’iniziativa ad
Annibale. Questi indugiò alcuni mesi nella Spagna
settentrionale, poi improvvisamente, ai primi di agosto, si
avviò a valicare i Pirenei con 30 mila soldati e 37 elefanti.
Quando giunse la notizia della sua mossa, il console Publio
Cornelio Scipione imbarcò il suo esercito a Pisa e lo
trasportò nel porto dell’alleata Marsiglia, donde avanzò
verso l’interno per tentare di impedire al nemico il
passaggio del Rodano, ma arrivò troppo tardi. Allora fece
partire per la Spagna le sue legioni agli ordini del fratello
Gneo e ritornò nella Cisalpina, ove l’aspettavano altre due
legioni. Intanto Annibale si accingeva a valicare le Alpi (per
il Monginevro, come sembra più probabile) e, compiuta
felicemente l’impresa in un paio di settimane, alla fine di
settembre sboccò in Piemonte nel territorio dei Taurini.
76
6. Dal Ticino a Canne. - Annibale contava di ingrossare
le file dell’esercito attirando dalla sua parte quei Galli che
solo da qualche anno i Romani avevano sottomessi, e a tale
scopo si affrettò a cercare un successo marciando
rapidamente contro Scipione. Questi si era portato a nord
del Po e, sebbene si movesse cautamente in attesa
dell’arrivo dell’altro console che risaliva a grandi giornate
dalla Sicilia, non poté evitare uno scontro fra le opposte
cavallerie, che si concluse in maniera sfavorevole e nel
quale per poco non perdette la vita.
Ripassato il Po e attestatosi a difesa sul fiume
Trebbia, Scipione fu raggiunto dall’esercito del collega, il
quale sui suoi consigli di prudenza fece prevalere il
desiderio di cercare subito una soluzione sul campo. Fu
così che le legioni, dopo aver attraversato le acque della
Trebbia in una rigida giornata di dicembre, si scontrarono
con l’opposto schieramento in condizioni tutt’altro che
favorevoli, e sebbene si battessero con valore rimasero
soccombenti. Su 40.000 uomini, solo un quarto trovarono
scampo e, ripassato il fiume, si rinchiusero a Piacenza, che
assieme a Cremona seppe poi resistere per tutta la durata
della guerra.
Per valicare l’Appennino, Annibale dové attendere la
primavera, e nel frattempo i Romani riorganizzarono
alacremente le loro forze, affidandone il comando ai nuovi
consoli Gneo Servilio e Gaio Flaminio. Questi, per meglio
sorvegliare i possibili itinerari del nemico, si dislocarono il
primo a Rimini e il secondo ad Arezzo, ma in tal modo
attuarono una divisione delle forze che non tardò a
risultare disastrosa. Ai primi di maggio del 217 Annibale si
mise in marcia da Bologna e, superato l’Appennino al
passo di Collina, arrivò a Fiesole. Appena ne fu informato,
Flaminio avvertì il collega di accorrere con le sue forze da
Rimini e non si mosse dalle sue posizioni se non quando
77
l’esercito nemico, lasciatosi alle spalle Arezzo, s’inoltrò
verso sud in direzione di Cortona. Allora Flaminio si pose
alle calcagna di Annibale per controllarne le mosse in attesa
dell’arrivo del collega, e così, superata Cortona,
s’incamminò verso Perugia lungo la sponda settentrionale
del lago Trasimeno.
Quivi, nei pressi di Passignano, il Cartaginese gli
aveva teso un’imboscata, e in un nebbioso mattino di
giugno l’esercito di Flaminio si trovò improvvisamente
stretto fra il lago e i monti che lo fiancheggiano da vicino,
mentre le forze nemiche, opportunamente predisposte,
gl’impedivano sia di avanzare sia di retrocedere. Nella
carneficina restarono sul campo, assieme al console, oltre
ventimila uomini, e poco dopo, ad accrescere le
proporzioni del disastro, venne la disfatta dei 4.000
cavalieri che precedevano l’esercito dell’altro console.
Era stato un altro grosso successo, ma Annibale non
s’illuse di poter puntare direttamente sul Lazio. Per il
momento il suo piano era di scardinare uno dei pilastri
della potenza romana, e cioè di isolare Roma spingendo
alla defezione la massa degli alleati italici: proprio per
questo ne aveva rimessi in libertà quanti ne aveva fatti
prigionieri. Con tale progetto raggiunse il Piceno e,
avanzando lungo la costa adriatica, scese attraverso il
territorio dei foederati sino all’Apulia.
I Romani, per loro conto, reagirono con grande
energia e cominciarono con l’accentrare il potere nelle mani
di un dittatore, Quinto Fabio Massimo. I precedenti
disastri avevano convinto Fabio che con Annibale
occorreva usare soprattutto grande prudenza, ed egli
inaugurò una strategia temporeggiatrice consistente nel
molestare il nemico con piccole azioni di disturbo, senza
mai venire ad uno scontro decisivo. Se in tal modo non si
riportavano vittorie, almeno si evitavano sconfitte e, nel
78
frattempo, qualche opportunità migliore poteva anche
maturare. Questa condotta della guerra aveva però il grave
inconveniente di lasciare che Annibale portasse ovunque
liberamente la distruzione, e oltre l’Apulia ne soffrirono
anche il Sannio e la Campania. “Temporeggiatore”
(cunctator) Fabio fu soprannominato per scherno, e solo più
tardi, quando si comprese che egli aveva salvato la patria da
una nuova catastrofe, quell’epiteto ingiurioso si trasformò
in titolo di gloria. Ma sulle prime molti disprezzarono la
sua cautela come codardia, e quando spirarono i sei mesi
della dittatura la maggioranza in Roma era desiderosa di
rompere gl’indugi e di tentare la prova decisiva.
Uno dei consoli eletti per il 216, Gaio Terenzio
Varrone, aveva riportato larghi suffragi appunto con la
promessa di una rapida soluzione della guerra, mentre il
prudente Lucio Emilio Paolo solo a stento conseguì
l’elezione. Furono rinnovati col più grande fervore i
preparativi e, alla testa di 50000 uomini, i due consoli
scesero in Apulia incontro ad Annibale, che ne contava
solo 35000, ma aveva una cavalleria quasi doppia di quella
romana. Lo scontro avvenne il 2 agosto sulla destra del
fiume Ofanto nei pressi di Canne (a dodici km da Barletta)
e segnò un altro trionfo della superiore capacità tattica del
condottiero cartaginese. L’abilità di Annibale consisté da
un lato nell’accorto sfruttamento della superiorità della sua
cavalleria, dall’altro nell’avere sdoppiato - per così dire - lo
schieramento della sua fanteria, disponendo sul davanti i
fanti celtici e iberici, e dietro a questi i fanti libici. Mandata
all’attacco la sola fanteria celtica e iberica, questa a un certo
punto, non potendo sostenere la pressione dei legionari,
prese a indietreggiare, ma quando i Romani ebbero piegata
la sua tenace resistenza si trovarono di contro la fanteria
libica, che fino a quel momento Annibale aveva tenuto
ferma al suo diretto comando. E fu proprio allora che
79
queste truppe fresche entrarono in azione mentre, con
perfetta sincronia, alle spalle dei legionari piombava la
cavalleria nemica che aveva già volta in fuga quella romana.
Il disastro fu pauroso: cadde, fra gli altri, il console L.
Emilio, e solo 10000 uomini riuscirono a salvarsi
raggiungendo la colonia di Venosa.
7. Da Canne al Metauro. - A Roma per un momento
tutto sembrò perduto, ma superato il primo sgomento il
senato prese in pugno la situazione curando in primo luogo
di mantenere fra i cittadini la concordia necessaria per
affrontare l’estremo pericolo. Così, per esempio, non fu
mosso alcun rimprovero al console Terenzio Varrone che
aveva ostinatamente voluto la battaglia nonostante le
perplessità del collega, anzi gli furono rese pubbliche grazie
per non aver disperato della repubblica. Per l’ulteriore
condotta della guerra si decise di attenersi alla strategia,
poco prima tanto discussa, di Fabio Massimo: sottoporre
l’invasore ad una serie di azioni di logoramento che ne
esaurissero le forze, e mantenere il dominio del mare per
impedire che potesse ricevere aiuti dalla Spagna o
dall’Africa. Non si potette, invece, impedire che non pochi
dei foederati dell’Italia meridionale passassero dalla parte del
vincitore, e soprattutto a questo mirò Annibale convinto
che, anche dopo la strepitosa vittoria di Canne, i tempi non
erano maturi per un tentativo diretto contro Roma.
Particolarmente grave fu la defezione di quella che
era ancora una delle città più importanti della Penisola,
Capua, a cui poco dopo si aggiunse quella di Siracusa ove,
alla morte del re Gerone (215), prese il sopravvento il
partito antiromano. Nello stesso tempo il re dei Macedoni
Filippo V, che aveva visto assai di malocchio i Romani
metter piede sull’altra sponda dell’Adriatico, ritenendo che
80
nessuna occasione migliore gli si sarebbe offerta per
buttarli a mare, firmò un trattato di alleanza con Annibale.
Infine, nel 212, anche Taranto si diede ai Cartaginesi; ma
ormai gli energici provvedimenti adottati dal senato per
raddrizzare la situazione cominciavano a dare i loro frutti
imprimendo agli eventi un corso sempre più favorevole.
Nel 211, dopo vari mesi di assedio, veniva
riconquistata Capua, che invano Annibale aveva tentato di
sbloccare cercando di distrarre gli assedianti con
un’improvvisa ed audacissima marcia alla volta di Roma
alla testa di un gruppo celere. Ma, per espugnare la città, ci
voleva ben altro che un colpo di mano, e al Cartaginese,
dopo aver contemplato le mura da Porta Collina (sulla via
Nomentana), non restò che tornarsene nell’Italia
meridionale. Ancora nel 211, dopo due anni di assedio,
cadeva Siracusa nonostante le sue potenti fortificazioni e gli
apprestamenti difensivi escogitati da Archimede. La città fu
saccheggiata e ridotta a provincia come tutto il resto della
Sicilia. Meno bene le cose andarono in Spagna ove i due
Scipioni, Publio e Gneo, dopo aver per oltre sei anni impegnate le forze cartaginesi, perirono in combattimento nello
stesso anno 211; ma anche qui la situazione fu ben presto
ristabilita ad opera soprattutto del giovane Publio Cornelio
Scipione, rispettivamente figlio e nipote dei due caduti.
Ripresa Taranto nel 209, Annibale si trovò pressoché
bloccato nel Bruzio; venuta meno la speranza di rinfoltire
l’esercito con i foederati ribelli, egli non poteva contare che
su rinforzi provenienti per via di terra dalla Spagna, e
l’impresa riuscì al fratello Asdrubale, che nella primavera
del 207 valicò anch’egli le Alpi e scese in Italia con un buon
numero di uomini e alcuni elefanti. L’intenzione di
Annibale era di effettuare il congiungimento delle forze
nell’Italia centrale, e quindi avanzò in Apulia; lo teneva
sotto vigile controllo il console Tiberio Claudio Nerone, al
81
quale capitò la fortuna di catturare alcuni messaggeri inviati
da Asdrubale al fratello per avvisarlo dei suoi movimenti.
La decisione del console fu allora tanto rapida quanto
audace. Lasciata solo una parte dei suoi uomini a
sorvegliare le mosse di Annibale, col resto delle forze
marciò rapidamente lungo l’Adriatico, si unì alle legioni del
collega e, dopo aver largamente contribuito alla brillante
vittoria sul fiume Metauro (presso Fano), ove cadde lo
stesso Asdrubale, tornò velocemente in Apulia a riprendere
posizione di fronte ad Annibale.
8. Annibale e Scipione. - Annibale apprese la notizia
della catastrofe dal triste spettacolo della testa del fratello
gettata nel suo accampamento, e non poté che ritirarsi nelle
basi del Bruzio, dove riuscì a tenere il campo ancora per
quattro anni sebbene la sua condizione apparisse ogni
giorno di più senza una via d’uscita. Tra l’altro, nessun
vantaggio gli era venuto dall’alleanza con Filippo V di
Macedonia; ai Romani, infatti, senza sottrarre forze alla
guerra d’Italia, era bastato appoggiare l’azione dei nemici
che Filippo aveva in Grecia. Tra questi i più attivi furono i
confederati della lega etolica che, accordatisi coi Romani
nel 212, combatterono contro Filippo fino al 206. In
sostanza, quando il conflitto si concluse, nel 205, con la
pace di Fenice (capitale della lega d’Epiro), i Romani
serbavano sostanzialmente intatte le loro posizioni oltre
l’Adriatico.
Ormai i tempi erano maturi per un’azione decisiva; si
stabilì di portare la guerra in Africa e il comando
dell’impresa fu affidato al giovane Publio Cornelio
Scipione, che già si era distinto nelle campagne di Spagna
dal 210 al 206. Eletto console per il 205, Scipione si trasferì
in Sicilia per l’allestimento del corpo di spedizione, e nella
primavera dell’anno dopo, come proconsole, sbarcò presso
82
Capo Farina e pose l’assedio a Utica. Ma la tenace
resistenza della città, nonché l’arrivo di un esercito nemico
che si accampò nelle vicinanze, lo ridussero in una
situazione assai difficile da cui poté uscire perché i
Cartaginesi, per consiglio dell’alleato Siface, re dei Numidi,
intavolarono con lui trattative di pace. La stasi delle
operazioni permise di superare la crisi invernale, e quando
nella primavera i negoziati si conclusero con un fallimento,
Scipione sferrò l’attacco contro gli accampamenti dei
Cartaginesi e dei Numidi menando gran strage. Il successo
fu ribadito qualche mese appresso (giugno 203) da una
nuova vittoria riportata ai Campi Magni (un centinaio di
km a sud di Utica), dopo la quale Siface fu catturato e
sostituito, come re dei Numidi, da Massinissa, fedele alleato
di Roma. Occupata Tunisi, Scipione si preparava a investire
la stessa Cartagine che s’affrettò a richiamare Annibale,
avviando insieme nuove trattative.
Sebbene le condizioni imposte dal duce romano
fossero durissime, i Cartaginesi le accettarono, ma, poco
dopo, l’arrivo di Annibale fece nascere nuove speranze e la
parola fu ancora una volta alle armi.
Lo scontro decisivo (detto comunemente battaglia di
Zama) avvenne a Naraggara nell’estate del 202, dove
Annibale diede un’altra prova delle sue capacità. Infatti
nell’effettuare lo schieramento egli non mise in linea tutte
le forze disponibili e, ritornando ad una geniale
innovazione di Alessandro Magno rimasta senza seguito
per oltre un secolo, tenne da parte una vera e propria
riserva da gettare nella mischia al momento più propizio.
Ma a Naraggara si trovò di fronte a un condottiero di non
minor talento. Infatti Scipione appena che, travolto lo
schieramento avversario, si accorse dell’esistenza di quella
riserva, impedì che i suoi si sparpagliassero
nell’inseguimento e, dopo averli fatti riordinare, partì
83
nuovamente all’attacco. Per Annibale fu una disfatta
irreparabile, ed egli stesso spinse i suoi ad accettare la pace,
che fu firmata nel 201 a patti gravissimi, fra cui il
pagamento di una forte indennità, e, soprattutto, il divieto
di far guerra senza il permesso dei Romani.
Sulla prima guerra punica, e sull’intervallo fra la prima e la seconda,
fondamentale il racconto di Polibio (nei primi due libri), il quale utilizzò da un
lato uno storico filocartaginese, l’agrigentino Filino, dall’altro Fabio Pittore, il
più antico annalista, cercando di rintracciare la verità dei fatti nel raffronto delle
due contrastanti versioni. Nel III libro Polibio incominciava l’esposizione della
seconda punica (anche qui non mancando di utilizzare, accanto a fonti
filoromane, anche fonti filocartaginesi come Sileno di Callatis e Sosilo
spartano), ma la sua opera ci è giunta intera soltanto fino al V libro; per il resto
non ci rimangono che frammenti più o meno ampi.
Quanto a Livio, il racconto che egli dava della prima punica è
scomparso con la perdita della seconda decade, mentre la terza decade si apre
col racconto degli inizi della seconda punica. In questa parte del suo lavoro
Livio utilizzò svariati materiali attingendo da opere dell’annalistica recenziore
(Valerio Anziate), dalla monografia di Celio Antipatro sulla seconda punica,
dalle Storie di Polibio, col risultato di una compilazione di valore parecchio
disuguale. Nella sua Biblioteca storica Diodoro trattò della prima punica nei libri
XXIII e XXIV, della seconda nei libri XXV-XXVII (superstiti solo pochi
frammenti), attingendo da una fonte che probabilmente fu poi utilizzata anche
da Appiano (della cui opera ci sono giunti, fra l’altro, il libro Iberico, il libro
Annibalico e il libro Libico).
Ben poco allargano il quadro dell’informazione più attendibile sia le
Vite di Amilcare e di Annibale scritte da Cornelio Nepote, sia le Vite plutarchee
di Fabio Massimo e di Marco Claudio Marcello; di materiali liviani era intessuta
in prevalenza, per questa parte, l’opera di Cassio Dione (frammenti). Da
un’analisi di questa complessa tradizione deve prendere le mosse ogni
ricostruzione dell’età delle guerre puniche, su cui v., in generale, S.
MAZZARINO, Introduzione cit. Su Cartagine e i suoi ordinamenti, oltre il classico
S. GSELL, Histoire ancienne de l’Afrique du Nord, I-IV, Paris 1913-1921, v. CH.
JULLIEN - CH. COURTOIS, Histoire de l’Afrique du Nord dès origines à la conquête
arabe, 2a ed., Paris 1951.
Su Gerone di Siracusa, e la situazione che precedette l’intervento
romano oltre lo stretto di Messina, cfr. A. SCHENK VON STAUFFENBERG, König
Hieron der Zweite von Syrakus, Stuttgart 1933.
84
Sull’origine e gli sviluppi della marina militare romana, i due lavori di J.
H. THIEL, Studies on the History of Roman Sea-power in Republican Times
(Amsterdam 1946) e A History of Roman Sea-power before the Second Punic War
(ibid. 1954). Il testo dell’elogium inciso sulla colonna rostrata di C. Duilio (che fu
restituito in età augustea) in C.I.L. I2 25. Un altro documento epigrafico sulla
prima punica, e in particolare sulle operazioni di guerra dell’anno 259 nelle
acque della Corsica, è rappresentato dall’epitaffio di L. Cornelio Scipione
(C.I.L. I2 8, 9). Sulla leggenda dei supplizi inflitti ad Attilio Regolo (Polibio non
ne parla), cfr. F.W. WALBANK, A Commentary on Polybius, 1, p. 92 sg.
Un’idea dello sforzo finanziario sopportato dalla repubblica nel corso
della prima punica si può avere dai calcoli (inevitabilmente approssimativi) fatti
da T. Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, vol. I. Rome and Italy of the
Republic, Baltimore 1933, p. 64 sgg. Più eloquenti, o almeno di più immediata
evidenza, i dati sulla diminuzione del numero dei cittadini rilevata dai
censimenti. Mentre nel 251 erano stati censiti (LIV., periocha XVIII) 297.797
civium capita (cittadini soggetti alle armi, quindi con esclusione dei proletarii), il
loro numero nel censimento dell’anno 246 (LIV., per. XIX) risultò ridotto a
241.212. Questo non lieve sacrificio di sangue, sopportato per la gran parte dai
cittadini di più basso livello censitario, propiziò una riforma in senso più
democratico dei comizi centuriati, riforma che - come sembra suggerire un
nuovo documento epigrafico - potrebbe essere stata attuata nel 230-29 dai
censori Quinto Fabio Massimo e Marco Sempronio Tuditano (cfr. G. VITUCCI,
Intorno a un nuovo frammento di elogium, in “Riv Filol. Class.” 1953, p 43 sgg.; ID.,
Un nuovo episodio della II Punica, in “Annuario dell’Accademia Etrusca di
Cortona”, 1964. V. anche S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico. II, 1, Bari
1966, p 323 sg.; ID., sul trattato dell’Ebro e la connessa dibattutissima
questione della responsabilità della seconda guerra punica (in Introduzione, cit.,
p. 100 sgg.).
Sullo svolgimento dei fatti d’arme, oltre i già ricordati Antike
Schlachtfelder di J. KROMAYER E G. VEITH, v. G. DE SANCTIS, in Storia dei
Romani, vol. III, 1-2; sulla varia composizione delle forze che dominavano la
scena politica a Roma cfr. A. LIPPOLD, Consules. Untersuchungen zur Geschichte
dea römischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr., Bonn 1963, e soprattutto F.
CASSOLA, I gruppi politici romani del III sec. a.C., Trieste 1962.
Sugli accordi che, al tempo della prima guerra romano-macedonica,
regolarono la collaborazione coi Romani degli Etoli (accordi prima conosciuti
soltanto da qualche cenno di LIV., XXVI 24, 8-13), nuova luce è venuta dalla
recente scoperta di un documento epigrafico. Si tratta di un’iscrizione
frammentaria rinvenuta in Acarnania nel 1949 (ora pubblicata in Inscr. Graecae
IX, 12, 2, 241) contenente alcune clausole del trattato di alleanza stipulato nel
212 fra i Romani e la lega etolica. Una quindicina di anni dopo fra le due parti
insorsero controversie sull’interpretazione di questi patti e, nel darcene notizia,
Polibio (XVIII 38) fa riferimento alle clausole del 212 in maniera non corrispondente con ciò che si legge nel documento ora ritrovato: la propensione
per i Romani spinse lo storico ad oscurare la verità. Sull’argomento è da vedere
85
S. CALDERONE, Pistis-Fides. Ricerche di storia e diritto internazionale nell’antichità,
Messina 1964 (cfr. S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II, l, p. l18 sg.); sul
valore dell’espressione tecnica venire in fidem, già A. PIGANIOL, in “Mélanges F.
de Visscher”, Bruxelles 1950, IV, p. 339 sgg.
86
VI
Militarismo e imperialismo.
Dall’espansione in Oriente alla distruzione
di Cartagine.
La vittoria di Scipione, che nel 201 celebrava uno
splendido trionfo e assumeva il soprannome di Africanus,
indirizzò su un nuovo binario gli sviluppi della politica di
Roma. Suggellata dal buon esito di tanti sforzi comuni la
concordia fra i cittadini, ribaditi i legami con i foederati
italici, strappata ai Cartaginesi la supremazia nel
Mediterraneo occidentale, la repubblica cominciò a subire
sempre più l’influsso delle personalità che l’avevano
innalzata a tanta potenza, e sotto la loro spinta imboccò la
via dell’espansionismo militaristico.
Quelli che ora si aprivano alle brame dei nuovi
conquistatori erano i paesi del mondo ellenistico; da tempo
questi avevano conosciuto il travaglio di continue lotte di
predominio, ma proprio alla fine del III secolo una nuova
crisi minacciò più gravemente il loro equilibrio già tanto
instabile. Si trattava in primo luogo degli Stati che si erano
costituiti in seguito allo smembramento dell’impero di
Alessandro Magno: la Siria, comprendente all’incirca il
territorio dell’antico impero persiano) sotto i Seleucidi,
l’Egitto sotto i Lagidi, la Macedonia sotto gli Antigonidi, il
regno di Pergamo sotto gli Attalidi, mentre nella Grecia i
due maggiori organismi politici erano la lega etolica e la
lega achea, formate da libere città unitesi per preservare la
loro indipendenza minacciata dalle mire egemoniche della
Macedonia.
87
1. Il conflitto con la Macedonia e il protettorato sulla Grecia. Nel 204 era salito sul trono d’Egitto il minorenne Tolemeo
V Epifane, e gl’intrighi fra i dignitari che se ne
contendevano la tutela provocarono una serie di lotte e
quindi un declino del regno. Di tale circostanza vollero
approfittare Antioco III di Siria e Filippo V di Macedonia,
che si accordarono per impadronirsi il primo della Celesiria
(terra di confine a lungo contesa fra Lagidi e Seleucidi),
l’altro dei possedimenti egiziani sull’Ellesponto e sulle coste
della Tracia. Dall’energica azione intrapresa da Filippo si
sentirono minacciati sia il re Attalo I di Pergamo sia la
repubblica marinara di Rodi, che sollecitarono l’intervento
di Roma. Ma più gravemente la situazione si complicò
quando, nella primavera del 200, Filippo fece invadere
l’Attica dai suoi alleati Acarnani. Poiché i Romani nella
pace di Fenice stipulata qualche anno prima con la
Macedonia avevano dichiaratamente assunto la difesa
dell’indipendenza di varie città e popoli della Grecia, fra cui
anche Atene, ecco che il desiderio dei militaristi di portar le
armi in Oriente si trovò legittimato dall’obbligo di
proteggere gli Ateniesi. A Filippo venne inviato un
ultimatum le cui condizioni erano praticamente inaccettabili,
e fu la guerra.
Un esercito romano sbarcò in Epiro nell’autunno
dello stesso anno 200 e, dopo aver svernato in Apollonia,
fece un’ardita puntata verso la Macedonia attraverso i passi
orientali dell’Illiria, mentre Filippo non osava impegnarsi a
contrastarne l’avanzata. L’anno dopo fu prescelta per
l’invasione una via più meridionale, ma Filippo,
presidiando saldamente le gole del fiume Aòo presso
Antigonia (od. Tepeleni, in Albania), riuscì a bloccare i
movimenti dell’avversario. Così stavano le cose quando,
nell’estate del 198, assunse il comando delle operazioni il
88
console T. Quinzio Flaminino; si trattava di un giovane
esponente delle nuove leve politiche, caratteristico
rappresentante di quei circoli che, sulla scia dell’Africano,
propugnavano l’affermazione della potenza romana sui popoli dell’Oriente ellenistico pur non mancando di
apprezzarne l’alto grado di civiltà.
Con un’abile manovra aggirante, Flaminino riuscì a
far sloggiare Filippo dalle sue posizioni sull’Aòo e lo
inseguì fino in Tessaglia, mentre la flotta romana che
operava nell’Egeo riportava numerosi successi strappando
ai Macedoni le piazzeforti dell’Eubea. Attirata dagli
atteggiamenti filellenici del console, si dichiarò a favore dei
Romani anche la lega achea, e a Filippo, dopo un fallito
tentativo di accordo, non rimase che tentare la sorte della
battaglia campale. Questa ebbe luogo nel giugno del 197 in
Tessaglia, sulle alture di Cinoscefale, e per Filippo si risolse
in un’irreparabile disfatta: la falange macedone, onusta di
gloria e invitta per oltre un secolo, dovette piegare di fronte
alla superiorità della più agile tattica manipolare romana.
Alla vittoria di Cinoscefale avevano collaborato anche
gli Etoli, i più accaniti nemici di Filippo nella Grecia, i quali
avrebbero voluto addirittura l’abbattimento della
monarchia macedone, ma i loro desideri non furono
esauditi. Il governo di Roma non stimava, in quel
momento, di impegnarsi troppo nel complesso mondo
politico balcanico, e si limitò a ridimensionare la potenza
della Macedonia escludendola da ogni ingerenza nella
Grecia. E così, durante la celebrazione dei giuochi istmici
nell’estate del 196, Flaminino fece solennemente
annunziare, fra le più entusiastiche acclamazioni, che Roma
concedeva e garantiva la libertà a tutti i Greci d’Europa e
d’Asia. Naturalmente, anche se non sarebbe giusto ritenere
senz’altro ipocrita un simile atteggiamento, è un fatto che
Roma, nell’atto stesso di dichiarare liberi i Greci, li
89
sottometteva alla propria tutela, e questa non tardò molto a
trasformarsi in aperta ingerenza e in predominio.
2. Roma e l’impero siriaco. - Mentre Filippo era stato
duramente contrastato nelle sue mire egemoniche, Antioco
III di Siria aveva potuto impadronirsi a suo agio di tutta la
costa occidentale dell’Asia Minore e, procedendo oltre
l’Ellesponto, della costa tracica, assoggettando fra l’altro
numerose colonie greche.
Anche nei suoi confronti i Romani non indugiarono a
dichiararsi difensori dell’indipendenza dei Greci, e gli
fecero ripetute intimazioni che rimasero inascoltate. A
irrigidirlo sulle sue posizioni contribuì anche l’incitamento
di Annibale, da poco giunto alla sua corte profugo da
Cartagine per evitare di essere consegnato a Roma, che ne
aveva fatto richiesta nel sospetto che stesse preparando la
riscossa. D’altro canto, il timore suscitato dalla presenza del
Cartaginese presso Antioco contribuì forse non poco a
spingere i Romani ad un’azione risoluta, e quando il re,
accogliendo le sollecitazioni degli Etoli, sbarcò con un
esercito in Tessaglia, essi si prepararono alla lotta con
grande impegno.
Il re di Siria, evidentemente, non si proponeva di
abbattere la potenza di Roma, ma solo di costringerla a
riconoscere la sua preponderanza nell’Egeo, e questo
spiega perché egli scendesse in campo con forze piuttosto
modeste di cui i Romani ebbero facilmente ragione, grazie
anche all’appoggio di Filippo di Macedonia e di Eumene di
Pergamo. Nella primavera del 191, mentre l’esercito del
console Manio Acilio Glabrione gli si faceva incontro,
Antioco cercò di sbarrargli il passo alle Termopile, ma,
come già nella più famosa battaglia del 480, la posizione
venne aggirata e l’esercito siriaco, attaccato alle spalle, fu
sterminato. Il re riuscì a salvarsi con la fuga e, con poche
90
centinaia di superstiti, s’imbarcò alla volta di Efeso.
Qualche mese dopo gli Etoli s’indussero a chiedere un
armistizio mentre una vittoria navale presso l’isola di Chio
spianava la via all’invasione dell’Asia.
La spedizione fu preparata per l’anno dopo e se ne
voleva affidare il comando a Scipione l’Africano, ma questi
non poteva essere eletto console perché non erano ancora
trascorsi dieci anni dal precedente consolato (194); allora fu
fatto console suo fratello, il meno brillante Lucio Cornelio
Scipione, in modo che l’Africano, come suo consigliere,
avesse ugualmente la possibilità di dirigere le operazioni.
Rinnovato l’armistizio con gli Etoli, l’esercito attraversò la
Macedonia e la Tracia; quindi, dopo un’altra grande vittoria
della flotta, traghettò indisturbato l’Ellesponto e scese
verso la Lidia a incontrare il nemico. Era il dicembre del
190 e Antioco, fallito un tentativo di accordo per le
condizioni troppo gravose imposte da Scipione, si decise
ad offrire battaglia non lungi dalla città di Magnesia, presso
il monte Sipilo.
Assente l’Africano, colpito da una malattia, la
responsabilità del comando gravò sulle spalle del valente
Gneo Domizio Enobarbo, un altro consigliere di Lucio
Scipione. Con un accorto schieramento delle forze, il duce
romano compensò il notevole svantaggio numerico; poi la
bravura dei gregari fece il resto, e per l’esercito siriaco fu la
strage. Bastò questa sola vittoria a prostrare l’impero
seleucidico; Antioco ottenne la pace a durissimi patti, tra
cui il pagamento di un’ingente indennità (15.000 talenti
euboici rispetto ai 10.000 imposti a Cartagine dopo tutte le
devastazioni inflitte all’Italia da Annibale!) e la rinuncia a
tutti i possedimenti in Asia Minore a occidente del monte
Tauro. Questi territori, che il senato preferì non ridurre a
provincia per evitare i complessi problemi di una nuova
dominazione diretta, furono poi ceduti agli alleati di
91
Pergamo e di Rodi. Dei consoli del successivo anno 189,
l’uno, Cneo Manlio Vulsone, riportò grandi vittorie sui
Gàlati (così i Greci chiamavano le tribù di Galli che s’erano
stanziate da circa un secolo in Asia Minore, nella regione
detta appunto Galazia), l’altro, Marco Fulvio Nobiliore, costrinse alla pace gli Etoli.
In tal modo con pochi anni di guerra, e grazie anche
all’insipienza di Antioco, che con una strategia
temporeggiatrice - quale gli consentiva l’immensa
estensione del suo impero - avrebbe potuto mettere in serie
difficoltà l’esercito invasore, i Romani riuscirono ad
affermare la loro supremazia anche nel Mediterraneo
orientale.
3. La dissoluzione della monarchia macedone e il predominio
sulla Grecia. - Tale supremazia fu consolidata qualche
decennio dopo nel corso di nuovi interventi che presero
per lo più la forma di un fitto lavorìo diplomatico
punteggiato qua e là, nei momenti cruciali, da decise azioni
di forza. L’interesse del governo di Roma in quei paesi era,
in generale, quello di mantenere lo stato di equilibrio che vi
aveva creato, e pertanto si intromise con energiche
ambascerie sia nel conflitto scoppiato nel 186 fra Eumene
di Pergamo e il confinante Prusia di Bitinia, sia nella guerra
che qualche anno dopo divampò fra lo stesso Eumene e
Ariarate IV di Cappadocia, da un lato, e Farnace, re del
Ponto, dall’altro in altre occasioni fu necessario far ricorso
alle armi - come nel caso della Macedonia ove il re Perseo,
figlio e successore di Filippo V, andava svolgendo un’attiva
politica di riscossa nazionale - cercando nello stesso tempo
di scuotere il prestigio romano nel mondo greco-orientale.
Per effetto di una abile preparazione diplomatica che portò
all’isolamento della Macedonia, Perseo fu costretto a far
affidamento sulle sole sue forze; e se la guerra, dichiarata
92
nel 171, si trascinò fino al 168, ciò dipese non solo dalla
condotta esitante del re, timoroso delle sorti di uno scontro
decisivo e perciò sempre in cerca di un accordo di
compromesso, ma anche dalla mediocrità dei consoli
romani che si alternarono al comando prima dell’arrivo di
Lucio Emilio Paolo. Questi era un duce di consumata
esperienza, appartenente anche egli al circolo degli
Scipioni, e ben presto riuscì ad imprimere alle operazioni
un corso più rapido e favorevole. Infatti, dopo aver
costretto Perseo a sloggiare dalle sue posizioni difensive, lo
impegnò in campo aperto presso la città di Pidna e
gl’inflisse un’irrimediabile sconfitta (giugno del 168).
La vittoria di Pidna segnò l’inizio di una svolta
decisiva nelle relazioni tra Roma e i paesi dell’Oriente
ellenistico, relazioni che furono sempre più improntate alla
massima intransigenza nella tutela del prestigio e degli
interessi romani. Infatti non solo la Macedonia dovette
subire l’abolizione della monarchia, che ne cementava
l’unità statale, e lo smembramento del territorio in quattro
repubbliche, ma anche altri stati furono duramente colpiti,
come ad esempio la repubblica di Rodi, cui si imputava di
aver tenuto un atteggiamento troppo tiepido nei confronti
di Roma, e che fu punita con la creazione del porto franco
di Delo.
Un trattamento pressoché identico fu riservato alla
Grecia, e cioè alla lega achea e alla lega etolica che vi
costituivano i più importanti organismi politici. In
particolare, la lega achea già da tempo aveva dovuto
tollerare che Roma s’intromettesse a dirimere, di solito a
suo sfavore, le controversie che la opponevano alle città di
Sparta e Messene. Dopo il trionfo di Pidna, i Romani
pretesero la punizione di tutti coloro che in seno alla lega si
erano dichiarati contrari alla loro politica, e la conseguenza
fu che circa un migliaio di personalità achee vennero
93
deportate in Italia in attesa di giudizio. Uno di questi
deportati fu Polibio che, accolto amichevolmente nel
circolo degli Scipioni, ebbe agio di fare in Roma quella
personale e diretta conoscenza di uomini e cose che gli
servì per delineare nella sua opera i presupposti e gli
sviluppi dell’espansione romana nel bacino del
Mediterraneo.
4. L’assoggettamento della Macedonia e della Grecia. L’assetto dato alle cose di Macedonia e di Grecia era
quanto mai precario. Ancora una volta il governo romano
aveva cercato d’imporre la sua dominazione in maniera
indiretta, cioè di mantenere le sue posizioni di forza senza
impegnarsi nella risoluzione dei problemi che sarebbero
sorti dal moltiplicarsi dei domini di tipo provinciale, e
nondimeno una tale situazione si protrasse per circa un
ventennio. Infatti fu solo nel 149 che la Macedonia,
sobillata dalle mene di un tale Andrisco, un avventuriero
che si spacciava per figlio del re Perseo e accampava
pretese al trono, venne percorsa dall’incendio di una
generale sollevazione antiromana. La guerra fu liquidata
con l’invio di due legioni agli ordini del pretore Quinto
Cecilio Metello (detto poi Macedonico) e con la definitiva
riduzione della Macedonia a provincia (148).
Qualche anno dopo una sorte non troppo diversa
toccava alla Grecia. Una nuova intromissione di Roma
negl’interminabili dissidi tra Sparta e la lega achea provocò
in quest’ultima uno scoppio di furioso bellicismo, favorito
anche dall’illusione che i Romani, impegnati nell’estremo
duello con Cartagine, non sarebbero intervenuti con la
consueta
energia.
Ma
Cecilio
Metello,
sceso
immediatamente con le sue forze dalla Macedonia, inflisse
alla coalizione avversaria una prima sconfitta che fu, poco
dopo, ribadita dalla vittoria riportata nel 146 a Leucopetra
94
(presso Corinto) dal console Lucio Mummio, sopraggiunto
con un altro esercito dall’Italia. Saccheggiata e distrutta
Corinto, ordinato lo scioglimento delle leghe che avevano
partecipato alla guerra antiromana, anche la Grecia nel 145
venne assoggettata al diretto dominio di Roma e collegata
con la provincia di Macedonia, salvo i territori di alcuni
popoli e città alleate, come Sparta e Atene, che rimasero
liberi.
Si concludeva così un lunghissimo ciclo politico che
aveva avuto il suo massimo splendore nella intrepida difesa
dell’indipendenza nazionale contro gli invasori persiani e
poi aveva preso a declinare irrimediabilmente a causa delle
continue discordie. E fu fortuna che la Grecia trovasse i
suoi conquistatori pronti a raccoglierne il retaggio di civiltà.
5. La penetrazione nell’Italia settentrionale e nella Spagna. Mentre in questo modo, senza troppi sforzi, Roma riusciva
ad assicurarsi il controllo del mondo greco-orientale, assai
più duramente dovette impegnarsi per eliminare le
resistenze che ancora si opponevano al suo dominio nei
paesi del Mediterraneo occidentale. Intanto si dovette
incominciare con il recuperare nella stessa Italia
settentrionale le posizioni in gran parte perdute al tempo
dell’invasione annibalica: così, nella Gallia Cisalpina, furono
battuti nel 197 gli Insubri e i Cenomani che qualche anno
prima avevano messo a ferro e fuoco la colonia di
Piacenza, poi, nel 191, fu la volta dei Galli Boi, nel cui
territorio furono fondate nel 189 la colonia latina di Bononia
(Bologna), e nel 183 le colonie romane di Parma e Mutina
(Modena). Più a oriente, oltre i confini degli alleati Veneti,
come baluardo contro le incursioni delle tribù illiriche fu
fondata nel 181 la colonia latina di Aquileia, cui tenne
dietro l’assoggettamento dell’Istria (con una campagna di
due anni che fu conclusa nel 177 dal console Gaio Claudio
95
Pulcro) e della Dalmazia (155). A occidente si procedette
alla riconquista della Liguria debellando i Liguri Ingauni
(stanziati presso Genova) e soprattutto i Liguri Apuani (tra
Pisa e Lucca), che dopo la disfatta furono in numero di
circa 40.000 trapiantati nel Sannio (181). L’arrivo di
numerosi coloni e l’influsso da essi esercitato sulle
popolazioni locali diedero l’avvio a un rapido processo di
romanizzazione
dell’Italia
settentrionale,
favorito
dall’apertura di grandi strade come la via Emilia, che
proseguendo la via Flaminia (Roma-Rimini) allacciava
Rimini e Bologna a Piacenza, la via Cassia, che portava da
Roma a Firenze e Lucca per sboccare poi nella via Aurelia
(Roma-Pisa-Genova), e la via Postumia che congiungeva
Genova ad Aquileia passando per Piacenza e Verona.
Assai più aspre furono le lotte per completare
l’assoggettamento della Spagna cominciato fin dall’inizio
della seconda guerra punica. Nel 197 erano state
ufficialmente costituite le due province di Hispania citerior (a
nord) e di Hispania ulterior (a sud), ma la soggezione ai
Romani era un fatto tutt’altro che pacifico per le bellicose
tribù dell’interno, e si dovette imporla a prezzo di guerre
interminabili e sanguinosissime, che praticamente si
conclusero solo al tempo di Augusto. Intanto nello stesso
197 si verificò un’insurrezione generale, capeggiata dai
Turdetani, che fu domata dall’intervento di un grosso
esercito agli ordini di Catone, il futuro censorio; poi si
dovettero via via affrontare le resistenze di altre
popolazioni, soprattutto dei Lusitani e dei Celtiberi, contro
i quali si distinse per il suo comportamento, insieme fermo
e generoso, il console Tiberio Sempronio Gracco, padre
dei due famosi tribuni della plebe. I suoi successori
tornarono invece ai metodi delle repressioni violente e delle
devastazioni, che acuirono negl’indigeni la volontà di
resistenza e portarono, fra l’altro, alla lunga ed estenuante
96
guerra contro i Celtiberi (154-133); questa si concluse con
la espugnazione della città di Numanzia ad opera di Scipione Emiliano, ma non mise fine a quelle ricorrenti
carneficine in cui periva il fior fiore delle legioni romane.
Valoroso animatore della resistenza dal 147 al 139 (quando
venne ucciso a tradimento) era stato Viriato, un umile
pastore che si era fatto duce della sua gente nella lotta per
l’indipendenza.
6. La terza guerra punica. - Lo stesso anno 146, che
aveva portato la distruzione di Corinto, vide dall’altra parte
del Mediterraneo la distruzione di Cartagine. Nei
cinquant’anni, circa, che intercorsero tra la fine della II
guerra punica e l’inizio della III, le relazioni romanocartaginesi, dopo essersi mantenute buone per un lungo
periodo, avevano cominciato a subire un rapido
deterioramento. Una clausola del trattato di pace del 201,
vietando a Cartagine di prendere le armi senza il permesso
del senato di Roma, l’aveva esposta senza difesa alle
continue usurpazioni territoriali di Massinissa, il re della
vicina Numidia. Le relative dispute, sottoposte di volta in
volta all’arbitrato romano, furono quasi sempre risolte in
favore di Massinissa finché nel 150, dopo un decennio di
umiliazioni, si ebbe in Cartagine un violento contraccolpo
che sboccò nella conquista del potere da parte del partito
democratico antiromano e nell’apertura delle ostilità contro
i Numidi, in spregio del divieto sancito nel trattato. Non
meno grave fu la reazione a questi avvenimenti in Roma,
ove il senato, accogliendo la proposta che da qualche anno
il vecchio Catone andava ripetendo come un’idea fissa
(delenda Carthago), deliberò di distruggere la città rivale.
Perché una decisione così drastica e per di più attuata
con fredda determinazione quando i Cartaginesi, non
appena accortisi dei gravissimi pericoli cui s’erano
97
incautamente esposti, si dichiararono ed erano realmente
disposti a qualunque riparazione? Si risponde, in genere,
che la decisione romana fu dettata soprattutto da ragioni
economiche:
motivi
di
rivalità
commerciali,
preoccupazione per la concorrenza dei prodotti agricoli
cartaginesi, cupidigia delle fertili terre africane; ma nel
mondo antico non vi fu uno Stato che al pari di Roma si
disinteressasse di proteggere lo sviluppo dei suoi traffici
commerciali. Piuttosto è da ritenere che la deliberazione del
senato fu ispirata da considerazioni squisitamente politiche.
Catone e i suoi seguaci, in sostanza, vedevano in Cartagine
un pericolo crescente: nella floridezza economica che la
città aveva riacquistato essi individuavano le basi per
un’immancabile ripresa dell’antica potenza e, per ragioni di
sicurezza, si fecero convinti assertori della necessità di una
guerra preventiva.
Sbarcati in Africa con un poderoso esercito, i due
consoli del 149, dopo essersi fatti consegnare dai
Cartaginesi tutte le armi che avevano, dichiararono che
un’altra riparazione essi dovevano per espiare il malfatto:
abbandonare la loro città e fabbricarsene un’altra dove
volessero, a non meno di 15 miglia dal mare, perché
Cartagine doveva essere rasa al suolo. Di fronte a questa
incredibile intimazione, i Cartaginesi seppero celare la loro
disperata volontà di resistenza, e col pretesto di trattative
guadagnarono tempo per approntarsi alla estrema difesa.
Quando i consoli si accorsero di tali preparativi, era
troppo tardi per impadronirsi della città senza colpo ferire,
e dovettero rassegnarsi a intraprendere le operazioni di
assedio che tutto faceva prevedere lunghe e difficili. E
infatti le cose presero un andamento più favorevole solo
quando il supremo comando fu affidato a Scipione
Emiliano, eletto console per il 147 con procedura
d’eccezione non avendo ancora raggiunta l’età minima
98
prescritta dalla legge. Nato nel 184 da Lucio Emilio Paolo
(il vincitore di Pidna), ed entrato nella famiglia degli
Scipioni per adozione da parte di un figlio del grande
Africano, egli non deluse le speranze dei suoi fautori.
Stretta in una morsa impenetrabile, travagliata dalla fame e
dalla pestilenza, Cartagine fu espugnata casa per casa fino
all’acropoli; quivi gli ultimi difensori si arresero a patto di
aver salva la vita mentre la città veniva saccheggiata e poi
distrutta dalle fondamenta. Il centro amministrativo della
nuova provincia d’Africa, che veniva a comprendere solo
una parte dei domini cartaginesi, fu stabilito nella città di
Utica, e Scipione Emiliano, dopo il trionfo, assunse anche
egli il titolo di Africanus.
7. Trionfo del conservatorismo. Catone e Scipione. - Gli
eventi che portarono la repubblica a primeggiare fra i paesi
del Mediterraneo influirono sul corso della politica interna
di Roma assai più di quanto non ne fossero stati
influenzati. Si è accennato più di una volta alla ritrosia del
senato ad ampliare la sfera dei domini diretti mediante la
costituzione di nuove province. Per governare queste si
rendeva necessario accrescere il numero dei magistrati
forniti di imperium (dei pretori, cioè, dato che nessuno mai
pensò che i consoli potessero essere più di due), ma a ciò
contrastava lo spirito conservatore della nobiltà al potere,
che per oltre un secolo lasciò invariato il numero di sei
raggiunto dai pretori nel 197 quando furono create le due
province di Spagna. Intanto, per eliminare gl’inconvenienti
derivanti dal numero troppo esiguo dei magistrati superiori,
si fece ricorso il più possibile alla prorogatio imperii, mediante
la quale a un console o a un pretore, terminato l’anno di
carica, si conservava ancora per uno o più anni l’imperium,
che ora egli continuava ad esercitare in qualità di
promagistrato, cioè di proconsole o di propretore.
99
Ma a parte questo, la tendenza a non ampliare i
domini provinciali corrispondeva in primo luogo al
desiderio di non moltiplicare i territori nei quali i magistrati
o i promagistrati, in veste di governatori, avrebbero
esercitato una somma pressoché illimitata di poteri, civili e
militari, lontani dal controllo del senato, l’organo che
sorvegliava e assicurava l’attuazione delle direttive della
classe di governo. In generale, può dirsi che nel periodo
delle grandi conquiste l’atteggiamento della oligarchia
nobiliare patrizio-plebea fu tanto più gelosamente
conservatore quanto più difficile diventava mantenere il
predominio in un organismo politico che, dalla mediocre
misura di un piccolo staterello, si era innalzato al rango di
potenza mondiale, con una mole di problemi assai più
complessi e, soprattutto, molto diversi da quelli di un
tempo.
La medesima gelosia, poi, si manifestava non solo
nell’ostacolare l’ascesa degli homines novi, ma anche nel
vicendevole sorvegliarsi dei nobiles per impedire che
qualcuno di loro avesse a salire in potenza tanto da
prendere il sopravvento e rompere l’equilibrio del sistema.
A questo fine, verso il principio del II secolo, un’apposita
legge fissò norme precise per lo sviluppo del cursus honorum,
cioè vennero stabiliti l’ordine progressivo delle
magistrature, l’età minima per accedervi, gl’intervalli fra
l’una e l’altra e, per la massima fra tutte, il consolato, venne
sancito che nessuno poteva rivestirla un’altra volta se non a
dieci anni di distanza dalla precedente. Le deroghe a tali
norme furono pochissime; quando esse divennero più
frequenti, come i sei consolati di Mario dal 107 al 100, era
segno che si appressava il tramonto del regime oligarchico.
Quanto agli sviluppi della lotta politica, questa
continuò a svolgersi sui consueti binari della rivalità fra le
casate nobiliari più cospicue. Ma in assenza di veri e propri
100
partiti politici con programmi prestabiliti, e poiché
sussisteva un accordo sostanziale fra i nobili nel mantenere
le comuni posizioni di privilegio, si trattava per lo più di
divergenze di metodi o di questioni personali connesse con
particolari situazioni di famiglia o di preparazione
individuale. Fa spicco, tuttavia, in tali contrasti l’antitesi fra
una tendenza più rigidamente conservatrice, attaccata alle
tradizioni e decisa ad affrontare i nuovi compiti dello Stato
ingrandito senza nulla toccare degli istituti esistenti, e una
tendenza, sia pur moderatamente, innovatrice che,
consapevole dell’insufficienza dei vecchi schemi di governo
rispetto ai nuovi compiti da assolvere, auspicava un più
libero esplicarsi della vita politica in forme meglio aderenti
alla situazione mutata. Esponente della prima tendenza fu
Catone il Censorio, della seconda Scipione Africano, il
vincitore di Annibale, che alla fine ebbe a soccombere.
Attaccato insieme col fratello Lucio (l’Asiatico) in una serie
di processi, direttamente ispirati da Catone, sotto l’accusa
di essersi approfittato dell’enorme somma riscossa dal re
Antioco come anticipo dell’indennità di guerra stabilita
dopo la vittoria di Magnesia, l’Africano riuscì in ultimo ad
evitare una vera e propria condanna, ma subì una
irrimediabile perdita di prestigio e si vide costretto ad
allontanarsi da Roma e a ritirarsi a vita privata. Poco dopo
(184) moriva a Literno.
8. Squilibrio economico e società in fermento. - Il prevalere
della tendenza più intransigente non soltanto assicurò la
conservazione degli antichi istituti politici, suggellando la
definitiva trasformazione della aristocrazia in oligarchia, ma
ostacolò ogni benefica evoluzione nel campo economicosociale, ove assai opportuno sarebbe stato intervenire in
favore delle classi meno abbienti, soprattutto per arrestare
la rovina dei cittadini piccoli proprietari.
101
Oltre a questi strati inferiori dei cives Romani, aveva
rivendicazioni da far valere tutta la numerosa schiera dei
foederati Latini e Italici. Costoro, come avevano validamente
collaborato ad affermare il primato romano nella Penisola,
e a preservarlo resistendo alle lusinghe o alle minacce di
Annibale, così volenterosamente e a prezzo di molto
sangue avevano dato il loro apporto sui campi di battaglia
d’Oriente e d’Occidente per l’espansione del dominio
romano. I benefici delle grandi conquiste, terre, bottino,
tributi, erano però andati esclusivamente a vantaggio dello
Stato romano, il quale inoltre cominciava a intromettersi
con mano sempre più pesante negli affari interni delle città
alleate. Da un simile stato di cose stava per germogliare
l’aspirazione dei foederati in genere a diventare anch’essi cives
Romani, aspirazione a lungo soffocata dall’egoismo della
città dominante finché non esplose nell’aperta ribellione e
nella guerra.
Altro lievito in fermento nel tessuto sociale della
repubblica era rappresentato dalla categoria dei cavalieri,
cioè dall’insieme di quei cittadini che, a partire dal III sec.,
vennero distinti perché in possesso di un determinato
censo. Vi apparteneva soprattutto la ricca borghesia degli
imprenditori, dei trafficanti, degli appaltatori, che in breve
tempo, operando specialmente nei vari paesi conquistati,
avevano avuto agio di accumulare enormi fortune senza
dover sostenere la concorrenza dei nobili, rimasti
tradizionalmente legati alla grande proprietà terriera. Anche
se i cavalieri non giunsero mai ad una loro particolare
visione dello Stato e dei suoi ordinamenti, ma limitarono la
loro azione politica alla egoistica difesa dei propri interessi,
tuttavia con tale azione essi diedero spesso serie
preoccupazioni al governo nobiliare.
Riuscì, dunque, per vari decenni al trionfante
conservatorismo della nobiltà, che con le sue splendide
102
imprese di conquista si era posta come al di sopra di ogni
discussione, di mantenere intatti i suoi privilegi rinviando la
risoluzione dei vari problemi, soprattutto di ordine
economico e sociale, cui si è accennato. Formalmente, alla
base dell’ordinamento statale continuò ad essere la
sovranità popolare, ma le assemblee in cui questa si
manifestava restarono ancor più di prima in balìa della
potente organizzazione delle grandi casate, anche perché a
radunarsi per dare il loro voto erano per lo più i cives
residenti in Roma, mentre di norma risultava assente la
gran massa di quelli sparsi nei municipi e nelle colonie.
9. Cultura greca e “humanitas” romana - La reazione
ultraconservatrice impersonata da Catone giunse anche a
combattere come pericoloso per l’integrità dei costumi
nazionali il diffondersi della cultura greca, dei Graeculi come
quello diceva con aperto disprezzo. Ma qui non si trattava,
in fondo, che di un argomento polemico nel contrasto con
l’avversa fazione, accentrata nel circolo filellenico degli
Scipioni. Quello che di deteriore Catone scorgeva nel
costume pubblico e privato dei Greci, corruzione, viltà,
ambizione sfrenata, non poteva essere sconosciuto alla più
antica società romana: solo che cominciava allora a
manifestarsi in maggiori proporzioni, ma non certo per
colpa dei rapporti più immediati col mondo grecoorientale.
Era vero, invece, che sotto l’influsso più diretto dei
modelli greci veniva costituendosi una tradizione letteraria
capace di dare frutti cospicui non solo per un gusto
particolare e per l’intensità dell’espressione, ma talora
anche per originalità, come il teatro di Plauto e di Terenzio,
o l’epopea di Nevio e di Ennio, o l’efficace satira di Lucilio.
E il formarsi di una nuova lingua poetica apriva la strada
alla fioritura dell’età successiva, nella quale le lettere
103
romane si sarebbero degnamente affermate nella letteratura
del mondo civile per restare fonte di ispirazione perenne
alle generazioni a venire.
Inoltre, nelle opere di qualcuno degli scrittori
ricordati si sentono riecheggiare i nuovi ideali civili e morali
sviluppatisi nel circolo degli Scipioni per l’innesto della
cultura greca nella concezione romana tradizionalmente
informata alla preminenza degli interessi della res publica su
quelli dell’individuo. Lo storico Polibio aveva trovato la
giustificazione del dominio universale di Roma
nell’eccellenza delle sue istituzioni, e quindi nella virtus
collettiva della sua classe dirigente; il filosofo Panezio,
geniale trapiantatore dello stoicismo in terra romana,
teorizzava per l’individuo stesso l’esigenza di elevarsi alla
dignità di persona umana mercé l’assiduo sforzo di
adeguare la sua azione ad un’etica “convenienza con se
stesso”. Sorgeva così in Roma l’idea di una humanitas, intesa
come coscienza della condizione umana e capace d’ispirare
sentimenti di giustizia e di comprensione verso gli altri.
Questa nuova concezione non restò estranea ai
progressi della scienza giuridica, che nell’assiduo sforzo di
adeguare le norme di legge ai bisogni sempre nuovi di uno
Stato in vigorosa espansione, e soprattutto di coordinare i
rapporti tra individui appartenenti a paesi di tradizioni e
civiltà diverse, avrebbe fatto Roma madre di diritto alle
genti.
Sull’imperialismo, che avrebbe determinato la spinta espansionistica al
principio del II secolo, si è molto discusso e ancora si discute: com’è naturale,
trattandosi in fondo di un’etichetta che dovrebbe caratterizzare un’azione
politica lunga e complessa, della quale conosciamo assai meglio il risultato
finale (la conquista) che non il lento maturare delle situazioni che ne
promossero i successivi sviluppi; cfr. A. PIGANIOL, La conquête romaine, cit., p.
203 sgg. Siamo poi, anche qui, condizionati dalla “tendenza” delle nostre fonti,
104
rappresentate soprattutto da Polibio (framm. dei libri XVI e sgg.) e poi da
Livio, libb. XXXI-XLV (con il lib. XLV, l’ultimo conservato per intero, si
arriva all’anno 167; per il periodo successivo le periochae e i sunti degli
epitomatori). Come Livio, si rifanno a materiali polibiani anche Diodoro
(framm. dei libri dal XXVIII in poi), Appiano (oltre i già ricordati libro Iberico e
libro Libico, il libro Macedonico e Illirico e il libro Siriaco) e Cassio Dione (framm. dei
libri dal XVIII in poi, in massima nell’epitome di Zonara). Inoltre le Vite
plutarchee di Tito Quinzio Flaminino, di Lucio Emilio Paolo, di Catone il
Censorio, di Filopemene.
Nella storia militare del mondo antico la battaglia di Cinoscefale, il
primo scontro fra la legione romana e la falange macedone-orientale, consacrò
una volta per tutte la facile superiorità dell’una rispetto all’altra. Un evento che
lasciò attoniti i contemporanei e spinse Polibio a soffermarvisi espressamente
(XVIII 32, 13) “perché molti dei Greci non soltanto al tempo in cui i
Macedoni furono sbaragliati considerarono il fatto come una cosa incredibile,
ma anche in futuro continueranno a chiedersi con meraviglia perché e come la
falange risulta inferiore allo schieramento romano”. E l’inferiorità della falange,
come già vide lo stesso Polibio, stava nella sua rigidità, cioè nella sua scarsa
adattabilità a un terreno che non fosse sgombro e pianeggiante; cfr. H.
DELBRÜCK, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen Geschichte, I, Berlin
1920, p. 424 sgg.
Polibio (XVIII 46, 5; sulle sue orme, più o meno fedelmente, LIV.,
XXXIII 32, 5; PLUT., Flaminin. X 5; Appian., IX 4) ci ha trasmesso il testo del
proclama di Tito Quinzio Flaminino ai Greci: “Il senato dei Romani e il
proconsole Tito Quinzio, vinti in guerra il re Filippo e i Macedoni, lasciano
liberi, senza guarnigioni, non soggetti a tributi, con la possibilità di godere delle
leggi ereditate dai padri, Corinzi, Focesi, Locresi, Eubei, Achei Ftioti, Magneti,
Tessali, Perrebi”. Il testo è così riferito da LIV, l.c.: senatus Romanus et T.
Quinctius imperator Philippo rege Macedonibusque devictis liberos, immunes, suis legibus
esse iubet Corinthios, Phocenses Locrensesque omnis et insulam Euboeam et Magnetas,
Thessalos, Perrhaebos, Achaeos Phtiotas. Assai numerose furono le attestazioni di
omaggio riservate dai Greci al duce romano “liberatore”, la nostra
informazione in proposito si è arricchita recentemente di un decreto scoperto
ad Argo (cfr. G. DAUX, in “Bull. Corr. Hell.” LXXXVIII, 1964, p. 569 sgg.) dal
quale si ricava che in quella città, dopo circa un secolo, si celebravano ancora le
feste istituite appunto in onore di Tito Quinzio Flaminino. E non è a dire che
questi durante le operazioni di guerra avesse trattato i Greci con mano leggera;
ce lo attesta, fra l’altro, un nuovo documento epigrafico (cfr. M. MITSOS, in
“Rev. ét. gr.” LIX-LX, 1946-47, p. l50 sgg.; F.G. MAIER, Griech.
Mauerbauinschriften, I, Heidelberg 1959, p. 132 sgg.) che consente di precisare la
narrazione liviana sulla conquista di Elatea nella Focide, avvenuta negli ultimi
mesi del 198. Livio (XXXII 24) racconta che Flaminino, dopo aver espugnato
la città, occupata da Filippo una ventina d’anni prima, dovette affrontare le
ultime resistenze opposte nella rocca dai soldati dei presidio macedone e dagli
Elateesi, e ne venne facilmente a capo: missis in arcem qui vitam regiis, si inermes
105
abire vellent, libertatem Elatensibus pollicerentur, fideque in haec data, post dies paucos
arcem recipt. Dunque, Flaminino aveva promesso agli Elateesi la libertas, ma dal
nuovo documento apprendiamo che Elatea cessò di esistere come polis, che gli
Elateesi furono espulsi dalla città e costretti a rifugiarsi a Stinfalo in Arcadia,
donde solo una decina d’anni dopo riuscirono a ritornare in patria.
Sulla politica “filellenica” del gruppo de gli Scipioni e sulla opposizione
capeggiata da Catone, v. F. DELLA CORTE, Catone Censore. La vita e la fortuna,
Torino 1949.
Circa l’ammontare delle indennità di guerra imposte ai nemici vinti (che
nell’età delle grandi conquiste rappresentarono uno dei cespiti più cospicui
della finanza statale) si consideri che un talento euboico equivaleva a 80 libbre
di argento (gr. 327 x 80), e poiché in quell’epoca una libbra equivaleva a 84
denarii da gr. 3,90, il talento euboico era uguale a 6720 denarii. Pertanto la
somma imposta ad Antioco in conto riparazioni fu di 100 milioni e 800 mila
denarii. Ora, secondo i calcoli più o meno approssimativi del FRANK (An
economic survey, cit., I, p. 126 sgg.), nei primi decenni del II sec. a.C. le entrate
dello Stato romano si aggirarono, mediamente, sui 14 milioni e 200 mila
denarii, il che significa che l’indennità imposta ad Antioco rappresentava la
entrata media globale di oltre sette esercizi finanziarii. Su Antioco, in generale,
v. di recente H. H. SCHMITT, Untersuchungen zur Geschichte Antiochos’ des Grossen
und seiner Zeit, Köln - Graz 1964.
Sulla sempre crescente ingerenza romana nelle cose di Oriente, cfr. G.
CARDINALI, Il regno di Pergamo, Roma 1906; G. VITUCCI, Il regno di Bitinia, Roma
1953; E. BADIAN, Foreign Clientelae (264-70 B. C. ), Oxford 1958.
Sul tramonto del regno dei Macedoni, v. P. MELONI, Perseo e la fine della
monarchia macedone, Roma 1953; sulla rivolta di Andrisco, G. CARDINALI, Lo
Pseudo-Filippo, in “Riv. Filol. Class.” XXXIX (1911) p. 1 sgg.
Sulla fine dell’indipendenza greca, cfr. G. GIANNELLI, La repubblica
romana, Milano 1955, p. 482 sgg. Per un’analisi della situazione nella quale
venne maturando in Roma la determinazione di annientare Cartagine, cfr. L.
ZANCAN, Le cause della terza guerra punica, Venezia 1936; W. HOFFMANN, Die
römische Politik des 2. Jahrhunderts und das Ende Karthagos, in “Historia” IX (1960)
p. 309 sgg.
Per la conquista della provincia d’Asia, G. CARDINALI, La morte di Attalo
III e la rivolta di Aristonico, in “Studi di storia antica offerti a Giulio Beloch”
Roma 1910, p. 269 sgg. V. anche D. MAGIE, Roman Rule in Asia Minor, I-II,
Princeton 1950, p. 147 sgg., 1033 sgg.
Sulle guerre per consolidare ed ampliare le conquiste nella Spagna, C.
W. H. SUTHERLAND, The Romans in Spain, London 1939; R. THOUVENOT, Essai
sur la province romaine de Bétique, Paris 1940.
Le norme regolatrici della carriera dei pubblici honores vennero
promulgate con la lex Villia (proposta nel 180 dal tribuno della plebe Lucio
Villio), sulla quale c’informa in maniera sommaria LIV., XL 44, 1; cfr.
MOMMSEN, Staatsrecht, I3, p. 529 sg.; G. RÖGLER, Die lex Villia Annalis, in
“Klio” XL (1962) p. 76 sgg.
106
Sul costituirsi in seno alla società romana della classe dei cavalieri, uno
degli aspetti più caratteristici dell’evoluzione economica nell’età delle grandi
conquiste, cfr. A. STEIN, Der römische Ritterstand, München 1927; M.
ROSTOVZEV, Storia economica e sociale dell’impero romano, trad. it., Firenze 1933, p.
10 sgg.; A. FERRABINO, L’Italia romana, Milano 1934, p. 197 sgg.; C. NICOLET,
L’ordre équestre à l’époque républicaine, I, Paris 1966.
Una fra le più violente manifestazioni della politica di chiusura
propugnata da Catone verso ogni forma d’influsso greco si ebbe nel 186,
quando scoppiò lo “scandalo” dei Baccanali, che erano riunioni misteriche con
rituale orgiastico di provenienza greco-orientale. È notevole che tali riti fossero
vietati dal governo di Roma non soltanto ai cittadini romani, ma anche ai
cittadini delle città alleate, il che costituiva un’indebita e pesante ingerenza nei
loro affari. Della vicenda siamo informati, oltre che da LIV., XXXIX 8-19,
anche da una delle più antiche iscrizioni latine, il cosiddetto Senatusconsultum de
Bachanalibus (C.I.L. I2 501).
107
VII
La crisi del regime nobiliare.
Dai Gracchi alla guerra sociale.
1. Ripercussioni interne delle grandi conquiste. - Si è fatto
cenno, poco sopra, della pesante crisi di ordine economico
e sociale che nell’età delle grandi conquiste aveva preso a
travagliare in maniera sempre più grave i ceti inferiori della
cittadinanza romana, in particolare la categoria dei
contadini piccoli proprietari. Per costoro il disastro era
cominciato al tempo dell’invasione annibalica, quando
erano stati costretti ad abbandonare le loro terre alla furia
devastatrice del nemico. Poi erano sopravvenute le
continue campagne di guerra, anzitutto nella Spagna, a
tenerli lontani dal lavoro con la conseguenza del
progressivo indebitamento e dell’inesorabile rovina delle
loro piccole aziende.
Costretti a cedere le loro terre, che passavano a
ingrossare i latifondi della ricca nobiltà, gli antichi
proprietari si venivano riducendo al rango di braccianti, se
non addirittura di disoccupati, per l’impossibilità di
sostenere la concorrenza della mano d’opera servile. Infatti
un’altra conseguenza delle grandi conquiste era stato
l’afflusso in Italia di masse sempre più numerose di schiavi,
all’origine prigionieri di guerra, che vennero largamente
adibiti ai lavori agricoli. Si trattava di una mano d’opera
assai a buon mercato, dato che il padrone la compensava
solo con quel tanto che bastava a non farla morire di fame,
e in breve le campagne d’Italia brulicarono di questi
lavoratori stranieri, tenuti all’ordine con inflessibile e
spesso crudele disciplina, mentre buona parte della
precedente popolazione agricola si inurbava trasformandosi
108
in plebaglia oziosa al servizio delle manovre elettorali dei
potenti.
Vi era poi un altro aspetto, e non meno
preoccupante, di questa crisi, e cioè le ripercussioni di
carattere militare. I cittadini piccoli proprietari, che
prestavano servizio nelle legioni, costituivano ancora il
nerbo delle forze armate della repubblica, e il loro continuo
scadimento al livello dei proletari nullatenenti (che ancora
erano esclusi, di fatto, dal servizio militare), rappresentava
un fenomeno di non poca gravità.
Di questa complessa situazione di disagio pareva non
darsi troppo pensiero l’oligarchia dominante, che tutta
intesa alla tutela dei suoi privilegi si limitò a una ripresa
della colonizzazione alla periferia della Penisola, cui
l’esausta popolazione romana rispose con scarso
entusiasmo. Ben altri provvedimenti, ormai, erano
necessari per sanare le piaghe del tessuto sociale, e ad essi
pose mano, con ardore di idealista, Tiberio Sempronio
Gracco.
2. Il tribunato di Tiberio Gracco. - Nato nel 162
dall’omonimo personaggio che era stato due volte console,
nel 177 e nel 163, e da Cornelia, figlia dell’Africano
Maggiore, imparentato con l’Africano Minore, che aveva
preso in moglie sua sorella Sempronia, Tiberio apparteneva
alla più schietta nobilitas. Ma, forse anche per l’influsso di
dottrine filosofiche a sfondo egualitario apprese dai suoi
maestri greci, egli assunse rispetto alle questioni politiche e
sociali dei suo tempo un atteggiamento assai diverso da
quello della nobiltà in genere, e soprattutto in contrasto
con i suoi egoistici interessi.
Per restituire al lavoro dei campi le masse del
contadiname inurbato e riportarle all’antica dignità di liberi
agricoltori, egli si propose di mettere a partito le
109
opportunità che offrivano le immense estensioni dell’agro
pubblico, e quando fu eletto al tribunato della plebe per
l’anno 133 concretò i suoi progetti in uno schema di
plebiscito da sottoporre all’approvazione dei comizi.
Esisteva da gran tempo un insieme di provvedimenti
che, di tanto in tanto, lo Stato aveva emanato per regolare il
possesso dell’ager publicus contenendolo entro un certo
limite. L’ultimo di questi provvedimenti, vecchio ormai di
un cinquantennio, aveva stabilito che nessuno potesse
possederne più di 500 iugeri (cioè oltre 120 ettari; si tenga
ben presente la sostanziale differenza tra proprietà e
possesso, che è uso di una cosa senza esserne proprietari; i
possessori dell’agro pubblico lo sfruttavano, ma senza
averne il diritto di proprietà, che restava allo Stato). Tiberio
si riallacciò a questa disposizione, come se volesse
richiamarla in vigore dato che il limite dei 500 iugeri era
stato spesso superato, ma la sostanza della sua proposta
mirava in fondo a qualcosa di ben diverso. Si doveva
procedere ad una ricognizione generale dell’agro pubblico
per eliminare ogni sorta di abusi e restringere i possessi,
che fossero risultati legittimi, nei limiti dei 500 iugeri;
inoltre, e qui era la novità, le terre possedute abusivamente,
o in eccedenza del limite, dovevano essere riprese dallo
Stato, che ne avrebbe curato la distribuzione a cittadini
nullatenenti in lotti di 30 iugeri (poco più di 7 ettari).
Quelli che sfruttavano su larga scala l’ager publicus,
come s’è accennato, erano i ricchi latifondisti della nobiltà,
e si comprende come la loro reazione alla proposta agraria
di Tiberio fosse violentissima. Animati dalla più fiera
volontà di resistenza, cui naturalmente si ispirò
l’atteggiamento ufficiale del senato in questo affare, essi
pensarono di osteggiare la riforma agraria con una manovra
ostruzionistica guadagnando alla loro causa uno dei nove
colleghi di Tiberio, il tribuno Marco Ottavio. Costui si
110
avvalse del suo diritto di veto per bloccare la proposta di
legge, e fu irremovibile ad ogni preghiera o minaccia finché
Tiberio, per uscire dal grave imbarazzo, si risolse a
proporre ai comizi la sua destituzione. Era una proposta
senza precedenti nella storia ormai plurisecolare del
tribunato della plebe, ma, secondo Tiberio, essa trovava la
sua giustificazione nei fatto che Ottavio aveva agito a
danno e non a favore del popolo; i comizi, comunque,
l’approvarono spianando la strada alla successiva
approvazione della legge agraria.
Si trattava di un grande successo contro le forze
coalizzate della nobiltà, ma tutt’altro che decisivo, come
presto si vide. Approvata la legge e affidatane l’esecuzione
ad un collegio di triumviri agris iudicandis adsignandis (Tiberio,
il fratello Gaio e l’ex console Appio Claudio, suocero di
Tiberio), costoro si trovarono dinanzi ad una mole enorme
di lavoro soprattutto per dirimere le numerose questioni
che nascevano sulla legittimità dei possessi. Dopo pochi
mesi, Tiberio si accorse che l’anno del suo tribunato non
sarebbe stato sufficiente a condurre a termine l’opera
iniziata, e nello stesso tempo capì che la fine della sua
magistratura avrebbe insieme segnato l’abbandono della
sua riforma. S’indusse allora a imboccare quella che gli
parve l’unica via di uscita e nell’estate, con un atto che era
in contrasto con un’antica prassi costituzionale, pose la
candidatura per essere rieletto al tribunato per il successivo
anno 132.
L’opposizione del senato questa volta fu ancora più
violenta e decisa, anche perché la mossa di Tiberio offriva
il destro all’accusa di voler rivoluzionare l’ordine costituito.
Respinta come illegale la sua candidatura e scoppiato il
tumulto nell’assemblea popolare, il senato chiese al console
Publio Mucio Scevola di intervenire con i suoi poteri per
imporre il rispetto della legalità e, poiché quello esitava,
111
Scipione Nasica si pose a capo di una schiera di senatori
più risoluti che con il loro seguito di clienti e di servi fecero
irruzione nell’area capitolina provocando una zuffa
disordinata. Ne rimase travolto lo stesso Tiberio, che fu
raggiunto da una mazzata alla testa e steso esanime.
3. Dal programma conservatore di Tiberio a quello
rivoluzionario di Gaio Gracco. - Si concludeva così,
tragicamente, la breve parabola politica del non ancora
trentenne Tiberio, che la trionfante reazione del governo
nobiliare condannò come un dissennato rivoluzionario
mentre la sua opera, anche se rivoluzionaria fu o poté
apparire nei metodi, in realtà era intesa proprio alla
conservazione degli istituti politici tradizionali, anzi alla
restaurazione dell’antico.
Tiberio, in fondo, non aveva mirato che a riedificare
le strutture dello Stato agricolo mercé la ricostituzione della
classe dei contadini-soldati che avevano fatto la grandezza
di Roma. A tal punto aveva gli occhi fissi nel passato, da
non accorgersi che i tempi erano mutati anche per quello
che riguardava i problemi militari: ormai non si trattava più
di difendere il suolo della patria, compito che l’antico
esercito aveva assolto egregiamente, ma di mantenere il
dominio di terre lontane, compito che rendeva sempre più
urgente la creazione di un esercito di mestiere. Dopo la sua
morte, la reazione del senato non si spinse fino a provocare
l’abolizione della legge agraria, e la commissione
triumvirale (nella quale l’ex pretore Publio Licinio Crasso,
suocero di Gaio Gracco, aveva preso il posto di Tiberio)
poté continuare i suoi lavori. Ma, oltre alle precedenti,
incontrò nuove difficoltà per le proteste degli alleati italici:
di questi i più ricchi, possessori anche essi di porzioni
dell’agro pubblico, erano stati colpiti dalle limitazioni
imposte dalla legge, mentre i più bisognosi non potevano
112
partecipare alla distribuzione dei nuovi lotti, riservata ai
cittadini romani. Le loro lamentele trovarono ascolto
presso Scipione Emiliano, che fece trasferire ai consoli i
poteri giurisdizionali del collegio triumvirale rendendone in
tal modo ancor più difficoltoso il compito. Poco tempo
dopo Scipione fu trovato morto nel suo letto (a. 129), e
sebbene si parlasse ufficialmente di morte naturale, non è
escluso che in realtà si trattasse di un assassinio politico.
Nello stesso tempo gli alleati si agitavano con sempre
maggiore insofferenza finché nel 125 il console Marco
Fulvio Flacco, uno dei più autorevoli ed entusiasti aderenti
al movimento graccano, propose di estendere ad essi la
cittadinanza romana. Naturalmente il suo progetto, che
avrebbe leso troppi interessi, restò lettera morta, e allora il
malcontento dilagò irrefrenabile. Nella colonia di Fregelle
scoppiò la rivolta e si dovette domarla con la forza delle
armi: perché la punizione fosse di monito agli altri alleati, la
città fu rasa al suolo.
In quest’atmosfera irrequieta, carica di timori e di
speranze, veniva eletto al tribunato della plebe per il 123
Gaio Sempronio Gracco, di otto anni minore del fratello
Tiberio. Dotato anch’egli di grande talento, e di
un’eloquenza ancora più efficace, che travolgeva le masse
popolari, Gaio si dedicò subito a continuare l’opera del
fratello, o meglio a integrarla con un programma di riforme
così vaste da farne qualcosa di totalmente diverso. Se ne
ricava l’impressione che egli mirasse a trasformare l’assetto
costituzionale, imperniandolo su un suo potere personale
derivante dall’investitura del popolo sovrano attraverso
successive rielezioni al tribunato, rielezioni che una nuova
norma aveva reso non più illegittime come ai tempi di
Tiberio.
113
4. L’azione politica di Gaio Gracco. - Prendendo a
spiegare un’attività veramente instancabile, Gaio fece
approvare una lex frumentaria, che disponeva la periodica
distribuzione ai cittadini più bisognosi di una certa quantità
di grano a prezzo di favore, una lex militaris, per migliorare
le condizioni del servizio, una lex agraria, che richiamava le
norme già dettate da Tiberio reintegrando nella pienezza
delle sue attribuzioni la commissione triumvirale.
Ce n’era più che a sufficienza per assicurarsi la
rielezione per l’anno 122 e, forte del consenso popolare,
Gaio continuò per la sua strada preoccupandosi ora sia di
procacciare all’erario il denaro necessario all’applicazione
delle leggi già approvate, sia di assicurarsi l’appoggio dei
cavalieri nella lotta che si profilava inevitabile contro
l’opposizione del senato. Questo duplice intento egli
conseguì mediante la lex de provincia Asia. Una decina di
anni prima, nel 133, era morto l’ultimo re di Pergamo,
Attalo III, lasciando in eredità al popolo romano il suo
regno, che era entrato a far parte dei domini provinciali col
nome di provincia d’Asia. Con la sua legge Gaio stabilì che
essa fosse assoggettata al pagamento di una serie di
imposte e che l’appalto della loro riscossione fosse
concesso ai grossi finanzieri dell’ordine equestre.
I cavalieri furono inoltre blanditi con la approvazione
di una lex iudiciaria che ne accresceva grandemente
l’importanza sul piano politico. I giudici incaricati di
emanare le sentenze nei processi a carico di governatori di
provincia accusati di concussione (estorsione di denaro a
danno dei provinciali) erano stati scelti fino allora
esclusivamente nell’ambito dell’ordine senatorio; la legge di
Gaio stabilì invece che tali giudici dovevano essere non
senatori, ma cavalieri. Giustificazione del provvedimento
era il frequente verificarsi di assoluzioni scandalose di
governatori provinciali (che erano anch’essi senatori) da
114
parte dei giudici-senatori; ma le cose non migliorarono
perché i giudici-cavalieri si valsero del loro potere per
paralizzare con la minaccia di un processo i governatori che
volessero impedire gli abusi dei cavalieri appaltatori
d’imposte.
All’inizio del 122, al culmine della popolarità, Gaio si
decise ad avanzare un’altra proposta, che avrebbe
rappresentato il coronamento della sua opera riformatrice
mettendola al sicuro da ogni pericolo. Si trattava di
estendere il diritto di cittadinanza romana agli alleati latini e
il “diritto latino” agli alleati italici: un provvedimento che,
se da un lato dava l’agognata ricompensa a chi con tanti
sacrifici aveva collaborato alla grandezza di Roma, dall’altro
avrebbe permesso a Gaio di allargare a tutta l’Italia la
cerchia degli entusiasti fautori della sua politica.
Ma su questo punto il suo buon fiuto l’aveva tradito.
La concessione della cittadinanza a grandi masse di
stranieri non poteva non suscitare l’opposizione dei cives
Romani, in generale ugualmente gelosi dell’antico privilegio,
dal più potente al più umile. Lo si era constatato appena
pochi anni prima col fallimento del progetto di Fulvio
Flacco, e il senato colse ora il destro per dare inizio al
contrattacco; indusse il tribuno Livio Druso a intervenire
col suo veto e la proposta di Gaio rimase bloccata. Poco
dopo, essendosi Gaio recato in Africa per presiedere alla
fondazione, nel territorio di Cartagine, della colonia Iunonia,
che egli stesso aveva voluto far sorgere per aprire un altro
sfogo al proletariato di Roma, il senato sviluppò la sua
manovra facendo avanzare da Livio Druso alcune proposte
ultrademagogiche che ebbero l’effetto di scalzare ancor più
la sua declinante popolarità. E quando pochi mesi dopo
rientrò dall’Africa, Gaio dové constatare che il suo
prestigio era irrimediabilmente scosso, al punto di non
riuscire a farsi eleggere tribuno per l’anno appresso.
115
Era il trionfo dei suoi avversari, che ben presto
posero mano a smantellarne l’opera. Adducendo che la
fondazione della colonia a Cartagine era avvenuta sotto
sfavorevoli “auspìci”, essi promossero l’abrogazione della
legge che l’aveva autorizzata, e nel giorno dell’assemblea
popolare, com’era facilmente prevedibile, si verificarono
scontri sanguinosi fra i graccani e i loro oppositori. Il
senato non aspettava altro per scatenare la sua violenta
reazione e, decretato che lo Stato era in pericolo, invocò i
necessari provvedimenti. Il console Lucio Opimio, che era
accanitamente avverso al programma graccano, non
indugiò a dare il via alla repressione. Gaio, che con i più
fidi partigiani si era ritirato sull’Aventino al termine di
inutili trattative, invano cercò scampo nella fuga e preferì
farsi uccidere da un servo.
5. Reazione nobiliare e sopravvivenza delle istanze graccane. L’eliminazione di Gaio Gracco assicurò ancora per molti
decenni all’oligarchia senatoria il predominio nel governo
della repubblica, ma qualche cosa era ormai
profondamente mutato, se non nelle forme, nella sostanza
del sistema politico tradizionale. Tranne particolari di
minore importanza, il grosso dell’attività riformatrice del
tribuno era destinato a sopravvivere alla sua morte. La
potenza non più esclusivamente economica, ma anche
politica, raggiunta dai cavalieri attraverso la legge
giudiziaria, e soprattutto la nuova consapevolezza del
proletariato cittadino di poter sostenere al potere col suo
voto chi gli avesse procurato più larghi benefici, erano
elementi tali da compromettere la solidità delle basi su cui
da secoli poggiava la repubblica nobiliare. Anche se non si
addivenne alla costituzione di un vero e proprio partito con
un programma di rivendicazioni sociali (poiché questo,
propriamente, non furono i populares), esisteva ormai una
116
forza in grado di muoversi a sostegno delle istanze
democratiche solo che trovasse qualcuno atto a suscitarla e
organizzarla. A chi fosse capace di tanto, e sia pure per
ragioni contingenti di lotta politica o di opportunismo
personale, era aperta la via per scardinare il vecchio regime.
Senza dire, poi, del pericolo rappresentato per le forze
conservatrici dall’aspirazione sempre più irrefrenabile degli
alleati latini e italici al conferimento della cittadinanza
romana; una aspirazione certamente giusta, ma che una
volta realizzata avrebbe introdotto nuovi elementi di
squilibrio nelle strutture dello Stato.
Ma questi sviluppi erano appena all’orizzonte, e
l’oligarchia nobiliare, come poté dedicarsi più o meno
indisturbata alla restaurazione della sua autorità all’interno,
così poté provvedere all’allargamento e al consolidamento
delle conquiste esterne, specialmente nel settore
occidentale.
Mentre nella Spagna si trascinava la lotta incessante e
sanguinosa per piegare i Lusitani e i Celtiberi, nel 154 si era
dovuto intervenire anche nella Gallia meridionale per
difendere l’alleata Marsiglia dalle incursioni degli Arverni.
Circa trent’anni dopo le incursioni si rinnovarono, e furono
necessarie due campagne di guerra (a. 122 e 121) per
debellare la resistenza degli Arverni e degli alleati Allobrogi.
Per stabilire la continuità territoriale fra l’Italia
settentrionale e la Spagna, la regione venne ordinata in una
nuova provincia che fu detta Gallia Narbonensis (dal nome
della colonia di Narbo, oggi Narbonne, fondata nel 118),
corrispondente a un dipresso all’odierna Provenza, che
ancora conserva nel nome il ricordo del suo ingresso come
provincia nel mondo romano.
6. Giugurta e l’ascesa di Gaio Mario. - Di molto maggior
rilievo, anche per le complicazioni di politica interna,
117
furono le operazioni che si svolsero in Africa. Il regno di
Numidia, che si estendeva per largo tratto dalla Mauretania
alla Cirenaica racchiudendo il territorio comparativamente
modesto della provincia d’Africa, era travagliato da una
grave crisi. Il re Micipsa, figlio e successore di Massinissa,
alla sua morte (a. 118) aveva lasciato in eredità i propri
domini ai due figli Aderbale e Iempsale e al nipote
Giugurta, da lui benvoluto e adottato. Giugurta era tanto
avido di potenza quanto privo di scrupoli, ed essendo
venuto in discordia coi cugini per la ripartizione del regno
non esitò a far assassinare Iempsale e a impadronirsi poi
con le armi anche della parte di Aderbale. Questi si affrettò
a Roma per sollecitare l’intervento dei senato, che provvide
a dirimere la lite e a delimitare i domini dei due
contendenti.
Ma qualche anno dopo Giugurta rinnovò
l’aggressione e, nonostante gli ammonimenti romani, la
portò a termine con l’espugnazione di Cirta, capitale del
regno di Aderbale. Nella strage perirono anche alcuni
membri della fiorente colonia di mercanti italici che
operavano nella città, e questo spinse in Roma l’ordine
equestre a reclamare la guerra contro Giugurta, guerra che
il senato avrebbe volentieri evitato, essendo alieno dal
trasformare in dominio provinciale l’assai più comodo
protettorato sulla Numidia. Ma non si poteva lasciare
invendicata l’offesa al prestigio romano, e quando la guerra
fu dichiarata (a. 111) il senato sperò di mantenerla nei limiti
di una spedizione punitiva. La campagna, pertanto, fu
intrapresa con una certa fiacchezza, intramezzata da
trattative nelle quali sempre più arrogante si fece il
comportamento di Giugurta, che poi arrivò anche ad
infliggere una umiliante sconfitta alle forze del legato Aulo
Postumio Albino costringendole alla capitolazione (a. 110).
118
A questo punto, sotto la crescente pressione dei
cavalieri appoggiati dai populares, fu deciso di dare più
vigoroso impulso alle operazioni, e il comando ne fu
affidato al console (del 109) Quinto Cecilio Metello,
appartenente a quell’esigua minoranza di senatori che non
erano contrari alla guerra in Numidia. Metello si preparò
con impegno, circondandosi anche di valenti collaboratori
tra cui Gaio Mario, e nella primavera del 108 riportò una
bella vittoria sul fiume Muthul (d’incerta identificazione).
Non volle, peraltro, o non seppe, addentrarsi
all’inseguimento del nemico nel cuore del suo territorio per
cogliere un successo definitivo, e allora il favore dei
cavalieri e dei populares si spostò su Mario nella speranza
che fosse lui l’uomo adatto a chiudere la partita con
Giugurta.
Nato ad Arpino da mediocre famiglia, Mario aveva
raggiunto la pretura nei 115 all’età di 42 anni: una buona
carriera politica per un homo novus, anche se aveva goduto
l’appoggio della potente casata dei Cecili Metelli. Ora non
si lasciò sfuggire l’occasione favorevole, che pure lo
contrapponeva al suo comandante e protettore, e sebbene
da questo in vario modo osteggiato riuscì a tornare a Roma
e a porre la sua candidatura al consolato. Eletto console per
il 107 e incaricato espressamente, con apposita legge, del
comando in Africa, attese alacremente ai preparativi
preoccupandosi soprattutto del buon esito delle operazioni
di arruolamento. Infatti nell’organizzazione militare di
Roma repubblicana, in mancanza di veri e propri organici
in servizio permanente, quando gli sviluppi della politica
sboccavano nella guerra colui al quale veniva affidato il
comando delle operazioni doveva in primo luogo
preoccuparsi di allestire l’esercito. E questo o creandolo ex
novo, o potenziandolo nel caso avesse assunto il comando
di un esercito già costituito.
119
Ora, già dal tempo delle interminabili campagne di
Spagna le leve si svolgevano con una certa difficoltà perché
buona parte dei cittadini tenuti al servizio nelle legioni (cioè
quelli iscritti nelle 5 classi censitarie) cercavano di sottrarsi
ai loro obblighi. Per ovviare all’inconveniente era stato via
via diminuito (fino alla cifra bassissima di 1. 500 assi) il
censo minimo per l’attribuzione dei cittadini alla V classe,
sicché molti degli appartenenti agli strati più poveri della
cittadinanza potessero esservi iscritti e, quindi, venir
chiamati a prestar servizio nelle legioni, naturalmente
armati ed equipaggiati a spese dello Stato. Rivelatosi
inadeguato anche tale espediente, Mario fece ancora un
passo avanti reclutando direttamente, come volontari, i
capitecensi, con il risultato che allora, e poi in seguito, le
legioni risultarono formate pressoché esclusivamente di
nullatenenti, per i quali il servizio militare diventò un vero e
proprio mestiere. E nessuno allora si rese conto che tale
innovazione, attuata soltanto per assicurare il necessario
afflusso alle armi dei cittadini, avrebbe in breve portato alla
completa trasformazione dell’esercito. Infatti questo finì
per diventare uno strumento al servizio non più dello Stato,
ma del comandante che meglio sapesse compensarlo e, in
ultima analisi, elemento dominante nei contrasti politici che
segnarono la fine degli ordinamenti repubblicani.
Assicuratosi col nuovo sistema di arruolamento un
buon contingente di truppe fresche e desiderose di far bella
prova, Mario ritornò in Africa nella primavera del 107 e,
mentre Metello rientrava a Roma (ove ottenne il trionfo e il
titolo di Numidicus), intraprese una serie di energiche azioni
addentrandosi vittoriosamente nel territorio nemico. Ebbe
anche la fortuna di veder favorevolmente concludersi, due
anni dopo, le trattative già avviate da Metello col re della
Mauretania Bocco, il potente alleato e suocero di Giugurta.
Una parte di primo piano nel condurre a termine le
120
trattative ebbe Sulla, allora legato di Mario, al quale Bocco
consegnò Giugurta ottenendo in cambio un ingrandimento
del suo regno e un trattato di amicizia e di alleanza. Anche
la Mauretania entrava così a far parte del sistema degli Stati
vassalli di Roma, al pari della Numidia che venne
confermata in tale condizione sotto lo scettro di Gauda,
fratellastro di Giugurta, mentre questi veniva trascinato a
Roma in catene per rendere più splendido il trionfo del
vincitore, celebrato il capodanno del 104.
7. I Cimbri e i Teutoni. La gloria di Mario. - Era appena
chiusa la guerra giugurtina che una nuova, e ancor più
grande, occasione si offriva al talento di Mario. Nel corso
di un largo movimento migratorio che investì le regioni
dell’alto corso del Danubio e i territori della Germania
meridionale, i Cimbri e i Teutoni, popolazioni di stirpe
germanica, si spostarono verso occidente alla ricerca di
nuove terre e, superato il Reno, penetrarono nella Gallia
minacciando direttamente la provincia romana. I ripetuti
tentativi di respingerli si risolsero in altrettanti disastri,
specialmente l’ultimo, che per la discordia tra il console
Cneo Mallio Massimo e il proconsole Quinto Servilio
Cepione, entrambi a capo di un esercito, si trasformò nel
105 in un’orribile strage presso Arausio (odierna Orange).
Dopo la pessima prova dei generali di parte nobiliare,
tutte le speranze si appuntarono su Mario, il quale venne
eletto console per la seconda volta per l’anno 104 in deroga
alla norma che prescriveva un intervallo di almeno dieci
anni tra un consolato e l’altro (e anzi fu poi rieletto
successivamente di anno in anno fino al 100). Poiché i
barbari dopo la vittoria di Arausio, invece di concentrare gli
sforzi alla ricerca di un successo risolutivo (il che, del resto,
doveva essere estraneo ai loro disegni), si erano dispersi a
far bottino per la Gallia e la Spagna, Mario ebbe tempo di
121
arruolare un nuovo esercito e di addestrarlo a dovere,
cercando anche di perfezionarne l’armamento. Inoltre egli
portò a compimento la trasformazione degli organici già in
corso, per cui ogni legione risultò articolata non più in 30
piccole unità (quali erano i manipoli), ma in 10 coorti di
circa 600 uomini, ciascuna delle quali costituiva un’unità
tattica sufficientemente grande per operare con una certa
autonomia e consentire un più agile impiego della legione.
E si deve anche ricordare che fu Mario a fare dell’aquila,
affidata a un aquilifer, la bandiera di ogni legione e, quindi, a
stimolare l’ardore combattivo dei gregarii con il pungolo
dello “spirito di corpo”.
Così, quando qualche anno dopo i barbari mossero in
direzione dell’Italia, l’esercito romano era pronto a
sostenerne l’urto. Fu anche salutare che le orde degli
invasori si accingessero all’impresa separatamente; infatti i
Teutoni presero ad avanzare verso la Gallia meridionale,
mentre per loro conto i Cimbri si disponevano a valicare i
passi delle Alpi centrali. Mario si fece incontro dapprima ai
Teutoni, e nel 102 li sterminò presso Aquae Sextiae (oggi
Aix-en-Provence); l’anno dopo affrontò i Cimbri che,
travolta ogni resistenza, avevano dilagato attraverso la valle
dell’Adige nella Transpadana, e li annientò nella battaglia
dei Campi Raudii, presso Vercelli. Il pericolo era stato
veramente terribile, e il vincitore a buon diritto fu colmato
di onori, eletto console per la sesta volta e accomunato a
Romolo e a Camillo col titolo di “fondatore di Roma”.
8. Inasprimento della lotta politica. Eclissi di Mario. - Il
prestigio di Mario era immenso, ma stava per tramontare
rapidamente.
Proprio nell’anno del suo sesto consolato più acuta
si era fatta la tensione tra il governo nobiliare e i populares
122
sotto la guida del focoso tribuno Lucio Apuleio Saturnino
affiancato dal pretore Gaio Servilio Glaucia. Approfittando
dell’indiscussa autorità dell’homo novus che al favore
popolare doveva l’essere salito ai più alti fastigi, Saturnino
si fece promotore di un vasto programma di leggi a favore
del proletariato cittadino e, più ancora, degli alleati italici, e
riuscì a vararle superando le resistenze non soltanto del
senato, ma degli stessi cavalieri, di cui veniva a ledere
gl’interessi. Ai senatori, poi, inflisse la grave umiliazione di
costringerli a giurare che avrebbero osservato i suoi
provvedimenti, e sull’esempio di Mario tutti si piegarono al
giuramento, tranne Cecilio Metello Numidico, che preferì
partire in esilio.
Per poter sviluppare il suo programma, Saturnino si
fece rieleggere tribuno per l’anno 99 mentre Glaucia,
nell’intento di assicurarsi l’elezione al consolato, non
esitava a fare assassinare il competitore Gaio Memmio. A
questo punto il senato, come già ai tempi di Gaio Gracco,
poté decretare che la repubblica era in pericolo e incaricare
il console, Gaio Mario, di provvedere. Per Mario era il
momento della scelta: puntare sulla carta della rivoluzione,
che avrebbe avuto l’appoggio degli Italici più che delle
masse urbane, oppure aderire alla richiesta di ripristinare
l’ordine costituito separando le proprie responsabilità da
quelle degli attivisti democratici. Preferì la seconda
alternativa, che gli parve più idonea a tutelare la sua
posizione, anche se questa in ogni caso era
irrimediabilmente compromessa. Pur dopo il voltafaccia,
non poteva sperare di essere accolto nella ristretta cerchia
dei dirigenti della politica nobiliare, né, ormai, conservare la
figura di esponente della parte popolare; e mentre
Saturnino e Glaucia cadevano sotto i colpi della reazione
senatoria egli dovette allontanarsi da Roma, ufficialmente
123
per svolgere una missione diplomatica presso Mitridate, il
re del Ponto.
9. L’agitazione degli Italici e la guerra sociale. - Senatori e
cavalieri erano stati uniti nel soffocare il moto capeggiato
da Saturnino, ma restava ancora a dividerli l’insanabile
dissidio creato dalla legge giudiziaria di Gaio Gracco.
L’atteggiamento di inflessibile contestazione assunto
dai giudici-cavalieri nei confronti dei governatori-senatori
spinse il senato al progetto di avvalersi delle forze popolari
nella speranza di trovare un docile strumento delle sue
rivendicazioni nel tribuno Marco Livio Druso. Costui, che
era figlio dell’omonimo avversario di Gaio Gracco, avanzò
effettivamente nel 91 un certo numero di proposte, ma
queste, se comprendevano l’abolizione del monopolio
giudiziario dei cavalieri, d’altro canto blandivano i ceti più
bassi della cittadinanza con un insieme di concessioni rese
ancor più preoccupanti dalle contemporanee promesse agli
Italici di accogliere la loro aspirazione a diventare cittadini
romani. In realtà erano gli Italici, presenti in Roma con
numerose delegazioni, che sembravano i più interessati alle
sorti del programma di Druso, e proprio da parte loro
venne la più violenta reazione quando il senato, non pago
di averne abolito le leggi per vizio di procedura, fece
addirittura assassinare il tribuno. Era la riprova che a Roma
almeno in un punto si stabiliva la convergenza fra senato,
cavalieri e populares, quello di opporsi al desiderio degli
alleati di ottenere i diritti di cittadinanza romana. A costoro
non restava che la via dell’aperta rivolta, ed essi
l’imboccarono decisamente scatenando la guerra.
La guerra sociale (cioè contro i socii ribelli) avvampò
dapprima presso i Marsi e le confinanti popolazioni
sannitiche, che si unirono in lega con capitale a Corfinio,
poi si estese nella Campania, nell’Apulia, nella Lucania. Le
124
forze di cui i ribelli disponevano non erano numerose, ma
ottimamente addestrate alla tattica dell’esercito romano che
esse da secoli avevano affiancato sui vari campi di battaglia.
La consapevolezza, poi, di battersi per una causa sacrosanta
ne raddoppiava l’ardore, e sotto la guida di due duci valenti
quali Pompedio Silone e Papio Mutilo seppero dare molto
filo da torcere ai Romani.
A questi era rimasto l’appoggio degli alleati
mantenutisi fedeli, a cominciare dai Latini, ed essi
affrontarono animosamente la lotta anche se ben presto
dovettero accorgersi che per riportare la vittoria era
necessario concedere quanto fino allora avevano cercato di
negare. I due consoli del 90, Publio Rutilio Lupo e Lucio
Giulio Cesare (parente molto alla lontana del futuro
dittatore), aprirono la guerra su due fronti recandosi l’uno
ad affrontare Marsi e Piceni, l’altro i Sanniti; ma il bilancio
delle operazioni fu negativo, anzi Rutilio Lupo cadde
addirittura in combattimento.
In tali condizioni, incombendo il pericolo che la
ribellione si allargasse agli Umbri e agli Etruschi, e
sopraggiunta anche la notizia che in Oriente Mitridate
minacciava le posizioni romane, si fece strada in senato una
tendenza conciliatrice. La propugnava lo stesso console
Giulio Cesare, che fece votare una legge con la quale si
conferiva la cittadinanza romana ai Latini e a tutti gli Italici
che non avessero partecipato all’insurrezione. La medesima
tendenza ispirò l’anno dopo (89) una legge proposta dai
tribuni Marco Plauzio Silvano e Gaio Papirio Carbone (che
allargava la con cessione della civitas Romana ai cittadini
delle comunità federate che ne facessero richiesta entro i
sessanta giorni) e un’altra fatta approvare dal console Cneo
Pompeo Strabone (padre di Pompeo Magno), con la quale
si concedeva ai Transpadani il diritto latino, cioè la stessa
condizione che fino allora avevano avuta gli alleati Latini.
125
Tali provvedimenti non mancarono di sortire l’effetto
desiderato sull’esito della guerra, anche se questa si trascinò
ancora con una certa virulenza, tanto che vi perdette la vita
l’altro console dello 89, Lucio Porcio Catone. I successi più
ragguardevoli li colsero Pompeo Strabone, che riuscì ad
espugnare Ascoli Piceno e ad assicurarsi l’onore di un
trionfo, e Sulla, che condusse una serie di fortunate
operazioni nel Sannio e nella Campania per spezzare le
ultime resistenze degl’insorti.
Sembrava che, superata ormai felicemente la fase
sanguinosa della ribellione, le rivendicazioni dei socii non
dovessero più turbare la politica interna di Roma; invece
proprio da esse partì la scintilla di un nuovo conflitto, anzi
della prima di una serie di guerre civili che si conclusero col
naufragio del regime repubblicano.
La nostra informazione sugli aspetti più notevoli dei mutamenti
verificatisi nelle strutture sociali ed economiche del mondo romano per effetto
delle grandi conquiste riposa principalmente - oltre che sulla tradizione derivata
da Livio - su Plutarco (Vite di Tiberio e Gaio Gracco, di Mario, di Sulla) e su
Appiano (Guerre civili, lib. I), cioè su autori relativamente tardi. È andata infatti
pressoché interamente perduta la ricca produzione degli storici contemporanei
o più vicini ai fatti, tra cui fanno spicco le figure di Calpurnio Pisone (console
nel 133), di Sempronio Asellione (tribunus militum nel 134-133 sotto Numanzia)
e di Gaio Fannio, da identificare con il console del 122. Fannio, che fu
favorevole alla politica riformatrice di Gaio Gracco (salvo che nella questione
dei socii Italici), compose degli Annales in cui dei fatti dell’età graccana si trattava
con una obiettività (veritas), che fu poi assai lodata dal democratico Sallustio, al
quale piacque di raccogliere questa voce discorde fra le tante ispirate dalla
tendenza senatoria-ottimate (cfr. S. MAZZARINO, Il pensiero storico classico, II, 1,
p. 414 sgg.; v. anche ibid. p. 138 sgg. circa il valore della tradizione confluita in
Appiano).
Sulla personalità e sull’opera dei due Gracchi, v. G. CARDINALI, Studi
graccani, Genova 1912; ID., Capisaldi della legislazione agraria del periodo graccano, in
“Historia” VII (1933) p. 517 sgg.; J. CARCOPINO, Autour des Gracques: études
critiques, Paris 1928.
A testimonianza dell’attività svolta dai triumviri graccani restano alcuni
cippi terminali rinvenuti soprattutto in Lucania, in Apulia e in Campania, su cui
v. C.I.L. I2 p. 511 sg. Sul punto culminante dell’attività legislatrice di Gaio
Gracco, quello concernente l’accoglimento dei foederati nel seno della civitas
126
Romana, è difficile afferrare i termini esatti della situazione per il grande
divario, delle versioni conservate nelle fonti superstiti; si va da un programma
massimo riportato da Velleio Patercolo (II 6, 2: dabat civitatem omnibus Italicis,
extendebat eam paene usque Alpis) ad uno assai più moderato, riferito da Appiano
(Bell. civ. I 23, 99), che prevedeva il conferimento del ius civitatis ai soli Latini,
mentre gli altri socii venivano “promossi” alla condizione che era stata propria
dei Latini, quindi con possibilità di partecipare anch’essi ai comizi con diritto di
voto, sia pure molto limitato.
Su Giugurta, e sul bellum Iugurthinum di Sallustio, che per noi è la fonte
principale su quegli avvenimenti, cfr. G. FUNAIOLI, Sallustio e la storiografia
romana, Roma 1942, p. 12 sgg.; G. DE SANCTIS, Sallustio e la guerra di Giugurta, in
Problemi di storia antica, Bari 1932, p 187 sgg.; S. MAZZARINO, Il pensiero storico,
cit., II 1, p. 364 sgg.
Sulla figura e sull’opera politica di Gaio Mario in generale, si vedano gli
studi di A. PASSERINI (in “Athenaeum” n.s. XII, 1934) e di R. ANDREOTTI, C.
Mario, Gubbio 1940; in particolare, sulle riforme militari, A. SCHULTEN, Zur
Heeresreform des Marius, in “Hermes” LXIII (1928) p. 240 sgg.; A. PIGANIOL, La
conquête romaine, cit., p. 343 sgg.; sulle campagne per difendere l’Italia
dall’invasione, A. DONNADIEU, La campagne de Marius dans la Gaule Narbonnaise
(104-102 av. J.-Chr.), in “Rev. étud. anc.” LVI (1954) p. 2 sgg.; T.F.CARNEY,
Marius’ Choice of Battlefield in the Campaign of 101, in “Athenaeum” n. s. XXXVI
1958, p. 229 sgg. Sul crollo della posizione politica di Mario, F.W.ROBINSON,
Marius, Saturninus and Glaucia, Bonn 1912; W. SCHUR, Das sechste Konsulat des
Marius, in “Klio” XXXII (1918) p. 313 sgg.
Sul tribunato di Marco Livio Druso e sullo scoppio della guerra sociale,
cfr. A. BERNARDI, La guerra sociale e le lotte dei partiti in Roma, in “Nuova rivista
storica” 1944-45. Accanto alle fonti letterarie (oltre ai frammenti del lib.
XXXVIII di DIODORO, VELL. PAT. II 15; APPIAN., Bell. civ. I 35 sgg.; LIV.
LXXIII-LXXV) ci è rimasto anche qualche documento. In primo luogo le
glandes Asculanae, proiettili di piombo usati nelle operazioni di guerra del 90-89
a.C. intorno ad Ascoli e recanti incise varie parole. I proiettili rinvenuti erano
stati quasi tutti in dotazione ai socii ribelli, e infatti vi si leggono le scritte: Itali,
Italiensis, T. Laf(renius) pr(aetor) (uno dei capi degl’insorti, cfr. APPIAN., Bell. civ. I
47, 204 sgg.), fer(i) Pom(peium) (= colpisci Pompeo), fer(i) Sul(picium) (uno dei
legati di Pompeo Strabone): cfr. C.I.L. I2 p. 550 sgg. Un altro documento
epigrafico ci ha conservato il testo del decreto emanato da Pompeo Strabone
nel suo campo ad Ascoli il 18 novembre dell’89, decreto con il quale, in
applicazione di una clausola della lex Iulia de civitate, si concedeva agli
appartenenti a uno squadrone di cavalleria spagnola il diritto di cittadinanza
romana come ricompensa al valor militare (C.I.L. I2 709). Sono poi da
ricordare, fra i documenti di carattere numismatico, le monete emesse dai
confederati Marsi con tipi e leggende riferentisi alla guerra in corso. Tra le più
significative, il denario argenteo che reca nel verso l’immagine di un toro che
calpesta la lupa (simbolo di Roma) e l’iscrizione VITELIU (= ITALIA); cfr. E.A.
SYDENHAM, The Coinage of the Roman Republic, London 1954, p. 89 sgg. E.
127
BERNAREGGI, Problemi della monetazione dei Confederati italici durante la guerra sociale,
in “Riv. It. Num.” LXVIII (1966).
128
VIII
Le guerre civili: Mario, Sulla, Pompeo.
1. Il pronunciamento di Sulla. - Costretto a trasformare
larghe masse di alleati in cittadini romani, il governo
nobiliare si preoccupò - anche troppo - del pericolo che
costoro avessero a sconvolgere il preesistente equilibrio
politico. Poiché anch’essi, al pari di tutti gli altri cittadini,
dovevano ora venire iscritti nelle tribù territoriali, si ricorse
all’espediente di iscriverli soltanto in un numero limitato di
tribù, il che voleva dire ridurre ufficialmente al minimo la
loro importanza nella vita dello Stato (un’importanza che
sarebbe stata in ogni caso attenuata dal fatto che il cittadino
non residente a Roma, o che non vi si recava
appositamente nei giorni dei comizi, in pratica non aveva
modo di esercitare i suoi diritti politici). Infatti nei comizi
tributi (a quell’epoca la principale assemblea legislativa),
ove i cittadini votavano per tribù, essi avrebbero potuto
eventualmente concorrere a determinare soltanto il voto
delle poche tribù in cui erano stati registrati, mentre i
vecchi cittadini, esprimendo la loro volontà in un numero
maggiore di tribù, avrebbero continuato ad avere
facilmente la prevalenza. Lo stesso valeva per i comizi
centuriati, la principale assemblea elettorale, nei quali le
centurie dei votanti si costituivano con un sistema che
prendeva in considerazione i cittadini non soltanto in base
alla classe censitaria, ma anche alla tribù di appartenenza.
Perché la conquista della cittadinanza da parte degli alleati
non restasse una vittoria mutilata, mettendoli in una
dichiarata condizione d’inferiorità che avrebbe causato
nuovi conflitti, sarebbe stato necessario che all’atto della
129
registrazione essi venissero ripartiti fra tutte le 35 tribù, e a
questo appunto si prefisse di arrivare il tribuno Publio
Sulpicio Rufo.
Correva l’anno 88 e a Sulla, eletto console, era
toccato in sorte il comando della guerra contro Mitridate
proprio in un momento in cui si era acuita la tensione fra
senatori e cavalieri per la solita questione giudiziaria. Ora
poi un comando militare di Sulla, uomo devoto alle
direttive del senato, in quei paesi d’Oriente ove
prosperavano gli affari più o meno puliti dei capitalisti, era
cosa tutt’altro che desiderabile per l’ordine equestre, e
Sulpicio cercò di sfruttare ai suoi fini questa situazione. Per
guadagnarsi l’appoggio dei cavalieri e superare
l’opposizione del senato alla sua proposta in favore dei
nuovi cittadini, avanzò un altro progetto di legge in forza
del quale il comando della guerra mitridatica doveva essere
trasferito da Sulla a Mario. Sulla, che era occupato a
liquidare gli ultimi strascichi della guerra sociale e stava
assediando Nola, si affrettò ad accorrere a Roma per
cercare d’impedire l’approvazione delle leggi di Sulpicio,
ma questi, con l’aiuto dei cavalieri, non esitò a scatenare la
piazza e Sulla, minacciato di morte, fu costretto a fuggire
lasciando libero il campo agli avversari.
Le sue legioni sarebbero ora dovute passare agli
ordini di Mario, ma i tempi erano cambiati anche per la
disciplina militare: il nuovo esercito di mestiere si sentiva
legato assai più alla persona del capo che non al rispetto
delle leggi, e così fu facile a Sulla infiammare l’animo dei
suoi uomini a vendicare il torto subito dal loro comandante
e intraprendere una marcia su Roma. Non v’era nulla che
potesse contrastare il passo a quelle sei agguerrite legioni; e
Sulla, impadronitosi della città, si sbarazzò per prima cosa
degli avversari facendoli dichiarare hostes publici: Sulpicio fu
subito eliminato, Mario riuscì a stento a fuggire in Africa.
130
Vennero quindi adottati alcuni provvedimenti per tarpare
le ali agli agitatori di parte popolare e infine, sperando di
essersi in tal modo assicurato il terreno alle spalle, Sulla
partì per la guerra mitridatica.
E invece per niente sicuro egli doveva sentirsi dopo
aver dato il pericoloso esempio di inserire le forze armate
nelle competizioni politiche. A nessun comandante fino
allora era stato lecito entrare in Roma a capo di un esercito
in armi, nemmeno per celebrare il trionfo; da quel
momento sulla scena politica avrebbero avuto una parte di
primo piano gli eserciti o, piuttosto, coloro che meglio
avessero saputo farne strumento delle loro ambizioni.
2. La sedizione di Cinna e la vendetta di Mario. - Non
appena Sulla fu partito, in Roma riprese il sopravvento la
fazione popolareggiante guidata dal console dell’87 Lucio
Cornelio Cinna, che era un ardente fautore di Mario. Per
revocare i provvedimenti di Sulla, Cinna non si fece
scrupolo di ricorrere ai tumulti di piazza, ed essendo stato
dichiarato hostis publicus dal senato, si rifugiò presso
l’esercito che aveva sostituito quello sullano nell’assedio di
Nola, l’attirò dalla sua parte e intraprese una nuova marcia
su Roma. Contemporaneamente Mario, reduce dall’Africa e
assetato di vendetta, si apprestava a rientrare anche egli in
città. Ogni tentativo di difesa fu vano, e l’ingresso dei
vincitori nell’Urbe diede inizio ad un’orgia di sangue che
durò cinque giorni e si concluse con la strage dei principali
esponenti della parte nobiliare. Sfogato il suo rancore, il
vecchio Mario ebbe pure la soddisfazione di vedersi eletto
console (per la settima volta!) per l’anno 86, anche se poco
dopo (il 13 gennaio) morì stroncato da una violenta
malattia. Abolite le leggi sullane, promulgatene altre a
favore del proletariato cittadino (cui si condonavano gran
parte dei debiti che l’opprimevano) e degli ex alleati italici
131
(cui si consentiva l’iscrizione in tutte le 35 tribù), i populares
si erano impadroniti saldamente del potere, ma su di loro
gravava la minaccia del prossimo ritorno di Sulla. Di
questo, soprattutto, dové preoccuparsi Cinna che, rieletto
console di anno in anno fino all’84, fu l’anima del governo
democratizzante. Dopo aver inviato in Grecia un corpo di
spedizione agli ordini di Lucio Valerio Flacco (console
suffectus nell’86 dopo la morte di Mario) con l’incarico di
esonerare dal comando Sulla, egli si adoperò per
organizzare un forte esercito col quale si proponeva di
affrontare personalmente l’avversario. Ma al principio
dell’84, mentre s’imbarcava ad Ancona, cadde vittima di un
moto sedizioso, e le truppe rimasero in Italia ad attendere
lo sbarco di Sulla.
3. Le imprese di Sulla in Oriente. - Nei circa quattro anni
trascorsi in Oriente, Sulla aveva avuto modo di rinsaldarvi
la preponderanza romana. Mentre i grandi regni di Siria e
d’Egitto si estenuavano sempre più nelle incessanti lotte
dinastiche, e i minori Stati vassalli vivacchiavano all’ombra
del patronato romano, il regno del Ponto (sulla costa
meridionale del Mar Nero) aveva intrapreso verso la fine
del II secolo una vigorosa politica espansionistica sotto la
guida del re Mitridate VI Eupatore. Allargata la sua signoria
sulla regione ad oriente del Mar Nero, Mitridate realizzò
con l’appoggio del re Nicomede III di Bitinia la conquista
della Paflagonia e della Galazia, poi quella della
Cappadocia; ma a questo punto le relazioni fra i due alleati
si guastarono e Nicomede sollecitò i Romani ad
intervenire. Si ebbe allora (a. 97) la missione diplomatica di
Mario e, cinque anni dopo, un intervento di Sulla in qualità
di governatore della Cilicia, ma nulla valse a fermare
Mitridate, che giunse anche ad invadere il regno di Bitinia
132
e, approfittando delle complicazioni della guerra sociale, a
dichiarare guerra a Roma.
Ai primi dell’88, con azione travolgente, Mitridate
s’impadronì della provincia d’Asia e diede ordine di
sterminare tutti i Romani e gli Italici che ivi attendevano ai
loro traffici lucrosi (si parlò di 80.000 morti).
Contemporaneamente, una furiosa ondata di rivolta
antiromana si propagava in Grecia (specie ad Atene) e in
Macedonia, e quando Sulla nella primavera dell’ 87
sbarcava in Epiro, ai Romani non restava che il controllo
dell’Etolia e della Tessaglia. Attraversata la Grecia
settentrionale, egli concentrò i suoi sforzi nell’assedio di
Atene, la principale base di Mitridate in terra ellenica, che
l’anno appresso cadde e fu abbandonata al saccheggio.
Pochi mesi dopo, sempre nell’anno 86, il duce romano
mosse incontro a un grosso esercito pontico, che
scendendo dalla Macedonia aveva invaso la Beozia, e a
Cheronea riportò con le sue forze relativamente modeste
una vittoria clamorosa. Il successo fu consolidato più tardi
da una nuova vittoria riportata ad Orcomeno: era la fine
della potenza di Mitridate in Grecia.
Intanto il corpo di spedizione, che nello stesso anno
86 Cinna aveva inviato contro Sulla al comando di Lucio
Valerio Flacco, aveva per suo conto recuperato la
Macedonia, la Tracia e, dopo l’uccisione di Valerio Flacco a
seguito di un ammutinamento capeggiato dal suo legato
Gaio Flavio Fimbria (che ora assunse il comando), aveva
incalzato il nemico oltre l’Ellesponto costringendo
Mitridate a rinchiudersi nella piazzaforte di Pitane (in
Misia). A questo punto il re si risolse ad aprire trattative
con Sulla, dal quale invano cercò di ottenere condizioni più
favorevoli minacciando che altrimenti avrebbe trattato con
Fimbria. Con la pace di Dardano (a. 85) il re dovette
133
rassegnarsi a restringere il suo regno entro gli antichi
confini, a consegnare la flotta e a pagare una indennità.
Da parte sua, Sulla poteva ritenersi pago di una tale
conclusione dell’impresa. In altre circostanze, gli sarebbe
stato agevole schiacciare le forze di Mitridate, specialmente
se avesse potuto ricevere qualche aiuto da Roma. Ma
proprio in Roma erano i suoi nemici più accaniti e, dopo
aver attirato dalla sua le truppe di Fimbria (che si tolse la
vita) ed essersi trattenuto a sistemare le cose d’Asia e di
Grecia, raccogliendovi soprattutto grandi somme di
denaro, partì da Patrasso e nella primavera dell’83 sbarcò a
Brindisi.
4. Il ritorno di Sulla. - Al suo arrivo Sulla non solo non
incontrò resistenze, ma vide affluire gran copia di aiuti da
parte di alcuni elementi della nobiltà che si erano preparati
alla riscossa contro il governo democratizzante. Erano fra
loro il proconsole Quinto Cecilio Metello Pio e gli ancor
giovani Marco Licinio Crasso e Cneo Pompeo,
quest’ultimo con ben tre legioni assoldate nel Piceno fra le
vastissime clientele che il padre si era ivi create al tempo
della guerra sociale.
Passato dall’Apulia nella Campania, Sulla si trovò di
fronte successivamente gli eserciti dei due consoli dell’83,
Lucio Cornelio Scipione Asiatico e Gaio Norbano.
Quest’ultimo, dopo uno scontro sfavorevole, fu costretto
ad asserragliarsi in Capua, mentre con Scipione
intercorsero trattative che non approdarono a nulla di
risolutivo salvo che, nel frattempo, i suoi uomini passarono
in blocco dalla parte di Sulla. Per l’anno appresso, che
doveva essere decisivo, i democratici affidarono la loro
fortuna nelle mani di Cneo Papirio Carbone e del
ventiseienne Gaio Mario, figlio adottivo del grande
scomparso. Eletti consoli, costoro si adoperarono per
134
levare rinforzi da ogni parte, specialmente fra gli Etruschi e
i Sanniti timorosi che una vittoria di Sulla avesse a privarli
dei benefici della cittadinanza ottenuti sotto il governo
popolare. Nella primavera di quell’anno 82 Sulla risalì dalla
Campania verso il Lazio, sconfisse l’esercito di Gaio Mario
obbligandolo a rinchiudersi a Preneste, e proseguì in
direzione di Roma che, occupata senza resistere, fu teatro
delle solite stragi. Avanzò quindi in Etruria contro Papirio
Carbone che, dopo uno scontro di esito incerto, di li a
poco fu preso e messo a morte da Pompeo. Intanto Sulla
aveva impedito che Preneste fosse sbloccata da due grossi
eserciti di Sanniti e di Lucani, e allora questi, abbandonati
gli assediati al loro destino, marciarono su Roma.
Il prenderla non avrebbe avuto alcuna importanza
per l’esito della guerra, che ormai appariva scontato;
l’intenzione era di ridurla in un cumulo di macerie,
disperata vendetta di una causa irrimediabilmente perduta.
Ma Sulla riuscì a parare il colpo: arrivato con marcia
rapidissima sotto le mura di Roma poche ore dopo gli
avversari, li attaccò con estrema energia e al termine di un
lungo e accanito combattimento (battaglia di Porta Collina)
riportò piena vittoria. Cadevano allora anche Preneste, ove
Mario trovò la morte, e poi man mano le altre città in cui si
erano arroccati i mariani, fra cui più a lungo resistettero
Norba, Nola e Volterra. Restavano poi da eliminare le
ultime resistenze mariane in alcune province, come l’Africa
e la Sicilia, e in queste operazioni si distinse Cn. Pompeo,
cui Sulla concesse l’onore di un trionfo e l’appellativo di
Magnus.
5. Dittatura e riforme antidemocratiche di Sulla. Scomparsi i consoli Mario e Carbone, la repubblica era
rimasta acefala; Sulla, ancora nell’anno 82, convocò i
comizi centuriati e ne fu eletto dittatore con il potere di
135
emanare leggi e di dare una nuova costituzione alla
repubblica, carica che mantenne ininterrottamente dall’82
al 79 rivestendo nell’80 anche il secondo consolato. Ogni
residua opposizione fu annientata con le proscrizioni (i
proscripti, i cui nomi venivano compresi in apposite liste
esposte in pubblico, potevano essere uccisi da chiunque, e i
loro beni erano confiscati e venduti all’asta), ed è inutile
dire che sotto l’etichetta politica furono consumate
vendette private e ogni sorta di ribalderie. Il flagello infierì
non solo in Roma, ma in tutta l’Italia, e si abbatté
specialmente su Etruschi e Sanniti che, per aver
accanitamente avversato la reazione capeggiata da Sulla,
furono sterminati fin quasi a scomparire dal quadro etnico
della penisola.
Cessato il bagno di sangue, per i vincitori si trattava
di smantellare l’opera del regime democratico e restituire
allo Stato la fisionomia di repubblica oligarchica. A questo
si accinse subito Sulla con una serie di provvedimenti
emanati per lo più nel corso dell’anno 81 in forza dei suoi
poteri eccezionali. Il senato fu restituito alla sua funzione di
cardine del governo nobiliare, e mentre fino ad allora era
stato di 300 membri (ma per le stragi degli ultimi anni si era
ridotto alla metà) fu portato a 600 membri, con
l’immissione, fra l’altro, di numerosi ufficiali che si erano
distinti nella guerra e con l’inclusione di 300 cavalieri (col
che si voleva eliminare il contrasto per la competenza
giudiziaria, restituita ora al senato). Fu poi riordinato il
cursus honorum, stabilendo gli intervalli fra le magistrature e,
soprattutto, il divieto di rivestire un secondo consolato
prima di dieci anni dal precedente. Particolarmente colpito
fu il tribunato della plebe, di cui fu limitato il diritto di
veto, mentre d’altra parte perdeva la facoltà di promuovere
leggi senza la preventiva approvazione del senato, il che
significava metter fine alla legiferazione del proletariato
136
urbano nei comizi tributi sotto la spinta degli agitatori
popolari. Fu anche stabilito che chi avesse rivestito il
tribunato della plebe non avrebbe più potuto ottenere altre
magistrature, e questa era una prospettiva poco allettante
per chi voleva fare carriera politica.
Con altri provvedimenti si cercò anche di evitare che
in futuro la repubblica fosse alla mercé dei magistrati con
comando militare, e così fra l’altro si stabilì che nessun
esercito in armi potesse trovarsi nel territorio della Penisola
a sud dell’Arno e del Rubicone (a nord di questa linea fu
creata la provincia di Gallia Cisalpina). Era proprio questo
il punto più delicato per la sopravvivenza della
restaurazione nobiliare, ma restavano insopprimibili le
conseguenze derivanti dal mutato carattere dell’esercito,
legato alla persona del condottiero capace di ricompensarlo
con maggiore munificenza (da ultimo, ben 150.000 veterani
avevano ottenuto da Sulla assegnazioni di terre). Pertanto
quando Sulla nel 79, in piena coerenza con la sua opera di
restitutore dell’antico equilibrio costituzionale, depose i
poteri eccezionali e si ritirò a vita privata per lasciare libero
campo al funzionamento degli organi di governo, il nuovo
assetto statale già recava i germi della dissoluzione, e fu
ventura per lui morire improvvisamente l’anno dopo senza
vederne il crollo.
6. Ripresa delle forze democratiche. Sertorio e la resistenza in
Spagna. - Benché momentaneamente prostrata e umiliata,
quella dei populares e dei cavalieri restava ancora una forza
notevole per chi fosse riuscito a riportarla nel giuoco della
competizione politica, e vi si accinse subito Marco Emilio
Lepido, uno dei consoli del 78, che propose l’abolizione
delle leggi sullane restrittive dei poteri del tribunato della
plebe. Immediatamente rialzarono il capo tutti i
malcontenti, e in primo luogo quanti erano stati colpiti
137
dalle confische, specie in Etruria ove si organizzò
apertamente la lotta contro i coloni stanziati da Sulla. Per
vincere la resistenza del senato, Lepido non esitò a mettersi
a capo della ribellione e nel 77, partito per assumere
l’ufficio di governatore della Gallia Narbonese, si fermò
invece in Etruria e, dopo un rapido concentramento delle
forze, mosse in armi contro Roma.
Dichiarata in pericolo la repubblica, il senato ne
affidò la difesa all’ex console Quinto Lutazio Catulo e a
Pompeo. Questi non aveva ancora trent’anni, ma si era
portato in primo piano con le imprese compiute a fianco di
Sulla, e sebbene fino a quel momento non avesse rivestito
alcuna magistratura, il senato gli fece conferire
eccezionalmente l’imperium con uno strappo alle norme
costituzionali. Pompeo e Catulo ebbero facilmente ragione
degli avversari e Lepido fu sconfitto presso Roma, ma
riuscì a ritirarsi in Sardegna con le sue forze, che passarono
poi in Spagna ad alimentarvi le superstiti resistenze
mariane.
Animatore di queste resistenze era Quinto Sertorio.
Pretore nell’83, dopo le prime vittorie di Sulla aveva
raggiunto il suo posto di governatore della Spagna Citeriore
dove con una vasta azione, militare a un tempo e
diplomatica, sulle popolazioni indigene aveva creato un
saldo organismo plasmato sulla falsariga degli ordinamenti
romani, ma improntato alla più viva ostilità verso il
governo di Roma. Vivo ancora Sulla, vani erano risultati i
tentativi di abbatterlo e, fattasi sempre più grave la
minaccia, il senato dovette decidersi ad un energico
intervento, mettendosi però ancora una volta nelle mani
della prepotente personalità di Pompeo, che ancora non si
risolveva a congedare l’esercito affidatogli per combattere
Lepido.
138
Rivestito ora, sempre in deroga alle norme sullane, di
imperium proconsolare con le funzioni di governatore della
Spagna citeriore, Pompeo vi si trasferì al principio del 76.
La sua campagna si svolse però sulle prime in maniera
tutt’altro che favorevole, e tra il 76 e il 74 subì vari
insuccessi. Di tali rovesci Pompeo attribuì la colpa al
senato, al quale scrisse in tono quasi minaccioso
sollecitando l’invio dei rinforzi richiesti, e solo quando
questi arrivarono le operazioni furono riprese e felicemente
concluse nel 72. Costretto dalle necessità della guerra a
gravare con mano sempre più ferrea sulle popolazioni
locali, che fino allora l’avevano sostenuto, e a instaurare i
metodi della più crudele disciplina, Sertorio aveva visto
rapidamente scemare la sua popolarità, e infine cadde sotto
i colpi di un suo luogotenente. Tale fu la fine di questa
discussa personalità: un grande capitano, indubbiamente,
ma che per il trionfo della sua parte politica non s’era fatto
scrupolo di stringere accordi anche col più fiero nemico di
Roma, Mitridate.
7. Mitridate, Spartaco e l’ascesa di Pompeo. - Dopo la pace
di Dardano, Mitridate non aveva mai abbandonato i
propositi di rivincita, e vi si era preparato allargando il suo
dominio su nuovi territori. Una buona occasione per
riprendere la partita gli parve quella della morte dell’ultimo
re di Bitinia, Nicomede IV, il quale aveva lasciato erede del
suo regno il popolo romano. Che la vicina Bitinia venisse
in potere dei Romani era troppo pregiudizievole per le sue
mire espansionistiche, ed egli deliberò di passare all’azione
invadendo la Bitinia e stringendo accordi con Sertorio e
con i pirati che erano tornati a infestare le acque del
Mediterraneo.
A Roma il comando della guerra fu assegnato ai due
consoli dell’anno 74, Marco Aurelio Cotta e Lucio Licinio
139
Lucullo, quest’ultimo un valente condottiero che si era
formato alla scuola di Sulla. Le operazioni da lui condotte
in Oriente durarono ininterrottamente fino al 67 (Aurelio
Cotta invece tornò a Roma già nel 71) e furono tutte un
susseguirsi di folgoranti successi, senza però che egli
riuscisse a chiudere vittoriosamente la guerra. Fu liberata la
Bitinia, fu occupato il Ponto, fu invasa l’Armenia, ove il re
Tigrane aveva offerto rifugio a Mitridate, e ne fu presa la
capitale Tigranocerta (a. 69), ma le continue campagne
finirono per stancare l’esercito, che Lucullo sottoponeva ad
una rigorosa disciplina, badando soprattutto che non si
abbandonasse a ruberie nei paesi attraversati. Questo fece
sì che la stanchezza si trasformasse in malcontento e in
aperto rifiuto di obbedienza, mentre il protrarsi della guerra
offriva il destro agli avversari di Lucullo in Roma di
intrigare finché il senato decise di inviargli un successore.
Intanto, nell’inazione del suo esercito, Tigrane e Mitridate
potevano disfarne le lunghe fatiche e rientrare in possesso
dei loro domini: un altro campo restava aperto per la gloria
di Pompeo.
Questi, tornato dalla Spagna nel 71, era arrivato in
tempo per assestare un colpo alle ultime bande di gladiatori
e di schiavi che si erano ribellati nel 73 e, agli ordini di
Spartaco, per due anni avevano percorso le regioni
centromeridionali della Penisola fra grandi stragi e
devastazioni. Dopo la sconfitta dei due consoli del 72, per
un momento si era temuto per l’incolumità della stessa
Roma, ma l’anno appresso il proconsole Marco Licinio
Crasso li aveva affrontati e sterminati, tranne quelli che
incapparono poi nelle mani di Pompeo.
Pompeo se ne fece un nuovo titolo di merito, da far
valere dinanzi al senato assieme a quelli già acquistati nella
lotta contro Sertorio e, oltre alla concessione del trionfo,
ottenne di poter presentare la candidatura al consolato
140
sebbene non avesse mai ricoperto una magistratura
ordinaria (dunque, senza passare per la lunga trafila della
questura, dell’edilità e della pretura). Pose la sua
candidatura anche Crasso, che dopo aver raccolto una
favolosa fortuna impiegando abilmente i denari accumulati
al tempo delle proscrizioni, aveva cercato di emergere nella
vita pubblica e voleva ora sfruttare la vittoria riportata
contro i gladiatori. I due si intesero per appoggiare
vicendevolmente le loro aspirazioni e, sbandierando un
programma di riforme democratiche, si assicurarono
l’appoggio delle forze popolari e vinsero le elezioni.
Tale vittoria significava, in pratica, la liquidazione di
quanto restava della legislazione antidemocratica di Sulla;
fra l’altro, i tribuni della plebe (cui già una lex Aurelia del 75
aveva restituito il diritto di poter rivestire altre
magistrature) vennero reintegrati nella pienezza delle loro
attribuzioni, e fu fortuna per gli ottimati che l’intesa fra i
due consoli ben presto si estinguesse nella scambievole
gelosia. Ma ormai che aveva raggiunto la dignità consolare
e si era assicurato il favore delle masse, ogni strada era
spalancata all’ambizione di Pompeo e al suo desiderio di
primeggiare nella vita della repubblica.
8. Fine di Mitridate e potenza di Pompeo. - Di lì a qualche
anno, nel 67, su proposta del tribuno Aulo Gabinio, venne
conferito a Pompeo l’incarico di estirpare la malapianta
della pirateria, cresciuta al punto da paralizzare i traffici
marittimi in tutto il Mediterraneo. Il senato cercò
inutilmente di contrastare la concessione di questo
comando straordinario, che doveva avere la durata di
almeno tre anni, e nelle mani di Pompeo fu concentrata
una massa di uomini e di mezzi così ingente, che
veramente ne facevano il padrone dello Stato. Con tali
enormi apparecchi fu agevole a Pompeo assolvere
141
rapidamente il compito affidatogli e, nello stesso tempo,
prepararsi il terreno per una nuova impresa ancora più
gloriosa: quella di concludere la guerra contro Mitridate.
A succedere nel comando a Lucullo era stato
designato il console del 67 Manio Acilio Glabrione, cui era
stato conferito per l’anno appresso il proconsolato di
Ponto e Bitinia; ma questi non ebbe tempo dimettersi
all’opera. Infatti con una proposta presentata al principio
del 66 dal tribuno Gaio Manilio (proposta che ancora una
volta il senato cercò invano di osteggiare, mentre a suo
favore parlarono Cicerone e Cesare) a Pompeo veniva
attribuito il comando sulla Cilicia, il Ponto e la Bitinia con
l’incarico di debellare Mitridate.
Anche per questa impresa le forze messe a sua
disposizione erano ingentissime, ma Pompeo, con la sua
solita tattica prudenziale, cominciò con una abile azione
diplomatica intesa a incrinare l’alleanza fra Mitridate e
Tigrane. Rimasto isolato, Mitridate nell’estate del 66 fu
sconfitto in battaglia campale sul fiume Lico (ove Pompeo
fondò poi, per ricordo, la città di Nicopoli) e costretto a
retrocedere fino al Bosforo cimmerio. Quivi sperava di
preparare la riscossa, ma intanto il vincitore (che nel 66
aveva ottenuto anche la sottomissione di Tigrane) prendeva
possesso del suo regno e nel 64 lo riduceva nella
condizione di provincia riunendolo alla Bitinia (prov. di
Bitinia-Ponto).
Ancora nel 64 Pompeo dal Ponto scese nella Siria,
che da tempo era in pieno sfacelo e, deposto l’ultimo dei
Seleucidi, Antioco XIII l’Asiatico, ne fece una nuova
provincia; quindi intervenne a regolare una contesa
dinastica in Giudea e, dopo aver preso Gerusalemme, ne
fece uno Stato vassallo. Mentre attaccava Gerusalemme,
giunse a Pompeo la notizia della morte di Mitridate. Con le
gravezze imposte ai sudditi per preparare la rivincita, il
142
vecchio re aveva suscitato una ribellione e, non riuscendo a
domarla, si era data la morte col veleno.
Sbarazzatosi così a buon mercato dell’implacabile
nemico, Pompeo poté procedere con tutto agio a dettare
gli ordinamenti per i nuovi dominii, a regolare i rapporti
con gli Stati vassalli e le città libere, e insomma a quanto era
necessario per inserire stabilmente i paesi del vicino
Oriente nell’orbita del mondo romano. Nessun condottiero
aveva imposto su terre così lontane e così vaste l’ossequio
al volere di Roma, nessuno aveva raccolto un bottino così
enorme e assicurato all’erario così ingenti tributi, nessuno si
era creato masse di clientele così imponenti, e quando nel
62 egli s’imbarcò per l’Italia la sua potenza toccava i più alti
fastigi.
Una certa discrepanza presentano le notizie che ci sono pervenute
intorno ai particolari dell’espediente adottato dal governo di Roma per limitare
l’importanza politica dei novi cives, cioè delle masse di ex-alleati accolti nella
civitas dopo la guerra sociale. In Velleio Patercolo (II 20) si legge: Cum ita civitas
Italiae data esset, ut in octo tribus contribuerentur novi cives, ne potentia eorum et multitudo
veterum civium dignitatem frangeret plusque possent recepti in beneficium quam auctores
beneficii, Cinna in omnibus tribubus eos se distributurum pollicitus est. Parrebbe, dunque,
che i novi cives fossero stati iscritti soltanto in otto delle 35 tribù. D’altro canto
in Appiano (Bell. civ. I 49) leggiamo che “I Romani non iscrissero questi nuovi
cittadini nelle 35 tribù allora esistenti nel loro ordinamento, affinché, essendo
più numerosi dei vecchi cittadini, non avessero il sopravvento nelle votazioni,
ma suddivisili in dieci parti crearono altrettante nuove tribù, nelle quali essi
votavano come ultimi. E spesso il loro voto risultava inutile, dato che le 35
tribù erano chiamate a votare prima e costituivano più della metà”.
Su questi problemi, sempre fondamentale TH. MOMMSEN, Ges. Schriften,
I, p. 262 sgg.; v. anche A. BISCARDI, La questione italica e le tribù soprannumerarie,
in “La Parola del Passato” VI (1951) p. 241 sgg. L’applicazione delle leggi sulla
concessione del ius civitatis agli ex-alleati si rispecchia nelle cifre dei censimenti
che ci sono state trasmesse per il periodo immediatamente anteriore e
posteriore alla guerra sociale. I censori del 115/4 avevano censito 349.336
civium capita (LIV., per. LXIII); questo numero salì nell’86/5 a 463.000 (cfr.
HIERON., Chron. p. 151 HELM) e a 910.000 nel 70/69 (LIV., per. XCVIII; cfr.
ASCON., p. 222 STANGL).
143
Sulla figura e l’opera di Sulla, in generale, DRUMANN-GROEBE,
Geschichte Roms in seinem Uebergange von der republikanischen zur monarchischen
Verfassung, vol. II, p. 364 sgg.; J. CARCOPINO, Sylla ou la monarchie manquée, Paris
1931.
Su Cinna e sul governo dei popolari in Roma durante l’assenza di Sulla,
v. H. BENNET, Cinna and his times, Chicago 1923; CH. M. BULST, ‘Cinnanum
tempus’, in “Historia” XIII (1964) p. 307 sgg.
Sulla spedizione di Sulla in Oriente (fonti principali il libro Mitridatico di
Appiano e la Vita plutarchea di Sulla), oltre i già citati Antike Schlachtfelder di J.
KROMAYER e G. VEITH (vol. II), v. N.G.L. HAMMOND, The two Battles of
Chaeronea, in “Clio” XXXI (1938), p 186 sgg.
Sulle riforme costituzionali sullane, cfr. M. A. LEVI, Silla. Saggio sulla
storia politica di Roma dall’anno 88 all’80, Milano 1924, ID., La costituzione romana
dai Gracchi a Cesare, Firenze 1928, G. NICOLINI, Il tribunato della plebe, Milano
1932; A. BISCARDI, Plebiscita et auctoritas dans la législation de Sulla, in “Rev. Hist.
Droit” XIX, 1959, p. 153 sgg. Come è detto espressamente nel testo, nell’anno
70, essendo consoli Pompeo e Crasso, si arrivò alla liquidazione di ciò che
rimaneva dei provvedimenti antidemocratici di Sulla, non del restante
complesso dei suoi ordinamenti, che continuarono ad essere in vigore come
espressione delle istanze della nobiltà rimasta detentrice del potere. Peraltro
quei provvedimenti antidemocratici avevano caratterizzato la riforma
costituzionale di Sulla, e pertanto appare legittimo continuare a parlare di un
crollo della costituzione sullana, nonostante le troppo sottili distinzioni di U.
LAFFI, in “Athenaeum”, LV 1967, p. 177 sgg.
Un’eco del contrasto in seno alla nobilitas fra oppositori e fautori del
ristabilimento dei pieni poteri tribunizi si può cogliere in CIC., De leg. III 22; 26.
Quivi le riserve degli oppositori appaiono così enunciate per bocca di Quinto
Cicerone: in ista quidem re vehementer Sullam probo, qui tribunis plebis sua lege iniuriae
faciendae potestatem ademerit, auxilii ferendi reliquerit, Pompeiumque nostrum ceteris rebus
omnibus semper amplissimis summisque effero laudibus, de tribunicia potestate taceo. Nec
enim reprehendere libet nec laudare possum. Al fratello l’oratore replica osservando:
Pompeium vero quod una ista in re non ita valde probas, vix satis mihi illud videris
attendere non solum ei quid esset optimum videndum fuisse, sed etiam quid necessarium.
Sensit enim deberi non posse huic civitati illam potestatem; quippe quam tanto opere populus
noster ignotam expetisset, qui posset carere cognita? Sapientis autem civis fuit, causam nec
perniciosam et ita popularem ut non posset obsisti, perniciose populari civi non relinquere.
Su Sertorio e le vicende della resistenza democratica in Spagna (fonti
principali PLUT., Vite di Pompeo e di Sertorio; APPIAN., Bell. civ. I 108 sgg.), v.
specialmente A. SCHULTEN, Sertorius, Leipzig 1926.
Sulla ripresa della guerra mitridatica e sulla personalità di Lucullo, v. K.
ECKHARDT, Die armenischen Feldzüge des Lucullus, in “Klio” IX (1909) pp. 400412 e X (1910) pp. 72-115 e 192-231; J.J. VAN OOTEGHEM, Lucius Licinius
Lucullus, Bruxelles 1959.
Sulle rivolte degli schiavi e dei gladiatori, e in particolare sulla figura di
Spartaco, v. G. RATHKE, De Romanorum bellis servilibus capita selecta, Berlin 1904,
144
S.J. KOVALEV - A.A. MOTUS, in “Vestn. Drevn. Istor.’’ II (1956) e III (1957),
J.P. BRISSON, Spartacus, Paris 1959; B. DOER, Spartacus, in “Altertum” VI (1960)
t p 217 sgg.
Sugl’inizi della carriera politica di Pompeo, M. GELZER, Cn. Pompeius
Strabo und der Aufstieg seines Sohnes Magnus, in “Abhandl. Berlin. Akad.”, Philos.Hist Klasse, 1941, ID., Pompeius, München 19492; su Crasso, oltre DRUMANNGROEBE, Geschichte Roms, cit. IV, p. 84 sgg., cfr. A GARZETTI, in “Athenaeum”
XIX,1941, pp.1-37; XX, 1942, pp. 12-40; XXII-XXIII, 1944-5, pp. 1-62.
Sulle imprese di Pompeo in Oriente, P. GROEBE, Zum Seeräuberkriege des
Pompeius Magnus (67 v. Chr.), in “Klio” X, 1910, p. 374 sgg.; G.C. ANDERSON,
Pompey’s campaign against Mithridates, in “Journ. Hell. Stud.’’ XII (1922) p. 99 sgg.;
D. MAGIE, Roman rule in Asia Minor, Princeton 1950, I, p. 351 sgg.; II, p. 1220
sgg.; G. VITUCCI, Gli ordinamenti costitutivi di Pompeo in terra d’Asia, in “Rend.
Acc. Lincei”, ser. VIII, vol. lI, 1947.
Sull’ammontare del bottino e delle nuove entrate procurate al bilancio
statale dalle imprese di Pompeo, notizie particolareggiate e sostanzialmente
attendibili riportano PLIN., Nat. hist. XXXVII 16; PLUT., Pomp. 45, 3; APP.,
Mithr. 116. Dopo aver distribuito al suo esercito, fra ufficiali e soldati, 384
milioni di sesterzi (APP., l.c.: “16 mila talenti”), Pompeo versò una somma
altrettanto ingente nelle casse dello Stato, e, con i tributi imposti in Oriente,
portò le entrate annue da 200 a 340 milioni di sesterzi (PLUT., l.c.).
145
IX
Il declino della repubblica
e la monarchia di Cesare.
1. Le ambizioni di Crasso e gl’inizi di Cesare. - Durante gli
sviluppi sempre più favorevoli della campagna in Oriente, il
corso delle vicende politiche in Roma non poteva
certamente ignorare l’irresistibile ascesa di Pompeo, anzi si
svolse in buona parte nell’aspettativa del suo ritorno. A
quali nuove mète avrebbe egli indirizzato la sua ambizione
e la sua ineguagliabile potenza? Ne erano impensieriti sia la
oligarchia nobiliare, nel timore che potesse verificarsi una
crisi dell’equilibrio costituzionale, sia coloro che di tale
equilibrio non si preoccupavano se non per romperlo a
proprio favore, in primo luogo M. Licinio Crasso.
Sfumata la momentanea convergenza stabilitasi al
tempo delle elezioni consolari per l’anno 70, Crasso aveva
cercato in vario modo di ostacolare le fortune di Pompeo,
e la sua azione si era fatta più scoperta soprattutto durante
l’assenza del rivale. Ebbe per qualche tempo l’appoggio di
C. Giulio Cesare, il giovane patrizio che, ricco di
un’antichissima nobiltà, ma sprovvisto di mezzi necessari a
contendere con gli altri nobili nella gara dei pubblici onori,
si era volto alla parte popolare carezzandola con
atteggiamenti che avevano suscitato l’entusiasmo dei
nostalgici di Mario. Crasso poteva fornire a Cesare il
denaro indispensabile per coltivare il favore delle masse,
Cesare poteva attirare su Crasso quella popolarità che, con
tutte le elargizioni, egli non era in grado di cattivarsi da
solo. Nel 65, mentre Cesare come edìle curule mandava in
146
visibilio il popolino con l’offerta di ludi di grandiosa
magnificenza, Crasso faceva avanzare dai tribuni una
proposta in base alla quale gli veniva conferito l’imperium
con l’incarico di procedere all’annessione dell’Egitto,
lasciato in eredità al popolo romano da Tolomeo XI
Alessandro II (morto nell’80), ma rimasto in possesso di
Tolomeo XII Aulete. Un simile comando in Egitto avrebbe
potuto in qualche modo bilanciare la potenza di Pompeo,
ma la proposta cadde per l’opposizione sia degli ottimati sia
degli equites, fedeli a Pompeo, e allora Crasso puntò sulla
carta di Catilina, sostenendone le sue aspirazioni al
consolato.
Di antica casata patrizia, L. Sergio Catilina aveva
anch’egli a suo tempo approfittato delle proscrizioni
sullane per costituirsi una fortuna ma, al contrario di
Crasso, l’aveva completamente dilapidata, ed ora cercava
con ogni mezzo di rimettersi in sesto. Dopo la pretura,
rivestita nell’anno 68, aveva tenuto per due anni il governo
della provincia d’Africa, ma suscitando con la sua rapacità
tali lamentele che il console presidente dei comizi non lo
ammise come candidato al supplemento di elezioni
consolari che nell’ottobre del 66 si tennero per il 65. Le
precedenti elezioni, in quell’anno 66, si erano svolte
all’insegna della più sfacciata corruzione, tanto che ai due
eletti fu vietato di entrare in carica ed essi vennero sostituiti
dai due competitori che li avevano accusati e che
risultarono poi eletti nelle elezioni supplementari. Per
togliere di mezzo costoro fu imbastita una congiura che, se
anche non ebbe attuazione, mise peraltro in chiara luce le
intenzioni sovversive di Catilina, uno dei suoi principali
artefici. Si disse che dietro a questi torbidi si agitava
l’ombra di Crasso, ma non è certo, mentre è un fatto che
nel 64 egli si diede a sostenere la candidatura di Catilina al
147
consolato dell’anno 63, sperando di farne strumento delle
sue mire.
Ma anche questa volta la sua manovra era destinata al
fallimento. I precedenti lontani e vicini di Catilina erano
tali, che la nobiltà era a ragione impensierita di ciò che
poteva accadere quando egli avesse avuto in mano le leve
della suprema magistratura e allora, in mancanza di meglio,
si decise ad appoggiare la candidatura di un homo novus, di
Cicerone, che sia pure per pochi voti riuscì a battere
Catilina. Deluso nei suoi piani, Crasso cercò di aprirsi un
altro spiraglio facendo avanzare nel 63 dal tribuno P.
Servilio Rullo una proposta di legge per una larghissima
distribuzione di terre in favore dei cittadini non abbienti;
della distribuzione doveva occuparsi un collegio di decemviri
muniti di imperium straordinario per la durata di cinque
anni. Era chiaro che Crasso, a capo di questo decemvirato
e con l’appoggio di Cesare, sarebbe stato in grado non solo
di aspettare tranquillamente il ritorno di Pompeo, ma di
costringerlo a venire a patti quando avesse chiesto terre per
i suoi veterani. Ma la proposta, avversata tra l’altro anche
dal console Cicerone (che nel 65 si era ugualmente battuto
contro la concessione del comando straordinario in Egitto),
non fu nemmeno messa ai voti; e mentre Crasso si
rassegnava ad abbandonare le sue mene, e Cesare si
adoperava con ogni mezzo per mantener vive le sue
simpatie presso il popolo, l’Urbe fu percorsa dal brivido
della congiura catilinaria.
2. La congiura di Catilina e l’effimero trionfo di Cicerone. Nell’estate del 63 Catilina aveva ripresentato la candidatura
al consolato per l’anno appresso con un nebuloso
programma di rivendicazioni economiche giovevoli, più
che ai ceti popolari, a quanti come lui desideravano pescare
nel torbido della politica per rifarsi una fortuna.
148
Vivacemente contrastato da Cicerone, e ancora una volta
battuto alle elezioni, Catilina decise di farsi largo ad ogni
costo e, d’accordo con alcuni nobili della sua risma, ordì le
fila di una cospirazione per impadronirsi del potere
attraverso una serie di azioni terroristiche a cominciare
dall’assassinio di Cicerone. Ma questi teneva gli occhi ben
aperti e, denunciata la congiura in senato, ne ottenne il
decreto che lo autorizzava ad agire per salvare dal pericolo
lo Stato. Non avendo però elementi sicuri per procedere
immediatamente contro Catilina, Cicerone lo attaccò alcuni
giorni dopo in senato con una celebre invettiva (la Prima
catilinaria) e lo costrinse ad allontanarsi da Roma
(novembre 63).
Mentre Catilina raggiungeva a Fiesole le bande
armate che un altro dei cospiratori stava apprestando per
marciare su Roma, rimanevano in città gli altri capi della
congiura; lasciati indisturbati, costoro continuarono
audacemente a tramare e si prepararono a passare
all’azione. Ma le loro mosse erano attentamente controllate
dal console, il quale questa volta raggiunse prove più
concrete e non indugiò ad arrestarli e a farli riconoscere
colpevoli dal senato.
Convocato ancora il senato perché stabilisse sulla
loro sorte (evidentemente, Cicerone voleva sottrarsi
all’odiosità di un provvedimento che certo auspicava e,
come console, avrebbe potuto senz’altro prendere egli
stesso), sulla tesi più benevola e insieme più legalitaria
sostenuta da Cesare, che proponeva di evitare i pericoli di
una deliberazione troppo affrettata ed eccepiva
l’incompetenza dei senatori a giudicare i congiurati,
prevalse quella più intransigente propugnata da Catone. Per
i prigionieri fu la pena di morte, che venne eseguita
immediatamente (dicembre 63); un paio di mesi dopo le
149
bande armate, con Catilina alla testa, venivano sterminate
presso Pistoia.
L’homo novus Cicerone aveva reso un buon servigio
all’oligarchia degli ottimati e ai ricchi cavalieri liberandoli
dalla minaccia di una sovversione economica; ne ebbe
molte lodi e più ancora se ne diede, ma in fondo non era
stato che un episodio di secondaria importanza. Tempi ben
più duri si preparavano per la vita della repubblica, e al
timone sarebbe occorso un polso assai più fermo del suo.
3. Dal ritorno di Pompeo al “primo triumvirato”. - Chiave
di volta della situazione politica fu il ritorno di Pompeo alla
fine del 62, anche se l’evento tanto atteso, e dai potenti
tanto temuto, si svolse in maniera così diversa da quella
immaginata. Sbarcato in Italia, il grande conquistatore che
aveva avuto ai suoi piedi l’Oriente licenziò l’esercito e si
presentò in Roma accompagnato solo da una piccola scorta
per chiedere al senato l’onore del trionfo: tutto secondo le
regole dell’ossequio più stretto alla costituzione nobiliare.
Sembrava quasi incredibile che Pompeo, anzi Pompeo
Magno, venisse a sottoporre disciplinatamente i suoi
desideri, e forse anche per questo si delineò fra i senatori
un atteggiamento di superba freddezza, che li ripagava delle
ansie provate al pensiero di ciò che poteva accadere al suo
ritorno. Alla richiesta di approvare gli atti da lui emanati in
Oriente e di assegnare terre ai veterani essi risposero di no,
e a Pompeo non rimase che pentirsi di aver troppo presto
congedato le legioni, e attendere il momento della rivincita.
Non dovette attendere a lungo. Nell’anno 60 Cesare
aveva posto la candidatura al consolato per il 59 ed era
riuscito eletto grazie a quel favore popolare che mai l’aveva
abbandonato. La consorteria nobiliare, che aveva cercato
invano di contrastargli il passo, corse ai ripari facendogli
assegnare dal senato, come incarico da svolgere nel 58 in
150
qualità di proconsole, quello di governare “le foreste e i
sentieri” (SUET., Iul. 19), un modo anche ingiurioso di
precludergli ogni campo di azione una volta finito il
consolato. Ma Cesare non era uomo da lasciarsi scoraggiare
e, per parare il colpo, si rivolse a Pompeo chiedendogli
l’appoggio della sua influenza e promettendogli in cambio
di fargli ottenere quella ratifica dei suoi atti in Oriente che il
senato gli aveva negato. L’accordo fu suggellato dal
matrimonio fra Pompeo e Giulia, figlia di Cesare, e poco
dopo fu allargato con l’adesione di Crasso, anch’egli in urto
col senato.
Era il “primo triumvirato”, come si suol dire con
termine poco preciso riprendendo la denominazione di
quello posteriore di Lepido, Antonio e Ottaviano, che fu
invece un potere triumvirale legalmente costituito. Forte di
questi appoggi segretamente pattuiti, Cesare pose mano
senza indugio a realizzare un ampio programma. Tra l’altro,
furono ratificati gli atti di Pompeo, fu diminuito (secondo il
desiderio di Crasso e dei cavalieri) il canone per l’appalto
delle imposte che si riscuotevano dalla provincia d’Asia, fu
autorizzata la distribuzione di terre ai proletari e ai veterani
di Pompeo. Di poi, con una legge proposta dal tribuno P.
Vatinio, Cesare ottenne per un quinquennio un imperium
proconsolare: era proprio quello che più gli stava a cuore
per evitare di trovarsi ridotto all’inazione al termine del
consolato.
Inoltre, per esser più sicuro di lasciarsi alle spalle una
situazione favorevole quando avrebbe dovuto partire da
Roma, si preoccupò di allontanare dal senato i principali
esponenti dei conservatori, Cicerone e Catone. A questo
scopo si avvalse dell’opera di P. Clodio, un mestatore
ambizioso e violento che s’era messo al servizio dei
triumviri e odiava mortalmente Cicerone. Eletto tribuno
per l’anno 58, Clodio fece passare una legge che
151
comminava l’esilio a chi avesse messo a morte cittadini
romani senza che fossero stati condannati in un regolare
processo. Era chiaro il riferimento a colui che, come
console, aveva provocato l’esecuzione sommaria dei
congiurati catilinari, e Cicerone dovette rassegnarsi a partire
da Roma. Qualche mese prima Catone era stato invece
allontanato con l’incarico (fattogli conferire ancora da
Clodio) di provvedere all’annessione dell’isola di Cipro, che
era in potere di un fratello di Tolemeo Aulete.
Così per opera di Cesare l’autorità del senato, e
quindi il predominio dell’oligarchia, aveva subìto un colpo
irreparabile, ed egli poteva intraprendere quell’instancabile
e multiforme attività destinata a farne una delle più grandi
personalità di ogni tempo.
4. Le prime campagne di Cesare nelle Gallie. - Il campo
d’azione che Cesare si era fatto assegnare con la legge
Vatinia per esercitare l’imperium proconsolare era l’Illirico e
la Gallia Cisalpina (cioè l’Italia a nord della linea ArnoRubicone). Questo, dunque, era l’ambito entro il quale
sperava di compiere qualche fortunata impresa militare per
accrescere il suo prestigio personale. L’accordo con
Pompeo e Crasso, che gli aveva consentito di spiccare il
volo, poteva venir meno da un momento all’altro, ed era
urgente costituirsi una posizione di forza per affrontare
con la maggiore libertà di movimenti i futuri sviluppi della
lotta politica. In un primo tempo fu l’Illirico ad attirare la
sua attenzione: una campagna vittoriosa che avesse esteso
la signoria di Roma nelle regioni danubiane sarebbe stata
impresa tale da assicurargli la desiderata base di potenza.
Poi, avendo per decreto del senato ottenuto in aggiunta a
quelli della legge Vatinia anche il proconsolato della
Narbonese, il suo interesse si spostò verso la Gallia, dove
152
movimenti migratori e conflitti tra Celti e Germani
avevano prodotto uno stato di pericolosa tensione.
Scegliendo la via della Gallia e dando inizio a
un’azione che nel corso di otto anni condusse a inserire
stabilmente e attivamente quel paese nell’orbita della civiltà
romana, Cesare si acquistava dinanzi alla storia uno dei più
grandi titoli di merito. L’impresa, di per sé ardua, fu resa
ancor più difficile dalla necessità di seguire attentamente
l’evolversi dalla situazione politica in Roma. Infatti questa a
un certo momento si complicò al punto da mettere in
pericolo il buon esito di tanti sforzi, ma Cesare riuscì a
rattopparla quanto bastava a consentirgli di proseguire nella
sua azione, poi, quando la crisi scoppiò insanabile, la
conquista della Gallia era compiuta ed egli ormai pronto al
duello finale.
Nella primavera del 58, all’arrivo di Cesare, la
provincia Narbonese era minacciata d’invasione da parte
degli Elvezi, che si stavano spostando verso occidente alla
ricerca di nuove terre. Dopo averli battuti e costretti a
rientrare in gran parte nelle loro sedi, Cesare si rivolse
contro Ariovisto, il re della gente germanica degli Svevi,
che da oltre dieci anni si era insediato in Gallia angariando
le popolazioni celtiche dei Sequani e degli Edui. Anche
questa campagna si concluse rapidamente nello stesso anno
58: fallito un tentativo di accordo, Ariovisto fu sconfitto e
obbligato a ripassare il Reno, e con questo Cesare si
assicurava il favore e l’alleanza degli abitanti della Gallia
centrale. La sua azione destava però l’ostilità delle bellicose
tribù belgiche, stanziate nelle regioni settentrionali della
Gallia, e poi quella degli Aremòrici, siti nella Gallia nordoccidentale; le une e gli altri furono debellati con le
campagne del 57 e del 56. Il bilancio di questo primo ciclo
di operazioni era certamente positivo, ma parlare di
un’avvenuta conquista della Gallia era almeno prematuro;
153
se Cesare scrisse a Roma di prepararsi all’annessione della
nuova provincia, dovette farlo per rafforzare la sua
posizione di fronte alla crisi politica che si era determinata.
5. Torbidi in Roma. Rinnovamento dell’intesa fra i
“triumviri”. - Dopo la partenza di Cesare, in Roma si era
sviluppato un movimento favorevole al richiamo di
Cicerone dall’esilio. Lo stesso Pompeo l’appoggiava, ma
l’avversava il tribuno Clodio, sempre animato da un odio
inestinguibile verso l’oratore. Il facinoroso mestatore, anzi,
alla testa delle sue bande armate mise Roma a soqquadro
con una serie di atti terroristici, ma Pompeo ne rintuzzò la
violenza contrapponendogli un’altra banda assoldata dal
fido T. Annio Milone, tribuno della plebe per il 57. In
questo clima di sanguinosi disordini fu approvato per legge
il ritorno di Cicerone, il quale si rituffò ben presto nella
politica raccomandando al senato il conferimento a
Pompeo di un imperium proconsolare per cinque anni, con
l’incarico di curare l’approvvigionamento dell’Urbe, afflitta
da una grave carestia.
Pompeo, che aspirava piuttosto a un comando che gli
permettesse di emulare le imprese di Cesare e vedeva ora
aprirsi la via di un’intesa con il senato, chiese l’incarico di
rimettere sul trono di Egitto Tolemeo Aulete, che da poco
era stato spodestato da lotte di palazzo, ma il senato disse
di no, a lui come a Crasso, che aveva avanzato la stessa
richiesta. Dunque, i “triumviri” cominciavano ad essere in
contrasto e il senato ne approfittava per alzare la testa:
troppo grave era la situazione che si delineava perché
Cesare non si affrettasse ad abbandonare per un momento
le sue legioni e a combinare un incontro con Pompeo e
Crasso per rinsaldare i vincoli della vecchia collaborazione.
Il convegno ebbe luogo a Lucca nel 56 e, grazie
all’abilità di Cesare, fu ristabilita la concordia con l’intesa di
154
riportare al consolato per l’anno 55 la coppia PompeoCrasso; debellata in tal modo l’opposizione nobiliare, i tre
si sarebbero divise le parti assicurandosi ciascuno un
comando straordinario. Nonostante i tentativi di resistenza
della nobiltà, che provocò un susseguirsi di tumultuose
agitazioni, il responso delle urne fu favorevole a Pompeo e
Crasso, i quali posero subito mano a realizzare gli accordi
dell’anno prima. Su proposta del tribuno C. Trebonio fu
conferito a Crasso un comando quinquennale sulla Siria per
agire contro i Parti, a Pompeo un comando quinquennale
nelle due Spagne; quindi i due consoli in persona fecero
approvare una legge che prolungava per cinque anni (fino
al 50) i poteri proconsolari di Cesare.
Pure in sua assenza, il piano di Cesare era pienamente
riuscito, ed egli poté concentrarsi nella impresa gallica
mentre Crasso, alla fine del 55, partiva per la sua
spedizione in Oriente; Pompeo, che al termine del
consolato aveva preferito non allontanarsi troppo da
Roma, si dedicava personalmente all’incarico degli
approvvigionamenti annonari, lasciando governare le
Spagne da suoi fiduciari.
6. Conquista e romanizzazione delle Gallie. - Nel 56
Cesare aveva progettato di compiere l’anno appresso una
spedizione in Britannia per troncare le relazioni tra quei
popoli e le vicine tribù d’Oltremanica, che ne ricevevano
incitamenti e aiuti per scuotere il giogo romano.
Sopravvenne però l’invasione della Gallia settentrionale da
parte dei germani Usìpeti e Tèncteri, e il proconsole dové
impegnarsi con tutte le forze per respingerli al di là del
Reno. Passato anch’egli il fiume, ma solo per una breve
azione dimostrativa in terra germanica, al ritorno prese il
mare con due legioni e sbarcò in Britannia nei pressi di
Dover (agosto 55). Ma l’autunno era alle porte, la flotta
155
aveva subìto danni dalle tempeste, e dopo poche settimane
a Cesare non rimase che ripassare il Canale col proposito di
rinnovare l’impresa al ritorno della buona stagione. Nel
giugno del 54 sbarcò nuovamente nell’isola con cinque
legioni e riuscì ad addentrarsi nel paese battendo le forze
del re Cassivellauno e occupandone la capitale al di là del
Tamigi. Ma non era nemmeno da pensare ad una conquista
duratura. Per questa sarebbe stato necessario permanere a
lungo nell’isola e disporre di basi sicure nella Gallia
settentrionale; quivi invece proprio allora cominciava a
divampare l’incendio della rivolta antiromana. Cesare
s’affrettò a reimbarcare le legioni per ricondurle nel
continente, ad intraprendere immediatamente la lotta
soprattutto contro gli Eburoni e i Treviri, che furono
battuti nel 53.
Assai più grave fu la sollevazione capeggiata l’anno
dopo da Vercingetorige, giovane principe degli Arverni,
intorno al quale si raccolsero da ogni parte tutte quelle
forze che aspiravano a scuotere il dominio o l’ingerenza
romana. Cesare, che era venuto a svernare nella Cisalpina
per seguire più da vicino gli sviluppi della politica in Roma,
dovette affrettarsi a ripassare in pieno inverno le Alpi e,
ricongiuntosi col grosso delle truppe, mosse alla volta di
Gergovia, la capitale degli Arverni, alla ricerca delle forze di
Vercingetorige. In un primo scontro questi ebbe la meglio,
ma in una successiva battaglia presso Alesia fu gravemente
battuto e costretto a rinchiudersi nella città. Mentre
stringeva Alesia entro la morsa di un vallo trincerato,
Cesare dovette fronteggiare le ingenti forze che
accorrevano in aiuto degli assediati e, invece di sloggiare,
cinse il suo schieramento di un’altra linea fortificata al
riparo della quale rimase insieme assediatore e assediato.
Falliti numerosi assalti, le forze celtiche desistettero dai
loro tentativi e si sbandarono abbandonando al suo destino
156
Vercingetorige, che poco dopo (settembre del 52) fu
costretto ad arrendersi per fame.
Privi di un capo di riconosciuta autorità, i Galli non
erano più in grado di sviluppare un’azione efficace; seppure
fu necessario ancora un anno di guerra per spegnere gli
ultimi focolai di resistenza, l’impresa poteva considerarsi
felicemente compiuta, e la Gallia, grazie anche alle miti
condizioni di pace, s’avviò a un rapido processo di
romanizzazione.
7. Fine di Crasso e inizio della lotta fra Cesare e Pompeo. Nel frattempo, con la scomparsa di Crasso e il graduale
passaggio di Pompeo sulle posizioni del senato,
dell’equilibrio raggiunto con gli accordi di Lucca non
restava più traccia, e la situazione politica precipitava a
grandi passi verso la rottura.
Crasso era partito per la Siria con la speranza che il
suo intervento nella contesa dinastica allora in atto nel
regno dei Parti si traducesse in una brillante campagna,
capace di dare anche a lui quella gloria militare di cui
godevano Pompeo e Cesare. Ma la spedizione si risolse nel
più completo disastro e, nell’estate del 53, disfatto presso
Carre, egli perdette la vita insieme con la maggior parte dei
suoi uomini.
Quanto a Pompeo, sulle prime egli si tenne in
disparte dai contrasti delle fazioni lasciando che Roma
cadesse sempre più in preda dei disordini causati dalle
opposte bande di Clodio e Milone. Quando le violenze
culminarono nell’uccisione di Clodio, lui solo era in grado
di mettere fine al caos con le forze di cui disponeva, e tale
fu appunto la richiesta che il senato si vide costretto a
rivolgergli.
Accettandola, Pompeo diventava lo strumento della
politica nobiliare di opposizione alle forze democratiche,
157
ma nello stesso tempo il senato doveva rassegnarsi a
subire la prepotente ambizione di Pompeo che, eletto consul
sine collega per il 52 in spregio alle norme costituzionali,
accumulava nelle sue mani una somma di poteri senza
precedenti. Così, mentre le ultime speranze dei popolari si
rifugiavano nel ritorno di Cesare, Pompeo e il senato
concentravano i loro sforzi per spogliare Cesare di ogni
potere alla scadenza ormai prossima del suo proconsolato.
Esisteva una legge fatta votare da tutti e dieci i tribuni
dell’anno 52 che, concedendo a Cesare di presentare la sua
candidatura al consolato pur essendo lontano da Roma a
capo del suo esercito, gli avrebbe dato la possibilità di
assumere i poteri di console appena scaduti quelli di
proconsole; Pompeo ne fece votare un’altra secondo la
quale le candidature dovevano esser poste in Roma di
persona. Inoltre, nella eventualità che Cesare riuscisse
comunque a conseguire l’elezione al secondo consolato,
Pompeo si adoperò per impedire che egli potesse poi
ottenere subito dopo un nuovo comando proconsolare, e
fece passare una legge in base alla quale i consoli potevano
esercitare un comando proconsolare solo cinque anni dopo
aver rivestito il consolato. Nello stesso tempo, il senato
prorogava per altri cinque anni, cioè fino al 47, l’imperium di
Pompeo. Contro quest’azione metodica, nulla avevano
potuto i filocesariani di Roma, e quando arrivò l’anno
cruciale, il 50, tutto faceva prevedere la fine della potenza
di Cesare, ritornato privato cittadino e ridotto alla mercé
dei suoi potenti avversari.
Ma nella lotta politica Cesare era stratega valente non
meno che sui campi di battaglia. Seppe abilmente attirarsi
dalla sua uno dei tribuni, C. Scribonio Curione, già suo
fiero nemico, dal quale fece avanzare una proposta
equilibrata e ineccepibile: per uscire dalla crisi dovevano
essere aboliti i comandi straordinari, quello di Cesare,
158
dunque, ma anche quello di Pompeo. Essendo nota
l’avversione di Curione per Cesare, era naturale che di tale
proposta sfuggisse sulle prime il lato favorevole a Cesare;
comunque essa fu caldeggiata da tutti quelli (ed erano la
maggioranza) che desideravano scongiurare il pericolo di
una guerra civile, e sulle prime il senato si pronunciò a
larghissima maggioranza nel senso che i due proconsoli
dovessero deporre i loro comandi. Ma subito dopo,
diffusasi forse ad arte la notizia che Cesare marciava su
Roma, prese il sopravvento la fazione anticesariana più
intransigente e fu preclusa la via ad ogni soluzione di
compromesso.
Verso la fine di dicembre, stando ancora a Ravenna,
Cesare inviò al senato una lettera nella quale si dichiarava
disposto a deporre il comando se anche Pompeo lo avesse
fatto, altrimenti avrebbe saputo provvedere a sé e alla
repubblica. Questa espressione minacciosa ebbe l’effetto
che il senato s’irrigidì nella richiesta che Cesare fosse
privato del suo imperium, e avendo i tribuni M. Antonio e
Q. Cassio Longino tentato di intervenire con il loro veto,
non solo ne furono impediti con la violenza, ma si
proclamò lo stato di emergenza. Incaricati i consoli di
prendere gli opportuni provvedimenti, il giorno dopo si
conferivano a Pompeo i più larghi poteri mentre Cesare,
appresa la decisione degli avversari, non esitava ad entrare
in azione e “gettava il dado” passando il Rubicone ed
entrando in armi nel territorio della repubblica (gennaio
49).
Era il primo atto di una guerra in cui culminava
l’annoso contrasto fra le forze democratiche e quelle del
conservatorismo manovrate dall’oligarchia senatoria, e
questa
considerazione
attenua
grandemente
le
responsabilità di Cesare. La lotta da lui scatenata era infatti
destinata a concludersi col definitivo superamento di un
159
regime che aveva dato buona prova nel governo di uno
Stato-città, ma era inadatto, anzi contrario, ad allargare le
sue basi di pari passo con l’espansione territoriale,
chiamando alla collaborazione anche le fresche energie
della borghesia municipale e provinciale. E se, alla fine, dal
dominio di un’oligarchia la repubblica cadde nel dominio di
uno solo, ed ebbe inizio la lunga serie dei Cesari, ciò non fu
solo per sua colpa. Lo affermarono gli storici romani
(generalmente di tendenze conservatrici) nel nostalgico
rimpianto della libertà repubblicana, ma della fine di questa
libertà erano anche responsabili coloro che l’avevano
voluta mantenere un privilegio di pochi.
8. Dal Rubicone alla morte di Pompeo. - La mossa di
Cesare colse di sorpresa il senato e soprattutto Pompeo,
sulle cui spalle gravava il compito di difendere le istituzioni.
Nella previsione, forse, che Cesare non avrebbe osato
passare così presto all’azione, Pompeo non aveva
richiamato nessuna delle legioni di Spagna, che erano tutte
ai suoi ordini, né aveva fatto preparativi di sorta. Pertanto
da contrapporre alla legione con cui Cesare era partito da
Ravenna non si trovavano in Italia che due legioni
accampate a Capua, ma queste fino all’anno prima avevano
militato in Gallia, e non v’era da illudersi che si sarebbero
impegnate contro il loro antico comandante. In queste
condizioni, mentre Cesare con marcia travolgente scendeva
attraverso l’Italia centrale, a Pompeo non rimaneva che
decidere, assai opportunamente, di sgombrare da Roma e
poi dall’Italia. A Brindisi ebbero rapidamente inizio le
operazioni d’imbarco dei maggiorenti anticesariani, con alla
testa i consoli, e per quanto Cesare s’affrettasse a marce
forzate non riuscì a impedire, anche per mancanza di una
flotta, la felice conclusione della ritirata strategica di
Pompeo.
160
Questi aveva stabilito di raggiungere i paesi grecoorientali, ancora risonanti delle sue gesta vittoriose, ove
sarebbe stato agevole raccogliere in gran copia gli uomini e
i denari necessari per organizzare la riscossa attraverso
un’azione combinata con le legioni di Spagna. A Cesare,
però, era rimasta l’Italia con la possibilità di arruolarvi
esperti ufficiali e soldati di ben altra capacità, senza dire
delle legioni che già erano affluite dalla Gallia, ed egli
riprese subito l’offensiva rivolgendosi contro le forze
pompeiane in Spagna. Naturalmente, si fermò prima alcuni
giorni a Roma per assicurarsi il controllo della situazione, e
fra le prime cose si fece autorizzare dal senato (composto
di quei pochi che non avevano seguito Pompeo) ad
attingere largamente dal pubblico tesoro.
Ben nove erano le legioni di stanza in Spagna agli
ordini di Pompeo, e non fu facile piegare la resistenza di
quelle truppe agguerrite. La campagna si complicò anche
perché Cesare volle assicurarsi le spalle occupando
Marsiglia, che da un momento all’altro poteva trasformarsi
in una base nemica, e poiché i Massalioti erano decisi a
mantenersi neutrali fu necessario un assedio di alcuni mesi
per espugnarla.
Disciolte le forze pompeiane in Spagna, Cesare
rientrò a Roma alla fine di quell’anno 49 e rivestì la
dittatura che il pretore M. Emilio Lepido, uno dei suoi
principali fautori, gli aveva fatto conferire quando si
trovava ancora a Marsiglia. Con tali poteri in appena undici
giorni realizzò un notevole programma di distensione
(richiamo di esiliati politici, alleviamento di debiti),
convocò i comizi che lo elessero console per il successivo
anno 48 e, dopo aver abdicato dalla dittatura, raggiunse a
Brindisi l’esercito che si preparava ad imbarcarsi per
l’Oriente.
161
Pompeo aveva posto il quartier generale a
Tessalonica (Salonicco) e s’era dato a concentrare ingenti
forze, anche di mare, che tenevano sotto controllo le acque
dell’Adriatico. Piuttosto modesta era la flotta che Cesare
aveva racimolato e la stagione non adatta alla navigazione,
ma di questi elementi a sfavore egli seppe trarre profitto
per un ardito colpo, e ai primi di gennaio del 48 riuscì a
sbarcare inosservato con sette legioni presso Orico
(Paleocastro, in Albania). Occupata la vicina Apollonia,
mosse contro Dirrachio (Durazzo), ma Pompeo, avvertito
tempestivamente, si affrettò ad accorrere e a presidiare la
città accampandosi nelle vicinanze. A questo punto la
posizione di Cesare cominciò a divenire ogni giorno più
difficile: circa una metà dell’esercito era rimasta sull’altra
sponda dell’Adriatico incapace di violare il blocco, le
vettovaglie scarseggiavano, e fu fortuna che Pompeo si
mantenesse sulla difensiva, sicuro com’era di aver ragione
dell’avversario senza bisogno di affrontarlo. In primavera
arrivarono i sospirati rifornimenti e rinforzi; anche le altre
legioni erano riuscite a passare il mare, e Cesare tentò di
portare un attacco a fondo alle posizioni nemiche ma fu
duramente respinto. Allora si ritirò in direzione della
Tessaglia per ristorare l’esercito, seguito da Pompeo che
continuava a lasciargli l’iniziativa limitandosi a controllarne
le mosse.
Ma questa condotta passiva creò un grande
nervosismo fra i pompeiani che alla fine imposero al loro
duce di non sottrarsi ulteriormente a una prova decisiva.
Lo scontro avvenne nell’agosto a Farsàlo, e l’ardore dei
legionari cesariani ebbe la meglio sulle schiere
contrapposte, più numerose ma meno affiatate. Delineatasi
la disfatta, Pompeo abbandonò il campo e con una piccola
scorta raggiunse Mitilene donde salpò per l’Egitto. Quivi
sperava di trovar riparo presso Tolemeo XIII, figlio del suo
162
protetto Tolemeo Aulete, ma i ministri del re giudicarono
ugualmente pericoloso sia l’accoglierlo, nel timore di
compromettersi con Cesare, sia il respingerlo, nel timore
che si rivolgesse a Cleopatra, la sorella e rivale di Tolemeo,
e appena Pompeo fu sbarcato a Pelusio lo fecero
assassinare.
9. Il potere monarchico di Cesare e le idi di Marzo. - Una
fine così imprevedibile del grande duello con Pompeo
giovava certamente a Cesare, che vedeva di colpo sparire
l’unica personalità capace di cementare la coalizione
avversaria, ma più ancora giovò a Roma per emergere più
presto dal flagello della lotta fratricida, anche se gli
strascichi della guerra furono ancora più sanguinosi.
Arrivato ad Alessandria poco dopo la morte di
Pompeo, Cesare s’intromise nella contesa dinastica tra
Tolemeo e Cleopatra risolvendola a favore di quest’ultima,
di cui s’era invaghito. I partigiani di Tolemeo provocarono
però un’insurrezione popolare che lo ridusse a mal partito,
costringendolo ad asserragliarsi con i suoi uomini nella
reggia, e solo parecchio tempo dopo, ricevuti i rinforzi,
poté imporre il rispetto della sua volontà.
Anche troppi erano stati i nove mesi di permanenza
in Egitto, e ora Cesare dové accorrere in Asia Minore ove
Farnace del Ponto, figlio di Mitridate, stava rinnovando le
clamorose gesta del padre mettendo in pericolo con le sue
conquiste i domini romani. Fu una campagna-lampo, e
dopo la vittoria di Zela (nel Ponto, agosto del 47) Cesare
ne diede notizia al senato col celebre veni, vidi, vici.
Era tempo, ormai, di rientrare in Roma, ove la sua
presenza era richiesta per ristabilire l’ordine turbato dalle
mene di alcuni demagoghi. Occorreva anche restaurare la
disciplina fra le truppe che M. Antonio stava radunando in
Campania per la prossima spedizione contro i pompeiani
163
d’Africa, e anche questo riuscì facile al grande prestigio di
Cesare, sicché alla fine dell’anno 47, cessata la seconda
dittatura ed eletto console per la terza volta, poté
imbarcarsi da Lilibeo.
In Africa la fazione senatoria e gli anticesariani in
genere, grazie anche all’appoggio di Giuba, re della
Mauretania, avevano raccolto forze notevoli con alla testa
uomini di gran nome come Q. Cecilio Metello Scipione e
M. Porcio Catone, ma ad esse difettava l’unità di comando.
Cesare le disfece con la vittoria di Tapso (aprile 46); non
molti scamparono rifugiandosi in Spagna, i più perirono e
fra questi Catone, che per non cadere nelle mani del
vincitore si tolse la vita a Utica (Catone Uticense) e fu poi
esaltato nei secoli come martire della libertà e contrapposto
a Cesare “tiranno”. La contrapposizione vera, però, era
ancora una volta in seno alla stessa nobilitas fra la tendenza
ciecamente conservatrice e quella innovatrice, fra un
vecchio e un nuovo ideale politico, cui il pensiero greco
offriva l’etichetta rispettivamente della “fermezza”
(teorizzata dagli stoici) e quella della “magnanimità”
(teorizzata dai peripatetici).
La rigida intransigenza di Catone non va immune dal
sospetto che, attraverso la preservazione dell’austera
disciplina tradizionale, mirasse a perpetuare i privilegi di
un’esigua minoranza; la generosità di Cesare, pur se
esagerata come motivo propagandistico, non ignorava i
bisogni e le speranze di strati più larghi, per i quali la libertà
strenuamente propugnata da Catone era poco più che una
vana parola.
Costituita la provincia di Africa nova col regno tolto a
Giuba e tornato a Roma, Cesare celebrò successivamente
quattro splendidi trionfi (sui Galli, sull’Egitto, sul Ponto,
sull’Africa) che superarono in magnificenza quelli celebrati
a suo tempo da Pompeo. Restavano però ancora in piedi
164
gli ultimi residui dell’opposizione, che al comando dei due
figli di Pompeo, Sesto e Gneo, si erano concentrati in
Spagna assicurandosi anche la collaborazione degli indomiti
Lusitani e Celtiberi. Cesare li debellò nella primavera del 45
con la vittoria di Munda (nell’od. provincia di Cordova),
riportata dopo un’aspra battaglia che per poco non lo vide
cadere prigioniero mentre, come al solito, partecipava
personalmente all’azione.
Celebrato un quinto trionfo, egli ebbe agio di
sviluppare il piano di riforme che già in precedenza, e
specialmente l’anno prima, aveva incominciato ad attuare.
Si trattava anzi tutto, dopo il crollo del sistema oligarchico,
di dare un nuovo assetto allo Stato migliorando le
condizioni dei ceti inferiori, in Roma e in Italia, ma anche
dei provinciali duramente soggetti all’arbitrio dei
governatori. Un riordinamento così radicale poteva essere
attuato soltanto disponendo di un potere assoluto capace
di trionfare dell’immancabile reazione conservatrice, e
quindi la crisi costituzionale non poteva sboccare che nella
monarchia di Cesare.
La configurazione e il nome di questo potere
personale, sia che Cesare aspirasse a un monarcato
teocratico di tipo ellenistico (come vogliono alcuni), sia che
volesse risuscitare la vetusta monarchia romana (come
vogliono altri), era problema più formale che sostanziale,
anche se nell’infuocato tramonto della repubblica l’idea che
in Roma tornasse a dominare un rex, accortamente sfruttata
dagli oppositori, era tale da destare la più profonda
emozione. Ma Cesare seppe guardarsi dalla tentazione del
titolo regale, tanto pomposo quanto inutile per chi, come
lui, dal favore popolare e da un senato prono all’ossequio
aveva ripetutamente ottenuto non solo poteri e privilegi
eccezionali (consolati per cinque e dieci anni, nomina a
dittatore perpetuo, conferimento della cura morum e del
165
titolo di imperator a vita), ma anche onori divini come
Iuppiter Iulius. Inoltre si era consolidata la pretesa che in
Giulo (figlio di Enea e nipote di Venere) avessero il loro
divino capostipite i Giulii, i quali in tal modo restavano
inseriti nella leggendaria origine troiana di Roma.
Forte di questa assoluta preminenza, che gli consentì
di mostrarsi assai generoso verso gli avversari (e anche la
sua Clementia fu deificata), Cesare accentrò nelle sue mani il
controllo delle magistrature e dei governi provinciali, ed
emanò una serie numerosa di provvedimenti intesi a
mettere nuovo ordine in ogni campo della vita pubblica e
privata, compresa la riforma del calendario che da lui ebbe
quella sistemazione che ancor oggi conserva, salvo il
piccolo ritocco apportato nel 1582 dal papa Gregorio XIII.
Fra le misure di carattere sociale a favore del proletariato e
dei veterani va ricordato il vasto programma di
colonizzazione, destinato anche a dare impulso allo
sviluppo della romanità al pari dell’ammissione in senato di
elementi provinciali e della concessione della cittadinanza
romana alla Transpadana, onde l’unità d’Italia, dalle Alpi
allo stretto di Messina, fu realizzata per la prima volta da
Cesare.
Si compiva così un altro grande passo verso la
creazione di uno Stato universale, che secondo i progetti di
Cesare doveva allargare i suoi confini in Oriente fino a
comprendere l’impero dei Parti. La conquista partica
sarebbe stato il coronamento della sua opera di fondatore
dell’impero romano, ma alle idi di Marzo del 44, pochi
giorni prima della partenza per l’impresa, egli cadeva sotto i
colpi di Bruto, di Cassio e di quanti altri speravano di
risuscitare, col suo assassinio, l’antica libertas repubblicana.
166
Sulla figura e l’opera di Cesare (fonti principali i suoi stessi scritti e,
accanto a quelli di Cicerone, Sallustio bell. Catilin., la Vita plutarchea, quella di
Suetonio, Appiano Bell. civ. e, della sezione superstite della Storia romana di
Cassio Dione, i libri dal XXXVI al XLIV per i fatti dal 69 al 44 a.C.) v. in
generale A. FERRABINO, Cesare, Torino 1941; M. GELZER, Caesar, der Politiker
und Staatsmann, 6a ed., Wiesbaden 1960. In particolare, sugl’inizi della sua
carriera politica, E. STRASSBURGER, Caesars Eintritt in die Geschichte, München
1938; O. SEEL, Zur Kritik der Quellen über Caesars Frühzeit, in “Klio” XXXIV
(1941) p. 196 sgg. Un quadro panoramico dei contrapposti schieramenti politici
dell’epoca in L. ROSS TAYLOR, Party Politics in the Age of Caesar, Berkeley - Los
Angeles, 1949.
Dell’opera di Cicerone come politico (fonti principali i suoi stessi
scritti, in primo luogo l’epistolario; poi, oltre la Vita di Plutarco, Sallustio,
Appiano e Cassio Dione, loc. cit.; di Livio ci è stata conservata la pagina del lib.
CXX con la descrizione della morte) la storiografia moderna ha dato varie
ricostruzioni e giudizi parecchio contrastanti: da quelli fortemente negativi
(così, dopo il MOMMSEN, Storia di Roma antica, trad. ital., Firenze 1960, p. 1274
sgg., J. CARCOPINO, Les secrets de la correspondance de Cicéron, I-II, Paris 1947; ma
v. A. PIGANIOL, in “Rev. Hist.” CCI, 1949, p. 224 sgg.) a quelli di tendenza
quasi panegiristica (v., p. es., E. CIACERI, Cicerone e i suoi tempi, Roma 1927-29).
Sull’inserirsi dell’Arpinate nel gioco delle principali correnti che si scontravano
sulla scena politica di Roma, v. J. KLASS, Cicero und Caesar. Ein Beitrag zur
Aufhellung ihrer gegenseitigen Beziehungen, Berlin 1939.
Sulle mene di Catilina, con riguardo specialmente alla loro reale portata
(fonti principali le Catilinarie di Cicerone e il bellum Catilinae di Sallustio), v. L.
PARETI, La congiura di Catilina, Catania 1935; R. SEAGER, The first Catilinarian
conspiracy, in “Historia” XIX (1964) p. 338 sgg.; da vedere anche CHR. MEIER,
Pompeius Rückkehr aus dem Mithridatischen Kriege und die Catilinarische Verschwörung,
in “Athenaeum” N. S. XI, (1962) p. 103 sgg.; Q. YAVETZ, The failure of Catiline’s
conspiracy, in “Historia” XII (1963) p. 485 sgg.
Sull’azione politica svolta da Cesare nell’anno del suo primo consolato
e sul maturare della situazione che sboccò negli accordi del cosiddetto primo
triumvirato, v. CHR. MEIER, Zur Chronologie und Politik in Caesars erstem Konsulat
in “Historia” X (1961) p. 68 sgg.; H. A. SANDERS, The so-called first trumvirate, in
“Mem. Amer. Acad. Rome” X (1932) p. 55 sgg.; R. HANSLIK, Cicero und das erste
Triumvirat, in “Rhein. Mus.” XCVIII (1955) p. 324 sgg.
Su Clodio: L. GURLITT, Lex Clodia de exilio Ciceronis, in “Philologus”
LIX (1900) p. 578 sgg.; F. B. MARSH, The policy of Clodius from 58 to 56 B.C., in
“Class. Quart.” XXII (1927) p. 30 sgg.
Sul proconsolato gallico di Cesare, e in particolare sulle operazioni di
guerra per l’assoggettamento della Gallia, è più che mai pregiudiziale il
problema critico dell’attendibilità della nostra principale fonte d’informazione,
rappresentata dai Commentarii de bello Gallico dello stesso Cesare. L’elemento
propagandistico è certamente presente nell’opera (cfr. p. es., C. E. STEVENS,
The Bellum Gallicum as a work of propaganda, in “Latomus” XI 1952), ma troppo
167
negative appaiono su questo punto posizioni come quelle di L. RAMBAUD,
L’art de la deformation historique dans les Commentaires de César, Paris 1953; cfr. S.
MAZZARINO, Il pensiero storico cit., II, 1 p. 196. Sullo svolgimento delle
successive campagne, oltre a C. JULLIAN, Histoire de la Gaule, vol. II, e a G.
VEITH, Geschichte der Feldzüge C. Julius Caesars, Wien 1906, v. E. KÖSTERMANN,
Caesar und Ariovistus, in “Klio” XXIV (1941) p. l96 sgg.; L. PARETI, Problemi sulla
conquista romana della Belgica, in “Riv. Filol. Class.” N. S. XXI (1943) p. 22 sgg.; J.
LE GALL, Alesia: archéologie et histoire, Paris 1963.
Sulla spedizione partica e la fine di Crasso, A. GUNTHER, Beiträge zur
Geschichte der Kriege zwischen Römer und Parther, Berlin 1922; D. TIMPE, Die
Bedeutung der Schlacht von Carrhae, in “Mus. Helv.” XIX (1962) p. 113 sgg.
Sull’acuirsi della lotta per il primato fra Pompeo e Cesare, e sul
precipitare della situazione sino allo scoppio della guerra civile, v. A.E. BOAK,
The extraordinary commands from 80 to 48 B.C., in “Amer. Hist. Rev.” XXIV
(1918-19), p. 21 sgg.; E. HOHL, Caesar am Rubico, in “Hermes” LXXX (1952) p.
246 sgg. Il passaggio del Rubicone (od. Fiumicino, presso Savignano), che
secondo il calendario ufficiale dell’epoca avvenne intorno al 10 gennaio del 49,
in realtà ebbe luogo nel novembre (astronomico) dell’anno precedente; il
calendario ufficiale era allora in anticipo per la omissione di varie intercalazioni,
e sta di fatto che quando qualche anno dopo (nel 46) Cesare provvide a
regolarlo, dovette inserire circa novanta giorni; cfr. SUETON., Div. Iul. 40: inter
Novembrem ac Decembrem mensem interiecit duos alios, fuitque is annus, quo haec
constituebantur, quindecim mensium cum intercalario, qui ex consuetudine in eum annum
inciderat.
Sulla guerra fra Cesare e Pompeo, oltre gli Antike Schlachtfelder, cit., II, p.
401 sgg., v. K. BARWICK, Caesars Bellum civile. Tendenz, Abfassungszeit und Stil,
Berlin 1951; A. SCHOBER, Zur Topographie von Dyrrachium, in “Jahresh. Oesterr.
Arch. Inst.” XXII (1926) p. 231 sgg.; M. RAMBAUD, Le soleil de Pharsale, in
“Historia” III (1955) p. 346 sgg.
Sull’attività riformatrice di Cesare, E. G. HARDY, Some problems in Roman
history. Ten essays bearing on the administrative and legislative work of Julius Caesar,
Oxford 1924; M. CARY, The municipal legislation of Julius Caesar, in “Journ. Rom.
Stud.” XXVII (1937) p. 48 sgg. Sui particolari aspetti dell’amministrazione
finanziaria, R. KNAPOWSKI, Die Staatsrechnungen der römischen Republik in den
Jahren 49-45, Frankfurt am Main 1967.
Sull’interpretazione del travaglio politico-costituzionale che si concluse
alle Idi di marzo, ED. MEYER, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius, 2a
ed., Stuttgart 1919; A. ALFÖLDI, Studien über Caesars Monarchie, Lund 1953.
Sul confronto tra le personalità di Cesare e di Catone nella famosa
pagina di Sallustio (Bell. Catil. 52, 2-54), cfr. S. MAZZARINO, Il pensiero storico cit.,
II, 1, p. 453 sg.
Sugli onori divini che furono decretati a Cesare ancora in vita, v. fra
l’altro CASS. DIO, XLIV 6, 4: “e infine gli diedero l’appellativo di Iuppiter-Iulius e
decretarono che fosse eretto un tempio a lui e alla sua Clemenza, nominandone
Antonio sacerdote con le attribuzioni di un flamen Dialis”.
168
X
Conclusione delle guerre civili.
Il principato augusteo.
1. Dalla morte di Cesare al triumvirato di Lepido, Ottaviano
e Antonio. - I congiurati, soprattutto per gli scrupoli di
Bruto, si erano limitati ad eliminare il “tiranno” senza
toccare i suoi principali collaboratori: Marco Emilio
Lepido, che rivestiva la carica di magister equitum di Cesare
dittatore, e Marco Antonio, collega nel consolato di Cesare
per l’anno 44. Sicuro dei sentimenti, ancora compressi,
della plebe romana turbata per l’uccisione di colui che tante
volte l’aveva beneficata, e con l’appoggio di Lepido, il
console Antonio seppe condurre un’abile manovra che
sboccò in un accordo con gli anticesariani: si concedeva
l’amnistia ai cesaricidi, ma nello stesso tempo si
convalidavano gli atti del defunto dittatore.
Impadronitosi delle carte e di buona parte dei denari
lasciati da Cesare, Antonio continuò poi a destreggiarsi tra
cesariani e repubblicani con la mira di aumentare la propria
influenza su entrambe le fazioni; ma il suo giuoco fu ben
presto complicato dal sopraggiungere di Gaio Ottavio,
pronipote di Cesare che nel testamento lo aveva adottato
come figlio e designato fra i suoi eredi. Sebbene Cesare
avesse dato molti altri segni della sua stima verso il giovane
(e si proponeva di farne il suo magister equitum nella
spedizione partica) si trattava soltanto di una designazione
ad erede del patrimonio privato, non ad una successione
politica cui era ancora lontano dal pensare. Ma l’ambigua
atmosfera che regnava in Roma per effetto del
169
compromesso fra le due opposte fazioni porse occasione
ad Ottavio di atteggiarsi a difensore della memoria di
Cesare, che egli lamentava offesa e tradita, e il suo dissidio
con Antonio andò sempre più accentuandosi nel tempo
stesso che sfumava l’intesa fra Antonio e i repubblicani. In
tale situazione si delineò una convergenza fra i repubblicani
e Ottavio, che ne approfittò per realizzare il disegno di
soppiantare Antonio a capo dei cesariani. Sebbene privo di
esperienza, il giovane sapeva muoversi con estrema
accortezza negl’intrighi della politica; e quando fu chiaro
che fra breve l’ultima parola sarebbe toccata alle armi, egli
non esitò a crearsi un esercito attirando dalla sua parte con
ingenti donativi due legioni che Antonio aveva richiamato
dalla Macedonia.
Pressato da due parti, Antonio decise di trascurare
per il momento Ottavio e di affrontare il pericolo
rappresentato dall’esercito dei repubblicani che Decimo
Bruto (diverso dal Marco Bruto capo della congiura) aveva
ai suoi ordini come governatore della Cisalpina. Mentre
Antonio assediava Bruto a Modena e, spirato l’anno del
consolato, continuava abusivamente ad esercitare il
comando, Ottavio s’intendeva col senato che ai primi del
43 legalizzò la sua posizione militare conferendogli un
regolare imperium propretorio. I “repubblicani”, con
Cicerone alla testa, potevano rallegrarsi di aver diviso i due
capi dei cesariani, e cioè di aver trovato in Ottavio un
ottimo strumento per combattere Antonio, ma li attendeva
la più amara delusione.
Ottavio dapprima unì le sue forze a quelle che il
senato aveva affidato ai consoli del 43 per accorrere in
aiuto di Decimo Bruto, e collaborò alla disfatta di Antonio
costringendolo a rifugiarsi nella Gallia Narbonese presso
Lepido; di poi, essendo rimasto l’unico comandante
dell’esercito per la caduta in combattimento di entrambi i
170
consoli, ne approfittò per reclamare l’elezione a console e
non si fece scrupolo di schiacciare le resistenze del senato
marciando su Roma. Ottavio non aveva ancora compiuto i
vent’anni quando il 19 agosto del 43 ascese al consolato:
era la violazione più grave che mai avessero subìto le regole
dell’ordinamento costituzionale repubblicano. Munito della
potestà consolare, egli ebbe cura in primo luogo di far
legalmente convalidare la sua adozione (il suo nome
diventò allora ufficialmente quello di Gaio Giulio Cesare
Ottaviano); quindi, alle manovre ostili della fazione
senatoria, rispose da un lato facendo revocare l’amnistia
per i congiurati, dall’altro riavvicinandosi ad Antonio e a
Lepido, con i quali alla fine di ottobre strinse un accordo
destinato a dar origine al “secondo” triumvirato. Infatti,
istituita poco dopo, con una legge fatta votare dal tribuno
Publio Tizio, la magistratura straordinaria dei triumviri rei
publicae constituendae, Lepido, Antonio e Ottaviano furono
rivestiti di imperium consolare per cinque anni (fino al 31
dicembre del 38) e praticamente si impadronivano di tutte
le leve di comando.
2. Rotta degli anticesariani e rivalità fra i triumviri. - I tre si
preoccuparono anzitutto di spazzare l’opposizione
senatoria, e si ritornò al sistema delle proscrizioni, di cui
una delle vittime più illustri fu Cicerone, mortalmente
odiato da Antonio per i violenti attacchi che gli aveva
sferrato con le “Filippiche”. Restavano però ancora in piedi
le forze che in Oriente si raccoglievano agli ordini di M.
Bruto e di Cassio, e fu deciso che ad affrontarle sarebbero
partiti Antonio e Ottaviano, mentre Lepido sarebbe
rimasto in Roma. Lo scontro decisivo avvenne nell’ottobre
del 42 a Filippi, nella Macedonia, e la vittoria fu merito
esclusivo di Antonio, che sconfisse in due battaglie prima
171
Cassio e poi Bruto (già vincitore di Ottaviano)
costringendoli a darsi la morte.
Dal trionfo finale sui cesaricidi usciva grandemente
rafforzata la posizione di Antonio, che ora avrebbe potuto
anche mettere in disparte Ottaviano, ma non lo fece, forse
per dedicare tutte le energie al piano di conquista in
Oriente che aveva in animo di intraprendere come fedele
continuatore dell’opera di Cesare. Infatti egli si riservò il
comando su tutte le province orientali oltre che sulle Gallie
e parte dell’Africa; ad Ottaviano rimasero il resto
dell’Africa, la Spagna, la Sicilia, la Sardegna e la Corsica,
mentre Lepido veniva escluso da questa ripartizione con
l’accusa di essersi accordato con Sesto Pompeo. Era questi
il superstite della battaglia di Munda, cui all’inizio del 43,
per assicurarsene l’appoggio nella guerra contro Antonio, il
senato aveva conferito il comando delle forze navali, e che
in seguito, con una serie di azioni fortunate, si era costituito
un potere personale che lo portò ad impadronirsi della
Sicilia, della Sardegna e della Corsica minacciando la
posizione di Ottaviano.
Tale complessa situazione politica doveva
semplificarsi nel giro di pochi anni. Dopo Filippi, mentre
Antonio si intratteneva in Oriente, Ottaviano era tornato in
Italia con l’incarico di procedere alla distribuzione di terre
ai veterani, compito difficile non solo per l’opposizione
della borghesia conservatrice, a cui quelle terre venivano
confiscate, ma anche per i gravi contrasti suscitati dagli
antoniani con a capo Lucio Antonio (il fratello del
triumviro, che nel 41 era console), e soprattutto da Fulvia,
la facinorosa moglie di Marco Antonio. Contro di questi
Ottaviano combatté nell’inverno dal 41 al 40 il bellum
Perusinum, così denominato dalla città in cui Lucio Antonio
fu stretto d’assedio. Espugnata Perugia, gli avversari di
Ottaviano si rifugiarono parte in Oriente (come Fulvia, che
172
si affrettò a portare le sue lamentele ad Antonio) e parte in
Sicilia presso Sesto Pompeo.
Si profilava l’eventualità di un accordo fra Antonio e
Sesto Pompeo contro Ottaviano, ma questi parò il colpo
avvicinandosi a Pompeo con un matrimonio politico e,
ripudiata la prima moglie Clodia, passò a nuove nozze con
Scribonia, sorella di Lucio Scribonio Libone, suocero di
Sesto Pompeo. Antonio mosse in forze dall’Oriente contro
Ottaviano, ma non riuscì a sbarcare a Brindisi né ad
ottenere alcun successo militare; d’altra parte si trattava di
una lotta che nessuno dei due aveva interesse di spingere a
fondo, sicché poco dopo, per l’intromissione di amici
comuni come Mecenate e Asinio Pollione, si venne ad
un’intesa sancita nel trattato di Brindisi (ottobre 40). A
suggellare l’accordo (in forza del quale ad Antonio veniva
assegnato l’Oriente, ad Ottaviano l’Occidente, esclusa
l’Africa riservata a Lepido) Antonio, rimasto vedovo di
Fulvia, sposava Ottavia, la sorella di Ottaviano.
L’equilibrio generale poteva sembrare raggiunto col
trattato di Miseno, concluso l’anno dopo, che riconosceva
a Sesto Pompeo il predominio su Sicilia, Sardegna e
Corsica, ma non si trattava che di un equilibrio instabile. Il
segno della rottura fu il ripudio di Scribonia (a. 39) da parte
di Ottaviano, che l’anno dopo passò in terze nozze con
Livia Drusilla, già moglie di Tiberio Claudio Nerone, e ben
presto divampò la lotta aperta per il possesso della Sicilia.
Ottaviano la iniziò dapprima con l’ostilità di Antonio, che
fece una nuova minacciosa apparizione a Brindisi, poi,
ristabilita nella primavera del 37 la concordia con il trattato
di Taranto (che portò al rinnovamento per un altro
quinquennio dei poteri triumvirali scaduti alla fine del 38),
la continuò con l’aiuto di Antonio e la concluse nel 36 con
la vittoria navale di Naulòco (presso Messina).
All’eliminazione di Sesto Pompeo seguì, nello stesso anno
173
36, l’accantonamento di Lepido. Questi nella guerra di
Sicilia aveva cercato di sollevare le legioni contro
Ottaviano, ma abbandonato dalle sue truppe finì per essere
spogliato dei poteri di triumviro e relegato nell’ombra,
conservando il solo pontificato massimo.
3. Il duello conclusivo fra Ottaviano e Antonio. - A
dominare l’impero del popolo romano restavano così due
uomini, Antonio e Ottaviano. Li legava il vincolo di
parentela per il tramite di Ottavia, ma li divideva
l’ambizione, se con una sola parola fosse possibile definire
quel complesso di ragioni per cui la visione politica
dell’uno non poteva essere e non fu quella dell’altro. Alla
spedizione contro i Parti, che Antonio intraprese nel 36 e
nell’ottobre dello stesso anno si concluse con un
insuccesso, Ottaviano non aveva inviato quel contingente
di 20.000 uomini che in base al trattato di Taranto era
tenuto a fornire; ma l’incendio della guerra civile tardò
ancora qualche anno a scoppiare. Ottaviano era assorbito
dalla sistemazione della Pannonia e dalla lotta contro i
pirati della costa adriatica, Antonio dalla guerra di rivincita
contro i Parti, nel corso della quale riuscì ora a conquistare
l’Armenia e a stabilire nei paesi orientali un certo equilibrio
fondato sulla più stretta collaborazione tra Roma e l’Egitto.
Infatti, anziché creare in Oriente nuove province, Antonio
vi costituiva una serie di Stati vassalli sotto una dinastia
romano-egiziana cui egli donava i vari territori, e i dinasti
erano, oltre la regina madre Cleopatra, i figli Alessandro
Helios, Tolemeo e Cleopatra Selene (nati da lui) e
Cesarione (nato da Cesare).
Questa sistemazione dell’Oriente porse ad Ottaviano
uno dei più efficaci argomenti propagandistici per la lotta
che egli aveva in animo di scatenare, quasi che Antonio
volesse porre al centro dell’impero l’Egitto e non più
174
l’Italia, allo stesso modo che, ripudiando Ottavia, dava la
preferenza a Cleopatra. Come prova delle sue tendenze
orientalizzanti e antiromane, ad Antonio venne imputato di
aver celebrato in Alessandria e non a Roma il trionfo
sull’Armenia, anche se allora, più che di un vero e proprio
trionfo, si trattò forse di una cerimonia dionisiaca inserita
negli sviluppi della politica religiosa attuata dal triumviro.
Infatti, per assicurarsi la devozione dei popoli orientali,
Antonio si era inoltrato sulla strada della divinizzazione che
già Cesare aveva imboccato, e si era atteggiato a novello
Dioniso, identificato in Egitto con Osiride.
Dopo quest’abile preparazione ideologica, Ottaviano
aprì la lotta all’inizio del 32; essendo scaduti alla fine
dell’anno precedente i poteri triumvirali, egli riuscì ad
imporsi con un colpo di forza debellando in Roma
l’opposizione degli antoniani e costringendo a fuggire i due
consoli e trecento senatori. Restavano dalla sua parte gli
altri settecento senatori, e più ancora il sostegno di un
solenne giuramento di fedeltà col quale l’Italia e le province
occidentali lo riconobbero capo della guerra che, per
evitare l’odiosità di un nuovo bellum civile, Ottaviano fece
dichiarare a Cleopatra, mentre Antonio, suo alleato, veniva
bollato come hostis publicus.
Ingenti erano le forze di cui Antonio disponeva, ma
alla prova del fuoco la sua posizione apparve notevolmente
indebolita per effetto della sua politica orientalizzante, la
quale non solo aveva suscitato nelle popolazioni grecoasiatiche una reviviscenza di spiriti nazionalistici e
l’aspirazione a una maggiore autonomia dal governo di
Roma, ma aveva anche depresso l’ardore delle sue legioni,
che sentivano di battersi per una causa contraria alla
assoluta supremazia romana. Questo, soprattutto, dà
ragione del corso a lui sfavorevole delle operazioni che
culminarono, il 2 settembre del 31, nella battaglia navale di
175
Azio (sulla costa ionica della Grecia centrale); l’anno dopo
era presa Alessandria e, mentre Antonio e Cleopatra si
toglievano la vita, l’Egitto fu ridotto a provincia. Finita la
guerra civile, debellati i nemici esterni, Ottaviano si
apprestava a soddisfare l’universale desiderio di pace e nel
28, con solenne cerimonia, faceva chiudere il tempio di
Giano rimasto aperto per più di due secoli.
4. Ottaviano “Augusto” e “principe” dell’impero. - Dopo lo
sfacelo del regime oligarchico e l’eliminazione del
competitore, restava ad Ottaviano di dare un nuovo
ordinamento allo Stato di cui s’era fatto padrone, ed egli vi
si dedicò con un lungo e paziente lavoro che fu
sostanzialmente di rivoluzione, nonostante i suoi sforzi per
presentarlo come di restaurazione dell’antica res publica. Si
trattava, in primo luogo, di dar veste costituzionale al suo
potere personale, e a questo si venne soprattutto nel corso
di due memorabili sedute del senato nel gennaio del 27.
Secondo l’espressione che più tardi l’imperatore stesso usò
quando scrisse l’index rerum a se gestarum destinato a essere
scolpito nel bronzo dinanzi al suo mausoleo (le cosidette
Res gestae divi Augusti), egli si spogliò allora della potestas
eccezionale che aveva fino a quel momento esercitata, ma
ottenne in cambio, oltre a vari onori, il riconoscimento
della sua auctoritas, cioè di una superiorità personale che lo
poneva al di sopra di tutti gli altri magistrati dello Stato. Al
riconoscimento di una tale auctoritas faceva riscontro il
conferimento del titolo di Augustus, che come auctoritas
deriva dalla stessa radice del verbo augeo. E Augustus
significava “accresciuto”, innalzato al di sopra degli altri, un
concetto non famigliare ai Greci che tradussero Augustus
con Sebastòs (“venerato”, da sébomai), ove è già un accenno a
quella concezione sacrale del nuovo potere destinata a
176
manifestarsi ben presto nel culto prestato (anche in Italia)
alla divinità dell’imperatore vivente.
Augusto, come da questo momento possiamo
chiamarlo, riceveva inoltre l’imperium proconsulare per dieci
anni, poi periodicamente rinnovato, sulle province non
pacificate (che furono dette “imperiali”, mentre quelle
pacificate furono dette “senatorie”), e ciò significava il
supremo comando sulle forze armate, che per lo più erano
stanziate appunto in tali province. In questo modo
l’esercito professionale, che con la sua devozione ai
condottieri aveva alimentato le guerre civili e contribuito al
tramonto del regime repubblicano, veniva stabilmente
inserito nel nuovo sistema politico attraverso la sua diretta
dipendenza dall’imperatore. Al precedente imperio
proconsolare dovevano aggiungersi qualche anno dopo, nel
23, un nuovo imperium proconsulare maius et infinitum e la
tribunicia potestas che, rinnovata di anno in anno, consentiva
all’imperatore di convocare il senato e di far votare leggi,
quasi fosse un tribuno del popolo (mentre tale non era, e
quindi non sottostava alle limitazioni della collegialità e
dell’annualità).
Tutti questi poteri si rispecchiavano nella titolatura
ufficiale del capo dello Stato, che oltre alla menzione della
tribunicia potestas comprendeva i titoli di Imperator (divenuto,
anzi, un vero e proprio prenome in luogo di Gaius), di
Augustus, di pontifex maximus, (dal 12, dopo la morte di
Lepido), di pater patriae, e nell’insieme delineava la figura del
princeps. Questo termine, che peraltro non assunse mai un
valore ufficiale, fu prescelto dallo stesso Augusto a definire
la sua posizione nello Stato; egli infatti non volle, a
differenza di Cesare, assumere la figura del dittatore, che in
Roma aveva sempre avuto e conservato un carattere
straordinario ed eccezionale, ma preferì essere “principe”,
177
cioè Primo cittadino tra gli altri cittadini, e “principato” fu
il nome del regime costituzionale da lui creato.
5. Compromesso tra vecchio e nuovo regime nelle riforme
augustee. - Per il funzionamento della macchina statale
Augusto chiamò alla collaborazione i ceti più elevati della
cittadinanza romana e fondò il nuovo ordine sul privilegio
della classe senatoria e della classe equestre. Ciò vuol dire
che nella complessa amministrazione dell’impero
determinate funzioni erano riservate esclusivamente ai
senatori o ai cavalieri. Così, per esempio, la carica di
governatore di provincia non poteva essere rivestita che da
un senatore, e ugualmente solo i senatori potevano
raggiungere il grado più elevato dell’ufficialità, il comando
di una legione, che essi esercitavano come luogotenenti
dell’imperatore. Ancora, solo a personaggi dell’ordine
senatorio erano accessibili le antiche magistrature: la
questura, il tribunato della plebe, l’edilità, la pretura, il
consolato; ma è appena necessario aggiungere che la
mutata situazione politica aveva svuotato queste
magistrature della maggior parte del loro contenuto. Prima
esse avevano costituito gli organi per l’attuazione del
programma politico della classe dirigente: ora invece, che il
potere era nelle mani dell’imperatore, non rappresentavano
più che qualifiche per poter esercitare determinate
funzioni. Esser console, per es., aveva un tempo significato
aver raggiunto la posizione più elevata nel governo dello
Stato, ora significava essere qualificato per ottenere i più
alti incarichi, ad esempio l’ufficio di governatore di
un’importante provincia. Nello stesso tempo il senato, pur
conservando svariate attribuzioni (tra cui importantissimo,
se non si fosse sempre più ridotto a una semplice formalità,
il diritto dell’investitura imperiale), perdeva l’antica
funzione di supremo moderatore della vita politica dello
178
Stato, e mentre per secoli era stato come il fortilizio della
nobilitas, nella quale solo pochi homines novi erano riusciti a
penetrare attraverso la gestione delle magistrature, ora
invece era in balìa dell’imperatore, che aveva la facoltà di
introdurvi chi volesse. Questa immissione di nuovi
elementi non riuscì peraltro a incidere troppo sulla
fisionomia del consesso, che in generale rimase a lungo
ancorato agli antichi ideali politici; i rapporti fra imperatore
e senato furono spesso improntati a reciproca diffidenza,
ma l’opposizione senatoria assai di rado diede luogo a
episodi di violenta ribellione, e tra i patres il principe trovò
sempre volenterosi collaboratori.
La classe dei cavalieri (equites), cioè la ricca borghesia
che da oltre un secolo aveva con varia fortuna lottato
contro l’oligarchia nobiliare per ottenere una parte di
maggior rilievo nella vita pubblica, ebbe anch’essa
riconosciuta dalla costituzione augustea una posizione di
privilegio, la quale anzi col tempo andò sempre
aumentando a detrimento del senato. Nell’ordinamento
militare, gli appartenenti all’ordine equestre avevano il
comando dei corpi ausiliari che fiancheggiavano le legioni:
le alae di cavalleria e le cohortes di fanteria, reclutate nelle
province. Nelle legioni, composte di cives Romani, essi
potevano raggiungere solo il grado di tribunus militum, in
sottordine al comandante (legatus legionis), che era di rango
senatorio. Poiché in Roma le forze navali furono
generalmente considerate a un livello inferiore rispetto alle
forze di terra, a cavalieri anziché a senatori venne affidato
da Augusto il comando delle due flotte principali, dislocate
a Miseno e a Ravenna.
Ma un impiego assai più importante trovarono gli
appartenenti all’ordine equestre nei numerosi uffici che
Augusto organizzò per le varie branche dell’amministrazione imperiale, riservando appunto a loro i posti direttivi
179
col titolo di praefectus o di procurator. Così fu appannaggio dei
cavalieri l’ufficio di praefectus praetorio (il comandante dei
pretoriani), destinato a diventare in seguito una delle
cariche più elevate, mentre ai tempi di Augusto fu di rango
alquanto modesto. Infatti era allora più importante la carica
di praefectus Aegypti, cioè di governatore dell’Egitto, unica
provincia affidata al governo di un cavaliere e non di un
senatore. Notevoli erano anche, fra le cariche riservate ai
cavalieri, quella di praefectus vigilum, il comandante delle sette
coorti di vigiles istituite con funzioni di polizia urbana e
specialmente di vigili del fuoco, e quella di praefectus annonae,
cioè di preposto a un servizio assai complesso e delicato
dovendo curare l’approvvigionamento della plebs urbana.
Così si chiamava la massa dei cittadini domiciliati in
Roma e non appartenenti alle classi senatoria o equestre;
non era un termine spregiativo, come può sembrare, anche
se di fatto larghi strati della cittadinanza romana erano
scaduti a popolino pronto a tumultuare quando non
otteneva ciò che soprattutto chiedeva, panem et circenses.
Augusto sembra si proponesse di restituire queste masse
all’antica dignità di cittadini e per un certo tempo ripristinò
i comizi popolari, ma i disordini che si verificarono
nell’assemblea lo dissuasero dal continuare su tale strada, e
i comizi decaddero per sempre. Tale decadenza si verificò
in connessione col fatto che il popolo cessò di aver parte
effettiva sia nell’approvazione delle leggi (emananti ora
sempre più direttamente dall’autorità dell’imperatore), sia
nella scelta delle magistrature di maggior rilievo,
determinata ora anch’essa dal beneplacito del principe di
intesa con un apposito comitato elettorale misto di senatori
e cavalieri. Su questo punto dell’attività riformatrice di
Augusto, piuttosto oscuro fino a non molto tempo fa,
nuova luce è venuta dal recente trovamento della tabula
180
Hebana, così chiamata dal luogo del fortuito ritrovamento,
la città di Heba in Etruria.
Di non poca importanza, nel quadro delle riforme
augustee, fu poi il riordinamento dell’amministrazione
finanziaria, suddivisa in vari uffici di cui erano a capo
numerosi procuratores, appartenenti di norma, come si è
detto, all’ordine equestre. Tale riordinamento, che accanto
all’antico tesoro dello Stato, l’aerarium populi Romani, vide
sorgere due nuove casse, l’aerarium militare e il fiscus
imperiale, fu imposto dall’obbligo di assicurare le entrate
necessarie per la pubblica spesa, specie per il
mantenimento dei funzionari e, soprattutto, dell’esercito. Si
trattava di quasi una trentina di legioni e di numerosi corpi
ausiliari (che Augusto stanziò stabilmente fuori d’Italia sia
perché fossero più pronti alla difesa dei confini, sia perché
non avessero a costituire una minaccia al suo potere) oltre
alle truppe che invece furono accasermate in Roma (cosa
inaudita nell’età re- pubblicana!): i praetoriani, i vigiles e gli
urbaniciani. Questi ultimi erano alle dipendenze del praefectus
urbi, titolare di un ufficio assai antico e ora riplasmato da
Augusto per esercitare un’alta sorveglianza sull’ordine
pubblico.
6. Pacificazione e riordinamento dell’impero. - Su questo
organismo, destinato a durare per secoli, Augusto fondò la
sua politica, che fu soprattutto una politica di
consolidamento della pace e della sicurezza, anche se
talvolta fu necessario far ricorso alla guerra. Sopiti i
contrasti all’interno, almeno nelle forme violente, esaltato
come restauratore della famiglia e della religione e come
fondatore della pax Augusta (l’eco più bella di questa
esaltazione risuona nella poesia di Virgilio, di Orazio, di
Ovidio), l’imperatore si preoccupò anche di provvedere alla
tranquillità delle province periferiche.
181
Pacificata definitivamente la Spagna per merito di M.
Vipsanio Agrippa, uno dei più valorosi collaboratori e
genero di Augusto, furono poi assoggettati la Rezia (od.
Tirolo e Baviera) e il Norico (il resto dell’od. Austria, con la
parte settentrionale della Slovenia) ad opera di Tiberio
Claudio Nerone, figliastro dell’imperatore, che portò il
confine al riparo del Danubio. Contemporaneamente
Druso, fratello di Tiberio, si spingeva vittoriosamente oltre
il Reno nel cuore della Germania e alla sua morte, nel 9
a.C., l’impresa veniva condotta a termine da Tiberio
(reduce dalla sottomissione della Pannonia, fra la Dalmazia
e il Danubio), che completava l’assoggettamento del
territorio fino all’Elba. Ma quest’ultima fu conquista poco
duratura perché i Germani, incitati alla ribellione da
Arminio, inflissero una tremenda disfatta al governatore
romano Publio Quintilio Varo, annientando le sue tre
legioni nella selva di Teutoburgo (9 d.C.). Anche per le
complicazioni di una grave rivolta in Pannonia, non rimase
che arretrare sul vecchio confine del Reno, e la rinuncia alla
riscossa ebbe l’effetto di lasciare per sempre la Germania
fuori del mondo romano.
Al di là dell’Eufrate, che con il Reno e il Danubio
segnava per grandi linee la demarcazione dell’impero, si
estendeva il regno dei Parti. Verso costoro Augusto
abbandonò i propositi aggressivi, che già erano stati di
Cesare e poi di Antonio, e intraprese una lunga ed accorta
azione diplomatica che nel 20 a.C. portò al riconoscimento
del prestigio di Roma: fra l’altro, si ottenne la restituzione
delle insegne che oltre trent’anni prima erano state
strappate a Crasso. Si trattava però di una situazione assai
fluida per le contrastanti mire dei due Stati ad assicurarsi il
controllo dell’Armenia, e il dissidio non tardò a riaffiorare
in forma violenta. A un quadro così sommario dell’opera
politica di Augusto bisogna almeno aggiungere un cenno
182
alla riorganizzazione territoriale e amministrativa dell’Italia
(ripartita in 11 regiones) e dell’Urbe (suddivisa in 14 regiones,
comprendenti ciascuna numerosi vici), all’impulso dato alle
opere pubbliche (di Roma poté dire che l’aveva trovata di
mattoni e la lasciava di marmo; cfr. Suet., Aug. 28),
all’incremento dei centri cittadini in Italia e nelle province.
Fu protetto lo sviluppo delle autonomie comunali, e nelle
varie regioni dell’impero ebbe inizio una splendida fioritura
di città grandi e piccole, fra cui numerose nuove colonie
che furono altrettanti centri d’irradiazione del romanesimo.
In un clima tanto propizio le arti e le lettere romane
attinsero vette assai alte, e nella nuova atmosfera del
principato, che un’abile propaganda seppe trasformare nel
regno della pace universale finalmente donata al mondo da
Augusto, Roma si avviò a diventare il principale centro di
cultura, oltre che il centro politico dell’impero. Nella
solenne festività dei ludi saeculares celebrati nel 17 a.C., per
bocca di un coro di pueri e puellae, le intatte speranze del
domani, saliva al cielo l’augurio di Orazio: Alme sol possis
nihil urbe Roma visere maius.
7. La conservazione del principato nel problema della
successione. - Informandosi ai severi dettami della filosofia
stoica, Augusto concepì la sua lunga opera come un dovere
e vi attese, soleva dire, con l’animo del soldato
incrollabilmente fermo al suo posto, senza lasciarsi
abbattere dagl’incomodi di una salute cagionevole e da una
serie di avversità domestiche. Si preoccupò anche, e assai
per tempo, di trasmettere l’impero nelle mani di un uomo
capace di reggerne l’immensa mole, naturalmente
scegliendolo nella cerchia dei famigliari, come imponeva il
carattere sacrale e personale del suo potere.
In mancanza di discendenza maschile (non aveva
avuto che una sola figlia, Giulia, nata nel 39 dalla seconda
183
moglie Scribonia), egli pensò dapprima al giovane Marco
Claudio Marcello, figlio di sua sorella Ottavia, cui nel 25
diede in sposa la giovanissima Giulia. Ma due anni dopo,
appena ventenne, Marcello, venne improvvisamente a
morte, e allora le speranze dell’imperatore si appuntarono
su Marco Vipsanio Agrippa, il valente suo collaboratore,
cui nel 21 fece l’onore di accoglierlo come secondo marito
di Giulia e nel 18 rese compartecipe dell’imperium
proconsulare e della tribunicia potestas. Morto nel 12 anche
Agrippa, restavano i figli da lui avuti con Giulia, e Augusto
sperò di trovare il successore nei primi due di questi nipoti,
che adottò come figli (chiamandoli Gaio Giulio Cesare e
Lucio Giulio Cesare) e colmò di onori straordinari
avviandoli all’arte del governo. Ma la sorte sembrava
accanirsi contro questi suoi piani, e i due giovani morirono
prematuramente, Lucio nel 2 e Gaio nel 4 d.C. Nella
famiglia imperiale non restava che il sedicenne Agrippa
Postumo, l’ultimo dei cinque figli di Giulia, ma
l’imperatore, ormai prossimo alla settantina, non ebbe la
forza di coltivare questa nuova speranza e si rassegnò a
lasciare che la successione andasse al figliastro Tiberio, già
maturo di anni e di esperienza.
Questi era nato nel 42 dall’omonimo senatore
patrizio Tiberio Claudio Nerone e da Livia Drusilla,
sposata da Augusto in terze nozze nel 38, e sebbene si
fosse largamente distinto anche come diplomatico
avveduto e valente condottiero, non era mai entrato nel
cuore del patrigno, che l’aveva posposto anche all’altro
figliastro Druso, suo fratello minore (morto nel 9 a.C.).
Negli ultimi tempi, amareggiato per le preferenze
dimostrate ai giovanissimi Gaio e Lucio Cesari, Tiberio si
era appartato soggiornando a Rodi per ben otto anni; ora,
dopo la morte di Gaio Cesare, venne adottato da Augusto
(e cambiò il nome di Tiberio Claudio Nerone in quello di
184
Tiberio Giulio Cesare), ma nel medesimo tempo, sebbene
avesse già un figlio, fu costretto ad adottare (perché un
giorno gli succedesse) Germanico, figlio del fratello Druso.
Si costituiva così, per via adottiva, la famiglia imperiale
giulio-claudia.
Come già a suo tempo aveva fatto con Vipsanio
Agrippa, Augusto rivestì Tiberio dell’imperium proconsulare e
della tribunicia potestas che, innalzandolo alla posizione di
correggente, gli spianavano la via a succedergli. Caduto tre
anni dopo in disgrazia, forse per i maneggi di Livia, e
relegato in un’isola il giovane Agrippa Postumo, esiliata già
da tempo Giulia, che il padre aveva implacabilmente voluto
punire per la sua vita scostumata, nessun ostacolo si
frapponeva ormai alla successione di Tiberio (che nel 13,
per effetto del conferimento di nuove attribuzioni, aveva
salito un gradino ancora più alto nella scala del potere), ed
egli la raccolse nel 14, quando Augusto venne a morte
all’età di settantasei anni.
Su questo periodo, che rappresenta una delle svolte di maggiore
interesse nella storia di Roma, sono andate in massima parte perdute le opere
degli autori contemporanei, a cominciare da quelle di due storici di così grande
importanza (anche per la diversità della loro “tendenza”) come Asinio Pollione
e Livio. Da Cicerone (Filippiche e Lettere, fino all’anno 43) si passa a scrittori di
piena età augusteo-tiberiana, come Nicolao di Damasco (Vita di Augusto) e
Velleio Patercolo; quindi ai più tardi Plutarco (Vite di Cicerone, di Bruto, di
Antonio), Suetonio (De vita Caesarum, I e II), Appiano (Guerre civili e libro
Illirico), Cassio Dione (libb. XLV-LVI). La tradizione a noi pervenuta
rispecchia, com’è ovvio, prevalentemente il punto di vista favorevole ad
Augusto (e, perciò stesso, contrario ai suoi avversari, a cominciare da Antonio),
frutto della elaborazione di quei motivi propagandistici di cui la prima eco può
cogliersi nelle celebrazioni della poesia augustea (Virgilio, Orazio, ecc.). Va
anche tenuto presente il cospicuo apporto delle fonti documentali, soprattutto
del materiale epigrafico, che consente di meglio approfondire vari punti; basti
pensare, per esempio, alle Res gestae divi Augusti, su cui v. appresso.
Sul vario gioco delle fazioni che dopo le Idi di marzo si contendevano il
campo, e sulle accorte mosse di Gaio Ottavio per inserirsi fra i cesariani e gli
anticesariani, v. T. RICE HOLMES, The architect of the Roman empire, I, Oxford
185
1928; W. SCHMITTHENNER, Oktavian und das Testament Caesars, München 1952.
Quelle stesse mosse dovevano più tardi essere presentate come i primi sacrifici
durati in difesa delle libere istituzioni della repubblica: Annos undeviginti natus
exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rem publicam a
dominatione factionis oppressam in libertatem vindicavi (Res gest. 1).
Sulla parte di primo piano avuta dalle forze armate nel decidere le sorti
dei contrasti politici, cfr. H. BOTERMANN, Die Soldaten und die römische Politik in
der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats, München 1967.
Con riferimento al bellum Philippense e alla disfatta dei cesaricidi, un
interessante esempio del prevalere della tradizione filoaugustea a scapito di
Marco Antonio può cogliersi nella notazione registrata nel Calendario
Prenestino al 23 ottobre (cfr. A. DEGRASSI, Inscr. Italiae, XIII 2, Roma 1963, p.
135; 524): [imp. Caesar A]ugustus vicit Philippis posteriore proelio Bruto occiso.
Sui contrasti che ben presto presero a dividere i triumviri r. p. c. fino a
trasformarsi di lì a poco in guerra guerreggiata (bellum Perusinum), e in
particolare sui contrasti fra Ottaviano e Lepido nell’anno 42, una testimonianza
interessante è costituita dalla cosiddetta laudatio Turiae. Questo testo, che ci è
stato trasmesso in un’epigrafe frammentaria (DESSAU, I. L. S. 8393; cfr. M.
DURRY, Éloge funèbre d’une matrone romaine, Paris 1950), contiene la celebrazione
di una defunta (di malsicura identificazione) fatta tra l’8 e il 2 a.C. dal marito, il
quale fra l’altro esalta l’affetto dimostratogli dalla sposa in un momento
terribile, quando egli era stato proscritto da Lepido e lei riuscì a farlo fuggire,
salvandogli la vita con grande rischio della sua, e poi a ottenergli la grazia da
Ottaviano (I 27 sgg.: Rara sunt tam diuturna matrimonia finita morte, non divertio
in[terrupta; nam contigit] nobis, ut ad annum XXXXI sine offensa perduceretur. Utinam
vetust[um ita extremam sub]isset mutationem vice m[e]a, qua iustius erat cedere fato
maiorem... (II 21 sgg.). Acerbissimum tamen in vi[ta] mihi accidisse tua vice fatebo[r,
reddito iam non inutili] cive patriae benificio et i[ud]icio apsentis Caesaris Augusti [quom
per te] de restitutione mea M. L[epi]dus conlega praesens inter[pellaretur et ad eius] pedes
prostrata humi, n[on] modo non adlevata, sed tra[cta et servilem in] modum rapsata,
livori[bus c]orporis repleta, firmissimo animo eum [admone]res edicti Caesaris cum
g[r]atulatione restitutionis me[ae, auditisque verbis eti]am contumeliosis et cr[ud]elibus
exceptis volneribus pa[lam ea praeferres], ut auctor meorum peric[ul]orum notesceret. Quo
noc[uit mox quod fecit!] Quid hac virtute efficaciu[s]? Praebere Caesari clementia[e locum et
cum cu]stodia spiritus mei not[a]re importunam crudelitatem [egregia tua] patientia? Pacato
orbe terrarum, restituta re publica, quieta deinde n[obis et felicia] tempora contigerunt.
Fue[ru]nt optati liberi, quos aliqua[mdiu sors inviderat. Si fortuna procede[re e]sset passa
sollemnis inservie[ns, quid utrique no]strum defuit? Procedens a[et]as spem [f]iniebat ...”.
Sul progressivo deterioramento delle relazioni fra Antonio e Ottaviano,
con particolare riguardo alla politica orientalizzante di Antonio che offrì ad
Ottaviano il destro di incentrare la sua offensiva ideologica nell’alternativa
“Roma o Alessandria”, v. R. SYME, The Roman revolution, Oxford 1939 (trad. ital.
1962); H. BUCHHEIM, Die Orientpolitik des Triumvirn M. Antonius, Heidelberg
1960. Sulla battaglia di Azio, v. M.A. LEVI, in “Athenaeum” N.S. X (1932) p. 1
186
sgg.; sulla fine di Cleopatra, T.C. SKEAT, The last days of Cleopatra, in “Journ.
Rom. St.” XLIII (1953) p. 98 sgg.
Per l’intelligenza più piena della riforma costituzionale augustea,
consistente in ultima analisi nell’inserzione dei poteri del princeps entro i vecchi
schemi del reggimento repubblicano, fondamentale la formulazione dello
stesso Augusto circa l’assoluta superiorità della sua auctoritas, che lo collocava al
di sopra di tutti coloro che pure furono rivestiti di una potestas (consolare,
proconsolare o tribunizia) pari alla sua (Res gest. 34, 1 sgg.: In consulatu sexto et
septimo [= a. 28 e 27], p[ostquam be]lla [civil]ia exstinxeram per consensum universorum
[po]tens [reru]m om[n]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populique Rom]ani
[a]rbitrium transtuli. Quo pro merito meo, senatu[s consulto Au]gust[us appe]llatus sum et
laureis postes aedium mearum v[estiti] publ[ice coronaq]ue civica super ianuam meam fixa
est [et clu]peus [aureu]s in [c]uria Iulia positus, quem mihi senatum pop[ulumq]ue
Rom[anu]m dare virtutis clement[iaequ]e iustitiae et pieta[tis caus]sa testatu[m] est pe[r
e]ius clupei [inscription]em. Post id tem[pus a]uctoritate [omnibus praestiti, potest]atis
au[tem n]ihilo ampliu[s habu]i quam cet[eri qui m]ihi quoque in ma[gis]tra[t]u conlegae
f[uerunt]. Qui si rivela anche la insufficienza della famosa teoria del Mommsen,
secondo cui in Roma si sarebbe instaurata una “diarchia”, cioè una divisione
del potere fra principe e senato, e a ragione quella teoria non ha più avuto
seguito. Sulle componenti della auctoritas dell’Augusto, con particolare riguardo
egli elementi sacrali ad essa inerenti, ci si limiterà a ricordare W. ENSSLIN,
Gottkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden, in “Sitzb. Bayer. Akad.”, 1943; W.
SESTON, Dioclétien et la tétrarchie, Paris 1946, p. 193 sg.; M. GRANT, From
Imperium to Auctoritas, Oxford 1946; A. MAGDELAIN, Auctoritas principis, Paris
1947; G. E. F. CHILVER, Augustus and the Roman constitution, in “Historia” 1
(1950), p. 420 sgg.
All’inizio del passo sopra citato delle Res gestae si trova un’indicazione
illuminante circa il fondamento dei poteri esercitati da Ottaviano fra il 32 e il
28: uno dei punti più dibattuti nella recente bibliografia. Scaduti il 31 dicembre
del 33 i poteri del secondo triumvirato, nel quinquennio successivo Ottaviano
considerò giustificata la sua posizione di arbitro dello Stato in base alla
continuazione di quel consensus universorum che gli aveva consentito di potiri rerum
omnium per aver posto fine alle guerre civili nel novembre del 36 (quando,
appunto, tolti di mezzo Sesto Pompeo e Lepido, gli venne conferita dal senato
la tribunicia potestas a vita). Cfr. L.A. MASCKIN, Il principato di Augusto, trad. ital.,
Roma 1956, e spec. S. MAZZARINO, in GIANNELLI-MAZZARINO, Trattato di
storia romana, II, p. 76.
Sui vari aspetti tecnici e organizzativi della riforma dell’amministrazione
statale (territoriale, finanziaria, militare ecc.) v. i contributi di vari autori
pubblicati nel volume “Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo”,
Roma 1938. Circa la pretesa dell’imperatore di voler essere considerato, anche
nell’esplicazione di questa sua attività riformatrice, come un restauratore
dell’ordine antico, è significativo, per es., che egli risuscitasse dopo qualche
secolo di obliterazione la figura del praefectus urbi. Però, mentre a suo tempo il
prefetto urbano veniva nominato ne urbs sine imperio foret (TAC., Ann. VI 11),
187
ossia per esercitare l’imperium in Roma durante l’assenza di quelli che
normalmente ne erano rivestiti, ora invece chi portava quell’antico titolo non
era altro che un funzionario imperiale incaricato di sovraintendere all’ordine
pubblico (e destinato a diventare poi uno degli organi più importanti del
governo cesareo: cfr. G. VITUCCI, Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale,
Roma 1956). Del resto, con riferimento alla ripartizione della città in qualche
centinaio di vici, si deve tener presente che ogni vicus aveva come centro sacrale
un compitum, cioè una cappella che sorgeva a un crocicchio; in queste cappelle
da tempo assai antico si usava venerare le immagini dei Lari: ora vi si aggiunse
il Genius dell’imperatore (da venerare, dunque, ad ogni angolo di strada), cfr G.
VITUCCI, in “Diz epigr.”, cit., vol. IV p. 402 sgg.
Riguardo alla celebrazione dei ludi saeculares, del 17 a.C., uno dei
momenti più significativi nell’ambito della restaurazione religiosa e morale
dello stato, sarà interessante richiamare due provvedimenti intesi a metterne in
risalto la particolare solennità. Il primo è un senatusconsultum, emanato su
proposta del console C. Silano, per concedere in via eccezionale di poter
assistere ai ludi a coloro che l’anno prima erano caduti sotto le sanzioni della
legislazione demografica di Augusto (C.I.L. VI 32323 = RICCOBONO, Leges,
Roma 19432, p 274 sg.): [d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt), ut quoniam ludi iei] religio[nis]
causa sun[t in]stituti neque ultra quam semel ulli mo[rtalium eos spectare licet..... ludos]
quos [m]ag(istri) XVvir(um) s(acris) f(aciundis) [ed]ent, s(ine) f(raude) s(ua) spectare liceat
ieis qui lege de marita[ndis ordinibus tenentur]. Il secondo provvedimento è
rappresentato da un editto dei quindecimviri sacris faciundis (C.I.L. VI 32323 =
RICCOBONO, op. cit., p. 317 sg.): XVvir(i) s. f. dic(unt): Cum bono more et
proinde celebrato frequentibus exsemplis, quandocumq[ue i]usta laetitiae
publicae caussa fuit, minui luctus matrona[r]um placuerit, idque tam
sollemnium sacroru[m l]udorumque tempore referri diligenterque
opserva[r]i pertinere videatur et ad honorem deorum et ad [m]emoriam
cultus eorum, statuimus offici nostri esse per edictum denuntiare feminis,
uti luctum minuant.
Nel campo dell’amministrazione provinciale è da rilevare l’importanza
degli editti augustei ritrovati a Cirene pochi decenni or sono (su cui v., p. es., P.
DE VISSCHER, Les édits d’Auguste découverts à Cyrène, Louvain 1940). A parte le
altre questioni particolari, qui si può osservare come il principe esercitasse i
suoi poteri eminenti anche nelle province “senatorie”: il suo imperium
proconsulare maius et infinitum - oltre che la sua auctoritas - gli consentivano di
sovrapporsi al normale imperium proconsulare del governatore (proconsul) della
provincia “senatoria” di Creta e Cirene.
Ma ancor più importante, nel quadro della documentazione di recente
acquisita, è la testimonianza contenuta nella cosiddetta tabula Hebana. Questa
tabula di bronzo, scoperta occasionalmente presso la etrusca Heba, od.
Magliano in provincia di Grosseto (cfr. U. COLI, in “Notizie degli Scavi di
Ant.” ser. VIII vol. I, 1947, p. 55 sgg.), contiene una legge sulle onoranze
funebri da tributare a Germanico (morto nel 19), in cui fra l’altro si dispone
che alle dieci centurie senatorio-equestri intestate a Gaio Cesare e Lucio Cesare
188
e istituite da Augusto nel 5 d.C. per procedere alla destinatio dei consoli e dei
pretori se ne aggiungeranno ora altre cinque intestate al defunto Germanico.
Su queste norme - prima ignote - relative al conferimento delle
magistrature più elevate, sono da notare brevemente almeno due cose: da un
lato che la scelta preliminare dei candidati (destinatio) era diventata dall’anno 5
d.C. frutto di una collaborazione col principe dell’ordine senatorio integrato da
una rappresentanza qualificata dell’ordine equestre; dall’altro che tali operazioni
della destinatio si svolgevano sotto la “protezione” dei defunti (ed eroizzati)
giovani principi della famiglia imperiale, ed erano quindi circonfuse di
quell’atmosfera di religiosità che Augusto volle presente in ogni suo atto di
governo. Il sistema della destinatio, di cui ci ha informati la tabula Hebana,
funzionò ancora per qualche tempo, e infatti sappiamo che venne “aggiornato”
nel 23, alla morte di Druso minore (figlio di Tiberio), con l’istituzione di altre
cinque centurie destinatrici (sempre miste di senatori e cavalieri) intestate
appunto all’eroe Druso. Poi, ancora sotto Tiberio, i cavalieri vennero messi da
parte, cioè la nobiltà senatoria riuscì a ottenere dall’imperatore di estromettere
l’ordine equestre dall’ingerenza che, a partire dal 5 d.C., aveva avuto nella
carriera dei senatori, e d’allora in poi l’elezione di costoro alla pretura e al
consolato fu un atto di esclusiva competenza dell’assemblea senatoria (sentiti,
naturalmente, i desideri del principe): cfr. MAZZARINO, Trattato cit. p 555 sgg.
Una testimonianza molto interessante circa la crescente esaltazione
della persona dell’Augustus e i connessi sviluppi del culto imperiale è
rappresentata da un editto emanato nel 10/9 a.C. dal proconsole d’Asia Paolo
Fabio Massimo e a noi pervenuto in via epigrafica (DITTENBERGER, O. G. I. S.
458; cfr. U. LAFFI, Le iscrizioni relative all’introduzione ecc., in “St. Class. e Or.”
XVII 1967). Con tale editto il proconsole invitava le poleis della provincia (che
erano formalmente autonome così come solo formalmente si può parlare qui
di un invito e non di un ordine) ad abbandonare il vecchio calendario e ad
introdurne uno nuovo avente come capodanno il 23 settembre, giorno natale
di Augusto. Nel preambolo introduttivo dell’editto, e a sua motivazione,
l’imperatore viene celebrato con le seguenti espressioni (all’inizio il testo è
lacunoso): “.... se sia un giorno più felice o più utile quello natalizio del
divinissimo Cesare, che giustamente potremmo considerare essere uguale al
principio di tutte le cose, e se non nell’ordine naturale certo nel rispetto
dell’utilità, giacché tutto ciò che decadeva e volgeva in rovina egli raddrizzò, e
dette un altro volto a tutto il mondo, che avrebbe accolto con gran gioia la
distruzione se non fosse nato Cesare, la comune felicità di tutti; perciò
giustamente uno potrebbe ritenere che principio della vita e del vivere sia stato
per lui quello in cui ha smesso di affliggersi di esser nato”; cfr. S. MAZZARINO,
Il pensiero storico, cit., II 2 p. 387 sg.
A penetrare nell’atmosfera ufficiale di devoto attaccamento verso
l’imperatore e la sua famiglia ci è di guida anche un testo contenente le
deliberazioni prese nel 4 d.C. dalla colonia di Pisa in segno di lutto per la morte
di Gaio Cesare (C.I.L. XI 1421 = I. L. S. 140): ..... cum a. [d. II]II nonas Apriles (il
2 aprile) allatus esset nuntius C. Caesarem, Augusti patris patriae [po]ntif. maxsumi
189
custodis imperi Romani totiusque orbis terrarum praesi[dis filium, divi nepotem, post
consulatum quem ultra finis extremas populi Ro]mani bellum gerens feliciter peregerat, bene
gesta re publica, devicteis aut in [fid]em receptis bellicosissimis ac maxsimis gentibus, ipsum
volneribus pro re pu[bli]ca exceptis ex eo casu crudelibus fatis ereptum populo Romano, iam
designatu[m i]ustissimum ac simillumum parentis sui virtutibus principem coloniaeque
no[st]rae unicum praesidium, eaque res nondum quieto luctu, quem ex decessu [L.
C]aesaris fratris eius, consulis designati auguris patroni nostri prin[c]ipis [iu]ventutis,
colonia universa susceperat, renovasset multiplicassetque ma[er]orem omnium singulorum
universorumque, ob eas res universi decurio[ne]s colonique .... consenserunt ..., oportere ex ea
die, qu[a ei]us deces(s)us nuntiatus esset usqu[e] ad eam diem qua ossa relata atque
co[nd]ita iustaque eius manibus perfecta essent, cunctos veste mutata, templisqu[e d]eorum
immortalium balneisque publicis et tabernis omnibus clausis, co[nv]ictibus sese apstinere,
matronas quae in colonia nostra sunt sublugere di[em]que eum quo die C. Caesar obit, qui
dies est a. d. VIIII K. Mart(ias) (il 21 febbraio), pro Alliensi lu[gub]rem memoriae
prodi, notarique in praesentia omnium iussu ac vo[lun]tate caverique, ne quod sacrificium
publicum neve quae supplica[tio]nes nive sponsalia nive convivia publica postea in eum diem
eo[ve d]ie qui dies erit a. d. VIIII K. Mart(ias) fiant concipiantur indicantu[rve], nive qui
ludi scaenici circiensesve eo die fiant spectenturve.
Sulle imprese militari di Augusto, da lui stesso elencate nell’Index a
partire dal cap. 26, v. p. es. l’ampio commentario del MOMMSEN nella seconda
edizione delle Res gestae, Berlin 1883. In particolare, per la sua politica con i
Parti (su cui v. p. es. D. MAGIE, Roman rule, cit. I, p. 482 sgg.; II, p. l343 sgg.) è
da tener presente anche la documentazione numismatica rappresentata, fra
l’altro, da due denarii (cfr. H. MATTINGLY, Coins of the Roman empire in the British
Museum, vol. I, p. 3 sg.) dei quali l’uno raffigura un Parto in ginocchio, che
porge un vessillo, e reca la leggenda CAESAR AUGUSTUS SIGN(IS)
RECE(PTIS), l’altro raffigura un re armeno in ginocchio e reca la leggenda
CAESAR DIVI F(ILIUS) ARME(NIA) CAPT(A). Su Arminio e l’abbandono
della politica di conquista in Germania, E. HOHL, in “Hist. Zeitschr.” 1943, p.
457 sgg.; ID. in “Sitzb. Deutsch. Ak. Berlin” 1951, p. 1 sgg.
Per gli sviluppi del problema successorio, di recente L. LESUISSE,
L’aspect héréditaire de la succession impérial sous les Julio-Claudiens, in “Les Étud.
Class.” XXX (1962) p. 32 sgg.
190
XI
Consolidamento del regime imperiale.
I giulio-claudi.
1. La personalità e il programma di Tiberio. - Il trapasso
del principato nelle mani di Tiberio ebbe luogo senza
scosse. Era il momento più delicato per la continuità del
nuovo regime, ma Augusto con troppa cura aveva
predisposto ogni cosa perché potesse verificarsi qualche
sorpresa. Con i suoi poteri di correggente, Tiberio aveva
già nelle mani le leve dello Stato; l’unica incognita, ma solo
fino ad un certo punto, restava l’atteggiamento del senato,
cui spettava l’investitura ufficiale del nuovo imperatore.
Non era infatti da escludere che nel consesso potesse
delinearsi, se non addirittura una corrente favorevole alla
restaurazione della repubblica, almeno un movimento di
opposizione al nuovo principe ad opera di qualche
esponente della nostalgica nobilitas. Simili timori, che i fatti
ben presto dimostrarono vani, è incerto se e fino a qual
punto Tiberio realmente li concepisse. Così sembrerebbe
dai resoconti piuttosto tendenziosi che alcuni storici, a
cominciare da Tacito, ci hanno lasciato su questi
avvenimenti, ove a Tiberio si attribuisce una grande
ambizione mascherata da un’ancor più grande ipocrisia;
invece, a veder le cose senza malanimo, si trattava soltanto
della naturale circospezione da parte di Tiberio
nell’intavolare le prime relazioni col senato in veste di
principe, e il malanimo di Tacito verso Tiberio, a più di
mezzo secolo dalla sua morte, derivava dal giudicarlo
191
colpevole di essersi fatto strumento, proprio lui che era un
diretto discendente della più antica nobilitas, del definitivo
consolidamento del nuovo regime.
Legittimata dal senato la sua posizione di princeps,
Tiberio mostrò di concepire il potere imperiale in maniera
alquanto diversa dal suo predecessore. Legato per nascita
alle antiche tradizioni nobiliari e ad esse molto più sensibile
del padre adottivo, che proveniva da famiglia di sola dignità
equestre, Tiberio rinunciò ad alcuni di quegli attributi che
avevano sottolineato la preminenza personale di Augusto.
Pertanto ricusò il titolo (o meglio, il nome) di Imperator e
quello di pater patriae e fu anche incerto se accettare l’epiteto
di Augustus, ma poi si piegò ad assumerlo per non
scardinare le basi ideologiche del nuovo regime, anche se
fermamente rifiutò ogni forma ufficiale di onori divini. Il
suo ideale sarebbe stato quello di instaurare una stretta
collaborazione col senato nel governo dell’impero per
conservare a Roma e all’Italia l’antica posizione di
preminenza; ma il sistema del principato per sua natura
rendeva oltremodo difficile tale collaborazione, e Tiberio,
con tutto il suo buon volere, non ne ricavò che fama di
ambiguità e d’ipocrisia. Eppure per lunghi anni egli si
sobbarcò a una fatica per vari rispetti più difficile dell’opera
rivoluzionaria di Augusto, quella cioè di mantenere il
regime sui binari del “principato civile” resistendo a quanti
avevano interesse alla sua trasformazione in un assolutismo
dispotico.
2. L’opposizione senatoria e il lungo ritiro di Tiberio. - In
rispondenza con un simile programma di conservazione,
Tiberio proseguì una politica estera fatta di cautela e
moderazione. Ponendo un freno allo spirito avventuroso
del figlio adottivo Germanico, che da tre anni operava oltre
il Reno senza pervenire a risultati concreti e proporzionati
192
agli sforzi, egli considerò lavata l’onta di Teutoburgo con la
vittoria riportata nel 16 nel campo Idistaviso, e richiamò
Germanico per affidargli una missione diplomatica presso i
Parti. Raggiunto un accordo col re Artabano III, che aveva
inaugurato una politica nazionalistica di tendenze
apertamente antiromane, Germanico sulla via del ritorno
morì improvvisamente in Siria (a. 19). Alimentata da coloro
che odiavano Tiberio, si diffuse ben presto la voce che era
stato proprio lui a far togliere di mezzo il figlio adottivo,
geloso delle generali simpatie che quello riscuoteva a
preferenza di Druso, suo figlio naturale. Vere o infondate
che fossero queste dicerie, intorno alla famiglia di
Germanico si raccolse un circolo di opposizione che ben
presto fu bersagliato da una serie di processi di “lesa
maestà” ispirati dalle mire ambiziose di L. Elio Seiano, il
prefetto del pretorio di Tiberio.
Questo cavaliere, oriundo di Volsinii (Bolsena), dopo
essersi cattivate le simpatie del vecchio imperatore, si era
audacemente proposto d’impadronirsi in qualche modo del
potere facendo il vuoto nella famiglia imperiale, e per
prima cosa gli riuscì (a. 23) di eliminare col veleno Druso (il
figlio di Tiberio) dopo averne sedotta la moglie Livia, di cui
peraltro invano chiese la mano all’imperatore. Qualche
anno dopo, mentre Tiberio si ritirava a Capri nauseato dai
malintesi e dall’equivoco che sempre più avevano
caratterizzato i suoi rapporti col senato, Seiano metteva
nella peggior luce presso di lui la vedova di Germanico,
Agrippina, provocando la deportazione di lei e del figlio
maggiore. Nel 31 la potenza del prefetto toccò il culmine;
Tiberio lo innalzò a suo collega nel consolato e ormai tutto
sembrava autorizzarlo alle più rosee speranze. La
prolungata assenza dell’imperatore (erano quattro anni che
non rimetteva piede a Roma) già aveva fatto di Seiano
l’arbitro dell’Urbe e dell’impero; ora egli ritenne fosse
193
giunto il momento propizio per l’ultimo passo e ordì un
complotto per sbarazzarsi di Tiberio. Ma questi, messa
finalmente sull’avviso dalla cognata Antonia, la vedova di
suo fratello Druso, ebbe tempo di aprire gli occhi e, senza
abbandonare la sua solita cautela, di architettare un piano
per la cattura e la soppressione dell’infedele ministro (a.
31).
Le malefatte e il tradimento dell’uomo in cui aveva
riposto tanta fiducia resero sempre più cupo e sospettoso
l’ormai settantatreenne imperatore e lo spinsero a
restarsene lontano dagli intrighi della capitale soggiornando
a preferenza nell’isola di Capri. Secondo i malevoli racconti
di Tacito e di Svetonio, egli avrebbe consumato i suoi
ultimi anni nei più turpi piaceri, trascurando le cure di
governo e abbandonando Roma in preda al terrore di una
sequela di processi politici. Viceversa è un fatto che egli
continuò ad adempiere ai suoi doveri di principe, come
mostra il suo energico intervento nel 35 contro Artabano
III per impedirgli d’insignorirsi dell’Armenia.
Anche il pensiero della successione fu per Tiberio
causa di tormento. Costretto dai fondamenti ideologici del
principato, come già Augusto, a non uscire dalla cerchia
della famiglia imperiale, non aveva da scegliere che tra un
uomo maturo (Claudio, figlio di suo fratello Druso) e due
giovanissimi (Gaio, figlio di Germanico, e Tiberio
Gemello, figlio di suo figlio Druso). Scartato il primo
perché gli sembrava inetto al grave compito, non seppe
decidersi fra gli altri due, e si astenne da una designazione
preferenziale pur prevedendo che la successione sarebbe
andata al maggiore d’età, Gaio, inviso a lui ma largamente
popolare come figlio di Germanico. E proprio Gaio
s’impadronì del potere all’indomani della sua morte,
avvenuta in una villa presso Miseno il 16 marzo del 37.
194
3. L’esperimento assolutistico di Caligola (37-41). - Quando
all’età di 25 anni assumeva il principato nelle forme ormai
consuete (investitura del senato, giuramento di fedeltà dei
magistrati, dei cittadini, dei provinciali, oltre che dei
soldati), Gaio, che era stato sempre tenuto nell’ombra da
Tiberio, non aveva dato alcuna prova di sé. Ma, come figlio
di Germanico, aveva dalla sua il favore del popolo e
soprattutto dell’esercito. Erano stati i soldati ad affibbiargli
l’affettuoso nomignolo di “scarponcino” (Caligola è da
càliga, la calzatura dei legionari con cui, da bambino, aveva
fatto la sua apparizione al seguito del padre durante le
campagne oltre il Reno del 14-16),e le simpatie si erano
moltiplicate dopo l’immatura morte di Germanico e le
persecuzioni subite dalla sua famiglia ai tempi di Seiano.
Il suo avvento fu salutato con favore anche dai ceti
più elevati, che auspicavano un cambiamento dei sistemi
piuttosto duri instaurati da Tiberio negli ultimi anni, e in
effetti il giovane principe ispirò i primi mesi di governo ad
una politica moderata e, almeno apparentemente, liberale
arrivando finanche a ripristinare i comizi popolari. Ma di lì
a poco si verificò un totale rivolgimento e Caligola scivolò
rapidamente verso uno sfrenato assolutismo, che si
manifestò anche nell’imporre il culto divino della sua
persona (giunse anche a progettare d’introdurre una sua
statua nel tempio di Gerusalemme, e fu solo per la sua
morte repentina che fu evitata una tragedia). Attento a
blandire il popolino con la più bassa demagogia, in rotta
con la nobiltà vessata nelle persone e negli averi (le
confische erano diventate un cespite ordinario per
sopperire ai bisogni di una politica di larga spesa),
l’imperatore non seppe nemmeno sfruttare l’enorme
potenziale bellico di cui disponeva per rinverdire la gloria
militare ereditata dal padre. Nel 39 passò il Reno alla testa
di un forte esercito, ma poco dopo rientrò in Gallia senza
195
aver nulla concluso; l’anno appresso mise in moto una
grossa spedizione per la conquista della Britannia, ma
nemmeno questa volta, pare, con serietà d’intenti.
In quegli anni l’impero andò avanti per forza
d’inerzia; unica via d’uscita era la morte dell’imperatore e,
dopo il fallimento di due congiure, una terza riuscì e
Caligola fu soppresso (24 gennaio del 41).
4. L’avvento di Claudio e i primi sviluppi della burocrazia. La congiura, cui avevano partecipato elementi dell’ordine
senatorio, cavalieri e liberti del palazzo imperiale, si era
prefissa soltanto l’eliminazione di Caligola, senza
affrontare, come sembra, il problema della successione. Ma
era un problema che s’imponeva con tutta l’urgenza e il
senato, immediatamente convocato dai consoli in
Campidoglio, prese a dibatterlo esaminando anche,
nientemeno, l’opportunità di una restaurazione del regime
repubblicano. Per noi è difficile dire quanti fossero i fautori
di un simile indirizzo politico, che a un pacato esame della
situazione non poteva apparire che un’utopia. Si trattava, in
breve, di sovrapporre all’edificio pazientemente costruito
da Augusto, e collaudato dalle prove di vari decenni, quelle
stesse pericolanti strutture sulle cui rovine Augusto aveva
edificato. Pertanto è da ritenere che la grande maggioranza
del senato, lasciando cadere il progetto di una riforma
costituzionale, si sia piuttosto soffermata sulla scelta di una
personalità capace di raccogliere l’eredità dei Cesari e di
continuarne l’opera nel maggior rispetto dei suoi privilegi.
Però, assai prima che fra i senatori si delineasse un accordo,
i pretoriani davano al problema la loro soluzione
acclamando imperatore Claudio, fratello di Germanico e
zio di Caligola, e il senato dové piegarsi a riconoscere il
fatto compiuto, mostrando quanto fosse infondata la
196
speranza sia di un cambiamento di regime, sia di avere un
successore estraneo alla famiglia imperiale.
Claudio aveva allora 51 anni; appassionato di studi
storici (era stato istruito da Tito Livio) e amante
dell’erudizione, era vissuto appartato dalla vita pubblica,
alla quale sembrava negato soprattutto per certi difetti che
ne compromettevano la prestanza fisica. Suo zio Tiberio lo
aveva giudicato inetto a succedergli, anche per la debolezza
del carattere; ma si trattava di persona tutt’altro che
sprovveduta, e debbono considerarsi esagerazioni malevole
quelle degli autori antichi che lo descrivono come uno
sciocco e un incapace. Se si tralasciano le poco onorevoli
traversie in cui lo coinvolsero le malefatte delle mogli
Messalina e Agrippina, Claudio appare, tra i principi della
casa giulio-claudia, uno dei più validi continuatori
dell’opera di Augusto.
Fedele alla concezione del “principato civile”, egli si
preoccupò infatti di consolidare il regime rendendolo più
efficiente mediante la creazione di una burocrazia capace di
coadiuvare l’imperatore nel disbrigo dei molteplici affari di
governo. Per le varie branche dell’amministrazione furono
istituiti appositi uffici, e la direzione ne venne affidata non
a personaggi dell’ordine senatorio o equestre, ma a liberti
della famiglia imperiale. Come nelle case della più ricca
nobiltà una schiera di liberti e servi sbrigavano le più
diverse incombenze, così servi e liberti imperiali
accudivano nel palazzo alle più svariate mansioni, e poiché
non esisteva una delimitazione precisa tra affari pubblici e
privati dell’imperatore, alcuni di questi liberti, da segretari
privati, si trasformarono in veri e propri funzionari
imperiali. Si ebbe così un liberto a rationibus, capo dei
servizi finanziari, un liberto a cognitionibus, preposto al
funzionamento del tribunale imperiale (ufficio destinato ad
assumere importanza sempre maggiore con lo allargarsi
197
della diretta ingerenza del principe nella amministrazione
della giustizia), un liberto ab epistulis per la corrispondenza
ufficiale dell’imperatore, un liberto a libellis (suppliche e
petizioni in genere); e alcuni capi di questi uffici, come
Pallante, Polibio, Narcisso e Callisto, raggiunsero una
potenza pressoché illimitata. Questi “ministri”, che per le
loro origini non si sentivano vincolati al rispetto delle
tradizioni nobiliari, seppero infondere nella politica di
Claudio una tendenza innovatrice che si manifestò, per es.,
nel conferimento ai notabili della Gallia del diritto di
accedere alle magistrature e al senato (e invano la gelosa
nobilitas cercò dì opporvisi), in larghe concessioni della
cittadinanza romana a provinciali, nell’accrescere
l’importanza dei cavalieri ammettendoli al governo di
alcune province minori col titolo di procuratores.
5. Le altre realizzazioni di Claudio. - Anche nella politica
estera la burocrazia di palazzo fece sentire la sua influenza,
e fu sotto la spinta di Narcisso che Claudio si decise a
intervenire in Britannia, per regolare una contesa dinastica
tra due capi locali, e quindi a organizzare un corpo di
spedizione che intraprese l’assoggettamento dell’isola.
Dopo i successi del primo anno di guerra (43) veniva
ridotta a provincia la regione sud-orientale, e mentre
Claudio celebrava uno splendido trionfo, aveva inizio una
serie di campagne per allargare la conquista e difenderla
dalla minaccia delle popolazioni che premevano dal nord.
Per il resto Claudio si attenne, sulle orme di Augusto e di
Tiberio, a una prudente difesa dei confini, rinforzando le
fortificazioni sul Reno e sul Danubio e riducendo nella
condizione di provincia il regno vassallo di Mauretania, ove
era scoppiata una violenta rivolta antiromana. Meno
fortunata fu la sua azione per affermare il prestigio di
Roma nei confronti dei Parti; questi, anzi, sotto il re
198
Vologese I recuperarono il loro predominio sull’Armenia
gettando le premesse di un nuovo conflitto.
Una cura particolare fu dedicata allo sviluppo delle
opere pubbliche, fra cui si ricorderà la costruzione di due
nuovi acquedotti, la sistemazione di un nuovo porto ad
Ostia, il prosciugamento nell’Abruzzo, presso Avezzano,
del lago Fucino (che se anche non riuscì completamente,
rimane una delle opere più ammirevoli dell’antica
ingegneria idraulica); in somma, tutto un fervore di opere
in relazione con la vigorosa ripresa economica dopo gli
sprechi di Caligola.
Durante il principato di Claudio, verso il 49, si ebbe
in Roma il primo provvedimento anticristiano. Le sue
prime persecuzioni (o, piuttosto, vessazioni) il
cristianesimo le aveva subite ad opera soprattutto dei
Giudei, e - secondo alcuni - per reazione a questa ostilità
l’imperatore Tiberio, visto che le aspettazioni messianiche
dei cristiani non erano rivolte contro l’autorità romana,
mentre l’intransigenza religiosa dei Giudei spesso
esplodeva in sommosse antiromane, avrebbe proposto nel
35 al senato di riconoscere la nuova fede come religio licita.
Il senato però avrebbe negato il prescritto riconoscimento
ufficiale, lasciando il cristianesimo nella condizione di
superstitio illicita (e, in quanto tale, perseguibile).
Mentre l’intervento favorevole di Tiberio rimane
dubbio, è invece un fatto che Claudio, come si legge in
Svetonio (Claud. 25), “espulse da Roma i Giudei che
incessantemente tumultuavano aizzati da un certo
Chresto”. Nel riportare tale notizia, Svetonio, o meglio la
sua fonte, non comprese che in realtà non si trattava di una
delle solite insurrezioni dei Giudei, capeggiata questa volta
da un agitatore di nome Chresto, ma di disordini provocati
in seno alla comunità giudaica di Roma dall’attiva
propaganda dei primi fedeli di Cristo. Quanto poi al
199
drastico provvedimento di Claudio, è chiaro che egli lo
adottò senza potersi render conto che dietro a quelle
infrazioni contro l’ordine pubblico fermentava un
movimento spirituale capace di realizzare la trasformazione
del mondo antico.
Di non poco detrimento fu per Claudio la condotta
della moglie Valeria Messalina, non solo per il disonore
nella vita privata, ma anche per il capriccioso
procacciamento di cariche e onori ai suoi favoriti, senza
che l’imperatore riuscisse a tenerla a freno. Nel 48,
invaghitasi di C. Silio, un ambizioso patrizio, Messalina non
esitò a sposarsi segretamente con lui accordandosi per la
destituzione di Claudio; questa volta però, messo
sull’avviso da Narcisso, l’imperatore riuscì a superare la
solita debolezza verso la moglie e lasciò che fosse
soppressa.
Per nulla più rispettabile si dimostrò Giulia
Agrippina, che Claudio (pur essendo suo zio) sposò l’anno
dopo; si trattava, inoltre, di una donna molto ambiziosa
che, per essere figlia di Germanico e di Vipsania Agrippina
(e, dunque, diretta discendente di Augusto), riteneva di aver
diritto a un posto di primo piano nella vita dell’impero. Dal
precedente marito Agrippina aveva avuto un figlio, L.
Domizio Enobarbo, ed ella si propose di assicurargli la
successione al principato a danno dei due figli di Claudio e
Messalina, Tiberio Claudio Britannico e Ottavia. Dopo
aver fatto fidanzare con Ottavia il giovanissimo Domizio,
ottenne l’anno dopo (50) di farlo adottare da Claudio (onde
quello cambiò il suo nome in Nerone Claudio Druso
Germanico Cesare) e quindi di metterlo sullo stesso piano
di Britannico (ma col vantaggio di avere quattro anni di
più). Naturalmente queste manovre suscitarono la reazione
di quanti erano interessati alla successione di Britannico, tra
cui il potente Narcisso; ma quando Agrippina si accorse
200
che il suo piano stava per fallire, non ebbe scrupolo di fare
avvelenare Claudio. Con l’appoggio di Afranio Burro, il
prefetto del pretorio che doveva la nomina al suo favore,
fece sì che il figlio fosse acclamato imperatore dai
pretoriani di guardia al palazzo; e anche il senato, come già
era accaduto per Claudio, non potette che limitarsi a dare il
suo riconoscimento (13 ottobre 54).
6. Nerone e il consolidarsi dell’assolutismo. - Il potere
imperiale era così venuto nelle mani di un giovane appena
diciassettenne, ma gl’inizi del nuovo principato, oltre che
dal giubilo popolare, furono accompagnati dalle più liete
speranze della nobiltà. Forte dell’appoggio devoto e
autorevole di Afranio Burro, Nerone risentiva anche i
benefici influssi dell’alta personalità del suo precettore, il
filosofo Seneca, ed egli inaugurò il suo governo con la
solenne dichiarazione di voler rispettare le attribuzioni del
senato e dei magistrati e di voler tenere ben distinte la sua
domus e la res publica (ciò che il predecessore non aveva
fatto). Però a questo impegno, che pareva tradurre in atto
la dottrina stoica del suo maestro sul “governo dell’uomo
migliore”, Nerone rimase fede le solo per alcuni anni.
Il suo cattivo genio fu dapprima la madre Agrippina;
ostacolata nelle mire di imporre i suoi voleri come reginamadre, costei intraprese un pericoloso gioco minacciando
di appoggiare le rivendicazioni dinastiche di Britannico, ma
con l’unico risultato di provocarne l’eliminazione da parte
del fratellastro. Per le stesse ragioni, quattro anni dopo
(59), Agrippina fu irremovibile nell’opporsi all’ingresso
nella famiglia imperiale di una donna ambiziosa come
Poppea Sabina; ma Nerone, che era fermamente deciso a
ripudiare Ottavia per sposarla, non indietreggiò dinanzi al
matricidio e la fece assassinare. Ufficialmente si parlò di
suicidio: Agrippina si sarebbe tolta la vita per il fallimento
201
di un suo complotto contro il figlio, ed essendo noti i suoi
intrighi la voce trovò credito; del resto la sua scomparsa fu
generalmente accolta con grande sollievo. Purtroppo, era
un gran freno che veniva a mancare per Nerone, ed egli
cominciò a sottrarsi a mano a mano anche al controllo di
Seneca e di Burro. Questi morì nel 62 (avvelenato, si disse),
e poco dopo, avendo anche Seneca lasciato il suo ufficio a
corte, il regime neroniano subiva un radicale mutamento di
indirizzo. Fino a quel momento esso era stato ispirato da
una tendenza nettamente favorevole agl’interessi della
classe senatoria, riconoscibile soprattutto in provvedimenti
di carattere finanziario, come la restituzione al senato del
diritto di emettere moneta d’oro e d’argento (aurei e denarii;
la concessione risulta poi revocata intorno al 62-63), o la
proposta, poi non attuata, di un’abolizione delle imposte
indirette. Al contrario nel 64 venne effettuata una riforma
monetaria consistente nel ridurre di peso sia l’aureus sia il
denarius, con profitto non solo dello Stato, ma anche della
piccola e media borghesia; questa infatti aveva nel denarius
la sua moneta, ed ora il rapporto fra oro e argento risultava
mutato a favore di quest’ultimo.
Animato da una grande passione per la poesia e
dotato di un certo talento istrionico, il principe non ebbe
ritegno di esibirsi in pubblico e di blandire le masse
popolari, cercando anche di diffondere un’atmosfera di
gusti ellenizzanti propizia alle sue pretese di assolutismo.
Ma, a parte l’odiosità attiratasi con l’uccisione di Ottavia,
falsamente accusata di adulterio, la necessità di spremere
denaro da ogni parte per alimentare la sua vita fastosa gli
alienò anche le simpatie popolari, e quando, nel luglio del
64, Roma fu in gran parte distrutta da un terribile incendio,
la voce pubblica lo additò come colpevole del disastro. Si
disse che, mentre le fiamme divoravano gli edifici, egli ne
traesse ispirazione per cantare la caduta di Troia, o anche
202
che aveva gettato nel lutto tante famiglie per il capriccio di
ricostruire più bella la città; tutte cose assai probabilmente
non vere, ma che gli fecero temere una sommossa, onde
cercò di placare gli animi addossando ai cristiani la
responsabilità del flagello.
7. Dalla prima persecuzione cristiana alla fine di Nerone. Già da qualche tempo l’opinione pubblica era ostile alla
comunità cristiana, considerata una raccolta di malfattori e
di “odiatori del genere umano”. Per volere di Nerone, che
cercava anche con questo mezzo di blandire le masse,
l’autorità stava dando libero corso alle accuse contro i
cristiani, rei di professare una religione non ufficialmente
ammessa (superstitio illicita), e incolpati di ateismo (essi
veneravano un solo Dio e non riconosciuto), di lesa maestà
e di tradimento dei costumi nazionali. Ora poi venne
scatenata la persecuzione, per fortuna limitata alla sola città
di Roma, e secondo la tradizione cristiana, non molto
distante dai fatti e pienamente attendibile, subirono allora il
martirio gli apostoli Pietro e Paolo.
L’anno dopo la scoperta di una vasta congiura ordita
dal consolare C. Calpurnio Pisone diede l’avvio a un nuovo
bagno di sangue (anche Seneca fu costretto ad aprirsi le
vene), e la repressione fu tanto più spietata quanto
maggiori erano le sostanze da confiscare ai condannati.
Preso da una frenesia di godimenti e di piaceri,
Nerone dedicò i due anni successivi (66-67) ad un viaggio
in Grecia, ove partecipò ai giuochi istmici e a varie gare,
naturalmente mietendo allori dovunque ed esaltandosi al
punto di concedere la libertà alla Grecia. Questa
concessione fece aumentare il malcontento delle altre
province, oppresse dal più rapace fiscalismo per contribuire
al fasto della corte imperiale, e specialmente delle province
203
occidentali, ove ben presto scoppiarono vari moti di
ribellione.
Il primo a sollevarsi fu il governatore della Gallia
Lugdunense C. Giulio Vindice, un senatore di origine
gallica, e poco dopo all’insurrezione si unirono Ser.
Sulpicio Galba, che reggeva la Spagna citeriore e M. Salvio
Otone, governatore della Lusitania. Vindice fu battuto
dall’esercito di Germania rimasto fedele a Nerone, ma
Galba alla testa delle sue legioni passò in Italia senza
incontrare ostacoli. Nerone poteva contare sull’appoggio
dei pretoriani, ma quando anche questi si ribellarono e
(allettati dalla promessa di un forte donativum) acclamarono
imperatore Galba, non gli rimase che togliersi la vita (9
giugno del 68).
Troppo solide erano ancora le fondamenta
dell’edificio imperiale se esso riuscì ad emergere indenne
dal malgoverno neroniano. Le antiche tradizioni
saldamente radicate in tanta parte della nobiltà, l’infaticabile
intraprendenza della borghesia, l’efficienza degli eserciti
erano evidentemente forze tali da operare quasi
automaticamente in favore della conservazione dell’impero
nonostante le carenze del governo centrale. Così il valente
generale Cn. Domizio Corbulone, al termine di una lunga e
brillante campagna, ottenne che il principe partico Tiridate
si assoggettasse a ricevere la corona dell’Armenia dalle
mani di Nerone come suo vassallo (a. 66). Venne anche
rinsaldato, dopo il fallimento della rivolta capeggiata dal la
regina Budicca (a. 60-61) il dominio sulla Britannia, mentre
fu assai più difficile venire a capo della grande insurrezione
giudaica scoppiata nel 66 e destinata a cessare solo quattro
anni dopo con l’assedio e la distruzione di Gerusalemme. E
quando, con Nerone, si estinse la famiglia giulio-claudia e
scomparve l’ultimo detentore della auctoritas augustea per
privilegio ereditario, quelle stesse forze fecero sì che
204
l’inevitabile crisi si componesse rapidamente in un nuovo
assetto che, senza rinnegare il passato, assicurava l’apporto
di fresche energie alle fortune dell’impero.
Tra le principali fonti letterarie a noi pervenute sul principato di Tiberio
figurano l’operetta del contemporaneo Velleio Patercolo, pubblicata nell’anno
30, e poi opere del II sec. (gli Annales di Tacito, libb. I-VI; la Vita di Svetonio)
e del III sec. (la Storia Romana di Cassio Dione, libb. LVII e LVIII). Com’è
noto, lo scritto di Velleio Patercolo è ispirato da una “tendenza” encomiastica
in netto contrasto con quella più o meno accentuatamente sfavorevole che
anima gli autori posteriori, a cominciare da Tacito: donde un grosso problema
critico che parte dalla ricerca delle fonti primarie e si sviluppa nell’analisi dei
diversi interessi materiali e delle varie istanze ideologiche che confluirono nel
determinare la fisionomia dei singoli filoni della tradizione. La bibliografia sugli
autori citati è vastissima; qui basterà rinviare a S. MAZZARINO, Il pensiero storico
classico, cit., II, 2.
Tra le numerose monografie dedicate a studiare complessivamente la
figura e l’opera di Tiberio, v. F.B. MARSH, The reign of Tiberius, London 1931; E.
CIACERI, Tiberio successore di Augusto, Milano 19442.
Di grande interesse, e assai dibattuto, è il problema sulla posizione
ufficiale che Tiberio aveva al momento di assumere la successione.
Fondamentale su questo punto è il passo di Velleio Patercolo (II 121): cum ...
senatus populusque Romanus postulante patre eius (cioè Augusto), ut aequum ei (cioè a
Tiberio) ius in omnibus provinciis exercitibusque esset, quam erat ipsi, decreto complexus
esset (etenim absurdum erat non esse sub illo, quae ab illo vindicabantur, et qui ad opem
ferendam primus erat, ad vindicandum honorem non iudicari parem). Il conferimento a
Tiberio (decretato dal senato nell’anno 13 d.C. a richiesta di Augusto) di un
aequum ius in omnibus provinciis exercitibusque introduceva nell’esercizio del potere
imperiale, in luogo della precedente collegialità disuguale, una collegialità uguale
(ad vindicandum honorem parem)? Stante l’estrema vecchiezza di Augusto, il
problema non può evidentemente avere riflessi di carattere sostanziale ma
soltanto formale, e sotto questo rispetto si deve rispondere che all’ideologia del
potere imperiale allora vigente l’ipotesi di una collegialità uguale non poteva
non essere estranea. In proposito, v., di recente, D. TIMPE, Untersuchungen zur
Kontinuität des frühen Prinzipats, in “Historia” Suppl. V (1962); L. DUPRAZ,
Autour de l’association de Tibère au principat, in “Mus. Helv.” 1963, p. 172 sgg.
Sull’articolarsi dell’opposizione a Tiberio, da un lato, negli stessi
ambienti di palazzo, una corrente fautrice di una politica di dichiarato
assolutismo (capeggiata da Antonia, figlia del triumviro e vedova di Druso
maggiore, e pertanto cognata di Tiberio), dall’altro la “resistenza” dei circoli
senatorii, v. W. ALLEN, The political atmosphere of the reign of Tiberius, in “Trans.
Proc. Amer. Phil. Ass.” LXXII (1941) p. 1 sgg. Lo studio dei rapporti tra
principe e senato ha dato stimolo a vari lavori dedicati a una presentazione
panoramica dei personaggi che componevano l’assemblea e di cui si sia
205
conservato il ricordo. Tali lavori, in ultima analisi, rientrano nella più ampia
cornice delle ricerche di carattere prosopografico, intese cioè ad offrirci una
serie alfabetica di “medaglioni” ridotti all’essenziale dei personaggi grandi e
piccoli del mondo romano antico (E. KLEBS, H. DESSAU, P. VON ROHDEN,
Prosopographia imperii Romani saec. I-III, Berolini 1897-98; in corso di
pubblicazione la seconda edizione iniziata nel 1933 da E. GROAG e A. STEIN e
giunta ora alla lettera I (Berolini 1966). Per quanto riguarda la composizione del
senato nell’età giulio-claudia, v. S.J. DE LAET, De Samenstelling van den Romeischen
Senaat gedurende de eerste eeuw van het Principat (28 voor Ch., 68 na Chr.),
Antwerpen 1941; LT. SCHNEIDER, Zusammensetzung des römischen Senates von
Tiberius bis Nero, Diss., Zürich 1942.
Sulla posizione che, scostandosi da quella di Augusto, Tiberio assunse
di fronte al potere imperiale, sono assai significativi sia i suoi atteggiamenti
contrari agli onori divini (v. M. ROSTOVZEV, L’empereur Tibère et le culte imperial,
in “Rev. hist.” 1930 p. 26 sgg.), sia la rinuncia a certe mediazioni per una più
larga intesa tra classi sociali, in particolare fra ordine senatorio e ordine
equestre; illuminante su questo punto l’abbandono del sistema introdotto da
Augusto per la destinatio dei magistrati più elevati (v. cap. prec.).
Per l’iniziativa di Tiberio, favorevole al riconoscimento del
cristianesimo come religio licita, il punto di partenza è un passo di Tertulliano
(Apol. V 2 sg.): Tiberius ergo, cuius tempore nomen Christianum in saeculum introivit,
adnuntiata sibi ex Syria Palaestina, quae illic veritatem ipsius divinitatis revelaverant,
detulit ad senatum cum praerogativa suffragii sui. Senatus, quia non ipse probaverat, respuit.
Caesar in sententia mansit, comminatus periculum accusatoribus Christianorum. Ciò che
soprattutto lascia dubbiosi circa l’attendibilità di questa notizia è la necessità di
ammettere che in un senatusconsultum dell’età di Tiberio - cui il dato di
Tertulliano dovrebbe risalire - si sapesse far chiaramente quella distinzione fra
Giudei e Cristiani che invece risulta ancora oscura ai tempi di Claudio.
Per il principato di Caligola, fonti principali restano la Vita svetoniana e
il lib. LIX di Cassio Dione, mentre il racconto di Tacito è andato interamente
perduto nella lacuna che ha inghiottito i libb. VII-X degli Annales. Tra le opere
dedicate a uno studio complessivo dell’opera e della personalità di Caligola, si
ricorda quella di J.P.V.D. BALSDON, The emperor Gaius, Oxford 1934. Nel
parlare di una sua “pazzia” le fonti, specie Svetonio, hanno esasperato
l’espressione della loro ostilità verso l’indirizzo assolutistico impresso al
governo imperiale. Una delle linee direttrici del nuovo regime fu la netta
contrapposizione ai precedenti tiberiani, ed è sotto questa luce che si deve
valutare la restaurazione dei comizi popolari, che Tiberio aveva finito per
abolire come ormai superati dalla situazione costituzionale creata dal
principato. Uno degli aspetti più caratteristici della nuova concezione teocratica
del potere imperiale si riflette in un passo della Vita di Svetonio (Calig. 35, 3)
ove nella cornice di un episodio di crudeltà e di capriccio è in realtà da scorgere
un intervento dell’imperatore per regolare l’arcaico sacerdozio del rex
Nemorensis, intervento cui egli si indusse per essersi identificato con Iuppiter
Latiaris (cfr. S. MAZZARINO, Trattato cit. p. 167).
206
Per il principato di Claudio fonti principali restano gli Annales di Tacito
(libb. XI e XII, relativi agli anni dal 47 al 54), la Vita di Svetonio, Cassio Dione
nei libb. LX e LXI (quest’ultimo nell’epìtome di Xifilino). Da ricordare anche
l’Apocolokyntosis di Seneca, in cui raggiunge i toni più aspri la “tendenza” delle
fonti generalmente avversa alla figura di Claudio. Questa è stata nell’insieme
largamente rivalutata dalla storiografia moderna; cfr., p. es., V. M. SCRAMUZZA,
The emperor Claudius, Cambridge Mass., 1940; T.F. CARNEY, The changing picture of
Claudius, in “Acta Class.” III (1960) p. 94 sgg.
Sulla realizzazione di Claudio che più appare meritevole di favorevole
apprezzamento, vale a dire l’impianto di un organismo burocratico capace di
assicurare una maggiore efficienza nel funzionamento dell’amministrazione
imperiale, v. in generale H.-G. PFLAUM, Les procurateurs équestres sous le HautEmpire romain, Paris 1950, p. 36 sgg. Nel quadro di questa attività di
potenziamento e di riorganizzazione degli organi di governo, una cura
particolare fu dedicata a migliorare il funzionamento degli uffici annonarii e
delle distribuzioni di frumento (frumentationes) che si tenevano periodicamente e
gratuitamente a beneficio dei cittadini di Roma: un impegno fattivo che
peraltro non giunse all’abolizione della praefectura frumenti dandi a suo tempo
istituita da Augusto (cfr. G. VITUCCI, Nota al cursus honorum di L.Iulius
Romulus ecc. in “Riv. Filol.”, 1947, p. 252 sgg.
Un altro degli aspetti più notevoli dell’attività novatrice di Claudio, la
sua politica di apertura verso le istanze dei maggiorenti della Gallia, ci è
testimoniato, oltre che dal racconto di Tacito (Ann. XI 23-25), anche da un
documento di primario interesse, la cosiddetta tabula Claudiana di Lione (C.I.L.
XIII 1668= I.L.S. 212), un’epigrafe che ha parzialmente conservato il testo del
discorso pronunziato in senato dall’imperatore nell’anno 48 per sostenere la
sua proposta de iure honorum Gallis dando.
Sulla conquista della Britannia, dopo HAVERFIELD, The Roman occupation
of Britain, Oxford 1924, si veda E. Birley, Roman Britain and the roman army,
Kendal 1953.
Per il principato di Nerone fonti principali restano i libb. dal XIII al
XVI degli Annales di Tacito (il lib. XVI s’interrompe ai fatti dell’anno 66), la
Vita di Svetonio, Cassio Dione (libb. LXII e LXIII nell’epìtome di Xifilino) e
vari accenni negli scritti di Seneca. L’esame critico della tradizione
rappresentata da questi autori è oggetto di un’apposita ricerca di K. HEINZ,
Das Bild Kaisers Nero bei Seneca, Tacitus, Sueton und Cassius Dio, Diss., Bern 1946,
ed è anche alla base della ricostruzione della figura e dell’opera di Nerone fatta
da M.A. LEVI, Nerone e i suoi tempi, Milano 1949. V. anche G. WALTER, Néron,
Paris 1955. Particolari aspetti di vita romana in età neroniana (e non nel III
sec., come volle anche il Niebuhr) si riflettono nel Satyricon di Petronio; cfr. S.
MAZZARINO, Trattato cit., p. 171 sg.
Sui primi anni di governo “costituzionale”, fino a quando non scoppiò
insaziabile il dissidio con l’assemblea senatoria, cf. F.S. LEPPER, Some reflections
on the quinquennium Neronis, in “Journ. Rom. Stud.” XLVII (1957), p. 95 sgg. La
svolta in senso assolutistico, preceduta dal matricidio e dall’allontanamento di
207
Seneca, si sviluppò attraverso una serie di provvedimenti che, mentre
danneggiavano la classe nobiliare, parallelamente favorivano l’economia dei ceti
inferiori. Dopo un fallito tentativo di riforma tributaria consistente
nell’abolizione delle imposte indirette, come i dazi e le dogane, una delle tappe
più significative di questo sviluppo fu la riduzione del peso dell’aureus da 1/40 a
1/45 di libbra (cioè da grammi 7, 70 circa a g. 7, 30 circa) e del denarius da 1/84
a 1/96 di libbra (cioè da grammi 3,90 circa a g. 3, 40 circa). Fu un’operazione
che si svolse a tutto vantaggio dello Stato (cioè dell’imperatore, che con la
stessa quantità d’oro emetteva adesso non più 40, ma 45 aurei, e con la stessa
quantità d’argento non più 84, ma 96 denarii) e della piccola borghesia che, per
pagare i suoi debiti ai ricchi signori, disponeva ora di un nominale - il denarius di diminuito valore reale (cfr E.A. SYDENHAM, The coinage of Nero, London
1920; L.C. WESP, Gold and silver coin standards in the Roman empire, New York
1941). Un altro provvedimento importante nel campo dell’amministrazione
finanziaria era stato quello di sottrarre la gestione del vecchio Tesoro (aerarium
Saturni) ai magistrati che la esercitavano per antica tradizione (i questori, poi
per qualche tempo, i pretori) e di affidarla a due funzionari imperiali, i praefecti
aerarii Saturni (TAC., XIII 28 sg.).
Sull’incendio di Roma, che certamente non fu doloso, e la persecuzione
dei Cristiani, v. F.W. CLAYTON, Tacitus and Nero’s persecutions of the Christians, in
“Class. Quart.”, XLI (1947), p. 8l sgg.; K. BUCHNER, Tacitus über die Christen, in
“Aegyptus”, XXXIII (1953) p. 181 sgg.; J. BEAUJEU, L’incendie de Rome en 64 et
les Chrètiens, in “Latomus”, XIX (1960) p. 65 sgg., 291 sgg.
208
XII
Dai Flavi agli Antonini.
L’ascesa della borghesia italica e provinciale.
1. La svolta degli anni 68-69. - Alla morte di Nerone
quattro principi si susseguirono nel giro di un anno e
mezzo alla testa dell’impero contendendosi il primato con
l’appoggio degli eserciti: nella carenza di un prestigio
personale, sia pure ereditario, il nuovo imperator non poteva
affermarsi che con la forza delle armi vittoriose.
Al vecchio Galba, che non aveva saputo destreggiarsi
tra le opposte fazioni del senato, e per di più aveva
disgustato i pretoriani con la sua severità, le maggiori
difficoltà cominciarono a venire dagli eserciti di Germania,
verso i quali aveva mostrato la sua avversione per il
soffocamento del moto di Giulio Vindice. Questi eserciti
acclamarono imperatore il loro comandante A. Vitellio e si
prepararono a marciare su Roma, ove qualche giorno dopo
una tempesta ancora più rovinosa si abbatteva sul capo di
Galba. Infatti nel gennaio del 69 i pretoriani insorgevano
contro di lui, l’assassinavano ed acclamavano imperatore
Salvio Otone.
Assicuratosi con abile azione il favore del senato e del
popolo, ottenuto il consenso dell’Italia e il giuramento di
fedeltà degli altri eserciti, Otone si apprestò a fronteggiare
la calata delle legioni di Germania e quindi mosse a
incontrarle nell’Italia settentrionale. La battaglia decisiva si
svolse in aprile a Betriacum (presso Cremona); quivi Otone
scontò il duplice errore di non aver atteso i rinforzi delle
209
legioni delle province danubiane e di non aver partecipato
di persona al combattimento, e per non sopravvivere alla
disfatta si diede la morte.
Entrato in Roma alla testa delle sue truppe, Vitellio si
preoccupò soprattutto di ricompensarle immettendole
largamente nelle coorti pretorie e urbane; per il resto lasciò
mano libera ai suoi generali (sebbene ostentasse il massimo
ossequio verso il senato) e si abbandonò alla crapula e ai
divertimenti. L’esito del conflitto aveva però lasciato un
grande scontento fra le legioni dell’esercito danubiano,
arrivate troppo tardi in soccorso di Otone; anche
nell’esercito di Oriente il giuramento di fedeltà a Vitellio
era stato prestato senza entusiasmo, e ai primi di luglio
tutte queste forze furono concordi nell’acclamare
imperatore Tito Flavio Vespasiano, che dal 67 dirigeva le
operazioni contro gl’insorti della Giudea.
Dalla loro parte era non solo il vantaggio numerico,
ma anche quello di una maggiore efficienza, perché le
truppe di Vitellio durante il soggiorno in Italia e in Roma si
erano infiacchite nei bagordi, e soprattutto avevano molto
sofferto per il cambiamento di clima. Così, senza attendere
l’arrivo delle legioni d’Oriente, riuscì a quelle dell’esercito
danubiano di battere i vitelliani (ancora a Betriacum,
nell’ottobre) e di risolvere la situazione in favore di
Vespasiano. Prima dell’ingresso dei vincitori in Roma, il
praefectus urbi Tito Flavio Sabino, fratello di Vespasiano,
cercò di concludere un accordo con Vitellio per una
pacifica abdicazione, ma i pretoriani si opposero ad ogni
compromesso, ed espugnato ed incendiato il Campidoglio,
dove Sabino si era asserragliato, lo uccisero e si
apparecchiarono alla più strenua resistenza. Dopo aspri
combattimenti per le vie della città, i castra praetoria vennero
presi d’assalto, Vitellio fu trucidato (20 dicembre) e il
210
giorno dopo Vespasiano, rimasto unico capo dell’impero,
otteneva il riconoscimento del senato.
2. Il principato “borghese” di Vespasiano. - T. Flavio
Vespasiano era nato presso Rieti nel 9 d.C. da famiglia di
sola dignità equestre, ma era riuscito a percorrere una
brillante carriera raggiungendo sotto Claudio il consolato.
La mediocrità delle sue origini e la modestia del suo tratto,
unite alle solide qualità dimostrate nei vari incarichi,
l’avevano raccomandato a Nerone per conferirgli
l’importante comando della guerra giudaica; quelle stesse
qualità, tipiche della borghesia italica, si affermavano ora
con lui alla testa dell’impero, contendendo all’antica nobiltà
romana il monopolio delle cariche goduto fino a quel
momento. Infatti era soprattutto una nuova mentalità che
con l’avvento di Vespasiano si affermava nel governo della
cosa pubblica, meno incline al fasto del luxus nobiliare e più
sensibile alle esigenze di una sana amministrazione.
Debitore all’esercito della sua elezione, ma
fermamente deciso a mantenere il regime sui binari del
“principato civile”, egli cercò anzitutto di risolvere il
problema costituzionale dei suoi poteri personali.
Considerandosi, e ben a ragione, non sufficientemente
dotato di auctoritas per fondarvi il suo primato nella
direzione dell’impero, si fece conferi re dal senato e dal
popolo un esplicito mandato attraverso la promulgazione
della cosiddetta lex de imperio Vespasiani, ove tra l’altro si
legge che egli veniva autorizzato a compiere qualsiasi atto
nell’interesse dello Stato utique quaecumque ex usu rei publicae
maiestate divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum
esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti divo Aug(usto)
Tiberioque Iulio Caesari Aug(usto) Tiberioque Claudio Caesari
Aug(usto) Germanico fuit.
211
Forte di questa solenne investitura, che lo sottraeva ai
mutevoli umori degli eserciti, l’imperatore poté attendere a
una severa restaurazione della disciplina militare, smarritasi
in due anni di guerre civili, e quindi procedere alle
opportune riforme. Da buon borghese, si preoccupò in
particolar modo di rimettere in sesto la finanza statale, e vi
pervenne sia con una politica di rigide economie,
accompagnata da un fiscalismo anche troppo esoso, sia
incrementando i redditi del patrimonio imperiale, che per
effetto delle continue confische si era dilatato al punto da
fare dell’imperatore il più grande proprietario terriero. Più
difficile gli riuscì invece realizzare il desiderio di mantenere
sul piano della cordiale collaborazione i suoi rapporti col
senato. Infatti, nonostante egli vi avesse introdotto nuovi
elementi presi dal fior fiore della borghesia italica e delle
province occidentali, nell’assemblea continuarono a
prevalere taluni atteggiamenti dell’antica nobilitas ispirati ad
una certa sostenutezza verso il principe, tuttavia senza dar
luogo a conflitti insanabili.
Risolti i principali problemi di governo, Vespasiano
ebbe cura di rimettere ordine nei diversi campi
dell’amministrazione periferica, e tale scopo fu raggiunto
anche mediante la creazione di nuovi organismi cittadini
(colonie e municipi) e col promuovere l’assimilazione dei
provinciali attraverso larghe concessioni del diritto di
cittadinanza romana o, almeno, del “diritto latino” (che fu
esteso a tutta la Spagna).
A questo fervore di opere per il consolidamento delle
basi politiche e sociali dello Stato si accompagnò
un’energica politica per la difesa dei confini e la
conservazione della pace. La rivolta dei Batavi, che
scoppiata nel clima turbinoso dell’anno 69 sembrò per un
momento sfociare nella secessione della Gallia, fu
prontamente domata l’anno appresso, e la saggia rinuncia a
212
troppo drastici provvedimenti repressivi fece sì che la pax
Romana tornasse ben presto a regnare in quelle regioni.
Assai più dura, a causa del suo carattere, fu nell’estate dello
stesso anno 70 la conclusione della guerra giudaica che il
figlio Tito, portava a termine con l’espugnazione di
Gerusalemme, la distruzione del Tempio, la riduzione del
paese a provincia romana (provincia imperiale di Giudea).
La vittoria fu sottolineata dalla celebrazione di un
magnifico trionfo e più tardi dalla dedica dell’arco che
ancor oggi si erge sulla via Sacra. Altre operazioni furono
condotte sui confini del Reno e del Danubio, per
fortificarvi il sistema difensivo, e in Britannia, ove la
conquista fu allargata fino alla Scozia.
Nell’assiduo sforzo di consolidare l’impero,
Vespasiano si preoccupò anche di assicurare la continuità
del regime e perseguì una vera e propria politica dinastica,
preparando assai per tempo la successione a Tito. Fin dal
71 gli fece conferire la tribunicia potestas, lo ebbe collega in
sette consolati, e, cosa più importante e a un tempo
inconsueta, lo nominò prefetto del pretorio (carica riservata
ai cavalieri), evidentemente per garantirsi la fedeltà dei
pretoriani; e quando dopo dieci anni di principato morì, il
23 giugno del 79, il potere passò senza scosse nelle mani di
Tito (Titus Flavius Vespasianus, primogenito e dunque
omonimo di suo padre).
3. Tito e Domiziano. L’impero sotto i Flavii. - Eccellenti
erano le prove di intelligenza e di capacità che per tanti
anni Tito aveva dato a fianco del padre, ma erano note
anche una certa sfrenata ambizione e una tendenza ai
piaceri smodati che a molti facevano temere si preparasse
l’avvento di un nuovo Nerone. Accadde invece che la
responsabilità dell’impero, ormai tutta sulle sue spalle,
gl’ispirò consigli di moderazione e di prudenza, e in breve
213
egli seppe conciliarsi quelle simpatie che gli valsero l’epiteto
di “delizia del genere umano”. Qui si esprimeva soprattutto
la soddisfazione degli ambienti tradizionalisti, e quindi in
primo luogo dei circoli senatorii, per il fatto che Tito,
anche se perdutamente innamorato della principessa
giudaica Berenice, la bellissima sorella del re Erode Agrippa
II, si era ben guardato dal prenderla in moglie e dal
rinnovare, così, lo scandalo che a suo tempo avevano dato
Antonio e la sua unione con l’egizia Cleopatra.
Purtroppo il suo principato venne funestato da un
susseguirsi di calamità. Nell’agosto del 79 una terribile
eruzione del Vesuvio seppelliva le città di Pompei, Stabia
ed Ercolano (e vi perì anche Plinio il Vecchio, il dotto
naturalista che, per studiare troppo da vicino il fenomeno,
fu una delle prime “vittime della scienza”). L’anno dopo un
nuovo incendio, paragonabile quasi a quello neroniano,
distruggeva una gran parte dell’Urbe, e per di più faceva la
sua apparizione lo spettro della pestilenza. Per la
ricostruzione di Roma e per soccorrere le vittime di tanti
flagelli Tito stanziò somme enormi, e con una generosità
tale, che il suo successore si trovò poi in gravi difficoltà
finanziarie.
Un’improvvisa malattia lo stroncava, a soli 42 anni, il
13 settembre dell’81, e il principato passava nelle mani del
fratello Tito Flavio Domiziano.
Nato il 24 ottobre del 51, Domiziano stava per
compiere i trent’anni quando l’acclamazione dei pretoriani
e il riconoscimento del senato lo consacravano principe
dell’impero. Non aveva, dunque, una età troppo giovanile,
ma era sprovvisto di esperienza perché sia il padre sia il
fratello, pur pensando alla eventualità di una sua
successione, l’avevano tenuto in disparte dagli affari di
governo giudicando il suo carattere ribelle e ambizioso.
214
Giunto al potere assai prima di quanto potesse
sperare, Domiziano avvertì immediatamente il disagio di
non possedere alcun prestigio personale e, abbandonata la
politica conciliante col senato già seguita dal padre e dal
fratello, imboccò la via del più autoritario dispotismo.
Pertanto ebbe cura di potenziare la burocrazia di palazzo,
di accrescere l’importanza del consilium principis, formato dai
suoi consiglieri privati, e soprattutto di assicurarsi il favore
degli eserciti e del popolo, premesse indispensabili per
imporre la pretesa di essere ubbidito come dominus e
venerato come deus. Assillato ben presto dalle difficoltà
finanziarie, cercò di aumentare le entrate con vari mezzi,
fra i quali non ultimo una serie di confische a danno della
ricca nobiltà, che con il suo atteggiamento ostile gli offriva
continue occasioni di imbastire processi di lesa maestà.
Del resto il suo fu un malgoverno più dal punto di
vista formale (per il carattere assolutistico e l’abbandono
delle tradizioni del “principato civile”) che sostanziale,
come mostrano l’assiduo controllo esercitato di persona sul
funzionamento della amministrazione centrale e sul
comportamento dei governatori di provincia. Domiziano
cercò anche di restaurare il culto tradizionale arginando il
propagarsi delle nuove religioni orientali; infierì
specialmente contro i Giudei, ma anche i Cristiani vennero
perseguitati (a. 95), e fra costoro caddero vittime anche
Tito Flavio Clemente, cugino dell’imperatore, e sua moglie
Flavia Domitilla. Sarà appena il caso di dilungarsi a rilevare
quanta strada avesse già fatto il proselitismo cristiano: gli
autori classici, legati alla tradizione pagana, passano la cosa
sotto uno sprezzante silenzio, ma è un fatto che già nel
corso del primo secolo un senatore di rango consolare,
come Flavio Clemente, aveva abbracciato la nuova fede.
Assai notevole fu anche la ripresa della politica di
espansione sui confini dell’impero. Allargata ulteriormente
215
la conquista della Britannia e avviata l’opera di
romanizzazione dell’isola, l’imperatore condusse anche una
guerra vittoriosa contro la gente germanica dei Catti e ne
occupò il territorio procedendo ad una rettifica del confine
assai vantaggiosa per la difesa. Meno brillante fu l’esito
della lotta contro il re dei Daci, Decebalo, che si concluse
con una pace di compromesso, ma servì a contenere per il
momento la minaccia di quei barbari sulle province
danubiane.
Nonostante questi innegabili successi, Domiziano si
trovò sempre più invescato nella lotta contro l’opposizione
senatoria, e la necessità di difendersi da una serie di
congiure lo portò a instaurare negli ultimi anni un regime di
terrore che rese ancora più cupo il carattere tirannico del
suo principato. Dopo vari tentativi falliti, riuscì un
complotto ordito da personaggi delle classi più elevate
d’accordo con liberti e schiavi imperiali, e il 18 settembre
del 96 Domiziano fu pugnalato nei suoi appartamenti.
Con lui si estingueva la dinastia dei Flavii, che
nell’insieme aveva largamente meritato dell’impero
preservandone la coesione contro la minaccia delle
incipienti tendenze separatiste e, soprattutto, attuando
un’illuminata politica, fatta insieme di conservazione e di
innovazione. Conservazione specialmente del costume e
della disciplina tradizionali (le ripetute espulsioni dei
filosofi greci da Roma risposero ad un bisogno di difesa
contro le distruttive ideologie anarcoidi da essi professate),
innovazione specialmente per l’immissione nella classe
dirigente di nuovi elementi attinti dalle aristocrazie
municipali dell’Italia e delle province. A tale proposito è
notevole che proprio in questo periodo si ebbe in Roma la
istituzione di scuole superiori a spese dello Stato;
evidentemente, l’imperatore avvertiva l’esigenza di
promuovere e indirizzare la preparazione di una nuova
216
classe di governo, mentre in precedenza tale istruzione
aveva sempre rivestito un carattere privato.
E fu appunto il progressivo inserimento di queste
nuove forze che, continuando ad allargare le basi politiche
dell’impero a scapito della gelosa nobiltà di Roma (e
pertanto ostinata nella sua opposizione), preparò e
contribuì al fulgore dell’era successiva. Di pari passo,
intanto, procedeva il diffondersi della humanitas romana, e
se l’Italia continuò a restare (ma ancora per poco) al centro
del movimento artistico e letterario, ad essa già si
affiancavano le province più romanizzate, come la Gallia, la
Spagna e l’Africa ormai pronte a raccogliere e sviluppare
l’antica tradizione culturale.
4. Nerva e il principato “adottivo”. - Alla morte di
Domiziano il senato elesse imperatore il vecchio consolare
Marco Cocceio Nerva, uomo di antica nobiltà patrizia, che
era stato fra gli esponenti della congiura. Egli però non
aveva un passato di condottiero, e la sua elezione provocò
il malumore dei pretoriani, sia per il loro attaccamento a
Domiziano, sia perché avrebbero preferito scegliere essi
stessi il successore. Nonostante la promessa del solito
donativum, il malumore non tardò a trasformarli in ribelli, e
l’imperatore, dopo una vana resistenza, dovette subire
l’umiliazione di consegnare loro alcuni fra i congiurati, che
furono immediatamente passati per le armi.
Dopo questo sconcertante episodio ritornò una certa
calma, ma a Nerva apparve subito l’estrema debolezza della
sua posizione e pensò di rafforzarla adottando come figlio
un uomo capace di riscuotere i consensi del senato e
dell’esercito. La sua scelta cadde su Marco Ulpio Traiano,
allora governatore della Germania, che all’atto stesso della
sua adozione (nell’autunno del 97) venne designato alla
217
successione e rivestito poco dopo della potestà tribunicia e
dell’imperium proconsulare.
Aveva inizio così la serie dei principi “adottivi”, sotto
i quali l’impero toccò il suo apogeo traducendo in vigorosa
spinta di espansione in ogni campo tutte le sue energie,
senza più soffrire troppo il travaglio della lotta tra principe
e senato. La nobiltà senatoria, abbandonato ormai da
tempo ogni sogno di un’impossibile restaurazione
repubblicana, auspicava che il potere imperiale venisse
acquisito non per diritto di sangue, ma per meriti personali
capaci di contraddistinguere nel suo seno “l’uomo
migliore”. La natura del principato, al contrario, era tale da
esigere quasi di necessità una politica dinastica, come già
Augusto per primo aveva mostrato.
Ora la circostanza che gl’imperatori da Nerva ad
Antonino Pio non avessero discendenza maschile rese
possibili, mediante l’adozione del successore, sia la scelta
del “migliore” sia la continuità dinastica di padre in figlio
(adottivo).
La nuova atmosfera politica, così diversa da quella
che aveva regnato sotto i Flavii, e specialmente sotto
Domiziano, venne salutata dalla nobilitas con l’entusiasmo
che si può cogliere, per esempio, nelle parole di Tacito
(Agr. 3) quando scriveva che Nerva aveva mostrato come si
potessero “conciliare due cose un tempo inconciliabili, il
principato e la libertà”. Naturalmente, non era nemmeno
da pensare che il principato facesse qualche passo indietro
o soltanto si fermasse sulla parabola che stava percorrendo
verso il più rigido assolutismo. Il senato, invece che
trascurato o perseguitato, si vide restituito nella sua dignità;
ma nel tempo stesso che gli mostrava la sua deferenza, il
principe continuava ad accentrare nelle sue mani il potere,
e quindi a sviluppare una burocrazia sempre più invadente
nei campi un tempo riservati alla competenza dei senatori218
magistrati. Ad ogni modo una distensione vi fu, e vi
concorse anche il fatto che, mentre il senato si veniva
rapidamente mutando, se non nei suoi ideali, nella sua
composizione per effetto dell’ingresso sempre più largo di
elementi provinciali, ugualmente provinciali (cioè romani di
famiglia residente in provincia) furono due dei più grandi
imperatori di questo periodo, Traiano e Adriano.
E fu appunto nel corso del II secolo che il sistema
amministrativo del principato, attraverso una più armonica
fusione e il perfezionamento delle sue strutture, raggiunse il
grado più alto di efficienza. La determinazione sempre più
precisa dell’ambito delle funzioni pubbliche e la loro
inserzione nella cornice di un rigoroso ordine gerarchico
vennero anche esteriormente espresse nei titoli, diventati di
uso comune sotto Marco Aurelio, di clarissimus per gli
appartenenti all’ordine senatorio e di egregius per gli
appartenenti all’ordine equestre (o anche di perfectissimus o
di eminentissimus per i gradi più elevati).
Fu specialmente la carriera equestre che venne
inquadrata entro schemi determinati fino a raggiungere
stabilità di struttura sotto Adriano. Avvenne allora che,
divenuta completamente pubblica l’amministrazione del
palazzo imperiale, ne scomparvero i liberti che dirigevano i
vari dicasteri per cedere il posto a procuratores, e questi erano
cavalieri al pari degli altri procuratores preposti ai vari uffici
amministrativi in ogni parte dell’impero. Anche le
prefetture, all’apice della carriera equestre, vennero
ordinate secondo una scala gerarchica che dal tempo di
Traiano si svolse secondo i gradi della prefettura dei vigili,
dell’annona, dell’Egitto, del pretorio. Sorvolando su altri
particolari, è almeno da ricordare che sempre nel II secolo
venne migliorata la situazione fiscale col passaggio della
riscossione dei tributi dal sistema delle società appaltatrici
(publicani) a quello della gestione diretta.
219
Nell’insieme, l’impero vide attenuarsi in certo grado
la sua fisionomia di organizzazione per lo sfruttamento
delle province a beneficio della città dominante, e
dall’accrescersi dei consensi sempre maggior impulso
doveva ricevere la diffusione della romanità, sentita come
apportatrice di ordine e di pace universale. Questo
processo toccò ora il suo apogeo, favorito dall’esistenza di
un’unica grande area monetaria, dalla tendenza verso un
comune sistema giuridico, dall’affermarsi del latino in tutto
l’occidente (nel mondo orientale il greco aveva tradizioni
culturali troppo valide, e continuò a imporsi come seconda
lingua dell’impero). Agricoltura, industria, commerci,
potenziati anche da una fitta rete stradale (ma per i
trasporti si usò a preferenza la più economica via marittima
o fluviale), prosperarono di pari passo con la vita
intellettuale. Poeti, oratori e letterati, a parte quelli di lingua
greca, provennero non solo dall’Italia, ma anche dalla
Spagna e specialmente dall’Africa. Dappertutto, poi, vi fu
una notevole fioritura delle arti, specie dell’architettura,
creatrice di monumenti che ancor oggi da un capo all’altro
del Mediterraneo parlano con la più grande immediatezza
della civiltà di Roma.
5. Traiano e la ripresa dell’espansione territoriale. - Dopo il
breve principato di Nerva, il nuovo clima politico si
rispecchia nell’impero di Traiano (98-117).
Oriundo della Spagna, una delle province più
romanizzate, il nuovo imperatore era un tipico
rappresentante di quella borghesia municipale che i Flavii
avevano inserito nella classe dirigente. Figlio di un
consolare, Traiano aveva anch’egli raggiunto il consolato
ordinario nel 91 per i suoi meriti di valoroso condottiero e
di prudente amministratore. L’adozione di Nerva lo
raggiunse mentre, come governatore della Germania, stava
220
curando il rafforzamento delle difese sull’alto Reno, ed egli
continuò ad attendervi anche dopo aver ricevuto la notizia
che alla morte del padre adottivo (27 gennaio del 98) il
potere era passato nelle sue mani. Sicuro che in Roma
nessun pericolo poteva minacciarlo, si trattenne ancora un
anno a sistemare la frontiera dell’alto Danubio e quindi,
nella primavera del 99, fece il suo ingresso nella capitale fra
le più entusiastiche accoglienze.
Con una consumata abilità di politico che uguagliava
le doti di capitano, Traiano seppe improntare a reciproco
rispetto le sue relazioni col senato, mostrandosi in ogni
occasione pieno di ossequio verso l’assemblea, che lo
ripagò col titolo di optimus. Tutto questo, peraltro, non
portò ad alcun sostanziale mutamento del rapporto fra
attribuzioni del senato e poteri del principe, che
continuarono a restare preminenti nella direzione politica
dell’Italia e dell’impero. Pertanto è difficile dire se fu
veramente sotto l’influenza del senato, oppure no, che egli
svolse all’interno un’azione per vari aspetti conservatrice.
In quest’ambito sono almeno da ricordare le sue
provvidenze intese a impedire che l’incipiente declino
economico, sociale e demografico facesse decadere l’Italia
dalla secolare funzione di spina dorsale dell’impero.
Pertanto, riallacciandosi a un progetto di Nerva, egli
sviluppò l’istituto degli alimenta, consistente nel sostenere
l’agricoltura mediante la concessione di prestiti ipotecarii a
modico interesse ai proprietari di terre, e nel devolvere poi
gli interessi introitati all’allevamento e all’educazione di un
certo numero di ragazzi.
Ma il campo in cui egli certamente impose la sua
personalità fu quello della politica estera, ove due problemi
in particolare si ponevano per la sicurezza dell’impero. Si
trattava, da un lato, di allontanare dalle province danubiane
il pericolo dei Daci, già fattosi minaccioso sotto
221
Domiziano, dall’altro di arrivare ad una stabile
sistemazione dei rapporti con i Parti, l’ormai secolare e
irriducibile nemico di Roma sul confine orientale. Della
risoluzione di questi due problemi egli fece il centro del suo
programma, e stimò che solo con le armi avrebbe potuto
raggiungerla in maniera radicale.
La campagna contro i Daci si svolse in due riprese,
negli anni 101-102 e 105-106 e, al termine di un’aspra lotta
(raffigurata negli episodi più salienti sulla colonna che
ancora si erge nel foro Traiano), si concluse con la disfatta
del re Decebalo e la riduzione a provincia di un vasto e
ricco territorio al di là del Danubio. La Dacia divenne così
il baluardo avanzato dell’impero nell’Europa centrale, e fu
rapidamente romanizzata mediante il trapianto di numerosi
coloni, la cui lingua ancor oggi si continua nei dialetti
romeni.
Alla lotta contro i Parti Traiano dedicò gli ultimi tre
anni del suo principato. Preceduta dalla riduzione a
provincia dell’Arabia (cioè del regno degli Arabi Nabatei,
che dei territori compresi fra l’Asia Minore e l’Egitto era
l’unico rimasto ancora soggetto a Roma nella forma
indiretta del vassallaggio), la guerra prese le mosse da uno
dei tanti episodi della lunga contesa per il predominio
dell’Armenia, ove il re dei Parti Cosroe aveva imposto la
sovranità del fido Partamasiri.
Entrato nell’Armenia nei primi mesi del 114, Traiano
non accettò le profferte di vassallaggio di Partamasiri e
dichiarò la regione provincia romana; quindi avanzò
vittoriosamente fino al Golfo Persico e, occupate una dopo
l’altra Babilonia, Seleucia e la capitale Ctesifonte, istituì le
altre due province di Mesopotamia e di Assiria, mentre
Cosroe era costretto a fuggire. Il successo era stato
folgorante, e mai prima di allora l’impero aveva abbracciato
territori così vasti. Ma proprio mentre sarebbe stato assai
222
opportuno un periodo di raccoglimento per consolidare le
nuove conquiste, scoppiava in Egitto e in Cirenaica,
provocata dall’elemento giudaico, una furiosa rivolta
antiromana che si propagò anche nei territori appena
occupati, ove i Parti ripresero la lotta guidati dal principe
Partamaspate. Costretto a ridimensionare il suo programma
di conquista, Traiano si rassegnò a lasciar sopravvivere un
regno partico, mutilato della Mesopotamia, e ne incoronò
sovrano Partamaspate come vassallo di Roma. Poté quindi
provvedere a domare la rivolta giudaica, ma intanto Cosroe
stava per tornare alla riscossa; si rendevano necessari nuovi
grandiosi preparativi e l’imperatore partì alla volta di Roma,
ma durante il viaggio si ammalò e morì in Cilicia a
Selinunte (agosto 117).
Troppo impegnativo si era rivelato il piano di
distruggere lo Stato partico, e soprattutto troppo
pericoloso per l’economia generale della difesa dell’impero;
tale almeno lo giudicò Publio Elio Adriano, che, appena
salito al principato, si affrettò a dare un diverso indirizzo
alla politica orientale di Roma.
6. Il nuovo corso di Adriano. - Anche la successione di
Adriano era stata preceduta da un’adozione, fatta da
Traiano quasi in punto di morte; lo affermò Plotina, la
vedova dell’imperatore, e sebbene molti ne dubitassero (a
ragione, probabilmente), nessuno osò sollevare obiezioni.
Raggiunto in Antiochia dalla notizia della morte del padre
adottivo, Adriano vi fu acclamato imperatore dalle truppe e
poco dopo gli arrivò il riconoscimento del senato.
Al pari di Traiano, Adriano era un romano di Spagna
(erano nati entrambi a Italica, la colonia fondata nel 206
a.C. da Scipione presso Siviglia), e anch’egli aveva percorso
una brillante carriera distinguendosi da ultimo nella guerra
partica. Partendo per l’Italia, Traiano gli aveva lasciato il
223
comando delle forze in Oriente; ora, a quarantun anni, si
trovava sulle spalle il pesante fardello dell’impero, e in
primo luogo la responsabilità dell’impresa contro i Parti
rimasta incompiuta. Su questo punto egli non ebbe
esitazioni, e, considerando poco profittevole per l’impero la
ripresa della politica aggressiva di Traiano, rinunziò
senz’altro alle nuove conquiste oltre l’Eufrate e alla stessa
provincia di Armenia, che tornò nell’antica condizione di
stato vassallo. L’Arabia e la Dacia furono invece conservate
e potenziate mercé il loro definitivo inserimento nel
sistema provinciale come province “imperiali”.
Fermamente convinto della necessità di non
espandere ulteriormente l’impero, ma di aumentarne
piuttosto la coesione migliorando l’organizzazione in tutti i
campi, Adriano provvide a sviluppare i quadri degli uffici
amministrativi e intraprese un’instancabile azione di diretta
sorveglianza che si esplicò attraverso una serie di lunghi
viaggi nelle varie province. Nel corso di tali viaggi
ispezionò di persona gli eserciti e i loro apprestamenti,
controllò
le
finanze
locali,
diede
impulso
all’amministrazione della giustizia e ai lavori pubblici,
ovunque cementando con la sua presenza i vincoli
dell’unità imperiale e guadagnandosi l’entusiastica adesione
dei sudditi che, specie in Oriente, gli attestarono la loro
devozione venerandolo come dio.
Oggetto di cura particolare fu la sicurezza dei confini,
che egli cercò di assicurare con grandiose opere di difesa,
tra cui si deve almeno ricordare la costruzione in Britannia
di una linea fortificata, comprendente anche un muro, largo
circa 3 metri e alto 6, che per 117 km tagliava tutta l’isola
dal Solway Firth al Mare del Nord. Naturalmente, il
programma difensivo dell’imperatore, che si concretò
anche in un potenziamento dell’esercito, non poteva del
tutto escludere le guerre, tra cui la più impegnativa fu
224
quella combattuta dal 132 al 135 contro i Giudei, che erano
nuovamente insorti e opposero la più accanita resistenza
prima di lasciarsi piegare.
In politica interna Adriano si mostrò rispettoso del
senato come Traiano, anche se il suo programma di
riorganizzazione amministrativa dell’impero lo portò di
necessità a intromettersi in campi tradizionalmente riservati
alla competenza dei senatori, destandone il più vivo
malcontento. E, in ultima analisi, fu proprio lui ad avviare
quel processo evolutivo che si concluse sotto Diocleziano
con la riduzione a provincia dell’Italia e con il suo
livellamento alle altre province. Adriano divise infatti
l’Italia in quattro distretti, preponendo a ciascuno un
consularis, cioè un alto funzionario imperiale che vi
esercitava la giurisdizione civile (cfr. S.H.A., Vita Hadr. 22).
Sebbene fosse appassionato cultore di lettere ed arti, non
trascurò di dedicare la sua attenzione a nessuno dei
problemi di governo, e, fra l’altro, con l’approvazione
dell’editto “perpetuo” provvide ad una definitiva
codificazione delle norme di diritto emanate annualmente
dai pretori.
Negli ultimi anni, che trascorse nella sua splendida
villa presso Tivoli (Villa Adriana), l’imperatore si
preoccupò della successione; non avendo avuto figli,
adottò prima (a. 136) il giovane Lucio Ceionio Commodo
(poi L. Aelius Caesar), che gli premorì, poi Tito Aurelio
Antonino, che gli successe pochi mesi dopo, il 10 luglio del
138.
7. Gli Antonini e la fine dell’impero liberale. - T. Aurelio
Antonino (ora Imp. Caes. T. Aelius Hadrianus Antoninus
Aug.), che era nato nel Lazio, a Lanuvio, ma da famiglia
originaria della romanizzatissima Gallia Narbonese, aveva
allora 52 anni, e i molti uffici di governo lodevolmente
225
ricoperti lo indicavano come degno continuatore dell’opera
dei suoi predecessori. Le fonti mettono in rilievo la
dirittura del suo carattere, la nobiltà dei sentimenti,
l’attaccamento al dovere che informarono la sua azione a
grande equilibrio e decoro: ciò che va posto in relazione
con il suo atteggiamento conciliante verso l’assemblea
senatoria.
Con questa, che aveva avuto di che dolersi per
l’invadente politica accentratrice di Adriano e che
minacciava di negare al defunto imperatore la consueta
apoteosi (cioè di consacrarlo ufficialmente divus), Antonino
seppe abilmente destreggiarsi; con qualche concessione
riuscì a placarne i risentimenti verso il padre adottivo e ne
ottenne per sé il cognome di Pio. Ma il suo programma
differiva da quello di Adriano solo per il desiderio di
instaurare una più stretta intesa col senato, senza sacrificare
nessuna delle prerogative del potere imperiale; per il resto
si propose anch’egli di perfezionare l’organizzazione civile
e militare dell’impero e di potenziare il sistema di sicurezza
dei confini sia con una complessa azione diplomatica, sia
con la costruzione di opere difensive (come la nuova linea
fortificata in Britannia, circa 100 Km a nord di quella di
Adriano).
Quando Antonino Pio venne a morte, il problema
della successione non si poneva; essa era già stata regolata
più di vent’anni prima secondo la volontà di Adriano che,
nell’atto stesso di adottare Antonino, gli aveva fatto
adottare il diciassettenne Marco Annio Vero e il piccolo
Lucio Ceionio Commodo (figlio di Lucio Elio Cesare).
Annio Vero, vissuto dopo l’adozione col nome di M. Aelius
Aurelius Verus Caesar nel palazzo imperiale presso
Antonino, ne aveva sposato la figlia Annia Galeria
Faustina, e il 7 marzo del 161 gli successe col nome di
226
Marco Aurelio Antonino (Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus
Aug.).
Marco Aurelio era allora sui quarant’anni, e li aveva
trascorsi interamente fra gli studi nutrendosi specialmente
di dottrina stoica, senza mai partecipare agli affari di
governo. Quest’ultima circostanza lo metteva in condizione
d’inferiorità rispetto ai predecessori, ma dai severi dettami
dello stoicismo egli attinse tutta l’energia necessaria ad
affrontare i nuovi doveri, resi più ardui da un complesso di
avversità e di pericoli.
Uno dei suoi primi atti fu quello di innalzare a
correggente dell’impero il fratello (per adozione) Lucio
Ceionio Commodo, che si chiamò ora Imp. Caes. L. Aurelius
Verus Aug. Così, per la prima volta, titolari della potestà
imperiale furono allora due Augusti; ma la collaborazione
non si dimostrò proficua, del che nelle fonti si dà la colpa a
Lucio Vero, il quale avrebbe continuato nella sua vita di ozi
e di piaceri. Eppure più che mai opportuno sarebbe stato
per Marco Aurelio riuscire a realizzare una collaborazione a
così alto livello; infatti, mentre tanta parte restava da
attuare della politica di pacifico sviluppo dell’impero
promossa da Adriano e da Antonino Pio, egli dovette
invece sobbarcarsi a una lunga serie di campagne di guerra.
Non per questo tralasciò di affrontare i complessi problemi
della riorganizzazione amministrativa, e sebbene fosse
rispettoso del senato non esitò (seguendo l’esempio già
dato da Adriano con l’istituzione dei quattro consulares) a
sottrargli il governo dell’Italia per riordinarlo ed affidarlo a
nuovi funzionari imperiali, gli iuridici.
Ma ad imporsi con eccezionale gravità erano ancora i
problemi che Traiano aveva tentato di risolvere con la
forza delle armi, quello della frontiera danubiana e quello
della frontiera partica. Già peggiorate sotto Antonino Pio,
le relazioni con i Parti arrivarono alla rottura per
227
l’aggressività del re Vologese III, che, dopo aver imposto
una sua creatura sul trono d’Armenia, invase anche la
provincia di Siria. Furono necessari cinque anni di guerra,
dal 162 al 166, per ripristinare la situazione, che fu anche
migliorata con l’occupazione dell’Osroene al di là
dell’Eufrate.
Appena terminata la guerra partica, si profilò per
l’impero una nuova e assai più grave minaccia ad opera
delle popolazioni barbariche dell’Europa centrale che,
spinte da un vasto movimento migratorio, invasero la
Dacia e superarono il Danubio arrivando anche in Italia,
ove posero l’assedio ad Aquileia. A tutto questo si
aggiungeva poi il flagello di un’epidemia di peste. Marco
Aurelio s’impegnò personalmente nella difesa, e la guerra si
svolse in due fasi: la prima (167-168) si concluse con la
cacciata degli invasori al di là del Danubio; la seconda, che
l’imperatore condusse da solo essendo morto nel 169 L.
Vero, si svolse dal 169 al 175 per sottomettere le
popolazioni dei Quadi, dei Marcomanni e degli Iazigi.
Durissimi furono i disagi e i pericoli che l’esercito romano
dovette affrontare in questa campagna oltre il Danubio, e la
ferocia della lotta traspare anche dalla sua descrizione sui
bassorilievi della colonna Antonina (in piazza Colonna). I
barbari furono obbligati a riconoscere il protettorato
romano, obbligandosi a fornire truppe ausiliarie; ma non
ebbe tregua l’imperatore costretto nello stesso anno 175 a
muovere verso l’Oriente, ove l’ambizioso governatore C.
Avidio Cassio aveva usurpato il potere imperiale.
Ristabilita in quelle regioni la sua autorità, M. Aurelio
ritornò sulla frontiera danubiana, ove Quadi, Marcomanni
e Iazigi avevano ripreso le armi, ma non riuscì a concludere
la guerra. Stroncato dalla peste il 17 marzo del 180 a
Vindobona (Vienna), suggellava con la morte
nell’accampamento la sua vita di filosofo-imperatore, che
228
con impegno di stoico aveva tenuto fino all’ultimo il suo
posto di responsabilità.
Con la scomparsa di M. Aurelio aveva termine la serie
degli imperatori adottivi e, insieme, la politica
liberaleggiante degli Antonini. Già nel 177 M Aurelio,
rinnovando l’esperimento già fatto con L. Vero, si era
associato all’impero come Augustus L. Aurelio Commodo,
nato dal suo matrimonio con Annia Galeria Faustina.
Sperava forse in un miglioramento delle pessime
inclinazioni del giovane, oppure riteneva di non poter
altrimenti assicurare un più pacifico trapasso dei poteri alla
sua morte; ad ogni modo nel 180 l’impero si trovò nelle
mani di un diciannovenne infatuato di sé e sfrenatamente
dispotico. Atteggiandosi a novello Ercole, Commodo si
curò solo d’ingraziarsi popolino e pretoriani; per la nobiltà
senatoria ricominciarono le persecuzioni e, col terrore, si
diffuse dovunque il disordine amministrativo e
l’indisciplina negli eserciti.
Sembrava di essere tornati ai tempi più cupi di
Domiziano, e come allora si ebbe un susseguirsi di
macchinazioni finché, nell’ultimo dell’anno del 192,
Commodo cadde vittima di una congiura di palazzo che
portò all’impero del prefetto urbano T. Elvio Pertinace.
Sul costituirsi e sul valore della tradizione a noi pervenuta intorno agli
avvenimenti dei 68-69 (principalmente Tacito, Historiae libb. I-III e Svetonio,
Vite di Galba, Otone e Vitellio; inoltre anche Plutarco, Vite di Galba e di
Otone) v. P. ZANCAN, La crisi del principato nell’anno 69 d.C., Padova 1939.
Perdutosi il seguito delle Historiae di Tacito dopo la parte iniziale del V lib., e
ridotto il racconto di Cassio Dione (libb. LXIV-LXVII) al compendio di
Xifilino, fonte principale per l’età dei Flavi rimangono le biografie di Svetonio
(su cui v. p.es., H.R. GRAF, Kaiser Vespasian. Untersuchungen zu Suetons Vita divi
Vespasiani, Stuttgart 1937). Per i fatti della guerra giudaica e le varie sue
connessioni, fonte assai importante è il contemporaneo Flavio Giuseppe, su cui
v. W. WEBER, Josephus und Vespasian, Berlin 1921.
229
Sull’emergere della figura di Vespasiano fra i pretendenti all’investitura
imperiale, G.E.F. CHILVER, The army in politics, A.D. 68-70, in “Journ. Rom.
Stud.” XLVII (1957) p. 29 sgg.
La cosiddetta lex de imperio Vespasiani è edita in C.I.L. VI 930 = I. L. S.
244; su di essa v. M.A. LEVI, in “Athenaeum” N. S. XVI (1938) p. 85 sgg. Sul
risanamento delle finanze e il riordinamento dell’organizzazione tributaria, v.
C.H.V. SUTHERLAND, Aerarium and fiscus during the early empire, in “Am. Journ.
Philol.” LXVI (1945) p. 151 sgg.; F. MILLAR, The fiscus in the first two centuries, in
“Journ. Rom. Stud.” LIII (1963) p. 29 sgg. Il dato di Svetonio (Vesp. 16, 3)
sull’ammontare delle entrate che Vespasiano avrebbe dichiarato necessario per
evitare squilibri nel bilancio statale è sicuramente da, respingere. Si legge, in
fatti, che l’imperatore fu ... ad manubias et rapinas necessitate compulsum summa
aerarii fiscique inopia; de qua testificatus sit initio statim principatus, professus
quadringenties millies opus esse, ut res p. stare posset. Quattrocentomila volte
(quadringenties millies) centomila sesterzi (sottinteso, secondo l’uso) fanno 40
miliardi di sesterzi, cifra assolutamente esagerata, derivante da un probabile
errore di trascrizione, e da ridurre forse a 400 milioni di sesterzi (cfr. S.
MAZZARINO, Trattato, cit. p. 246 sg.). Come punto di riferimento si può tener
presente PLIN., Nat. Hist. XII 84, dove si valuta in cento milioni di sesterzi
all’anno lo squilibrio della bilancia commerciale derivante dalle importazioni
dall’Oriente.
A proposito dei rapporti fra imperatore e senato, un quadro
panoramico dei componenti l’assemblea in B. STECH, Senatores Romani qui fuerint
inde a Vespasiano usque ad Traiani exitum, (“Klio” Beib. X) Leipzig 1912.
Sull’incremento dato alla diffusione della romanità, specialmente nella Spagna,
R.K. MCELDERRY, Vespasian’s reconstruction of Spain, in “Journ. Rom. Stud.”
VIII (1918) p. 53 sgg. e, in generale, M. ROSTOVZEV, Storia economica e sociale
dell’impero romano, cit., p. 123 sgg.
Sulla rivolta dei Batavi, v. R. ANDREOTTI, La lealtà gallica nella rivolta di
Giulio Civile, in “Atti V Congresso Studi Romani”, II, Roma 1940, p. 52G sgg.;
sull’ampliamento della conquista nella Britannia, E. BIRLEY - T. DAVIES PRICE,
The first Roman occupation of Britain, in “Journ. Rom. Stud.” XXV (1935) p. 58
sgg.
Su Tito, H. PRICE, Titus amor ac deliciae generis humani, in “Class. Weekly”
XXXIX (1945-6) p. 58 sgg.; J. A. CROOK, Titus and Berenice, in “Amer. Journ.
Philol.” LXXII (1951) p. 162 sgg.
Su Domiziano, e la tendenza a lui avversa che predomina nella
storiografia antica, v. H. NESSELHAUF, Tacitus und Domitian, in “Hermes”
LXXX (1952) p. 222 sgg.; sui caratteri e sulle manifestazioni del suo
assolutismo teocratico, K. SCOTT, The imperial cult under the Flavians, Stuttgart Berlin 1936, p. l02 sgg. Sulle cure di Domiziano per il buon funzionamento
della amministrazione provinciale, H.W. PLEKET, Domitian, the senate and the
provinces, in “Mnemosyne” XIV (1961) p. 296 sgg. Sulle sue imprese militari H.
BREUNERT, Zum Chattenkriege Domitians, in “Bonn. Jahrb.” CLIII (1953) p. 97
sgg.; E. KÖSTLIN, Die Donaukriege Domitians, Tübingen 1910; C. PATSCH, Der
230
Kampf um den Donauraum unter Domitian und Traian, in “Sitzb. Akad. Wien” 1937,
p. 38 sgg.
Per il periodo da Nerva a Commodo il racconto di Cassio Dione, che
occupava i libb. LXVIII-LXXIII, ci è giunto nel compendio di Xifilino, e
nemmeno completo perché si è perduta la storia del principato di Antonino
Pio e dei primi anni di M. Aurelio. Perdute anche le biografie imperiali (da
Nerva a Elagabalo) composte da Mario Massimo al tempo dei Severi, perduta
la parte iniziale delle Res gestae di Ammiano Marcellino, che prendevano le
mosse da Traiano (il primo dei libri superstiti è il XIV, relativo ai fatti dal 353
in poi), non ci restano che le operette di Aurelio Vittore, di Eutropio, di [Rufio]
Festo, la Epitome de Caesaribus, le Historiae adversus paganos di Orosio e, di gran
lunga più importante, la Historia Augusta. Sotto questo nome si suole designare
una grossa raccolta di biografie imperiali, da Adriano a Numeriano, che
abbracciano dunque gli anni dal 117 al 285, salvo una lacuna per il periodo dal
244 al 253, da Filippo l’Arabo all’inizio di Valeriano. Le biografie si presentano
come opera di sei autori diversi (Elio Sparziano, Giulio Capitolino, Vulcacio
Gallicano, Elio Lampridio, Trebellio Pollione, Flavio Vopisco) e, recando quasi
tutte una dedica o a Diocleziano o a Costantino, si presentano altresì come
composte in età dioclezianeo-costantiniana. In esse non mancano notazioni
precise - sorrette talvolta anche dalla citazione di documenti autentici - ma
queste rimangono come affogate in un contesto di notiziole assurde e di
aneddoti manifestamente fantastici, presentati anch’essi con l’appoggio di
documenti che sono certamente falsi. Senza dire, poi, dei molti anacronismi e
dell’uso che in alcune biografie si riscontra delle opere di Aurelio Vittore e di
Eutropio. È, nell’insieme, una strana caratteristica, e fu grande merito del
Dessau quello di aver intuito e preso a dimostrare che le Vite della Historia
Augusta erano opera di un solo autore vissuto non al principio, ma alla fine del
IV secolo (H. DESSAU, Ueber Zeit und Persönlichkeit der Scriptores Historiae
Augustae, in “Hermes” XXIV, 1889, p. 337 sgg.). Si apriva allora la Historia
Augusta-Forschung, uno dei capitoli più interessanti della storiografia antica, e
l’indagine continua ancora oggi con grande fervore per chiarire sempre meglio
la “tendenza” del compilatore e, soprattutto, gli scopi che egli si prefisse nella
sua “falsificazione”. In breve, può dirsi che l’autore delle Vite va considerato
come espressione dei circoli senatorii romani dell’età a cavallo fra il IV e il V
secolo e delle loro idee: a cominciare dall’impegno in difesa della tradizione
pagana di fronte al cristianesimo trionfante. Della vastissima bibliografia
sull’argomento, v. da ultimo S. MAZZARINO, Il pensiero storico, cit., II, 2 p. 214
sgg. Per concludere questo cenno sulle fonti, si ricordi che “dalla morte di
Marco Aurelio” e cioè dal regno di Commodo, cominciano le Storie di
Erodiano, uno storico contemporaneo e di notevole valore, del quale F.
CASSOLA ha dato recentemente una bella traduzione con introduzione e note
(ed. Sansoni, Firenze 1968). Per i contemporanei sviluppi del cristianesimo, la
fonte principale è rappresentata dalla Storia ecclesiastica di Eusebio, libb. III-V.
Sul breve principato di Nerva la monografia più recente è quella di A.
GARZETTI, Nerva, 1950. Si discute in vario senso sui risultati della sua politica
231
economica, e anche su certe sue riforme nel campo delle distribuzioni gratuite
di frumento in favore della plebe di Roma, cioè delle frumentationes, di cui egli
avrebbe restituito al senato la direzione; su ciò v. G. VITUCCI, Plebei urbanae
frumento constituto, in “Archeol. class.” X, 1958, p. 310 sgg.
Sulla figura e sull’opera di Traiano, oltre che dalle fonti sopra elencate,
importanti notizie si ricavano da Plinio (Panegirico e lib. X dell’Epistolario). Come
opera d’insieme è da ricordare R. PARIBENI, Optimus Princeps. Saggio sulla storia e
sui tempi dell’imperatore Traiano, I e II, Messina 1926-1927. Sul programma
“alimentario”, a noi documentato soprattutto dalla “tavola ipotecaria di Veleia”
(C.I.L. XI 1147 = I. L. S. 6675) e dalla “tavola dei Liguri Bebiani” (C.I.L. IX
1455 = I. L. S. 6509), v. di recente R. DUNCAN JONES, The Purpose and
Organisation of the alimenta, in “Pap. Brit. Sch. Rome” XIX (1964) p. l23 sgg.
Sulla conquista della Dacia, oltre il lavoro del PATSCH citato nel cap. prec., v.
I.A. RICHMOND, in “Pap. Brit. Sch. Rome” XIII (1935) p. 1 sgg. (a proposito
dei rilievi della colonna traiana, su cui v. anche G. BECATTI, La colonna coclide
istoriata, Roma 1960, p. 26 sgg.) e C. DAICOVICIU, Dacia capta in “Klio” n. s.
XXXVIII (1960) p. 174 sgg. Sull’impresa pertica, J. GUEY, Essai sur la guerre
partique de Trajan (114-117), Bucarest 1937; P.A. LEPPER, Trajan’s Parthian War,
Oxford 1948.
Sulla figura e sull’opera di Adriano gli studi complessivi più recenti
sono quelli di B.W. HENDERSON, The life and principate of the emperor Hadrian,
London 1923, e B. D’ORGEVAL, L’empereur Hadrien. Oeuvre législative et
administrative, Paris 1950. Sui mutamenti nella composizione dell’assemblea
senatoria, nella quale sempre più consistente si fa la rappresentanza delle
aristocrazie provinciali, v. P. LAMBRECHTS, La composition du sénat romain de
l’accession au trône d’Hadrien à la mort de Commode (117-192), Antwerpen 1936. Sul
potenziamento dell’amministrazione statale, e sullo sviluppo della burocrazia,
ora non più imperniata sull’attività dei liberti imperiali (come quando era stata
istituita da Claudio), ma sul lavoro regolarmente retribuito di funzionari scelti
nella classe dei cavalieri, v. H.G. PFLAUM, Les procurateurs équestres, cit., p. 58 sgg.
Sull’impegno personale dell’imperatore nel rendersi conto de visu della vita e
dei bisogni delle comunità provinciali, v. M. ROSTOVZEV, Storia economica e
sociale, cit., p. 415 sgg. Per l’Africa, P. ROMANELLI, Storia delle province romane
dell’Africa, Roma 1959, p. 332 sgg. Sul vallum costruito in Britannia, di recente
E. BIRLEY, Research on Hadrian’s Wall, Kendal 1961. Per la modificazione
dell’editto, v. S. RICCOBONO, La definizione del ius al tempo di Adriano, in “Bull.
Ist. Dir. Rom.” 1950 p. 5 sgg. Per gli onori divini, A.E. RAUBITSCHEK, Hadrian
as the Son of Zeus Eleutherios, in “Am. Journ. Arch.” XLIX (1945) p. 128 sgg.
Per il principato di Antonino Pio, alle fonti sopra elencate si deve
aggiungere l’orazione A Roma di Elio Aristide, su cui v. J. H. OLIVER, The ruling
power. A study of the Roman empire in the second century after Chr. through Roman oration
of Aelius Aristides, in “Trans. Proc. Am. Philol. Assoc.” XLIII (1953) p. 871 sgg.
Opera d’insieme: W. HÜTTL, Antoninus Pius, I-II, Praha 1933-1936; M.
HAMMOND, The Antonine monarchy, “Mem. Am. Acad. Rome”, 1959. Sul nuovo
vallum in Britannia, A.S. ROBERTSON, The Antonine Wall, Glasgow 1960.
232
Per una più completa comprensione della figura di M. Aurelio, alle
fonti sopra elencate si devono aggiungere i suoi Colloqui con se stesso
(). Tra le opere d’insieme, sono da
ricordare U. VON WILAMOWITZ, Kaiser Marcus, Berlin 1931; A.S.L.
FARQUAHRSON, Marcus Aurelius. His life and his world, Oxford 1951; F. CARRATA
THOMES, Il regno di Marco Aurelio, Torino 1953. Un’analisi della tradizione
(particolarmente avversa) su L. Vero, in P. LAMBRECHTS, L’empereur Lucius
Verus. Essai de réhabilitation, in “Ant. class.” III (1934) p. 173 sgg. Circa i
movimenti migratori in Asia, e le loro ripercussioni sulla spinta dei Germani
oltre il confine danubiano, v. L. HALFEN, in “Cambr. Anc. Hist.”, XII, p. 104
sgg.; sulla liberazione di Aquileia e le relative misure difensive, A. DEGRASSI Il
confine nord-orientale dell’Italia romana, Bari 1954, p 113 sgg. Sulla colonna
antonina e la sua storia sceneggiata delle campagne combattute fra il 171 e il
175, W. ZWIKKER, Studien zur Markussäule, I, Amsterdam 1941 e G. BECATTI,
La colonna coclide, cit. Sul tentativo insurrezionale di Avidio Cassio, J. KENYON,
The revolt of Avidius Cassius, in “Arch. f. Papyrusf.” VI, 1913, p. 213 sgg.
Sul regno di Commodo si ricorda anzitutto il lavoro di J. STRAUB in
“Reallex. f. Ant. u. Christ.” III (1957) p. 251 sgg. Un’ampia monografia
complessiva è ora quella di F. GROSSO, La lotta politica al tempo di Commodo,
Torino 1964, fondata su un minuzioso riesame della tradizione letteraria e del
materiale documentale.
233
XIII
La crisi del terzo secolo e il tramonto del principato.
1. Evoluzione politica e declino economico. - L’uccisione di
Commodo concludeva un primo ciclo di sviluppo del
sistema politico creato da Augusto. Nei progetti del suo
ideatore il nuovo regime risultava dall’inserzione del potere
personale del principe, pacificatore dei contrasti civili, nei
tradizionali schemi repubblicani incentrati nel senato,
espressione dell’antica nobiltà romana. Arbitro assoluto
delle forze armate, e in misura sempre crescente delle
finanze, della giustizia, delle leggi, l’imperatore aveva preso
in pugno le principali leve del comando, ma aveva lasciato
varie attribuzioni al senato e ai magistrati inaugurando un
sistema di collaborazione capace di caratterizzare come
“civile” il suo potere.
Peraltro la coesistenza, necessariamente equivoca, fra
poteri del princeps e istituzioni repubblicane richiedeva un
grande equilibrio per non scivolare nell’assolutismo, come
accadde durante le esperienze “tiranniche” di Caligola o di
Nerone o di Domiziano o di Commodo, e soprattutto
esigeva negli imperatori un prestigio personale (auctoritas)
capace di coordinare il contrastante gioco delle varie forze
e dei rispettivi interessi. Quando una di queste forze, quella
degli eserciti provinciali, prese il sopravvento e volle fare
dell’imperatore l’esclusivo rappresentante dei propri
interessi, il principato civile doveva cedere ineluttabilmente
il passo alla monarchia militare, e questa a sua volta
234
preparò l’avvento della forma assolutistica del “dominato”
attraverso una crisi che riempie di sé tutto il III secolo.
Gli aspetti di questa crisi furono molteplici: Settimio
Severo, il vincitore della lotta scatenatasi alla morte di
Commodo fra vari pretendenti, era ben consapevole che
della vittoria egli era debitore unicamente agli eserciti che
avevano appoggiato la sua candidatura, e che per
mantenersi al potere doveva assicurarsi il favore
dell’elemento militare Questo egli ottenne non soltanto con
l’elargizione di donativi e benefici vari, ma militarizzando,
per cosi dire, il governo dell’impero. Gli appartenenti alle
antiche aristocrazie dirigenti vennero in tal modo via via
esclusi da quei posti che per antico privilegio occupavano
negli uffici militari e civili, e costretti a far largo ad un buon
numero di nuovi elementi più o meno “barbari”, che si
erano distinti nel servizio militare risalendo dai gradi più
bassi fino ai comandi più elevati. Sulla fedeltà di questi
funzionari l’imperatore poteva tranquillamente fare
affidamento così come quelli potevano contare sui vantaggi
del suo favore.
Ma un tale sistema portava ad una grande instabilità
del potere imperiale. Gli eserciti provinciali, stanziati l’uno
assai lontano dall’altro e ormai reclutati non più in Italia,
ma fra le popolazioni locali, avevano bisogni e desideri
diversi. Una volta verificatasi la possibilità, per le forze
dislocate su un settore della frontiera, di imporre come
imperatore il loro comandante, e quindi di ricavarne
particolari benefici, era naturale che anche gli altri eserciti
alla prima occasione sostenessero un loro candidato e lo
contrapponessero a quello sostenuto da altri. Il progressivo
aggravarsi di questa caotica situazione, per cui ad un certo
punto la monarchia militare sfociò nell’anarchia militare,
aveva come effetto non solo di compromettere la difesa dei
235
confini dalle incursioni dei barbari, ma anche di svuotare le
casse dello Stato.
Per trovare i denari necessari a pagare stipendi e
donativi ai suoi soldati, l’imperatore seguiva la duplice via
delle confische e del più esoso fiscalismo. La pressione
tributaria nelle province fu spinta al massimo e, per
assicurare la riscossione delle tasse nei vari centri, ne
furono dichiarati responsabili i cittadini più abbienti che
dovevano versare di tasca loro quanto mancava a
raggiungere la somma stabilita. Ancora più disastrosa fu
l’introduzione della annona militaris, l’imposta in natura o,
piuttosto, un sistema di requisizioni adottato per ovviare
agli inconvenienti del continuo svilimento della moneta.
Settimio Severo per primo, come sembra, vi aveva fatto
ricorso per assicurare l’approv-vigionamento degli eserciti,
e la borghesia provinciale fu trascinata sull’orlo della
rovina. Quanto poi alle confische, esse colpivano
soprattutto i grandi latifondisti della classe senatoria e
contribuirono ad acuire l’ostilità del senato verso
gl’imperatori del III secolo. Fu una lotta talora scoperta
(come nel caso di Massimino, che il senato dichiarò hostis
publicus), ma per lo più sotterranea, nel corso della quale
gl’imperatori a poco a poco tolsero ai senatori quasi tutti i
loro privilegi amministrativi e, con Gallieno, giunsero ad
escluderli dai comandi militari e, quindi, dal governo di
buona parte delle province.
2. Mistica dell’assolutismo e trasformazione culturale. - In tal
modo, con l’appoggio dell’esercito, gli imperatori
piegavano l’opposizione dei senatori, ma nello stesso
tempo ancor più li umiliavano e, quindi, indirettamente,
toglievano importanza a quel riconoscimento ufficiale del
senato che ancora costituiva un elemento indispensabile
per legalizzare il loro potere. La naturale conseguenza di
236
ciò fu che verso la fine del secolo gl’imperatori smisero
addirittura di chiedere il riconoscimento del senato dopo
l’acclamazione dei soldati, e cercarono una nuova base di
legittimità al loro potere promuovendo lo sviluppo di una
vera e propria mistica dell’autorità imperiale, che ne
consacrava il carattere sovrumano.
L’intrinseca aridità dei culti ufficiali, insufficienti ad
appagare l’ansia interiore dell’individuo, aveva da tempo
favorito la diffusione fra tutte le classi sociali delle religioni
orientali, così ricche di speranze nell’avvento di un mondo
migliore (e si è notato che già nel 95 un console era
cristiano). Nella generale atmosfera di aspettazione
l’imperatore si presentò alle masse come l’unico capace di
realizzarne le aspirazioni e le avviò ad accogliere una nuova
forma di assolutismo teocratico che da una parte ribadiva la
natura divina della sua persona, dall’altra proclamava
l’origine divina dell’investitura imperiale. “Imperatore-Dio”
e “Imperatore per grazia di Dio” furono quindi due
concezioni che per un certo tempo si svolsero
parallelamente mentre in seguito, con l’avvento degli
imperatori cristiani, la seconda ebbe la prevalenza fino ad
escludere l’altra.
Ma bastava un malcontento fra le truppe, o
l’insorgere di un fortunato pretendente, per trascinare nella
polvere il dominus et deus. Innumerevoli furono gl’imperatori
del III secolo caduti per mano di quei soldati che li
avevano innalzati alla porpora imperiale, sicché può dirsi
che in quest’epoca la nomina ad imperatore equivaleva ad
una condanna a morte a più o meno breve scadenza.
Di una tale caotica situazione gl’imperatori erano,
dunque, più le vittime che gli artefici, costretti nello stesso
tempo ad assicurarsi la dubbia fedeltà dei soldati e a
resistere all’opposizione interna capeggiata dal senato e dai
ceti abbienti rovinati dalle enormi spese militari; costretti a
237
difendere i confini dalle incursioni dei barbari e, nello
stesso tempo, a lottare contro gli avversari suscitati dai vari
pronunciamenti militari. Anche l’unità dell’impero fu più
volte in pericolo; una via di salvezza fu escogitata da
Diocleziano con la suddivisione del potere nelle mani di
due Augusti e di due Cesari, ma anche questo espediente,
in fondo, ebbe l’effetto di assecondare l’azione delle forze
disgregatrici e di spianare la via alla divisione dell’impero
stesso. Contemporaneamente si accentuava lo svolgimento
dei tradizionali valori artistici e culturali: i primi con risultati
di grande validità specie nell’architettura e nella ritrattistica,
gli altri, naturalmente, con vari riflessi sulla letteratura
storica. Di questa non poca parte è andata perduta, e se
pure con l’ausilio delle superstiti fonti documentali
(iscrizioni, papiri, monete) è possibile tracciare un quadro
complessivo degli sviluppi del III secolo, meno agevole
riuscirà distinguere, in una rapida sintesi, la personalità e
l’opera dei singoli imperatori, anche perché in genere la
loro azione si svolse, per così dire, sui binari obbligati della
lotta contro i pretendenti, dell’affermazione del loro
assolutismo contro il senato, della difesa dei confini contro
la minaccia barbarica.
3. La dinastia dei Severi. - P. Elvio Pertinace, il quale come
s’è detto rivestiva l’alta carica senatoria di praefectus urbis
alla morte di Commodo, fu acclamato imperatore, dopo
solo tre mesi cadde vittima della indisciplina dei pretoriani,
che lo sostituirono con un altro consolare, L. Didio
Giuliano, il pretendente che li aveva comprati con l’offerta
del più alto donativum. Ma la posizione di costui era troppo
debole per resistere alla vigorosa azione intrapresa dal
governatore della provincia danubiana della Pannonia, P.
Settimio Severo, nato in Africa da famiglia equestre e salito
per le doti di condottiero fino alle più alte cariche militari
238
della carriera senatoria. Alla testa delle sue legioni, che lo
avevano acclamato imperatore, Settimio Severo,
atteggiandosi a vendicatore di Pertinace, marciò su Roma,
ottenne il riconoscimento del senato (giugno 193) e, dopo
l’immediata eliminazione di Didio Giuliano, si sbarazzò
anche dei più validi sostenitori di quello, i pretoriani,
sostituendoli con elementi tratti dal suo esercito. Da allora
in poi anche le coorti pretorie, come le legioni, sarebbero
state composte di provinciali, un altro aspetto del crescente
affermarsi di costoro di fronte all’elemento italico.
Quasi contemporaneamente a Severo si erano
sollevati il governatore della Britannia, D. Clodio Albino, e
quello di Siria, C. Pescennio Nigro. Dopo aver tenuto a
bada in un primo momento Clodio Albino con il
conferimento del titolo di Caesar, che implicava
associazione al potere imperiale e designazione alla
successione, Severo li batté entrambi (Nigro ad Isso nel
194; Albino a Lione nel 197) e rimase unico padrone
dell’impero. Per dare maggiore autorità al suo potere e,
insieme, per assicurarne la trasmissione ai figli, Severo si
autoadottò nella famiglia degli Antonini. Dopo avere, cioè,
ottenuta dal senato la riabilitazione e la divinizzazione di
Commodo, egli si proclamò ufficialménte nella titolatura
divi Commodi frater, e quindi divi Marci filius, divi Antonini Pii
nepos, divi Hadniani prònepos, ecc. e fece assumere al maggiore
dei suoi due figli (comunemente detto Caracalla) il nome di
M. Aurelio Antonino. Non si trattava, però, soltanto di un
espediente di governo, ma anche di una solenne
dichiarazione programmatica in favore della continuità di
quella politica che già gli Antonini avevano avviata, cioè la
politica
dell’inserimento
dell’elemento
provinciale
romanizzato fra le forze direttive dello Stato.
Uno degli aspetti di questa politica, che mirava in
fondo ad eliminare la differenza di rango fra cittadini e
239
sudditi dell’impero, fu anche l’impulso dato alla
rielaborazione del diritto, attenuando la rigidità dell’antico
ius civile e preparando quel livellamento che poi Caracalla
attuò con l’estensione del diritto di cittadinanza romana a
tutti i liberi abitanti dell’impero. Questa venne effettuata
con la emanazione della famosa constitutio Antoniniana del
212, la quale, secondo Cassio Dione, perseguiva soprattutto
l’intento di allargare il numero dei cives su cui gravavano
particolari imposte come, per esempio, la vicesima
hereditatium (la tassa di successione).
Fortemente impregnato delle superstizioni orientali
(la moglie, Giulia Domna, era una principessa siriaca della
famiglia dei re-sacerdoti del dio Baal), Settimio Severo ne
favorì la diffusione nell’impero; contro la resistenza
senatoria condusse una ferma politica di repressione e
riformò l’amministrazione statale militarizzandola nel
modo che s’è già accennato. Al termine di una vittoriosa
spedizione contro i Parti (a. 197), istituì le nuove province
di Mesopotamia e di Osroene, ma non riuscì nemmeno lui
a chiudere il secolare conflitto. Gli ultimi anni li dedicò a
consolidare il dominio della Britannia, ove i Caledonii
avevano superato la linea fortificata di Antonino Pio e
minacciavano di superare anche quella di Adriano, e morì a
Eburacum (York) il 4 febbraio del 211.
A capo dell’impero restavano i due giovani figli di
Settimio Severo, M. Aurelio Antonino, nato nel 186, e P.
Settimio Geta, nato nel 189, che egli già aveva innalzato alla
dignità di correggenti (Antonino Caesar dal 196 e Augustus
dal 198, Geta Caesar dal 198 e Augustus dal 199). Dopo circa
un anno Antonino si sbarazzò del fratello trucidandolo di
sua mano e inaugurò un regime di ferreo dispotismo.
Ambizioso e maniaco (dalla mania di portare un
lungo mantello barbarico, detto caracalla, gli rimase per
sempre questo nomignolo), egli continuò la politica del
240
padre per l’innalzamento dei provinciali (cui concesse,
come già s’è detto, il diritto di cittadinanza romana
mediante la constitutio Antoniniana del 212), e volle emularne
la gloria militare riprendendo nel 215 la lotta contro i Parti.
I risultati della spedizione furono peraltro di scarso rilievo e
nell’aprile del 217, presso Carre, egli cadde vittima di una
congiura ordita da Macrino, il suo prefetto del pretorio.
M. Opellio Macrino, il primo cavaliere che assunse la
porpora imperiale, cercò di mantenersi al potere col favore
dei militari e del popolino di Roma, ma dopo un anno
(giugno 218) fu travolto dalle macchinazioni della famiglia
dei Severi, che provocarono la ribellione dell’esercito. Il
pretendente contrapposto a Macrino era il quattordicenne
Eliogàbalo, figlio di Giulia Soemiade (una nipote di Giulia
Domna). Gran sacerdote del dio Elagabal, da cui fu
soprannominato, al momento dell’acclamazione a
imperatore egli assunse il nome di M. Aurelio Antonino,
già portato da Caracalla. La continuità dinastica era stata
così restaurata, ma con poco profitto della stabilità di
governo perché il ragazzo, che era completamente
dominato dalla forte personalità della nonna, Giulia Mesa,
dopo aver fatto di Roma il teatro delle sue stravaganze di
principotto orientale, nel marzo del 222 fu eliminato dalla
solita rivolta dei pretoriani. Gli succedeva suo cugino
Alessiano Bassiano (nato da Giulia Mamea, l’altra figlia di
Giulia Mesa), che la nonna gli aveva fatto adottare col
nome di M. Aurelio Severo Alessandro.
Severo Alessandro fu per vari aspetti principe
migliore di Caracalla e di Eliogabalo, anche se nella
storiografia antica, specialmente nella Historia Augusta, la
sua figura venne sottoposta a un processo di idealizzazione
ed esaltata come modello di virtù. In stridente contrasto col
nome che portava, quello del grande Alessandro (nome nel
quale si esprimevano le profonde aspirazioni di quell’età
241
verso la fondazione di una monarchia universalistica), il
nuovo principe era debole di carattere e subì dapprima la
volontà della nonna, l’ambiziosa Giulia Mesa ai cui intrighi
doveva il trono, poi quella della madre; del resto, quando
era stato chiamato all’impero non aveva che diciassette
anni. Tuttavia fu merito della mitezza della sua indole se
Roma non fu insanguinata dalle consuete violenze, anche
se non è da credere (come raccontarono taluni storici
antichi) che veramente per sua opera si realizzasse un
ritorno all’antico “principato civile”. Più esattamente si
deve ritenere che il senato non fu restaurato nelle antiche
attribuzioni, ma solo trattato con maggior riguardo.
Durante il principato di Severo Alessandro gravi
pericoli si delinearono in Oriente, ove sul trono dei Parti
alla dinastia degli Arsacidi era succeduta quella dei
Sassànidi, fondatori di un nuovo impero persiano ben
organizzato e fortemente espansionista. Il giovane
imperatore, che non aveva attitudini militari, fu costretto a
intraprendere una difficile campagna per la difesa dei
confini (a. 231-232), ma i risultati furono poco brillanti;
addirittura disastrosi, poi, quelli della guerra contro gli
Alamanni che avevano invaso la Gallia (a. 234-235). Il
comportamento troppo incerto e quasi vile di Severo
Alessandro, che si abbassò a comprare la pace a peso d’oro,
suscitò la rivolta dell’esercito, e il principe fu assassinato
insieme con la madre (marzo 235).
4. Il periodo della “anarchia militare”. - Alla morte di Severo
Alessandro ebbe inizio un vorticoso susseguirsi di
imperatori, acclamati dai vari eserciti e costretti a restare
quasi sempre sul campo per difendere i confini dai barbari
e, più ancora, il loro potere da numerosi pretendenti. È il
periodo della “anarchia militare”, che durò fino alla morte
di Gallieno.
242
C. Giulio Vero Massimino (detto comunemente
Massimino il Trace), pervenuto all’impero dopo una lunga
carriera militare incominciata dai gradi più bassi, dedicò i
tre anni del suo impero (235-238) a respingere le invasioni
di Germani, Sarmati e Daci spremendo tutte le risorse
dell’impero per i bisogni del suo esercito e tartassando
senza alcun riguardo senato e ricca borghesia. Sollevatosi in
Africa il proconsole M. Antonio Gordiano, il senato
riconobbe imperatori lui e l’omonimo figlio e, dopo aver
istituito un alto commissariato per la difesa dello Stato (i
vigintiviri consulares ex senatus consulto rei publicae curandae),
preparò la guerra a Massimino condannandolo come hostis
publicus. Mentre i due Gordiani, dopo circa un mese di
regno (aprile 238), erano soppressi dal comandante della
legione III Augusta di stanza in Africa, che non aveva
aderito alla rivolta, Massimino scese in Italia, ma incontrò
gravi difficoltà nell’assediare Aquileia, e nel maggio cadde
vittima del malcontento delle sue truppe.
Il senato, dopo l’uccisione dei due Gordiani, aveva
cercato di farsi arbitro della situazione proclamando
imperatori due dei vigintiviri consulares, D. Celio Calvino
Balbino e M. Clodio Pupieno Massimo; ma questa
soluzione non incontrò il favore della plebe romana,
infatuata di un suo ideale dinastico, tanto che si dovette
venire a un compromesso: designare alla successione
imperiale, col titolo di Caesar, il giovinetto Gordiano,
nipote dei precedenti. Ma questa nuova formula, in cui la
preminenza l’aveva il senato, non risultò di gradimento dei
pretoriani, i quali circa l’agosto di quello stesso anno 238
assassinarono Balbino e Pupieno e proclamarono Augusto
il cesare Gordiano.
Gordiano (III) era solo un ragazzo di circa dodici
anni, ma poté reggersi al potere fino al 244 grazie
all’appoggio del suocero, il valente prefetto del pretorio C.
243
Furio Sabinio Aquila Timesiteo, che ottenne brillanti
successi sulla frontiera del Danubio e dell’Eufrate. Morto
Timesiteo, forse per gl’intrighi di M. Giulio Filippo, questi
gli successe nella prefettura del pretorio e ben presto seppe
insinuarsi nelle grazie dell’esercito, che massacrò Gordiano
ed elesse lui imperatore.
Filippo (detto l’Arabo per la sua origine), resistette al
potere fino all’autunno del 249 distinguendosi nella difesa
del confine danubiano, ed ebbe la ventura di celebrare il 21
aprile del 248 il primo millenario della fondazione di Roma.
L’anno appresso fu battuto e ucciso da Traiano Decio,
generalmente noto per la violenta persecuzione contro i
cristiani, la quale va considerata come un aspetto della
politica di restaurazione dei valori tradizionali, anche
religiosi, tentata dall’imperatore. Decio, che fu il primo
imperatore romano a morire in battaglia, cadde nel 251
combattendo contro i Goti, e dopo due anni di lotte
convulse, nei quali si succedettero al potere Ostiliano, figlio
di Decio, C. Vibio Treboniano Gallo (251-253), C. Vibio
Volusiano (251-253) e M. Emilio Emiliano (253), il potere
venne nelle mani di P. Licinio Valeriano, proveniente da
famiglia di antica dignità senatoria.
Con la sua elezione il conflitto tra imperatore e
senato si assopiva ancor più che sotto Decio, ma intanto
cresceva da ogni parte la minaccia sui vari settori del
confine; associatosi come correggente il figlio P. Licinio
Gallieno, Valeriano si divise con lui i compiti della difesa
assumendo per sé la direzione della guerra contro i
Persiani. Dopo qualche successo, nel 260 patì una
disastrosa rotta ad Edessa e rimase prigioniero nelle mani
del re Shahpur I. Restava unico imperatore Gallieno, che
già aveva combattuto sul Reno e sul Danubio dal 254 al
258, e ora dovette continuare la guerra da solo, per di più
in condizioni generali tanto disperate, da far sembrare
244
compromessa l’unità stessa dell’impero. Infatti in
Occidente i disastri causati da una nuova invasione di
Franchi e di Alamanni portarono la Gallia ad organizzare,
per meglio difendersi, uno Stato separato (comprendente
anche la Spagna e la Britannia) con a capo l’imperatore M.
Cassianio Latinio Postumo (258-267), uno dei generali che
Gallieno aveva lasciato sul posto per sorvegliare la
situazione. D’altra parte in Oriente la città di Palmira (sita
al centro di un’oasi nel deserto siro-arabico, a metà strada
fra il Mediterraneo e l’Eufrate), dopo aver costituito un
valido baluardo contro i Persiani sotto il governo del
principe indigeno Odenato, alla morte di costui, venuto il
potere nelle mani della vedova Zenobia e del figlio
Vaballato, intraprendeva una nuova politica di autonomia e
di espansione antiromana, arrivando fino ad invadere
l’Egitto.
Gallieno tentò invano di stroncare questi due moti
separatisti, anche perché impegnato a respingere dall’Italia
un’invasione degli Alamanni e costretto a difendersi da un
nugolo di pretendenti. Questi durante il suo regno furono
tanto numerosi, da indurlo al provvedimento di escludere i
senatori dai comandi militari, sostituendoli con elementi
dell’ordine equestre; in realtà i comandanti militari di rango
senatorio, col loro maggior prestigio, più facilmente degli
altri erano spinti a tentare la scalata del potere. Fu mentre
assediava in Milano il pretendente Aureolo che Gallieno
venne eliminato da una congiura (marzo 268).
5. La ripresa sotto gli “imperatori illirici”. - Scomparso
Gallieno, a capo dell’impero si susseguirono alcune figure
di valenti condottieri che con la loro energia seppero
frenarne il processo di disgregamento. Si tratta degli
“imperatori illirici”, così detti perché originari delle
province danubiane. Il primo di essi fu M. Aurelio Valerio
245
Claudio (Claudio II), soprannominato il Gotico per la
grande vittoria riportata nel 269 a Naissus (odierna Nisch,
in Serbia).
Ucciso dalla peste nel 270 dopo appena due anni di
governo, ebbe un degno continuatore della sua opera in L.
Domizio Aureliano, un brillante ufficiale che proveniva dai
gradi più bassi. Liberata l’Italia dalla minaccia degli Iutungi,
che erano calati fino nell’Umbria, Aureliano riuscì a
restaurare l’unità dell’impero annientando da una parte le
mire autonomistiche di Palmira, dall’altra battendo Tetrico,
successore di Postumo, e ponendo fine all’esperimento
separatistico della Gallia. Ma i pericoli restavano gravissimi
(tanto che l’imperatore si preoccupò di fortificare con una
nuova cinta muraria la stessa Roma, le maestose “mura
Aureliane”), mentre scemavano i mezzi di difesa, e si
dovette abbandonare la Dacia riportando in quel settore il
confine sul Danubio. Dopo aver introdotto varie riforme
nell’amministrazione civile, soprattutto con l’istituzione dei
correctores Italiae (che rappresentò un altro passo verso quel
pareggiamento dell’Italia alle province che fu poi
definitivamente attuato da Diocleziano), Aureliano si
preparava ad una grande spedizione contro i Persiani, ma
presso Bisanzio cadde vittima di una vendetta privata (275).
Rimasto senza imperatore, l’esercito (cosa inusitata!)
chiese al senato di nominare il successore, e l’assemblea,
dopo lunghe esitazioni, designò il vecchio consolare M.
Claudio Tacito, dando in tal modo la misura delle sue reali
possibilità di fronte al problema del potere imperiale. Si
trattava infatti di un uomo di settantacinque anni, che
aveva percorso una carriera essenzialmente civile; se mai
aveva esercitato comandi militari di un qualche rilievo, egli
doveva essere allora inesperto delle importantissime
innovazioni tattiche e strategiche introdotte da Gallieno in
poi nell’esercito per renderlo più adatto alla guerra di
246
movimento. Sta di fatto che, dopo appena un anno, Tacito
fu travolto dal malcontento dei militari, che lo sentivano
estraneo al loro ambiente e ai loro ideali, e gli successe un
altro illirico, M. Aurelio Probo, degno continuatore
dell’opera di Aureliano.
Nei sei anni del suo regno (276-282) Probo si spostò
infaticabilmente da un settore all’altro del confine per
ristabilirvi la sicurezza, battendo sul Reno i Franchi e gli
Alamanni, sul Danubio i Burgundi, i Vandali e i Sarmati, in
Egitto i Blemmi. Rispettoso del senato, ma non, come
vorrebbe una tradizione tendenziosa, al punto da
reintegrarlo nelle sue antiche funzioni di governo (ciò che
del resto non aveva fatto nemmeno Tacito, l’imperatore
eletto dal senato), Probo si preoccupò di mantenere
nell’esercito la più severa disciplina, provocando però alla
lunga con i suoi rigidi sistemi il malcontento delle truppe.
Su questo stato di cose fece leva un movimento sedizioso
capeggiato dal prefetto del pretorio M. Aurelio Caro, e
l’imperatore, ormai incapace di tenere in pugno i suoi
uomini, restò travolto.
M. Aurelio Caro è soprattutto da ricordare come il
primo imperatore che, dopo l’acclamazione dell’esercito,
non si curò più di ottenere il riconoscimento del senato.
Questo perdeva allora definitivamente il diritto di
partecipare, sia pura in maniera formale, all’investitura
imperiale, il che rappresenta uno degli aspetti più
caratteristici del passaggio dal “principato” al “dominato”.
Caro, che si era associato all’impero i due figli Carino
(cui affidò la difesa dell’Occidente) e Numeriano, condusse
in Oriente una brillante spedizione, ma trovò la morte
l’anno dopo presso il Tigri (283). Il comando dell’esercito
fu allora preso da Numeriano e, in suo nome, dal prefetto
del pretorio (L. Flavio?) Apro; costui per impadronirsi del
potere assassinò Numeriano, ma non ebbe il favore
247
dell’esercito, che acclamò invece imperatore C. Valerio
Diocle, un ufficiale di origine dalmata. Assunto il potere
col nome di C. Aurelio Valerio Diocleziano (284), questi
marciò contro Carino che, seppure vittorioso, fu eliminato
da una congiura (285). Tutto era ormai nelle mani di
Diocleziano e in lui l’impero aveva trovato l’uomo capace
di realizzare le riforme che s’imponevano d’urgenza in ogni
campo.
Tra le fonti letterarie più importanti per la ricostruzione dell’età dei Severi è
la già ricordata opera del contemporaneo ERODIANO (libb. II-VI). L’altro
contemporaneo CASSIO DIONE (che raggiunse il consolato per la seconda volta
sotto Severo Alessandro nel 229, data terminale delle sue Storie) vi dedicò i suoi
ultimi libri, dal LXXIV all’LXXX, giunti a noi nel compendio di XIFILINO
tranne il LXXIX e l’LXXX, che in buona parte si sono conservati nel testo
integrale. Poi i breviarii del IV sec., già menzionati nel capitolo precedente, e,
soprattutto notevoli, le biografie della Historia Augusta. Sull’attività legislativa
degl’imperatori, parecchi elementi si possono ricavare dalle constitutiones inserite
nel Codex Iustinianus e dagli estratti dei giureconsulti raccolti nei Digesta.
Indicazioni sulla durata del regno e sul dies natalis degl’imperatori si trovano nel
calendario romano pubblicato nell’anno 354 da un anonimo che viene
denominato “il Cronografo del 354”, su cui v., p. es., H. STERN, Le calendrier de
354, Paris 1953. Della Storia ecclesiastica di EUSEBIO si riferisce all’età dei Severi il
libro VI.
Opere complessive di informazione e di orientamento sull’età dei
Severi (e, più in generale, della storia del III sec.): M. BESNIER, L’empire romain
de l’avènement des Sévères au Concile de Nicée (nella Histoire Générale fondée par G.
GLOTZ), Paris 1937; il vol. XII della già citata Cambridge Ancient History
(Cambridge 1939); A. CALDERINI, I Severi. La crisi dell’impero nel III sec., Bologna
1949.
Sui principali aspetti dell’evoluzione economica e sociale, sempre di
grande importanza la già citata sintesi di M. ROSTOVZEV, Storia economica ecc.,
cit., p. 459 sgg., del quale peraltro non si può condividere la concezione del III
secolo come di un’età caratterizzata dal conflitto tra le borghesie cittadine da
un lato, e dall’altro le masse dei diseredati soggette alla dura vita militare o al
faticoso lavoro dei campi. Con una simile interpretazione sono in contrasto,
oltre che il noto passo di HERODIAN. VII, 3, 3 sulle spoliazioni di Massimino,
anche le suppliche di comunità agricole a Gordiano III e ai Filippi perché
abbiano a cessare le vessazioni e le requisizioni cui sono sottoposte dai militari:
cfr. DITTENBERGER, Syll.3 888; O.G.I.S. 519.
Per i mutamenti verificatisi nella composizione dell’assemblea
senatoria, nella quale appaiono in aumento gli elementi di provenienza
248
orientale, v. P. LAMBRECHTS, La composition du sénat romain de Septime Sévère à
Dioclétien (193-284), Budapest 1937; G. BARBIERI, L’albo senatorio da Settimio
Severo a Carino, Roma 1952. Sull’ascesa della classe equestre (nella quale peraltro
cominciano a entrare, attraverso i gradi della bassa ufficialità, molti elementi
provinciali) v. C.W. KEYES, The rise of the equites in the third century of the Roman
empire, Princeton 1915; G. LOPUSZANSKI, La transformation du corps des officiers
supérieurs dans l’armée romaine du Ier au IIIe siècle ap. J.-C., in “Mel. d’arch. et
d’hist.” LV, 1938. In questa cornice la prefettura del pretorio, divenuta il
gradino più elevato della carriera equestre, s’avvia alle funzioni e alla dignità di
vicariato imperiale: cfr. A. PASSERINI, Le coorti pretorie, Roma 1939, p. 233 sgg.;
L.L. HOWE, The pretorian prefect from Commodus to Diocletian, Chicago 1942.
Sugli sviluppi del culto imperiale, oltre il già citato W. ENSSLIN,
Gottkaiser und Kaiser von Gottes Gnaden, v. G. HERZOG HAUSER, in R.E., s.v.
Kaiserkult, Suppl. IV, col. 806 sgg. Sulla mistica della vittoria imperiale, che si
nutre delle concezioni della teologia solare, FR. CUMONT, La théologie solaire du
paganisme romain, in “Mem. Acad. Inscr. Bell. Lettr.” XII, 2 (1913) p. 447 sgg.;
A. ALFÖLDI, Insignien und Tracht, cit., p. 84 sgg.
Sulla figura e sull’opera di Settimio Severo le due trattazioni
complessive di M. PLATNAUER, The life and reign of the emperor L. Septimius Severus,
Oxford 1918, e di J. HASEBROECK, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers
Septimius Severus, Heidelberg 1921.
Nella vasta bibliografia sul regno di Caracalla, una parte cospicua è
dedicata ai problemi relativi all’estensione del ius civitatis: la sua portata, la sua
data, il suo significato, ecc. Nemmeno menzionato da Erodiano, il
provvedimento si conosceva unicamente da un sommario cenno del Digesto (I
5, 17: in orbe Romano qui sunt ex constitutione imp. Antonini cives Romani effecti sunt), a
cui vari decenni fa si è aggiunta la testimonianza di un papiro (Pap. Giessen, 40).
Purtroppo il documento ci è pervenuto lacunoso, e uno dei punti più
controversi è rappresentato dalla espressione (che vi si legge alla l. 9)
,
cioè
“a
esclusione dei dediticii”. Si discute su ciò da cui i dediticii venivano esclusi (e pare
che si trattasse appunto della concessione del diritto di cittadinanza), e poi su
chi fossero i componenti la categoria dei dediticii (nei quali saranno con ogni
probabilità da vedere le masse indigene rimaste del tutto estranee al processo di
romanizzazione). Su queste interpretazioni, v. S. MAZZARINO, Trattato, cit., p.
397 sgg. La data finora generalmente accolta per l’emanazione della constitutio (il
212) è stata di recente posta in discussione: F. MILLAR, The date of the Constitutio
Antoniniana, in “Journ. Egypt. Arch.” XLVIII (1962), p. 124 sgg. vorrebbe
spostarla al 214, mentre secondo W. SESTON (in Mélanges offerts à J. Carcopino,
Paris 1966, p. 877 sgg.) la data più probabile sarebbe quella dell’estate-autunno
213. Sui risultati della campagna partica, celebrata con la leggenda
VIC(TORIA) PART(HICA) che compare nella monetazione del 217
(MATTINGLY-SYDENHAM, The Roman Imp. Coinage, IV, 1, p. 257), è da tener
presente lo studio di A. GÜNTHER, Beiträge zur Geschichte der Kriege zwischen
Römern und Parthern, Berlin 1922. Nel continuo peggioramento della moneta, il
249
denarius argenteo, che all’inizio dell’impero aveva avuto un contenuto di fino
pari al 90% circa, aveva visto ridursi tale contenuto a meno della metà; al
conseguente rincaro dei prezzi Caracalla cercò di ovviare col mettere in
circolazione un nuovo denarius di peso quasi doppio, il cosiddetto
“antoniniano” (cfr. L.C. WEST, Gold and Silver Coin Standards, cit., p. 121).
Contemporaneamente veniva “ritoccato” anche il peso dell’aureus, che Nerone
aveva portato a g. 7,28 e ora fu ulteriormente abbassato a g. 6,54: ma la
situazione economica continuò a peggiorare. Con l’ampia notizia di Cassio
Dione (LXXVII 9) circa l’oppressione fiscale messa in atto da Caracalla non è
che in apparente contrasto quanto si legge in un nuovo documento, ossia nel
rescritto indirizzato il 216 dallo stesso Caracalla ai cittadini della colonia di
Banasa nella Mauretania (cfr. R. THOUVENOT, in “Compt. Rend. Acad. Inscr.”,
1946, p. 548 sgg.): Obsequium et fidem vestram remunerans, omnia quaecumque sunt
debita fiscalia frumentaria sive pecuniaria, pendentium quoque causarum, concedo vobis ecc.
Se qui, in sostanza, l’imperatore condona gli arretrati delle imposte dovute sia
in denari sia in natura, ciò è solo perché i Banasitani possano in appresso meglio
assolvere ai loro obblighi verso il fisco, come viene espressamente sottolineato
dalla successiva espressione del rescritto: praesumo omnes de cetero annuas
pensitationes sive in frumento seu in pecunia eo promptius daturos quo me reputabitis non
expectasse quin ultro offerrem neque petentibus vobis neque sperantibus nova remedia et
magnificam indulgentiam.
Al tempo di Caracalla risulta testimoniato per la prima volta il
“correttorato dell’Italia”, istituzione destinata ad avviare il livellamento
amministrativo dell’Italia alle province; su ciò v. nelle note all’ultimo capitolo.
Sul breve tentativo di Macrino, v. H. MATTINGLY, The reign of Macrin, in
“Studies to D.M. Robinson”, II, Saint Louis 1953, p. 962 sgg.; su Elagabalo
(oltre gli antiquati O.F. BUTLER, Studies in the life of Heliogabalus, New York
1908, e J. STUART HAY, The amazing emperor Heliogabalus, London 1911), v. K.
GROSS, in “Reallex. f. Ant. u. Christ.” IV (1959), p. 987 sgg. Più e meglio
studiata la figura e l’opera di Severo Alessandro, anche in connessione col
progredire degli studi sulle biografie dell’Historia Augusta, nel cui ambito la vita
di questo imperatore occupa un posto particolare. Infatti la già notata
“tendenza” di reazione paganeggiante all’impero cristiano, dalla quale fu
ispirata la composizione delle Vite, portò a idealizzare (dunque, a deformare) la
rappresentazione di Severo Alessandro, facendone un modello di imperatore
del buon tempo antico. Per queste interpretazioni della Historia Augusta sono
fondamentali le ricerche di J. STRAUB (fra l’altro: Studien zur Historia Augusta,
Bernae 1952; Vom Herrscherideal im Spatantike, Stuttgart 1939). Il principe, che
nel suo nome di Alessandro proclamava l’aspirazione dei tempi verso la
fondazione di una monarchia universale, dovette invece sostenere una dura
lotta in difesa del confine orientale (contro l’aggressività della nuova dinastia
sassanide: cfr. A. CHRISTENSEN, L’Iran sous les Sasanides, 2a ed., Copenhagen
1944, p. 86 sg.) e del confine renano, ove gli venne meno l’appoggio
dell’esercito e fu massacrato (v., in generale, A. JARDÉ, Études critiques sur la vie et
le règne de Sévère Alexandre, Paris 1925). Di contro al ristagnare del paganesimo
250
tradizionale è da osservare da una parte l’ondata di nuovo fervore religioso
introdotto in Roma dalle principesse siriache della casa dei Severi (si ricordi che
fu per impulso di Giulia Domna che Filostrato scrisse la Vita del santone
Apollonio di Tiana), dall’altro il largo diffondersi della fede cristiana sino a dar
luogo ai contrasti che divisero il papa Callisto da Ippolito, eletto vescovo di
Roma dai suoi partigiani e contrapposto a lui.
L’informazione di cui disponiamo per la storia dell’impero dopo i
Severi è ancora più angusta. Il racconto di Erodiano cessa con la morte di
Massimino, e si deve far ricorso soprattutto alle Vitae della Historia Augusta,
oltre che ai più volte ricordati breviarii. Di grande importanza sarebbe stato
poter disporre delle opere del contemporaneo P. ERENNIO DEXIPPO, autore di
Chronika che andavano dalle origini fino al 268, e di Skythikà che trattavano il
periodo 238-270, ma non si sono conservati che pochissimi frammenti (ed. in
JACOBY, FGrHist II A, p. 452 sgg.). I Chronika furono continuati da EUNAPIO
DI SARDI, i cui Hypomnemata historika andavano dal 270 al 404; anche questi,
come gli scritti di Dexippo, sono andati perduti, ma noi li utilizziamo
indirettamente perché da essi attinse ZOSIMO, la cui opera ci è pervenuta.
Zosimo era un funzionario dell’impero d’Oriente che verso la fine del V sec.
scrisse una Nuova Storia in 6 libri, di cui il primo offre un compendio della
storia dei primi tre secoli dell’impero. Nella Storia Ecclesiastica di EUSEBIO si
tratta del periodo fra i Severi e Diocleziano nei libri VI e VII.
Sulla figura e l’opera di Massimino il Trace, v. G.M. BERSANETTI, Studi
sull’imperatore Massimino il Trace, Roma 1940 (con aggiunte in “Epigr.” III, 1941,
p. 5 sgg. e in “Riv. di Filol.” N. S. XX, 1942, p. 214 sgg.), nonché C. DI
SPIGNO, L’attività politico-militare dell’imperatore Massimino il Trace, in “Rend. Acc.
Lincei”, s. VIII, vol. III, 1948, p. 123 sgg. Stabilire la precisa successione dei
fatti di quell’anno 238 che vide, oltre la fine di Massimino, anche quella di altri
quattro Augusti: i due Gordiani, Balbino e Pupieno) dà luogo a non poche
perplessità; cfr. G. VITUCCI, Sulla cronologia degli avvenimenti del 238, in “Riv. di
Filol.” N.S. XXXII (1954) p. 372 sgg. Sulla politica di Gordiano III, cfr. P.W.
TOWNSEND, in “Yale Class. St.” IV (1934), p. 59 sgg. In particolare, sulle sue
imprese contro la Persia è da ricordare una testimonianza di carattere
eccezionale. Si tratta della grande iscrizione trilingue scoperta a Persepoli una
trentina di anni fa e contenente il racconto delle gesta compiute dal re Shahpur
I (241-272), onde si suole denominarla Res gestae divi Saporis per analogia con le
Res gestae divi Augusti, cfr. G. PUGLIESE CARRATELLI, Res gestae divi Saporis, in
“La Parola del Passato” II (1947), p. 209 sgg.; E. HONIGMANN - A. MARICQ,
Recherches sur les Res Gestae Divi Saporis, Bruxelles 1953.
Su Filippo e il millenario di Roma cfr. J. GAGÉ, Saeculum novum. Le
millénaire de Rome et le templum urbis sur les monnaies du IIIe siècle ap. J.-C., in “Trans.
Int. Num. Congr.”, London 1938, p. 179 sgg. Su Decio, F.S. SALISBURY, The
reign of Trajan Decius, in “Journ. Rom. St.” XIV (1924) p. l sgg. A proposito della
persecuzione (da considerare anzitutto come un atto di difesa del paganesimo,
e poi, indirettamente, di lotta al cristianesimo) è da ricordare che i papiri
egiziani ci hanno conservato un certo numero di documenti molto interessanti,
251
i libelli. Si tratta di attestati che si rilasciavano a chi avesse compiuto il prescritto
atto di culto agli dei, e servivano a proteggerlo dal pericolo delle gravi pene
previste per i trasgressori (cfr A. BLUDAU, Die ägyptischen libelli und die
Christenverfolgung des Kaisers Decius, in “Röm. Quartalschr.”, Suppl. XXVII,
1931).
Riguardo ai brevi regni degl’imperatori succedutisi fra la morte di Decio
e l’avvento di Valeriano (su cui la nostra informazione dipende in non poca
parte dal materiale numismatico), v. H. MATTINGLY, The Reigns of Trebonianus
Gallus and Volusian and of Aemilian, in “Num. Chron.” VI (1946) p. 36 sgg. Su
Valeriano, A. ALFÖLDI, Die Hauptereignisse der Jahre 253-261 n. Chr. im Orient im
Spiegel der Münzprägung, in “Berytus” IV (1937) p. 41 sgg.; G.M. BERSANETTI,
Valeriano ed Emiliano, in “Riv. di Filol.” N. S. XXVI (1948), p. 257 sgg. Sulle
nuove persecuzioni contro i cristiani, che Valeriano promosse più o meno
nello stesso spirito di quelle di Decio, cfr. P. PASCHINI, in “St. rom.” VI (1958),
p. 130 sgg. Su Gallieno, in generale, E. MANNI, L’impero di Gallieno. Contributo
alla storia del III sec., Roma 1949; in particolare, sulle sue riforme amministrative,
H.E. PETERSEN, Senatorial and equestrian governors in the third century A.D., in
“Journ. Rom. St.” XLV (1955), p. 47 sgg.; sulle riforme militari A. ALFÖLDI,
Zur Kenntnis der Zeit d. röm. Soldaten-Kaiser. I: Der Usurpator Aureolus und die
Kavalleriereform des Gallienus, in “Zeitschr. Num.” XXXVII, l927, p. 197 sgg.
Sull’imperium Galliarum, v. R. ANDREOTTI, L’usurpatore Postumo nel regno di
Gallieno, I, Bologna 1939; sullo stato palmireno, J.G. FEVRIER, Essai sur l’histoire
politique et économique de Palmyre, Paris 1931.
Su Claudio II, v. in generale P. DAMERAU, Kaiser Claudius II. Gothicus, in
“Klio” Beih. XX 1934; su Aureliano L. HOMO, Essai sur le règne de l’empereur
Aurélien, Paris 1904, aggiornato per quanto riguarda la documentazione
epigrafica da G. SOTGIU, Studi sulla epigrafia di Aureliano, Cagliari 1961. Sulle
nuove mura di Roma, I.A. RICHMOND, The city wall of imperial Rome, Oxford
1930, p. 27 sgg. Sulla restaurazione dell’unità imperiale, R. DUSSAUD, Un témoin
archéologique de la fin dramatique de Palmyre, in “Syria” XXII (1941) p. l94 sgg.; G.
ELMER, Die Münzprägung der gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand, in “Bonn.
Jahrb.” CXLVI (1941). Sul tentativo di raddrizzare la rovinosa situazione
finanziaria con una riforma monetaria (che resta piuttosto oscura nei
particolari), v. di recente C. GATTI, La politica monetaria di Aureliano, in “La
Parola del Passato” XVI (1961) p. 93 sgg. Sull’inconsistenza della tradizione
relativa ad una restaurazione dei privilegi del senato ad opera di Tacito, v. G.M.
BERSANETTI, in “Riv. Indo-Gr.-Ital.” XIX (1935) p. 19 sgg. Lo stesso tema
viene ripreso ancora una volta senza fondamento per Probo, ma v. per questo
e, in generale, sulla figura e sull’opera dell’imperatore, G. VITUCCI, L’imperatore
Probo, Roma 1952. Sugli ultimi predecessori di Diocleziano è da vedere la
esauriente monografia di P. MELONI, Il regno di Caro, Carino e Numeriano, Cagliari
1948, accurata nell’analisi delle fonti e generalmente plausibile nella
ricostruzione di un periodo storico per vari aspetti così tormentato e oscuro.
252
XIV
Il dominato.
Da Diocleziano alla fine dell’impero
d’occidente.
1. Diocleziano e il nuovo volto dell’impero. - L’opera
riformatrice di Diocleziano fu veramente grandiosa e sotto
vari rispetti rappresentò il coronamento di un travaglio
durato per tutto il corso del III secolo. E in effetti la
personalità di Diocleziano bene s’inquadra fra le figure dei
restitutores illirici; saldamente ancorato alla tradizione, egli
cercò sempre con grande impegno, anche se non sempre
con altrettanta fortuna, di salvare i vecchi istituti politici: un
uomo del passato rispetto all’uomo del futuro, a
Costantino, che saprà superare la tradizione e gettare le basi
di un ordinamento capace di sopravvivere ancora a lungo.
L’opera di restaurazione imponeva anzitutto di
consolidare il potere imperiale, liberandolo dalla piaga delle
continue usurpazioni, e di metterlo quindi nelle condizioni
migliori per assicurare la difesa dei confini. Diocleziano,
che già nel 285 aveva conferito al suo valoroso
collaboratore M. Aurelio Valerio Massimiano il titolo di
Caesar (senza tribunicia potestas), affidandogli il compito di
restaurare l’ordine nelle Gallie e sul limes renano, l’anno
dopo (1° aprile 286) lo innalzava alla dignità di Augustus
253
(con tribunicia potestas) con l’incarico di abbattere
l’usurpatore Carausio sollevatosi in Britannia.
L’impresa si rivelò più ardua del previsto, e nel
frattempo Diocleziano maturò il convincimento che i due
Augusti non potevano da soli provvedere agli sterminati
compiti della difesa militare e della amministrazione civile.
Pertanto nel 293 (10 marzo) a Massimiano venne
affiancato, col titolo di Cesare, C. Flavio Giulio Costanzo
(comunemente
detto
Costanzo
Cloro)
e
contemporaneamente Diocleziano nominava suo Cesare
un altro valente generale, C. Galerio Valerio Massimiano.
Nasceva così la “tetrarchia”, un sistema che, ripartendo fra
quattro capi il governo dell’impero, rappresentava come un
naturale sviluppo dell’istituto della correggenza entrato
ormai da gran tempo nella prassi costituzionale: esso era
destinato sia ad escludere il pericolo delle usurpazioni, in
quanto i Cesari erano designati a succedere agli Augusti, sia
ad attuare “la scelta del migliore” senza riguardo per i diritti
di sangue. Quest’ultima esigenza, in contrasto con la
naturale aspirazione dei principi ad assicurare la
successione ai loro figli, fu poi la prima ad essere calpestata,
ma intanto il potere imperiale acquistò una maggiore
stabilità che permise di condurre vittoriose operazioni su
tutti i fronti, ristabilendo dovunque la sicurezza dei confini
e riportando un certo grado di ordine e di pace.
In seno alla tetrarchia Diocleziano conservò una
posizione di preminenza non solo sui due Cesari, ma anche
rispetto all’altro Augusto, e la sua superiorità fu sottolineata
dall’assunzione del titolo di Iovius mentre M. Valerio
Massimiano prendeva quello di Herculius. In questi titoli si
proclamava la natura divina del potere imperiale, ormai
sottratto ad ogni ingerenza del senato ed esaltato dall’
introduzione a corte di un ancor più fastoso cerimoniale
254
orientalizzante; e come Giove era superiore ad Ercole, così
Diocleziano Giovio era superiore a Massimiano Erculio.
Forte di una tale assoluta e indiscussa autorità,
Diocleziano poté realizzare il suo vastissimo piano di
riforme. Fra queste un carattere di maggiore originalità
rivela il tentativo di risolvere i problemi finanziari
dell’impero con l’introduzione del sistema fiscale della
capitatio-iugatio. Tale sistema, nel quale si stabiliva l’identità,
ai fini della tassazione, fra caput (testa di lavoratore-colono)
e iugum, cioè fra unità di forze di lavoro e unità di superficie
lavorabile,
veniva
a
incidere
profondamente
sull’organizzazione dello stato, la cui vita restava
rigidamente condizionata dalla quantità di denaro di cui si
poteva disporre per far fronte alle necessità fondamentali, a
cominciare da quella della difesa militare. E poiché
l’imposizione tributaria colpiva soprattutto le plebi
rusticane delle province, la riforma fiscale ebbe dirette
implicazioni nella riforma dell’amministrazione provinciale.
Le antiche province furono da Diocleziano spezzettate in
unità minori, oltre un centinaio, col che si voleva anche
eliminare il ricorrente pericolo del separatismo, mentre
all’esigenza di mantenere la compattezza dell’impero e,
insieme, di rafforzare il potere centrale, rispondeva il
raggruppamento delle nuove province in dodici distretti
maggiori, le diocesi. E appunto nell’ambito di ogni diocesi
si computavano sia il numero dei coloni, sia l’estensione
delle terre soggette a imposizione (comprese in un apposito
catasto), e poi, in base al rapporto fra questi due elementi,
si determinava l’ammontare del tributo per ogni caput:
ammontare che variava da diocesi a diocesi, essendo
inversamente proporzionale alla densità demografica. E
come per assicurare la riscossione del tributo si applicava
rigorosamente il principio della responsabilità collettiva,
così allo stesso fine rispose l’istituzione del più stretto
255
legame fra il colono e la terra, la servitù della gleba. Ma
anche il più rigido sistema fiscale non poteva da solo
bastare a raddrizzare una situazione economica
compromessa, fra l’altro, dalla circolazione di una moneta
divisionale come il denarius, ridottosi a un piccolo pezzo di
rame imbiancato. A cominciare dai produttori, questi si
rifiutavano di cedere la loro merce in cambio di una
moneta il cui valore intrinseco era di gran lunga più basso
del potere di acquisto attribuitogli dall’autorità statale, e
invano Diocleziano sperò di mettere un freno al rincaro dei
prezzi con l’emanazione di un calmiere, il famoso edictum de
pretiis del 301. Uno dei capisaldi della riforma
dell’amministrazione provinciale fu poi la definitiva
separazione, già avviata da Gallieno, del potere civile da
quello militare. Ai governatori di provincia spettava
unicamente la cura dell’amministrazione civile, mentre il
comando dei presìdi militari era riservato ai duces, da essi
indipendenti; i duces erano poi subordinati ai rispettivi vicarii,
i capi delle dodici diocesi, che alla loro volta erano agli
ordini dei prefetti del pretorio.
Nella cornice dell’instancabile attività con cui
Diocleziano cercò d’impedire lo sfacelo dell’impero, vanno
messi in rilievo sia il potenziamento dell’esercito con
l’istituzione, fra l’altro, di una forza di manovra (i
comitatenses) al seguito diretto dell’imperatore, sia l’impulso
dato alla costruzione di strade che dovevano giovare alla
difesa militane. Tra queste particolarmente notevole la
strada fra Bostra (Arabia) e Palmira; un monumento
impressionante è poi il palazzo che l’imperatore si fece
costruire nel territorio di Salonae in Spalato.
Ma la sua figura di restitutor dell’impero, di
restauratore anche a costo di adottare provvedimenti
rivoluzionari, risalta in special modo dall’opera data al
riordinamento amministrativo dell’Italia. Al suo ideale di
256
restaurazione dell’impero egli infatti sacrificò anche una
delle istituzioni che vigevano incontrastate dai lontani
tempi della repubblica e, annullando l’antica posizione di
privilegio che nei confronti delle province aveva goduto
l’Italia, provincializzò anche questa dividendola in correcturae
e sottoponendola al regime fiscale della capitazione (a.
292). Il nuovo ordinamento fu portato a termine intorno al
298, quando la diocesi Italiciana, risultante dall’insieme delle
varie province (correcturae), fu posta sotto l’amministrazione
di due vicarii praefectorum praetorio (le altre diocesi
dipendevano invece ciascuna da un solo vicarius). Dei due
suddetti vicarii, corrispondenti alla divisione dell’Italia in
Italia annonaria (a nord) e Italia suburbicaria (quella
centromeridionale), il primo ebbe sede in Milano col titolo
di vicarius Italiae, l’altro in Roma col titolo di vicarius urbis
Romae. Degli antichi privilegi sopravvissero, per i cives
Romani domo Roma, quello di ricevere gratifiche di frumento,
di caro porcina e di vino a basso prezzo.
Un altro aspetto dell’impegno di Diocleziano nel
consolidare le pericolanti strutture dell’impero, restaurando
l’antica disciplina nel rispetto dei culti tradizionali, si deve
forse riconoscere nella grande persecuzione contro i
Cristiani che cominciò nel 303 e continuò poi per circa un
decennio. Ma la sua ferma convinzione che il risanamento
dell’impero dovesse fondarsi sulla fedeltà agli antichi ideali
politici e morali non impedì che Roma perdesse
importanza a favore di altre città che i tetrarchi scelsero.
come sede del loro governo (Nicomedia in Bitinia, Sirmio
in Pannonia, Milano, Treviri in Gallia). Era il primo passo
verso il definitivo sgretolamento della più grande opera di
unificazione politica realizzata nel mondo antico.
2. Fallimento della “tetrarchia”. Costantino e l’impero cristiano.
- Fra queste luci e queste ombre erano trascorsi vent’anni
257
di regno quando, nel maggio del 305, Diocleziano metteva
in atto il suo proposito di ritirarsi a vita privata (e vi rimase
fino alla morte, nel 316) facendo insieme abdicare il collega
Massimiano. Diventarono automaticamente Augusti
Costanzo Cloro e Galerio, e al loro posto furono scelti
come Cesari Flavio Severo e Massimino Daia.
Il sistema tetrarchico sembrava funzionare
regolarmente e avviarsi al suo consolidamento, ma appena
l’anno dopo riceveva un colpo mortale quando, essendo
morto Costanzo Cloro, suo figlio Costantino riapriva la
serie delle usurpazioni facendosi acclamare imperatore
dall’esercito (25 luglio 306). Galerio si rifiutò di
riconoscerlo ed innalzò ad Augusto il Cesare Flavio Severo;
qualche mese dopo in Roma si sollevavano i pretoriani che
proclamavano Augusto M. Aurelio Valerio Massenzio, il
figlio di Massimiano, e infine anche questi s’indusse a
rinunziare all’abdicazione riprendendo la porpora.
Si scatenava così un nuovo periodo di lotte per la
conquista del potere che nemmeno il personale intervento
di Diocleziano riuscì a comporre, ottenendo solo che
Massimiano tornasse ad abdicare mentre veniva creato
Cesare Licinio Liciniano. Eliminato Flavio Severo da
Massenzio, morto Galerio nel 311, l’anno appresso
Costantino travolse Massenzio nella famosa battaglia di
Ponte Milvio mentre in Oriente Licinio si sbarazzava di
Massimino Daia (313). Per un decennio l’impero rimase
diviso fra Costantino e Licinio finché, venuto meno
l’accordo fra i due, Licinio fu vinto nella battaglia di
Crisopoli (di fronte a Bisanzio) e Costantino rimase unico
imperatore (324).
Costantino (Imp. Caes. C. Flavius Valerius Costantinus
Aug.) continuò l’opera di Diocleziano rafforzando il potere
imperiale nelle forme del più rigido assolutismo teocratico
e perfezionando i nuovi ordinamenti militari e burocratici,
258
che strinsero in una ferrea morsa ogni forma di attività
pubblica e privata e furono tra le caratteristiche più salienti
del “basso Impero”. Per limitarsi a un quadro sommario
delle innovazioni di maggior rilievo, basterà osservare che
gli uffici un tempo riservati all’ordine equestre vennero o
aboliti o affidati a personaggi della classe senatoria. Questa
rimase pertanto l’unica categoria donde l’imperatore poteva
attingere i grandi funzionari e i dignitari di corte, ma ciò
non implicò affatto una maggiore importanza politica del
senato, che tra l’altro si trovò sminuito anche per il
trasferimento (a. 330) della capitale da Roma a Bisanzio
(più vicina al delicato scacchiere danubiano e ribattezzata
col nome di Costantinopoli), dove veniva istituito un altro
senato. Quanto alle tradizionali magistrature, l’unica a
conservare prestigio fu soltanto il consolato, rivestito
talvolta anche dagl’imperatori. Si trattava però solo di
un’altissima distinzione di rango sociale, senza alcun potere
specifico, come quello che invece spettava alle alte cariche
dell’amministrazione imperiale.
Queste si succedevano secondo un rigoroso ordine
gerarchico e disponevano di un personale anche esso
gerarchicamente ordinato, come risulta da quella specie di
“ruolo organico” rappresentato dalla Notitia dignitatum
omnium, tam civilium quam militarium in partibus Orientis et
Occidentis e giunto a noi in una edizione risalente al 430
circa. Sopravvivono le antiche prefetture come la praefectura
praetorio, la praefectura urbi, la praefectura annonae, la praefectura
vigilum, delle quali la prima subisce la più profonda
trasformazione; infatti a partire dal 320 il territorio
dell’impero venne suddiviso fino a costituire quattro
prefetture del pretorio: la prefettura delle Gallie, dell’Italia,
dell’Africa, dell’Oriente (con successive diverse
strutturazioni), e i relativi prefetti vi esercitarono poteri
amplissimi in veste di veri e propri vice-imperatori. Fra gli
259
organi dell’amministrazione centrale i più elevati diventano
il magister officiorum (una sorta di ministro degli affari interni,
da cui dipendono anche le scholae palatinae, cioè la nuova
guardia del corpo che sostituisce i pretoriani aboliti da
Costantino), il quaestor sacri palatii (specie di ministro della
giustizia), il comes sacrarum largitionum (per le finanze), il comes
rerum privatarum (per il patrimonio imperiale). Accanto a
questi dicasteri, e con la tendenza a invaderne la sfera
d’azione, importanza sempre maggiore venne acquistando
l’ufficio di praepositus sacri cubiculi; altro organo di particolare
rilievo fu infine il consistorium, il consiglio segreto
dell’imperatore composto dei più alti dignitari.
Ma la figura di Costantino grandeggia specialmente
per la nuova politica inaugurata di fronte al Cristianesimo,
che da lui ottenne pienezza di libertà e molti privilegi.
Scrittori contemporanei raccontarono che, alla vigilia dello
scontro decisivo con Massenzio al Ponte Milvio,
l’imperatore ebbe una visione che lo spinse a convertirsi,
promettendogli in cambio la vittoria. In una conversione
avvenuta in tali circostanze alcuni hanno voluto scorgere il
frutto di un calcolo opportunistico, ma senza alcuna buona
ragione. Certo è, comunque, che poco dopo Costantino
dette riconoscimento ufficiale alla nuova religione con
l’editto di Milano del 313, invitando poi i sudditi ad
abbracciarla e dichiarandosi egli stesso cristiano.
Naturalmente, la conversione non trasformò il carattere
assolutistico del suo potere, e non deve meravigliare che
egli s’intromettesse poi a regolare questioni non solo di
disciplina ecclesiastica, ma anche di fede, convocando fra
l’altro nel 325 il concilio di Nicea ove vennero definiti i
principi della dottrina trinitaria in quella formulazione che
(ritoccata dal concilio di Costantinopoli del 381) è rimasta il
Credo della Chiesa cattolica.
260
Battuti i Goti, accordatosi con i Sarmati, che secondo
un sistema inaugurato già nel III secolo furono accolti in
gran numero entro i confini, Costantino si preparava a
respingere un’invasione dei Persiani quando nel maggio
337 venne a morte presso Nicomedia.
3. I discendenti di Costantino. - Convinto sostenitore, a
differenza di Diocleziano, della successione per diritto di
sangue, Costantino già nel 335 aveva provveduto a ripartire
i territori dell’impero fra i suoi tre figli, Costantino,
Costanzo e Costante, e i due nipoti Delmazio e
Annibaliano, figli del fratellastro Delmazio. Alla sua morte
questi ultimi vennero ben presto eliminati, e dei tre fratelli
il primo, Costantino II, assunse il governo dell’Occidente
(Imp. Caesar Flavius Claudius Constantinus Aug.), il secondo,
Costanzo II, quello dell’Oriente (Imp. Caesar Flavius Iulius
Constantius Aug.), mentre Costante, sebbene rivestito
anch’egli della dignità di Augusto (Imp. Caesar Flavius Iulius
Constans Aug.), restava in sottordine e sotto la tutela di
Costantino II.
Dopo una vittoria sui Sarmati, Costante si rifiutò di
riconoscere la sua subordinazione al fratello, e quando
questi nel 340 mosse in armi per imporre la sua
supremazia, fu vinto e ucciso presso Aquileia. Rimasto
padrone dell’Occidente, Costante intraprese una serie di
vigorose operazioni in difesa dei confini mentre in Oriente
Costanzo II si batteva con energia, anche se con poca
fortuna, per respingere i ripetuti attacchi dei Persiani.
Disgustatosi l’esercito con la sua fermezza nel mantenere la
disciplina, nel 350 Costante cadde vittima di una congiura
che portò al potere Magnenzio, un ufficiale semibarbaro
(Imp. Caesar Flavius Magnus Magnentius Aug.). Costui cercò
invano di intendersi con Costanzo, che nel 353 invase la
Gallia e pose fine all’usurpazione ricostituendo nelle sue
261
mani l’unità dell’impero. Nominato Cesare nel 355 il
cugino Giuliano, con l’incarico di riorganizzare la difesa e
l’amministrazione delle Gallie, Costanzo dovette tornare a
riprendere le armi contro i Persiani; nel 360, pervenutagli la
notizia che Giuliano era stato acclamato imperatore, mosse
a incontrarlo ma, arrivato in Cilicia, si ammalò e morì
(361).
L’improvvisa scomparsa di Costanzo II lasciava
Giuliano unico signore dell’impero (Imp. Caesar Flavius
Claudius Iulianus Aug.) e libero di intraprendere quella
politica di restaurazione del paganesimo per cui gli venne il
nome di Apostata. Nato nel 331 da Giulio Costanzo,
fratellastro di Costantino I, da piccolo era stato educato alla
fede cristiana, ma poi l’aveva ripudiata sotto la suggestione
di studi filosofici in cui rimase immerso finché il cugino,
con la nomina a Cesare, lo chiamò a responsabilità di
governo. Dimostrando di possedere attitudini non solo alla
meditazione, ma anche all’attività politica, Giuliano si era
distinto nelle Gallie, prima liberandole dalla minaccia dei
Franchi e degli Alamanni, poi introducendo provvedimenti
intesi a lenire la crisi economica, e uguale cura spiegò più
tardi nel migliorare l’amministrazione dell’impero. La sua
reazione anticristiana, per quanto energica, rimase senza
conseguenze anche per la breve durata; infatti il giovane,
desideroso di gloria militare, s’imbarcò in una spedizione
contro i Persiani senza averne subito alcuna provocazione,
e nonostante le sue truppe avessero dato segni di scarso
entusiasmo. La campagna si concluse sfavorevolmente; vi
trovò la morte lo stesso Giuliano (363) e con lui si estinse
la dinastia fondata da Costantino.
4. I barbari nei confini e la bipartizione dell’Impero. - Dopo
pochi mesi di regno di Gioviano, il più anziano dei
protectores domestici (Imp. Caesar Flavius Iovianus Aug.),
262
l’esercito acclamò imperatore Flavio Valentiniano. (Imp.
Caesar Flavius Valentinianus Aug.), il quale si associò come
Augusto il fratello Valente (Imp. Caesar Flavius Valens Aug.),
affidandogli il governo della parte orientale. In Occidente
egli condusse alcune brillanti azioni in difesa del limes
renano e danubiano, ma per le spese militari fu costretto a
un fiscalismo sempre più feroce e rovinoso. Quando nel
375 venne a morte, doveva succedergli il figlio Graziano,
già nominato Augusto nel 367 (Imp. Caesar Flavius Gratianus
Aug.), ma l’esercito proclamò imperatore il figliastro
Valentiniano (Valentiniano II, 375-392: Imp. Caesar Flavius
Valentinianus Iunior Aug.) e i due s’intesero per una pacifica
divisione del potere. Nel frattempo Valente s’era prodigato
a proteggere le province orientali dalla pressione dei
barbari, e aveva dovuto accogliere entro i confini i Visigoti,
incalzati alle spalle dagli Unni. Qualche anno dopo i
Visigoti si ribellarono e, affrontati da Valente, lo travolsero
nella sanguinosa battaglia di Adrianopoli (378).
Allora Graziano nominò Augusto per l’Oriente
Teodosio (Imp. Caesar Flavius Theodosius Aug., 379-395), e
questi riuscì a raddrizzare la situazione militare, cercando
anche di stabilire rapporti di convivenza con i barbari per
trarne nuove forze a difesa dell’impero. Infatti è appunto
da questa epoca che intere tribù di barbari cominciarono ad
installarsi entro i confini, organizzandosi in maniera
autonoma e fornendo all’esercito imperiale contingenti
sempre più numerosi di foederati che combattevano agli
ordini di propri capi. Graziano scomparve nel 383 ad opera
dell’usurpatore Magno Massimo, ma quando costui volle
eliminare anche Valentiniano II, Teodosio intervenne e lo
debellò. Fu in quest’epoca che, condannata l’eresia di Ario,
si definirono i fondamenti dell’ortodossia cattolica (concilio
di Costantinopoli del 381), e questa fu anche l’epoca in cui
fiorirono a Roma alcuni ingegni pagani, fra i quali si può
263
ricordare l’oratore Q. Aurelio Simmaco, mentre senza
nome rimane per noi (perché egli volle dissimulare la sua
persona) l’autore delle più volte ricordate Vitae della
Historia Augusta. Protestando indirettamente contro il
regime imperiale, che si era fatto sempre più oppressivo e
persecutorio anche col voler imporre il cristianesimo come
unica religione di Stato, costoro svolsero un’appassionata
polemica contro la nuova fede in nome degli antichi ideali
di Roma pagana. Erano le ultime voci che si levavano ad
esaltare la passata grandezza e non possono non
commuovere, ma quando imputavano la presente miseria
all’abbandono delle tradizioni e delle credenze avite, non
tenevano conto che il nostalgico richiamo all’antica gloria
poteva soddisfare le aspirazioni di un cenacolo
aristocratico, non le esigenze delle masse indifferenti a un
passato per loro estraneo e protese verso ogni promessa di
un avvenire migliore.
Alla scomparsa di Valentiniano II, Teodosio tenne
per poco il potere da solo, e quando morì (395) lasciò
l’impero diviso tra i due figli (Arcadio in Oriente, Onorio
in Occidente) affidati alla tutela di Stilicone, un valente
condottiero di stirpe vandala.
Continuando l’indirizzo filobarbarico di Teodosio,
Stilicone cercò di attuare una politica di collaborazione in
senso unitario fra Oriente e Occidente, ma con scarsa
fortuna perché proprio allora maturavano le condizioni
morali e materiali che portarono le due partes dell’impero ad
assumere una fisionomia diversa e ad incontrare un diverso
destino.
5. L’Impero d’Oriente e la fine dell’Impero d’Occidente. I regni
romanobarbarici. - In Oriente Gainas, un generale di origine
gotica, incaricato di sedare una ribellione degli Ostrogoti
accolti nei confini da Teodosio, aveva fatto causa comune
264
con quei barbari e col loro appoggio si era imposto ad
Arcadio, instaurando a Costantinopoli una feroce dittatura.
La sua tirannide venne travolta a furore di popolo
(400), e allora in Oriente ebbe la prevalenza una ferma
politica antibarbarica, appoggiata da una nobiltà
consapevole dei suoi doveri verso lo Stato, sollecita dei
bisogni delle classi medie, preoccupata di preservare la vita
cittadina e ancor forte di una certa floridezza economica.
In tali condizioni Costantinopoli non poteva che opporsi a
Stilicone, considerato barbaro e protettore dei barbari, e
alla sua politica di unione con un Occidente imbarbarito,
economicamente dissestato, con una vita cittadina in
declino e con una nobiltà preoccupata solo di organizzarsi
a difesa dei propri privilegi in forme che preludono al
feudalesimo.
Da questo momento si apriva la frattura tra l’impero
d’Oriente, che si preparava a percorrere la lunga parabola
della civiltà bizantina, e l’impero di Occidente, avviato ad
operare quel complesso lavorio di reazione fra classicità,
cristianesimo e germanesimo che è alla radice della nostra
civiltà. L’uno sopravvisse ancora per un millennio; l’altro,
sommerso dalle invasioni, stava per “cadere”, o meglio per
procedere sulla via della sua trasformazione in nuovi
organismi politico-sociali.
A puntellare quella vuota impalcatura politicoburocratica, cui era ridotto l’impero d’Occidente, non
potevano più bastare vittorie come quelle di Stilicone
contro i Goti di Alarico (che però alcuni anni dopo, nel
410, diedero per primi il sacco a Roma) o quella di Aezio
nel 451 contro gli Unni di Attila. Costui l’anno appresso
irrompeva in Italia e, se si fermò per la distruzione di
Aquileia, fu anche per l’intervento di papa Leone I: Roma
poteva dirsi salva ma solo per poco, perché nel 455 cadde
in potere dei Vandali di Genserico, sbarcati dall’Africa, e fu
265
messa a sacco per la seconda volta. E poi, quelle non erano
state vittorie dei Romani sui barbari, ma di barbari su altri
barbari, e se l’impero d’Occidente si fa terminare nel 476
con la deposizione di Romolo Augustolo ad opera di
Odoacre, il capo ribelle delle milizie germaniche degli Eruli
stanziati in Italia, ciò è solo perché più nessuno, dopo di
quello, assunse in Occidente il titolo di Augustus.
Su questo periodo si vedano in generale L. CANTARELLI, La diocesi
italiciana da Diocleziano alla fine dell’impero occidentale, Roma 1903. E.
DEMOUGEOT, De l’unité à la division de l’Empire Romain, Paris 1951. F.
GABOTTO, Storia dell’Italia occidentale nel Medio Evo, I-II, Pinerolo 1911. F. LOT,
La fin du monde antique et les débuts du moyen Age, Paris 1928. S. MAZZARINO,
Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio, Roma 1942; ID., Aspetti sociali del quarto
secolo, Roma 1951. A. PIGANIOL, L’empereur Constantin, Paris 1932. Id., L’empire
chrétien (325-395), nella “Histoire générale fondée par G. Glotz”, Histoire
romaine IV 2, Paris 1947. L. RUGGINI, Economia e società nell’Italia annonaria,
Milano 1961. O. SEECK, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, I-VI, Stuttgart,
1895-1921. W. Seston, Dioclétien et la tétrarchie, Paris 1946. E. STEIN, Histoire du
Bas-Empire, I, éd. par J.-R. PALANQUE, Paris 1959. D. VAN BERCHEM, L’armée
de Dioclétien et la réforme constantinienne, Paris 1952. J. Vogt, Constantin der Grosse
und sein Jahrhundert, 2a ed., München 1960.
In particolare su Diocleziano, oltre la già citata monografia del Seston,
cfr., dello stesso autore, Iovius et Herculius ou l’épiphanie des tétrarques, in “Historia”
I (1950) p. 257 sgg. Su Costanzo Cloro, R. ANDREOTTI in “Didaskaleion” IX
(1930) p. 157 sgg. Sulla politica orientale di Diocleziano, W. ENSSLIN, Zur
Ostpolitik des Kaisers Diocletians, in “Sitzb. Bayer. Akad. Wiss.” 1942, Heft 1. Sul
passaggio dal comitatus di Diocleziano ai comitatenses di Costantino, cfr. W.
SESTON in “Historia” IV (1955) p. 284 sgg.
Per quanto concerne la riforma dioclezianea dell’amministrazione
provinciale, una fonte di grande interesse (oltre LACTANT., De mortib. persec. 7,
4) è il Laterculus Veronensis, cosiddetto perché conservato nella Biblioteca
Veronese, di cui la prima edizione critica fu data nel 1862 dal MOMMSEN nelle
“Abhandlungen” dell’Accademia di Berlino (si trova riprodotta in O. SEECK,
Notitia dignitatum, p. 247 sgg.). Si tratta di un elenco (laterculus), databile intorno
al 300 d.C., delle province, che vi appaiono raggruppate nelle rispettive diocesi.
È da notare che, mentre per l’Oriente l’elencazione delle diocesi con le
rispettive province è fatta seguendo un ordine geografico, per quanto invece
riguarda l’Occidente (salvo Britannia e Pannonia) l’elencazione rispetta un
ordine gerarchico di carattere ufficiale che si rispecchiava nel rango dei
266
rispettivi governatori. Tale duplicità di criterio ha fatto pensare, contro
l’opinione comune, che la lista non sia omogenea, cioè che risalga a due fonti
diverse e che sia stata redatta in due periodi diversi (cfr. J. B. BURY, in “Journ.
Rom. Stud.” XIII, 1923, p. 127 sgg.). Nell’elencazione, qua e là imprecisa, del
laterculus, le dodici diocesi (sei in Oriente e sei in Occidente) appaiono
menzionate in quest’ordine: I d. Orientis (con 16 province), II d. Pontica (con 7
prov.), III d. Asiana (con 9 prov.), IV d. Traciae (con 6 prov.), V d. Misiarum
(con 11 prov.), VI d. Pannoniarum (con 7 prov.), VII d. Britanniarum (con 6
province), VIII d. Galliarum (con 8 prov.), IX d. Biennensis (= Viennensis, con 7
prov.), X d. Italiciana (con 12 prov.), XI d. Hispaniarum (con 6 prov.), XII d.
Africae (con 6 prov.). L’equiparamento della posizione amministrativa dell’Italia
a quella delle province ebbe un primo avvio nel “correttorato dell’Italia”
testimoniato per la prima volta al tempo di Caracalla, sotto il quale C. Ottavio
Appio Suetrio Sabino, console ordinario del 214, fu elect(us) ad corrig(endum)
statum Ita[l(iae)], secondo la testimonianza di C.I.L. X 5398 = I.L.S. 1159.
L’ufficio di corrector Italiae (che aveva funzioni diverse da quelle meramente
giurisdizionali spettanti ai iuridici istituiti da M. Aurelio, ed esercitava più
sostanziosi poteri di carattere militare e amministrativo) appare poi rivestito,
sempre in età di Caracalla, da un Marcellino (Inscrip. Graec. ad res Rom. pertin., I
137), e una cinquantina d’anni dopo da un Pomponio Basso, che sembra il
console ord. del 259 e del 271 (C.I.L. VI 31747). Viene poi ricordato nelle fonti
letterarie il correttorato di Tetrico, che dopo essere stato battuto da Aureliano
come ultimo sovrano del separatistico imperium Galliarum, fu dallo stesso
Aureliano onorato con la nomina a corrector totius Italiae secondo S.H.A., Tyr. trig.
24, 5, con la nomina a corrector Lucaniae secondo AUR. VICT. 35, 5; EUTR. IX 13,
2; S.H.A., Vita Aurel. 39, 1. La discrepanza fra le due notizie non è di poco
momento, perché se realmente Tetrico ebbe il correttorato della sola Lucania si
dovrebbe ammettere che già sotto Aureliano l’Italia non costituisse più
un’unica correttura, ma fosse già stata divisa in varie corretture, cioè in vari
distretti amministrativi corrispondenti alle province del posteriore ordinamento
dioclezianeo. Ma nonostante tale opinione abbia trovato sostenitori (cfr. R.
THOMSEN, The Italic Regions, cit. p. 201) essa appare meno attendibile dell’altra
che vede in Diocleziano, l’uomo che giunse poi a dividere l’Italia in province,
l’istitutore dei correctores di singole province. L’iscrizione C.I.L. X 304, ove è
menzionato un corrector Campaniae sotto Carino, fu giudicata falsa dal
Mommsen.
Su Eusebio come autore della Vita Constantini, cfr. F. VITTINGHOFF,
Eusebius als Verfasser der Vita Constantini, in “Rhein. Mus.” XCVI (1953) p. 330
sgg.; F. WINKELMANN, Zur Geschichte der Autentizitäts-problem der Vita Constantini,
in “Klio” II (1962) p. 187 sgg. Sui problemi relativi alla cronologia della epoca
costantiniana, oltre A. PIGANIOL, Dates constantiniennes, in “Rev. Hist. et Phil.
Rel.” XII (1932) p. 360 sgg., sono da tenere presenti le indagini condotte sulla
base di un riesame dei dati numismatici da P. BRUUN (del quale si ricordano
qui, fra l’altro, gli Studies in Constantinian Chronology, New York 1961), anche se
taluna delle sue conclusioni non pare da accogliere, come p. es. lo spostamento
267
della data tradizionale (28 ottobre 312) della battaglia del Ponte Milvio; cfr. R.
ANDREOTTI, Recenti contributi alla cronologia costantiniana, in “Latomus” XXIII
(1964) p. 537 sgg. Sulla politica religiosa di Costantino, cfr. ultimamente S.
Calderone, Costantino e il Cattolicesimo, I, Firenze 1962. Sulla storicità dell’editto
di Milano, M. ADRIANI, in “Studi Romani” 1954 p. 18 sgg.
Sull’ordinamento dell’organizzazione tributaria, cfr. A. DELEAGE, La
capitation du Bas Empire, Paris 1945, il quale conclude: “Le principe essentiel de
Dioclétien fut de déterminer dans chaque région une unité idéale, en fonction
de laquelle tous les éléments concrets seraient apprécies” (p. 255); “la diversité
des noms de l’unité fiscale correspond seulement à la diversité des éléments
imposables qu’elle atteint et non à une différence intrinsèque. Toutes les unités
représentent une même valeur et peuvent être additionnées”. Secondo il LOT
(Nouvelles recherches sur l’impôt foncier et la capitation personnelle sous le Bas-Empire,
Paris 1955, Diocleziano “s’est borné à réprimer les abus des agents du fisc” (p.
31).
Sui secondi Flavii, cfr. G. Gigli, La dinastia dei secondi Flavii, Roma 1959.
Su Magnenzio, cfr. W. ENSSLIN, Der Usurpator Magnus Magnentius ein Germane, in
“Klio” XIX (1925) p. 478 sgg. Su Giuliano l’Apostata, J. BIDEZ, La vie de
l’empereur Julien, Paris 1930; R. ANDREOTTI, Il regno dell’imperatore Giuliano,
Bologna 1936; ID., L’opera legislativa e amministrativa dell’ imperatore Giuliano, in
“Nuova Rivista Storica”, 1930, p. 342 sgg.; G. NEGRI, Giuliano l’Apostata, 5a ed.,
Milano, 1954; G. RICCIOTTI, Giuliano l’Apostata, Milano 1956. Sulla datazione
del De rebus bellicis, S. MAZZARINO, Aspetti sociali del quarto secolo, cit.; A. D’ORS,
Un arbitrista del siglo IV y la decadencia del imperio romano, “Quadernos de la
Fondación Pastor” 7 (1963); R. ANDREOTTI, in “Riv. Filol. Class.”, N.S. XXXI
(1953), p. 164. Sull’impresa di Giuliano in Oriente, R. ANDREOTTI, in
“Historia” IV (1930), p. 236 sgg.
Su Valentiniano I, cfr. A. SOLARI, in “Riv. Filol. Class.”, N.S. X (1932),
p. 75 sgg.; R. ANDREOTTI in “Nuova Rivista Storica” 1931, p. 456 sgg. Sulla
generalis lex de specierum praebitione di Valentiniano I, cfr. A. PIGANIOL, in “Journ.
des Savants” 1955, p. 10: “l’oeuvre propre de Valentinien est naturellement
caractérisée par le plus haut sentiment des devoirs de l’Etat”. Sulla battaglia di
Adrianopoli, cfr. J. STRAUB, Die Wirkung der Niederlage bei Hadrianopel auf die
Diskussion über das Germanenproblem in der spätrömischen Literatur, in “Philologus”
1943, p. 255 sgg. Sulla Politica religiosa di Teodosio, cfr. V. ENSSLIN, in “Sitzb.
Bayer. Akad. Wiss.”, 1953, H. 2.
Si è largamente discusso sull’uso e destinazione dei contorniati, medaglie
del basso impero caratterizzate da un solco circolare o “contorno” su entrambe
le facce. Secondo A. ALFÖLDI, Die Kontorniaten. Ein verkanntes Propagandamittel
der stadtrömischen heidnischen Aristokratie in ihrem Kampfe gegen das christliche
Kaisertum, Budapest 1943), i contornati avrebbero avuto lo scopo di svolgere
una propaganda senatoria pagana contro il cristianesimo; ma cfr. S.
MAZZARINO, in “Encicl. dell’arte antica classica orientale” II (1959) p. 787 sgg.,
il quale vede nei contorniati una “pecunia valida solo entro l’ambito della
268
prefettura urbana di Roma”, e per questa spiegazione si fonda su un editto
prefettizio urbano, in cui si menziona la formula pecuniam spectaculis sibi vindicare.
Una sintesi dei problemi economici e sociali in A. PIGANIOL, La crise
sociale au Bas-Empire (in “Journ. des Savants”, 1955, p. 5 sgg.), che, accettando le
conclusioni di S. MAZZARINO (Aspetti sociali, cit.), afferma “renoncer à
l’adaeratio n’est donc pas du tout, comme prétendait Mickwitz, dans l’intérêt des
bureaucrates, mais dans celui des contribuables”. Altro problema consisteva nel
sapere se i limitanei erano contadini soldati, oppure no; ormai si può certamente
negare che essi fossero contadini soldati: cfr. S. MAZZARINO, op. cit., e A.
PIGANIOL, in “Journ. des Savants” 1955, p. 12 secondo cui i limitanei “sont
des paysans que la brutalité du recrutement arrache à leurs terres”. Quanto ai
gentiles (questi, sì, contadini che difendono le loro terre), cfr. G. VITUCCI,
L’imperatore Probo, cit. p. 46, 106; S. MAZZARINO, Note di storia economica
tardoromana, in “Economia e storia”, 1966, p. 469. Infine, per il problema dello
“chiffre total de la population” di Roma, cfr. ancora A. PIGANIOL, loc. cit., p.
13, il quale accetta il numero di 120.000 e 141.120 gratificati proposto,
rispettivamente per il 419 e per il 452, dal Mazzarino.
Sulla personalità di S. Ambrogio, cfr. J.-R. PALANQUE, St. Ambroise et
l’empire romain. Contribution à l’histoire des rapports de l’Eglise et de l’Etat à la fin du
VIe siècle, Paris 1933; F.H. DUDDEN, The Life and Times of St. Ambrose, I-II,
Oxford 1935; P. ROLLERO, S. Ambrogio e la sua età, 2a ed., Milano 1960.
269
nella quarta di copertina
Forsan et haec olim meminisse iuvabit
Virgilio, Eneide, I 203
Giovanni Vitucci (1917-2000), ordinario di Storia Romana nelle
Università di Trieste, Perugia e Roma per tutto un cinquantennio, finissima
figura di studioso, membro di numerose Accademie scientifiche, ebbe un ruolo di
primo piano nella fondazione e nell’avvio della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Ateneo di “Tor Vergata”.
La Facoltà, da Lui ordinata nel suo primo costituirsi, lo ebbe Preside per
lunghi anni e trasse da Lui vigore e sviluppo.
Agli impegni ufficiali Egli affiancò sempre con assoluta dedizione e
disponibilità l’insegnamento della disciplina di cui era titolare, unendo dottrina
e umanità, nella migliore tradizione delle istituzioni universitarie.
È in ragione del Suo magistero e del Suo legame con la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Ateneo di “Tor Vergata” che alcuni suoi antichi allievi hanno
provveduto alla riedizione di un volume di dispense, che fu utilizzato con
profitto da generazioni di studenti universitari.
Queste Linee di Storia Romana vengono riproposte così come le ha
lasciate il Maestro: grazie all’esposizione limpida, all’informazione completa e
articolata e alla profondità con cui viene illustrata la vicenda storica, esse
conservano intatta la loro efficacia formativa.
L’augurio è che i giovani studenti, attraverso la lettura di queste pagine, si
accostino, comprendano e conservino nel loro patrimonio culturale lo spirito e la
lettera di una civiltà che ha segnato la storia del mondo occidentale.
Anna Pasqualini
Giuseppina Prosperi Valenti
Mariano Malavolta
Roma, 23 settembre 2002.
270