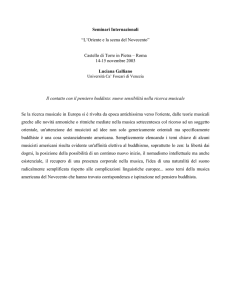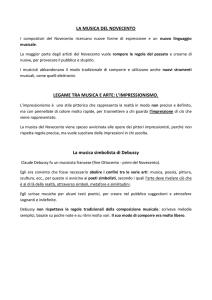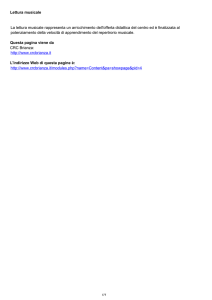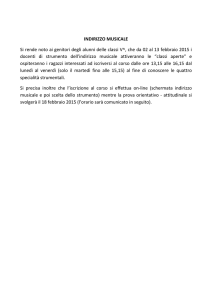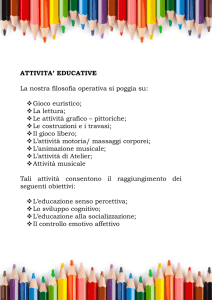novecento / parte seconda
Suoni (parole e segni)
del Novecento
(parte seconda)
R
ICOMINCIANDO DA FIGURE capitali del Novecento stori-
1. Debussy e la Nuova Musica
di Emilio Sala
2. «Ravel e l’anima delle cose»
di Enzo Restagno
3. Il Carrozzone di «Parade» a Roma
di Marco Vallora
4. Puccini e il Novecento
di Massimo Contiero
5. Gli anni della Secessione viennese
di Eugenio Bernardi
6. Schoenberg e Kandinskij: un incontro
di Paolo Petazzi
7. Anton Webern oltre la Nuova Musica
di Gian Paolo Minardi
8.ShostakovicheBritten:unpontetraesteovestnellaguerrafredda
di Mario Carrozzo
9. La calda voce del jazz
di Veniero Rizzardi
10. La musica per film
di Roberto Pugliese
11. Due rivoluzioni del pensiero musicale
E.Varèse–F.Zappa:ThePresent-dayComposer(s)RefusestoDie
di Giovanni Mancuso
12. Il carteggio Hofmannsthal – Strauss
di Leonardo Mello
13. Il Neoclassicismo del Novecento: un concetto problematico
di Raffaele Pozzi
speciale
co, che hanno segnato il percorso di questo turbolento
eppure avvincente e rapidissimo secolo, abbiamo cercato di concludere la carrellata novecentesca che aveva preso
le mosse da Debussy e Ravel, inerpicandosi il più delle volte in
analisi, speriamo non troppo scontate, di rapporti tra arti e artisti differenti, come il caso paradigmatico della coppia Schoenberg-Kandinskij.
Effettivamente queste ventisette stazioni (suddivise in due debordanti sezioni speciali) hanno di volta in volta indagato un particolare periodo di fermenti e
novità (ad esempio la Secessione viennese), un genere musicale che si fa per
la prima volta strada, come il
jazz o l’elettronica, un autore o una poetica dal valore emblematico e immediatamente riconoscibile. Grazie alla
competenza (oltre
Luigi Nono
che alla gentilezza)
speciale —
di tutti coloro che hanno firmato i diversi articoli ci auguriamo
di aver fornito non un percorso diacronico da un punto 1 a un
punto 2, quanto delle istantanee, brevi immagini che si susseguono e che, radunate tutte insieme, possano farsi lungometraggio e dare forse l’idea della molteplicità, cifra peculiare e assoluta della modernità e della contemporaneità.
Non era infatti in nessun caso nostra intenzione costruire un
ulteriore filone narrativo, che ambisse attraverso strumenti storico-critici a spiegare e rendere sistematico un periodo storico
tanto fluido e magmatico quanto forse ancora a noi troppo vicino.
Un periodo comunque dove John Cage si è incontrato con Luigi Nono, Berio ha collaborato con Calvino,
le colonne sonore si sono incrociate con la musica stocastica di Xenakis, la
computer music ha convissuto con il rock degli Stones. E
moltissime altre sono le sfaccettature,
gli snodi e i gangli cruciali che ci sono
di certo colpevolmente sfuggiti… ◼
M
ick
Jag
ge r
14. Le origini del Novecentismo italiano
di Virgilio Bernardoni
15. L’avvento della musica elettronica
di Alvise Vidolin
16. M’illumino di me
di Mario Messinis
17. Luigi Nono e Bruno Maderna
di Veniero Rizzardi
18. Luciano Berio e Italo Calvino
di Cesare Fertonani
19. «Attraverso» Mallarmé
di Paolo Petazzi
20. Sintesi interculturale e tempo teatralizzato
Gli «Études pour piano, premier livre» di György Ligeti
di Letizia Michielon
21. Hans Werner Henze
di Jacopo Pellegrini
22. Lo sradicamento radicale
Appunti per un’interpretazione di Xenakis
di Dino Villatico
23. I vulcani spenti di Lachenmann
di Gian Paolo Minardi
24. John Cage e l’espressionismo astratto
di Giampiero Cane
25. Minimalismo
di Giordano Montecchi
26. L’elettroshock rock: industria e modello giovanile
di Giò Alajmo
27. Un oscuro, incerto, fragile, forse unico varco d’uscita
di Quirino Principe
— speciale
novecento / parte seconda
Il carteggio
Hofmannsthal
– Strauss
della musica, e così ho capito che il piccolo intermezzo tra il cuoco e il giovane servo (…) non è affatto indispensabile. Se lo vuole tagliare, dunque, ha fin d’ora il mio consenso». Il poeta quindi, fors’anche un po’ ingenuamente, cerca di farsi «interprete»
della musica, e di assecondarla. Ma Strauss si mostra sempre infastidito dagli sconfinamenti del suo «librettista» in ambito musicale, che rivendica tutto per sé, come indica chiaramente la
missiva, un po’ risentita, del dicembre 1907: «C’è però una coGREGIO SIGNORE, non so se Ella si rammenta ancora
sa che vorrei chiederLe: di non pensare in alcun modo alla mudi un nostro colloquio a Parigi, e che allora Le accensica, quando Ella scrive il libretto, perché la musica è compito
nai all’idea di un balletto, al che Ella ebbe la cortesia
mio. Mi crei un dramma ricco di azione e di contrasti con podi dichiarare che eventualmente avrebbe musicato voche scene di massa, ma con due o tre personaggi di granlentieri qualcosa del genere».
de impegno».
Queste parole, datate 17 novembre 1900, danNel 1909 finalmente Elektra – che è il quarno inizio al sodalizio artistico più formidabito lavoro teatrale di Strauss, dopo Guntram,
le della prima metà del Novecento (e certo
Feuersnot e soprattutto dopo la meravigliouno dei più fortunati di tutta la storia delsa Salome da Oscar Wilde – va in scena ed è
la musica occidentale), quello tra Hugo
salutata con enorme successo, dando avvon Hofmannsthal, già allora affermavio a una felice e costante relazione arto poeta viennese, e Richard Strauss,
tistica che, a partire dal 1909, darà vita
che – all’apice della notorietà – di lì a
a capolavori come Der Rosenkavalier (Il
poco declinerà molto cordialmente
cavaliere della rosa, Dresda, Königliches
l’invito del poeta (e non sarà l’ultima
Operhaus, 26 gennaio 1911), Ariadvolta che proposte e progetti ideati dalne auf Naxos (Arianna a Nasso Vienna,
l’una o dall’altra parte moriranno ancora
Opertheater, 4 ottobre 1916) e Die Frau
prima di nascere). Si deve infatti aspettare
ohne Schatten (La donna senz’ombra, Viennove anni per veder fiorire il frutto di quena, Opertheater, 10 ottobre 1919), cui si
n
H
rd
sta straordinaria collaborazione: il 25 genaggiungono
poi anche Die äg yptische Helena
a
of m
ich
a n ns
R
naio 1909 – con la regia di Georg Toller – va in
(Elena
(
Elena
egizia,
egizia
Dresda,
Staatstheater, Operhaus,
n
o
thal c
scena Elektra,, musica di Strauss e libretto ricavato
6 giugno 1928) e Arabella (Dresda, Staatstheater,
E
ra
go
speciale
vo
St
Hu
uss
«
da Hofmannsthal da una sua precedente e applaudita riscrittura del dramma sofocleo, allestita il 30 ottobre del 1903 da Max
Reinhardt al Kleines Theater di Berlino. Già l’analisi comparata
tra il testo originale di Hofmannsthal – che sancisce, dopo la crisi denunciata un anno prima nella Lettera di Lord Chandos (1902),
l’abbandono della poesia per rivolgersi con ottimismo al teatro
– e il libretto per l’opera, in alcune parti assai diverso dalla prima
stesura, offrirebbe alcuni spunti per comprendere la complessa
natura del rapporto tra musicista e poeta, che – come nota Mario Bortolotto – «non erano stati mai propriamente amici, ma si sapevano insostituibili», divenendo «compagni di lavoro per vent’anni». Nel lavoro musicale infatti si percepisce l’influenza esercitata dal compositore, che spesso chiede allo scrittore – non sempre accondiscendente –
tagli e aggiustamenti.
A prescindere comunque dagli
aspetti caratteriali e affettivi, è ovvio
che l’incontro tra due personalità così diverse per sensibilità e formazione
non potesse che svilupparsi in termini dialettici talvolta anche aspri, pur se
temperati sempre dalla gentilezza formale, come testimoniano le tante lettere. Un esempio tra i tanti. Nel 1906
Hofmannsthal, in pieno lavoro creativo, scrive: «Recentemente (…) ho
provato a immergermi in Elektra con
i Suoi intendimenti, cercando l’effetto
Operhaus, 1 luglio 1933). In questo lungo periodo di tempo,
l’imponente Epistolario (più di 600 lettere) si va intanto infittendo di osservazioni, commenti, analisi, puntualizzazioni e sottolineature che, oltre a delineare con chiarezza il variopinto mondo teatrale del tempo, mettono in evidenza i punti d’incontro e
le divergenze tra due concezioni del mondo e dell’arte per alcuni aspetti assai distanti. Il tono delle missive varia molto di volta
in volta, in una gamma che va dalle informazioni pratiche (come
gli spostamenti continui di Strauss, richiestissimo come direttore, non solo delle proprie opere) al semplice rilievo tecnico
(una sfumatura dialettale da cambiare, un’orchestrazione che desta qualche perplessità). Più spesso i contorni
si allargano, giungono ad abbracciare
i rispettivi universi di competenza, come già si è accennato poco sopra. Ed
ecco allora che se il compositore rivendica a sé il contesto musicale, il poetadrammaturgo fa altrettanto per quanto
concerne le questioni sceniche, come
dimostrano le parole scritte da Hofmannsthal il 25 maggio del 1911,
poco tempo dopo la prima del Rosenkavalier, quando già era entrata
nel vivo l’elaborazione di Ariadne
auf Naxos: «Mio caro dr. Strauss,
(…) dobbiamo chiaramente dividere le rispettive competenze.
Tutta la parte scenica, anche i boz-
speciale —
novecento / parte seconda
speciale
zetti, lo stile, le danze, ecc., spetta a me». È piuttosto frequena questa categoria, si menziona qui una delle prime, inviata il 23
te incontrare passaggi come questo, che in modo più o meno
luglio 1911, ancora nel primo periodo di «incubazione» dell’Ariagarbato cercano di ricondurre il proprio interlocutore nei binadne. Strauss poco prima si era mostrato preoccupato dell’incomri di ciò che dovrebbe competergli. Ma quello che appare paleprensibilità del testo poetico, arrivando a suggerire la necessità
se, leggendo l’epistolario, è il diverso – e per alcuni versi antitetidi una «spiegazione». E Hofmannsthal, in una lunga missiva,
co – punto di partenza dei due artisti. In questo senso, paradigpuntualizza in modo diretto e un po’ didattico: «Mi permetta di
matico (e anche divertente) è lo scambio avvenuto tra il 25 magtornare con due parole sul punto che la preoccupa: il comprengio e il 6 giugno del 1916, quando i preparativi dell’Ariadne eradere e non comprendere; il fatto che Ella al primo contatto non
no quasi ultimati, e già il maestro bavarese immaginava nuovi,
abbia capito; il fatto che probabilmente il pubblico non capirà e
futuri progetti. E dopo aver messo al corrente il poeta sulla deche certamente non capiranno i critici. L’essenziale poetico di
finizione del dettaglio di una scena, di punto in bianco agun’opera di poesia, il reale contenuto, in un primo momengiunge: «Quanto a una nuova opera, ho in mente le
to non è mai compreso. Si comprende solo ciò in cui
due cose seguenti: o una commedia perfettamennon c’è nulla da comprendere: Tosca, Madama Butte moderna, tutta realistica, di caratteri e di psiterflyy, ecc. Cose più alte, cose essenziali restano
cologie nervose (…), oppure un grazioso lamisconosciute, senza eccezione. Le rammenvoro d’amore e d’intrigo, più o meno a meto lo scritto di Wagner del 1851 nel quatà strada tra la Liebelei di Schnitzler (…) e
le dichiara (…) che creazioni di tale semGeheimer Agent di Hackländer o Le Verre
plicità, di così sicura e sapiente struttud’eau di Scribe, un genere di commedia
ra teatrale come Lohengrin e Tannhäuser
a intrigo per cui ho sempre avuto una
non furono comprese, e non già la muspeciale predilezione. Per esempio, un
sica, ma il poema, sì che a quei tempi si
intrigo d’amore in ambiente diplomatichiesero: “Insomma, che ha voluto dico, al Congresso di Vienna, con protare?” (…) No, mio caro Richard, l’essengonista una spia in gonnella, di alta noza poetica è intesa gradualmente, molto
biltà. Lei dirà forse: robaccia! Ma noi mugradualmente».
sicanti siamo famosi, si sa, per un gusto un
Insomma, le 800 pagine in cui si dipapo’ scadente in cose di estetica». Al di là delna il carteggio danno conto di un incontro
R ic
la risposta inorridita e piccata di Hofmannsthal
straordinario e inimitabile, forse anche e soh a r d S t r a u ss
(«Ho dovuto ridere di cuore della Sua lettera. Per
prattutto grazie alla diversità di temperamento e
il mio gusto sono davvero cose orrende quelle che mi propone,
e potrebbero distogliere uno per tutta la vita dal fare il librettista») la controreplica di Strauss, più che la sua ingenuità in materia teatrale e il suo «gusto scadente in cose di estetica» mette in
evidenza la volontà – accompagnata dalla consapevolezza della
propria arte – di ricercare nuove forme espressive per far risaltare il proprio talento compositivo: «Mio caro signor von Hofmannsthal! Rida, rida: ma io so bene quello che voglio. Quando
avrà ascoltato il nuovo prologo (…) mi capirà e si accorgerà che ho un grande talento
per l’operetta – anche perché il mio lato
tragico è un po’ spompato, e dopo questa guerra la tragedia in teatro mi sembra per ora alquanto fiacca e infantile,
e il mio incoercibile talento (in fin dei
conti sono l’unico compositore oggi
che abbia veramente umorismo, arguzia e uno spiccato senso per la parodia)
lo vorrei mettere alla prova. Sì, mi sento
addirittura chiamato a divenire l’Offenbach del XX secolo, ed Ella sarà,
se deve essere, il mio poeta».
Un altro genere di epistole sono
poi quelle che Franco Serpa nella
sua edizione italiana chiama «lettere-lezione» teoriche, e che hanno tutte la stessa direzione, da Hofmannsthal verso Strauss. Tra le
molte che si potrebbero ascrivere
cultura dei due protagonisti. Ma se è vero che qua e là emergono costantemente diverbi e fraintendimenti, che si accrescono
nell’ultimo periodo della frequentazione, quando i capolavori
erano già stati scritti, è altrettanto certo che la morte improvvisa del poeta – avvenuta il 15 luglio 1929, un giorno dopo il suicidio del figlio – abbia lasciato Strauss a lungo in uno stato di
dolente prostrazione. E concludendo questo breve e necessariamente incompleto scritto sembra opportuno citare le parole che Quirino Principe dedica allo speciale legame che unisce
questa geniale coppia di artisti: «I due territori
intellettuali hanno almeno due zone in comune, e la sovrapposizione diventa fusione e consonanza: la scelta di vivere per l’arte, vanificando la storia attraverso la contemplazione, e l’insediarsi del sogno nella realtà con forza
rivelatrice. I due motivi di affinità sono decisivi, al centro, nell’uno e nell’altro, della vita individuale». (l.m.) ◼
Come bibliografia essenziale e tutt’altro che esaustiva si ricordano almeno:
Hugo von Hofmannsthal – Richard Strauss, Epistolario,, edizione italiana a cura di Franco Serpa,
Adelphi, Milano 1993
Mario Bortolotto, La serpe in seno. Sulla musica di RichardStrauss,Adelphi,Milano2007
QuirinoPrincipe,Strauss.Lamusicanellospecchiodi
Eros, Bompiani, Milano 2004
— speciale
novecento / parte seconda
Il Neoclassicismo
del Novecento:
un concetto
problematico
tori appartenenti storicamente al periodo barocco come Bach,
Haendel e Domenico Scarlatti saranno considerati «classici» della musica. Per la seconda è «classico» invece l’autore il cui stile si
richiama ad un ideale di equilibrio e di ordine formali. In questo
senso si può parlare di classicismo in compositori dell’Ottocento come Mendelssohn e Brahms.
La problematicità di una definizione in termini stilistici del
classicismo affiora anche in quelli che solitamente vengono identificati con l’etichetta di «classici» viennesi per eccellenza: Haydn,
Mozart e Beethoven. La musica linguisticamente nuova di questi compositori veniva ad esempio avvertita da uno scrittore e
di Raffaele Pozzi
musicista romantico come Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
a definizione concettuale di «neoclassicismo» presenta
come romantica. D’altra parte, lo stesso musicologo contemin musica molti aspetti problematici e non è afporaneo Charles Rosen, autore di un volume intitolafatto ovvia come si potrebbe pensare di prito Lo stile classico: Haydn, Mozart, Beethoven (Milano,
mo acchito. Concetto legato e derivato da quelFeltrinelli, 1979), ammette preliminarmente nel
lo più ampio e generale di «classicismo», essuo libro quanto una definizione di stile classiso si scontra in musica con le specificità di
co appartenga più alla storia del gusto e delun’arte, quale la musica, dove la classicità
la recezione che a quella della composizioantica, contrariamente alle numerose tene musicale.
stimonianze oggettuali e visive pervenuEntrambe le definizioni di «classico», siteci dal mondo greco-romano, non ci ha
stematico-normativa e storico-stilistica,
lasciato un analogo copioso patrimonio
sollevano inoltre importanti questioni di
sonoro.
estetica della musica delle quali si debboDella musica greca, la cui trasmissione
no avere ben chiare le implicazioni ideolodal periodo omerico fino al III secolo a.C.
giche. La concezione sistematico-normatiavvenne essenzialmente per tradizione orava della classicità tende ad individuare valole, ci rimangono infatti pochi frammenti nori
estetici universali che rischiano di irrigidirHe
os
itor
tati e di tarda epoca ellenistico-romana. La consi in un canone sovrastorico. L’approccio storiV il l a - L o b
creta realtà sonora della musica greca antica sfugge
co-stilistico, sottolineando la relatività storico-culspeciale
L
dunque ad ogni ricostruzione esecutiva mentre asturale e stilistica delle forme comunicative, rischia
sai ampio è il numero di testimonianze indiretd’altra parte di aggirare, ove si applichi un relatite relative al valore sociale, etico e religioso di
vismo radicale, la questione delle permanenze
essa. I miti greci, gli scritti di filosofi classici
profonde e dell’importanza della memoria
quali Platone, Aristotele, le teorie scientifinell’esperienza musicale umana.
co-musicali di Pitagora e Aristosseno, le
stesse pitture vascolari ci indicano il noNeoclassicismo e rappel à l’ordre
tevole rilievo che la musica ebbe nell’anLa mancanza in musica di exempla musitichità. Tale rilievo, e non le opere musicali greco-romani, quindi di un classicicali di fatto assenti, fu alla base del mito
smo in senso proprio, condizionò noteumanistico del primato della musica grevolmente il neoclassicismo musicale del
ca che la trattatistica e la nascente storioNovecento. Esso infatti si configurò come
grafia musicale registrano tra Cinquecento
un recupero e una reinvenzione di elemene Seicento in numerose opere teoriche tra le
ti della musica del passato non riferibili ad un
Da
quali le Istitutioni harmoniche di Gioseffo Zarlino
quadro storico-stilistico omogeneo. I vari retour
r ius M ilha u d
(1558) e il Dialogo della musica antica et della moderna di
à toccarono di volta in volta modelli differenti, in
Vincenzo Galilei (1581).
una sorta di mito dell’antico generalizzato e generico. I
Il neoclassicismo del secondo Settecento di Johann Joacompositori guardarono a varie epoche del passato, anche rechim Winckelmann – che individuò nelle opere dell’arte greca
cente: alla musica vocale del Medioevo e del Rinascimento (poligiunte fino a noi quella «nobile semplicità e serena grandezza»,
fonia medievale, Gesualdo, Monteverdi, ecc.); al Seicento (Bach,
secondo quanto egli scrisse nella sue note Considerazioni sull’imiHaendel, Scarlatti ecc.); al Settecento (Haydn, Pergolesi, Vivaldi,
tazione delle opere greche nella pittura e nella scultura (1755) – si basò sulecc.); all’Ottocento (Cajkovskij, Paganini, Rossini ecc.).
l’assunzione di modelli stilistici storico-archeologici. Il classiciIl neoclassicismo non è pertanto definibile come corrente dai
smo musicale non ebbe invece la disponibilità di analoghi mocaratteri stilistici ben determinati. Si presenta piuttosto come una
delli sonori. Ciò contribuì ad accentuare, in musica, la coesistenadesione al generale rappel à l’ordre che investì le arti dopo la priza di due definizioni di classicismo e neoclassicismo: l’una di tima guerra mondiale. Il movimento tentò di aprire una via alpo sistematico-normativo, l’altra di tipo storico-stilistico. Per la
la modernità differente dall’espressionismo, dalle avanguardie
prima è «classico» – nel senso etimologico del termine che risaradicali del periodo prebellico e, salvo eccezioni, dalle tendenze
le alle Noctes Atticae di Aulo Gellio (II sec. d.C.) – l’autore ecceltardoromantiche. In quest’ultimo senso il mito dell’antico non
lente assunto come modello. Da questo punto di vista composispiega altri importanti fenomeni neoclassici quali l’attrazione
novecento / parte seconda
speciale —
speciale
per il mondo del music-hall, della canzone leggera o della musiteatrale. La sfera della musica funzionale, d’uso quotidiano e di
ca d’uso. L’elemento ideologico presente nella concezione neoconsumo popolare, nel clima degli anni venti, fu considerata dai
classica, identificabile con la centralità della nozione ambigua di
compositori colti come una nuova sorgente di ispirazione. Stiordine, rese peraltro possibile negli anni trenta la convivenza di
lemi provenienti dal jazz e dalla musica popolare affiorano, ad
questo movimento con i regimi autoritari. Nella storia musicaesempio, nella Suite «1922», nel finale della Kammermusik n. 1 di
le il rappel à l’ordre fu del resto anche una risposta a due eventi trauPaul Hindemith o nei ragtime di Igor Stravinskij (1918) e di Damatici che la coscienza artistica dei contemporanei tese a sovraprius Milhaud (1922).
porre: da una parte la crisi della tonalità e l’avvento dell’atonalità,
Un autentico mito del rappel à l’ordre neoclassico fu Johann Sedall’altra il crollo del vecchio ordine politico europeo con la pribastian Bach, modello musicale in realtà chiamato in causa per
ma guerra mondiale che lasciò sui campi di battaglia dieci milioorientamenti stilistici assai diversi. Il fenomeno del «ritorno a
ni di morti. Tali fratture storiche provocarono nei compositori
Bach», propriamente neobarocco, rappresenta in effetti un coe nella stessa ricezione musicale una diversa qualità nel rapporto
spicuo settore della produzione neoclassica e ne mostra con evicon il passato. Mentre infatti i classicismi di epoche predenza l’intima contraddizione. A Bach si richiamano incedenti, si pensi al modo in cui Mendelssohn guarfatti Ferruccio Busoni con le sue solide architettudava a Johann Sebastian Bach, avvertivano una
re contrappuntistiche ((Fantasia contrappuntistica,
continuità storica nel rapporto tra presente e
1921); Igor Stravinskij con idee di una musica
passato, una sorta di vicinanza creativa con
dai profili strumentali astratti ((Ottetto, 1922);
la fonte, numerosi compositori più innovaPaul Hindemith, con la polifonia lineare
tivi e avanzati del Novecento volgendosi
della Kammermusik n. 4; Heitor Villa Loalle forme del passato finirono con l’acbos, con la sua ricerca di sintesi tra folklocentuare la cesura con il presente. Nel The
re brasiliano e scrittura bachiana (BachiaRake’s Progress (1951) di Igor Stravinskij, ad
na brasileira n.1, 1930).
esempio, il ricorso alle forme chiuse della
La stessa svolta dodecafonica di Arnold
tradizione operistica del Sette-Ottocento,
Schoenberg degli anni venti assume i tratnon celebra un pacifico ritorno al passato
ti di un’esigenza di ritorno ad un ordine linbensì un problematico e pessimistico riferiguistico e formale che guarda anche a forme
mento ad esso: nel finale dell’opera il protagoantiche, tendendo a convergere con la generaFe r
i
nista John Rakewell impazzisce immaginando
le
tendenza
neoclassica ((Serenade op. 24, 1923; Suin
r u c ci o B u so
se stesso proiettato nel mondo del mito greco.
te op. 25
25, 1921).
Le diverse maschere
Gli intenti modernistici di stampo antiromantidel Neoclassicismo
co sono infine evidenti nel neoclassicismo pariL’importanza del rappel à l’ordre come tratto di
gino che trova limpida esposizione ideologimatrice ideologico-normativa che accomuca negli scritti di Jean Cocteau ((Le coq et l’arna le maschere, i differenti orientamenti
lequin, 1926). Ironia, distacco emotivo, palequin
stilistico-musicali del neoclassicismo eurodia, gusto del pastiche, vitalismo ritmico e
ropeo, emerge nella stessa formulazione,
stile spoglio caratterizzano parte della proconcettualmente vaga, della junge Klassiziduzione del cosiddetto «Groupe des Six»
tät [giovane classicità] di Ferruccio Buso(Milhaud, Poulenc, Honegger, Auric, Duni. In una lettera di Busoni a Paul Bekker,
rey, Tailleferre) che elesse Erik Satie a propubblicata nella «Frankfurter Allgemeine
prio nume tutelare. Tra le opere più rappreZeitung» nel 1920, il musicista auspica l’avsentative di questo orientamento estetico, al
vento di una «nuova classicità» che si caratquale non era estranea una forte componenterizzi, tra altri aspetti, per la «rinuncia al sogte nazionalistica antigermanica, vanno ricordaIgor
gettivismo (la via verso l’oggettività – il ritrovarte Mouvements perpétuels (1918) di Francis Poulenc;
S tr a v i n s k ji
si dell’autore di fronte all’opera – una via di purificaLa création du monde (1923) di Darius Milhaud, balletzione, un cammino duro, una prova dell’acqua e del fuoto che, con richiami al jazz, narra la Creazione; Pacific 231
co), la riconquista della serenità».
(1923) di Arthur Honegger, brano sinfonico modernista il cui
In Germania, l’esigenza di prendere le distanze dal soggettimotorismo si ispira al movimento di una locomotiva.
vismo esasperato dell’espressionismo, si pensi in tal senso alla
Il neoclassicismo, nato a seguito dei disastri della prima
letteratura della neue Sachlichkeit [nuova oggettività], si incontrò
guerra mondiale, tramontò con la seconda guerra mondiacon le nuove istanze culturali della Sozialpolitik della Repubblile. Nonostante le sue contraddizioni e ambiguità, la pluralica di Weimar. Il mutamento ideologico in direzione razionalistità dei suoi orientamenti difficilmente sintetizzabili in un quaca e democratica trovò nel progetto del Bauhaus di Gropius una
dro unitario, esso fu radicalmente travolto dalla profonda esicompiuta realizzazione e analoghe istanze furono espresse dalgenza di rinnovamento artistico che si sviluppò negli anla Gebrauchmusik [musica d’uso] di Paul Hindemith, produzione
ni quaranta. L’orizzonte delle neoavanguardie dopo il 1945
pensata per musicofili dilettanti. In questo ambito, dalla collacoincise con la dolorosa ricostruzione postbellica e la moborazione con Bertolt Brecht nacque il Lehrstück (1929) per due
dernità musicale assunse le forme di un’ideologia della palinvoci maschili, voce recitante, coro, danzatore, tre clown e orgenesi che accantonò pastiches e parodie per tentare l’edificachestra, che prevede il coinvolgimento del pubblico nell’azione
zione, attraverso una nuova musica, di un nuovo mondo. ◼
CA’ DEI MIRACOLI
Venezia
Vuoi Comprare casa a Venezia? Credi nei Miracoli
C’è il pozzo in pietra di
Verona e c’è un prezioso pavimento in lastre di
marmo bianco e rosso, ci
sono le finestre grandi,
piccole o immense che si
rincorrono sulle facciate e ci sono le altane incastonate sui tetti. C’è tutta Venezia in un Palazzo,
che si chiama Ca’ dei Miracoli, risale al 1400 ed è
tornato a nuova vita grazie al paziente restauro
che l’ha trasformato in
un complesso nel quale
sono state ricavate quattordici unità, tra studi e
appartamenti, di dimensioni che vanno dai 23 ai
167 metri quadrati, tutti
affacciati sulla corte interna che sembra rubata
a una commedia del Goldoni. A cinque minuti da
Rialto e a dieci da Piazza
San Marco, a pochi metri
dalla Chiesa dei Miracoli e dal suo splendore di
marmi policromi, Ca’ dei
Miracoli sorge in un angolo della città dove il turismo di massa non è an-
cora arrivato. Nell’omonimo Campo ci sono i
bambini che giocano, la
bottega di paralumi, l’antiquario, i negozi di prima necessità (che in altre
parti della città sono diventati introvabili!). Due
ponti più in là c’è Campo
SS. Giovanni e Paolo e
l’infinita passeggiata lungo le Fondamenta Nuove
da dove partono i vaporetti per le isole. In questa fetta di Venezia dove
la vita scorre tranquilla,
Ca’ dei Miracoli propone
una serie di soluzioni abitative (e non) con caratteristiche veneziane ma soluzioni moderne. Tutti gli
appartamenti sono dotati
di ascensore e dispongono di riscaldamento autonomo, hanno la predisposizione per l’aria condizionata e sono accessibili tramite le due porte di
terra (in Calle Maggioni
e Ramo dei Miracoli) e
la porta d’acqua sul Rio.
Il restauro conservativo
del Palazzo ha permes-
so di salvare i contorni in
pietra d’Istria che ornano
le facciate, le travature lignee, le porzioni di muratura costituita da mat-
toni originali in cotto e
una bella corte interna.
Il fascino di Ca’ dei Miracoli sta proprio in questi dettagli e offre soluzioni per tutti, anche per
chi vuole abitare a un soffio dal cielo, lì all’ultimo
piano dove si rincorrono finestroni e terrazzi
tra le tegole rosse dei tetti veneziani.
Se vuoi saperne di più
vieni a trovarci a Venezia San Marco 514, tel.
041 5209747.
www.cadeimiracoli.com
[email protected]
NESSUNA PROVVIGIONE A CARICO DELL’ACQUIRENTE
novecento / parte seconda
Le origini
del Novecentismo
italiano
speciale —
ultimi sprazzi dell’era giolittiana e il primo dopoguerra, in cui la musica italiana s’identificò soprattutto con le voci di Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Ildebrando Pizzetti, Ottorino Respighi. Al loro tempo essi parvero un robusto drappello di novatori, disposero di voci critiche di prim’ordine in
grado di spiegarne e promuoverne le istanze dentro e fuori i confini nazionali, ebbero il giusto sostegno delle istituzioni, si videro perfino attribuire un’etichetta – quella di «generazione dell’80» per via delle nascite parallele negli anni intorno al 1880 –
che avrebbe dovuto contraddistiguerne
l’identità di gruppo teso a una meta condivisa. A loro la sorte riservò il compito
difficile di confrontarsi criticamente con
la tradizione del melodramma, proprio
nel momento in cui le azioni di quest’ultimo toccavano il punto di maggior depresLuigi Dallapiccola
sione presso la cultura nazionale, e di mi-
cità per progetto di Malipiero messa al servizio di bizzarre realizzazioni teatrali e sinfoniche, l’ascetismo linguistico e espressivo di estrazione arcaicizzante di Pizzetti, l’ispirazione orchestrale sontuosa e sgargiante di Respighi. Col tempo ciascuno di
essi finì per ripiegare verso un modernismo temperato, sempre più avulso dagli snodi vitali della musica d’arte novecentesca, alla quale altre generazioni dell’ottanta – quella di Berg
e Webern, patrocinata da Schoenberg, quella di Bartók, quella di Stravinskij – suggerirono orientamenti e vocazioni. Dal
che l’interesse assai circoscritto per i musicisti dell’80 da parte
dei colleghi italiani delle generazioni successive. In un primo
tempo Luigi Dallapiccola poté conformarsi all’intensità etica
di certo teatro malipieriano e Goffredo Petrassi agganciarsi alla matrice caselliana, tra elementi popolareschi e recuperi neoclassici. Ma poi i compositori d’avanguardia non avrebbero trovato ragioni valide
per rapportarsi ad essi: sintomatico l’abbandono del maestro Malipiero da parte
del giovane Luigi Nono per approdare alla scuola di Bruno Maderna.
Oggi, dopo il fuggevole slancio d’interesse innestato dalle celebrazioni centenarie a partire dall’anniversario-madre del
1980, quel grappolo di musicisti pare consegnato a un irreversibile processo di museificazione (con gli archivi di Casella, Malipiero, Respighi confluiti all’Istituto per la
musica della Fondazione Cini di Venezia e
quello di Pizzetti assorbito nella Biblioteca
Palatina di Parma) e di elaborazione del-
surarsi con le tendenze
del modernismo su scala internazionale, proprio quando la modernità s’avviava a diventare un imperativo dell’arte contemporanea e in
suo favore s’istituivano
enti e festival, s’organizzavano congressi, si varavano riviste e pubblicazioni. A loro toccò diAlfredo Casella,
stricarsi tra i prodromi
delle modalità novecentesche di articolazione tra musica d’arte e musica di massa, fra i
primi passi dello sfruttamento industriale dei prodotti musicali in campo discografico e cinematografico. La maggior parte
di essi fu testimone di due conflitti mondiali e in mezzo convisse con un totalitarismo politico che ne sfruttò l’arte a scopo di
consenso. Alcuni di loro, come Pizzetti (morto nel 1968) e Malipiero (morto nel 1971), sono vissuti abbastanza a lungo per assistere alla rivoluzione estetica delle avanguardie.
Come quel grappolo di musicisti abbia attraversato la fase più
tormentata del secolo breve è noto. Non riuscì mai a costituirsi come gruppo mosso da un’intenzione comune, poiché mancò di un vero progetto che rendesse complementare il percorso dei singoli. Nell’insieme si presentò come occasione passeggera d’incontro tra personalità diversissime per formazione e
obiettivi, ciascuna delle quali si sarebbe qualificata per propri
tratti distintivi: il vitalismo costruttivo di Casella, l’asistemati-
la memoria, favorita dalla pubblicazione di cataloghi, carteggi e abbozzi.
Salvo rarissime eccezioni, fra cui gli intramontabili poemi sinfonici di
Respighi, le musiche di
quella stagione del Novecento italiano sono di
nuovo scomparse dalla programmazione di
teatri e enti concertistiGian Francesco Malipiero,
ci e dai cataloghi delle case discografiche; sebbene lavori come La giara o Scarlattiana di Casella, come le Pause del
silenzio o il Torneo notturno di Malipiero, come il Concerto dell’estate
o le liriche da camera di Pizzetti siano degnissimi di trovar stabilmente posto in una sorta di repertorio idealtipico del Novecento musicale.
In definitiva, il lascito più significativo di quella prima stagione del modernismo italiano si riduce alle ragioni negative nelle quali i suoi protagonisti si riconobbero: l’opposizione alla tradizione melodrammatica ottocentesca, l’opposizione all’idea ormai anacronistica dell’autosufficienza della musica italiana. Per l’apertura al pensiero musicale europeo Casella si batté assai più dei compagni «ottantisti». Altri dopo di lui si sarebbero davvero avventurati oltre gli steccati del provincialismo culturale che egli con tanta pervicacia aveva voluto abbattere. Pochi di loro, però, avvertirono
qualcosa di più che un vago sentimento di riconoscenza. ◼
di Virgilio Bernardoni
C’
speciale
È STATA UNA STAGIONE del Novecento, iniziata tra gli
— speciale
novecento / parte seconda
L’avvento della
musica elettronica
sica elettronica pura», in cui il protagonista è sempre il compositore, al quale però viene imposto il vincolo, un po’ dogmatico,
di lavorare solo con suoni di natura elettronica. Rispetto a Parigi, Colonia non rifiuta il postwebernismo, anzi ne teorizza l’ampliamento tramite l’utilizzo del suono elettronico puro. E difatti chi abbraccia più a fondo questa ideologia è proprio il giovadi Alvise Vidolin
ne Karlheinz Stockhausen, il quale, pur avendo fatto un’espeCONSUETUDINE FAR risalire la nascirienza di musica concreta a Parigi, una volta
ta della musica elettronica al secon- Questo intervento nasce da un’intervista rientrato a Colonia sposa immediatamente
do Novecento, ma, come tutte le for- ad Alvise Vidolin realizzata a Venezia la filosofia seriale estesa a livello sonologico.
me espressive, anch’essa non sorge certo tutNormalmente, nella scrittura seriale, per fisnel mese di luglio 2008.
to d’un tratto, e infatti qualcosa si muove già
sare la serie dei timbri il compositore si limiprima della seconda guerra mondiale. C’è però un elemento che
ta a scegliere una serie di strumenti (se si tratta di un pezzo per
differenzia maggiormente il primo dal secondo Novecento: alensemble), o una serie di «tocchi» (se è un brano per strumenl’inizio questo tipo di musica (che in realtà allora veniva chiamato singolo): i timbri, quindi, non sono composti, ma sono semta «elettrica») era di fatto pensata e realizzata dagli eseplicemente scelti e organizzati serialmente. Stockhaucutori: sono loro i protagonisti, non i composisen invece, proprio grazie agli strumenti elettrotori, come invece avverrà nella seconda menici, arriva a comporre anche il timbro e Stutà del secolo. Tra questi esecutori uno dei
dio 1 ne è il primo importante esempio. In
più noti è senz’altro Maurice Martenot,
questo lavoro datato 1953 il timbro è fiche inventa le Ondes Martenot, uno
nalmente composto con le stesse restrumento musicale tuttora insegnagole formali e strutturali che regolato ai Conservatori di Parigi e Lione.
no tutto il pezzo. Studio 1 è un lavoUn’altro nome molto celebre è quelro fondamentale, anche se sul pialo di Lev Termen, un violoncellista
no dei risultati presenta delle limitarusso inventore del Teremin, divenzioni, dovute essenzialmente ai meztato famoso prima in Europa e poi nezi dell’epoca: la costruzione dei timbri
gli Stati Uniti. Questo strumento utilizsi limita a misture composte al massimo
M a u r ice M a r te n ot
za come tecnica di esecuzione il movimenda sei suoni sinusoidali simultanei. Se voles-
speciale
È
L ev
to della mano di fronte a un’antenna, riuscendo con
questo movimento a variare l’altezza del suono.
Nell’immediato dopoguerra invece il compositore diventa protagonista assoluto, e non usa
più gli strumenti elettronici in senso imitativo di quelli tradizionali. I suoi strumenti ora
sono presi dai laboratori di fisica, dalle apparecchiature degli studi di fonologia e di
radiofonia. Non è un caso infatti che le prime esperienze di musica elettronica nascano all’interno delle emittenti radiofoniche.
Il primo a lavorare in questo ambito è Pierre Schaeffer, che dal 1948 compie le sue sperimentazioni presso l’ente radiofonico francese.
en
Schaeffer è il padre di un nuovo genere, la «musica elettroacustica», che non usa tanto suoni elettronici in sé quanto suoni acustici – che possono essere generati sia da strumenti che da rumori della vita quotidiana – manipolati però elettronicamente. È lui a definire la
sua musica «concreta»: perché essa utilizza effettivamente suoni concreti e reali e perché si pone in contrapposizione all’astrazione formale del dominante postwebernismo. Schaeffer afferma che l’opera è il suono, non la partitura, e che non esistono alchimie intellettuali, ma soltanto il lavoro diretto sul suono.
Pochi anni dopo anche Radio Colonia inizia a lavorare nel
campo della musica elettronica, scegliendo una strada completamente diversa. In Germania si parte da una constatazione: la
novità è il mezzo elettronico (l’oscillatore, il filtro, il generatore
di rumore). Dunque ci si deve indirizzare verso una musica che
sia fatta esclusivamente con suoni elettronici: nasce così la «muTe
rm
simo paragonarla al mondo della pittura, si potrebbe dire che sia una composizione in bianco e nero. Però a partire da qui il musicista comincia ad
assimilare artisticamente il funzionamento delle apparecchiature elettroniche. Dopo Studio 2,
nel ‘55/’56 arriva Gesang der Jünglinge, il primo
capolavoro assoluto di musica elettronica. La
cosa interessante di questo pezzo è che rompe anche il dogma di Colonia, perché utilizza
assieme ai suoni elettronici anche la voce di
un bambino. Il risultato musicale è raggiunto senza blocchi ideologici: il compositore si
serve del mezzo di cui ha bisogno per esprimere il suo pensiero musicale. Un’idea che in realtà
già nel ‘52 Bruno Maderna aveva espresso chiaramente con Musica su due dimensioni, un lavoro per flauto e suoni elettronici presentato a Darmstadt in quell’anno. Per Maderna l’evoluzione del linguaggio musicale
non ha momenti di rottura, quindi il mezzo elettronico può solo aggiungere una nuova dimensione alla musica stessa, non interrompere il suo percorso.
In realtà esistevano dei motivi per ipotizzare una rottura con il
passato, perché il modo di comporre e scrivere pezzi elettronici era completamente diverso da quello «tradizionale»: a partire
da Studio 2, le partiture non hanno più alcun legame con il pentagramma. E c’è anche un altro fatto sostanziale: questa musica viene consegnata alla storia non più sotto forma di partitura, ma come documento sonoro. Stockhausen produceva un
nastro magnetico e quella era l’opera, che non aveva più bisogno di essere reinterpretata. Mentre in passato esisteva la neces-
speciale —
novecento / parte seconda
netto, lavorando molto con il microfono in quella che diventerà
una prassi nelle sue composizioni degli anni ottanta. Negli anni sessanta il filone della live electronics prende sempre più piede, a
cominciare dal gruppo Mev (Musica Elettronica Viva), che nasce in quel periodo a Roma. Insomma, anche la musica elettronica si evolve, si formano gruppi d’improvvisazione più libera (sempre a Roma, ad esempio, il gruppo «Nuova consonanza») e Stockhausen stesso rompe con il dogmatismo seriale. Ma
già alla metà di quel decennio comincia a emergere un nuovo
mezzo: il computer. Uno degli esponenti più rilevanti di questa
nuova frontiera è certamente Iannis Xenakis, che sta in quegli
anni elaborando la teoria della musica stocastica, e necessita di
un mezzo per sviluppare i calcoli probabilistici che stanno alla base della composizione. Oltreoceano, presso i Bell Telephone Laboratories, Max Mathews tra il ‘63 e il ‘64 crea i primi suoni mediante computer. La cosa curiosa è che sono gli
stessi anni in cui Robert Moog costruisce i primi
sintetizzatori, e quindi realizza per via analogica quello che Mathews realizza per via digitale. In seguito, negli anni settanta la computer music si sviluppa soprattutto nelle università del nord America, seguendo la rapida evoluzione della tecnologia informatica. Nel ‘75 Pierre Boulez fonda l’Ircam
a Parigi e quindi anche l’Europa ha finalmente un punto di riferimento nella ricerca musicale sul suono con le nuove tecnologie numeriche.
Gli anni settanta sono dunque caratterizzati dall’ingresso nella scena musicale di questa nuo-
gio a Vedova, un pezzo puramente elettronico
che l’autore ha sempre ritenuto un primo studio. Poi è la volta di Intolleranza 1960 (1961) e del
‘64 è La fabbrica illuminata, il brano che lui considera il primo pezzo effettivamente elettronico.
Lì troviamo una mescolanza tra la voce di un
soprano che canta dal vivo, i rumori registrati all’Italsider di Cornigliano e parti vocali manipolate con tecniche elettroacustiche. L’anno
successivo compone Ricorda cosa ti hanno fatto in
Auschwitz, un altro capolavoro dell’elettronica.
Ma citare qui tutti i lavori di quel fortunato periodo sarebbe impossibile.
Va notato che, mentre gli anni cinquanta erano tutti focalizzati sulla possibilità di lavorare su nastro magnetico – e si può dire che lo
strumento principale, in questo periodo, fosse proprio il registratore – negli anni sessanta
si comincia a sentire la necessità di far uscire
l’elettronica dai laboratori e portarla nelle saMax Mathews
le da concerto. I primi a riuscirci sono Cage e
soprattutto Stockhausen con Mixtur (1964) e
con il più significativo Mikrophonie I (1964), in
cui sono esplorati i suoni che un grande tam tam può generare
attraverso quella sorta di microscopio sonoro che è il microfono. Questo lavoro è un punto di svolta, perché apre la strada a
quello che verrà successivamente chiamato live electronics, ovvero musica elettronica eseguita dal vivo. Anche Nono sente quest’esigenza, e con A floresta é jovem e cheja de vida (1969), pur continuando a utilizzare il nastro, inserisce dal vivo le voci e un clari-
va macchina, che ha grandi potenzialità ma all’inizio anche molti vincoli. In quegli anni non
ci si poteva permettere l’acquisto di un computer, bisognava utilizzare quelli in dotazione
alle università e ai centri di ricerca scientifica.
In Italia le prime esperienze le conduce Pietro
Grossi lavorando al Cnuce di Pisa (Cnr) e noi
del Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di Padova. I primi suoni digitali
escono a Padova nel ‘73-’74 e fino a tutti gli anni ottanta continua un’importante esperienza
di collaborazione con La Biennale di Venezia,
fra cui la collaborazione nel Prometeo di Nono
(1984).
L’avvento del computer non porta automaticamente alla morte della musica elettronica.
Come si diceva prima con Maderna, anche il
computer aggiunge una nuova dimensione alla musica. In particolare, le difficoltà incontrate sul piano tecnico dalla ricerca e dalla sperimentazione degli anni cinquanta nel realizzare pezzi elettronici musicalmente importanti,
scompaiono negli anni settanta con l’avvento
del computer. Ma, come spesso accade, superato un limite se
ne crea immediatamente un altro e anche con il computer nascono nuove sfide tecnologiche. E questa è un’altra storia da
raccontare...
Altre, comunque, sono le sfide musicali, per cui composizioni magari più semplici da un punto di vista tecnologico risultano musicalmente molto più interessanti. ◼
e
ha
P ie rr e Sc
sità di avere una figura intermediaria fra ciò che aveva scritto il
compositore e il pubblico, con l’avvento della musica elettronica questa necessità di fatto sparisce: la musica è «scritta» in maniera definitiva sul nastro magnetico.
Un altro snodo cruciale è la fondazione nel 1955 dello Studio
di Fonologia della Rai di Milano, ad opera di Bruno Maderna
e Luciano Berio. Anche Berio, come Maderna, vede nel mezzo elettronico una possibilità per proseguire con nuovi mezzi
il lavoro compositivo, senza rotture o chiusure nette con la tradizione. Inoltre lo Studio milanese supera la diatriba tra musica concreta e musica elettronica pura aprendolo alla ricerca più
ampia e invitando molti altri artisti, tra cui John Cage, Henry
Pousser e, successivamente Luigi Nono, che sarà il protagonista dello Studio dagli anni sessanta fino alla chiusura avvenuta
nel 1983. Lo Studio di Fonologia era stato creato dalla Rai anche come supporto a un genere che in quegli anni riscuoteva molto successo, il radiodramma. Quindi
molti esperimenti venivano utilizzati in quella direzione, ma i lavori più importanti sono quelli di musica elettronica assoluta. Fra
questi, uno dei pezzi più belli realizzati da
Berio è Thema (Omaggio a Joyce) (1958), che
nasce da una ricerca che il musicista stava
conducendo con Umberto Eco sull’onomatopea, finalizzata ad una trasmissione
radiofonica. Un altro caposaldo dello Studio milanese è Continuo (1958) di Maderna,
r
la cui tecnica di composizione consiste nella
trasformazione continua del materiale sonoro
di inizio del brano stesso. Nel ’60 Nono crea Omag-
speciale
f fe
— speciale
novecento / parte seconda
M’illumino di me
perduto senza la regia del suono dell’autore, che richiese sei mesi
di prove a un gruppo di interpreti di sua fiducia.
Una mutazione avvenne tra il 1955 e il 1956 con Zeitmasse, vidi Mario Messinis*
cini alla «riflessione filosofica» sul tempo di Bloch, segnalata da
on credo ci sia stata solo l’influenza di Webern nel priErnesto Napolitano, con il Gesang der Jüglinge (Canto degli adomissimo Stockhausen. Nel 1951 scriveva contempolescenti) e con Gruppen. Zeitmasse si muove da premesse seriali
raneamente una Sonata per violino e pianoforte di gu(ancora l’astrattismo di Webern), ma poi alterna arabeschi ornasto francese, Formel per orchestra dall’affascinante tematismo di
mentali a blocchi temporali e a fughe periodiche da una musiimpronta berghiana, e Kreuzspiel nel quale si sente la voce di Weca totalmente determinata. Kontra-Punkte e Zeitmasse hanno incibern, senza dubbio, ma anche una ritmica alla Messiaen e una
so anche sull’avanguardia italiana, da Berio a Clementi, da Dosotterranea presenza di Varèse (la melopea dell’oboe così evonatoni a Togni. Il Gesang è forse una delle composizioni elettrocatrice). In fondo una più forte incidenza del
niche più impressionanti del Novecento. Per
grande maestro viennese si nota nei Klavierla prima volta Stockhausen affronta, anticistücke I-IV e nei Kontra-Punkte del 1953. È vepando le ricerche di Nono, il problema delro che, come dicono i manuali, in questi lala musica spaziale (l’opera viene diffusa attravori si allenta la «serialità integrale» (ossia il
verso quattro gruppi di altoparlanti disposti
controllo su tutti i parametri musicali), ma è
intorno al pubblico) con un continuum sonoanche vero che Stockhausen privilegia una
ro illuminato da una molto poetica e celestiarigorosa astrazione. Impassibili ornamenle voce infantile, che traduce in fonemi un teti puntano sulla varietà dei timbri (il timbro
sto biblico: sarà per mezzo secolo uno dei luoè tutto diceva Shönberg) e sul progressivo
ghi fissi del cosmo mentale dell’autore. Appaalleggerimento delle tensioni fino a sfiorarentemente Gruppen per tre orchestre (con tre
re il silenzio. I «romanzi in un sospiro» sodirettori), sono scritti secondo il più strenuo
no gelidificati.
strutturalismo. Ma gli interventi delle singoAlla metà degli anni cinquanta c’è una svolle orchestre non sono tutti prefissati; e d’altra
ta decisa con l’apertura alla indeterminazioparte la complessità della scrittura sfiora l’inne, che mette in discussione certezze acdeterminazione e l’amorfia intervallare. In
quisite. Stockhausen esclude di essere staquesto storico pezzo emerge una volontà coto influenzato da Cage. Certo il compositostruttiva e nel contempo una furia disgregaKarlheinz Stockhausen
re americano è giunto solo nel 1958 a Dartrice. Su un piano opposto si muove Carré del
speciale
N
mstadt, il cenacolo dell’avanguardia dominato allora da Stockhausen e da Boulez, e
tangenzialmente da Nono e da Maderna, e
la sua apparizione fu travolgente e provocatoria, con il sostegno autorevolissimo quanto arbitrario di Metzger, il luciferino allievo
di Adorno, che vedeva nell’atarassico e speculativo Cage il profeta della «negazione determinata», quasi fosse uscito dalla filosofia
e dall’espressionismo tedeschi. Peraltro Cage era già entrato nella cerchia di Darmstadt
e Stockhausen ebbe modo di conoscerlo nel
1954, durante una tournée con Davis Tudor,
il grande pianista che sarebbe divenuto uno
dei suoi più geniali interpreti. Il Klavierstück
XI del 1956 accoglie l’idea di Music of Changes
di Cage del 1951 dal punto di vista dell’inconFranco Donatoni
tro tra logica formale e indeterminazione.
Naturalmente il musicista interpretò l’aleatorietà all’interno di una concezione costruttiva di tutt’altro segno.
Anche le composizioni più radicali come Aus den sieben Tagen
(Dai sette giorni) nel 1968, nei quali il respiro musicale è
affidato al coinvolgimento degli interpreti (senza partitura e con didascalie), sono ricondotte a una concezione unitaria
che ripropone in termini intuitivi i principi della coerenza formale. Purtroppo questo ciclo grandioso, di sette ore di durata, è probabilmente
1960 per quattro orchestre e quattro cori (disposti spazialmente come Gruppen e guidati
da quattro direttori), uno dei primi pezzi spirituali e meditativi dell’autore, un cerimoniale estetizzante, in cui vibra un anelito alla trascendenza funeraria, ma anche un’idea consolatrice della morte. È una personale evocazione dell’idealismo romantico, così presente nella sua opera matura.
Due anni dopo Stockhausen muta ancora
registro con Momente per soprano, quattro cori e tredici strumenti. È l’opera che ha sollecitato il pensiero critico di Mario Bortolotto,
dopo la prima a Colonia e a Donaueschingen
(1962 e 1965) alla base del regale saggio introduttivo di Fase seconda (edito nel 1969), ovvero la riflessione teorica sull’indeterminazione. Stockhausen si muove sempre su due piani: da un lato esalta l’autonomia degli interpreti, e dall’altro crea un ferreo coordinamento costruttivo. La
presenza dello stesso Stockhausen come direttore (o altrove alla regia del suono) garantisce la coesione dell’insieme. È un’opera fondamentale in cui prevalgono gli aspetti gestuali e teatrali.
È molto forte la componente ironica, di un acre umorismo, della voce solista (alla prima una scatenata Martina Arroyo). Il coro trascorre dal parlato, al sussurro, alla vociferazione, al battito
delle mani e gli ottoni esibiscono taglienti asprezze. Tra il 1963 e
il 1964 Stockhausen, sempre interessato alle tecnologie, utilizza
per primo il Live electronics, la musica elettronica dal vivo, in Microphonie, che vede impegnati, intorno a un enorme tam-tam, due
speciale —
novecento / parte seconda
seduzione. Stockhausen amava ideare, nel suo polittico operistico, «musica, libretto, danza, azioni, gesti» come indicato nelle didascalie delle partiture; aveva escogitato anche per i movimenti
una sorta di notazione coreografica. Di conseguenza Luca Ronconi e Gae Aulenti, dopo due prime alla Scala, rinunciarono all’impegno: erano troppi i condizionamenti dell’egocentrico autore. Forse Licht andrebbe oggi riproposto in forma concertata
o tutt’al più semiscenica. Musicalmente è un romanzo incantatorio. L’esotismo nel cosmo sonoro (ma non scenico) costituisce
un antecedente, che viene concepito come allusione metaforica,
al pari di quanto avviene nel Canto della Terra di Mahler ove non ci
sono cineserie, nonostante le liriche cinesi dei
testi. Quindi le componenti orientali (India o
Giappone molto frequentati) sono totalmente assimilate alla cultura europea.
Dopo la conclusione di Licht Stockhausen è
tornato alla musica pura e ci ha offerto alcune
delle sue pagine più significative, sia sul piano strumentale – il ciclo non ultimato di Klang
– che elettronico, soprattutto quando riafferma la sua caratteristica sistematicità compositiva, come nella polifonia a ventiquattro canali degli Impulsi cosmici.
Karlheinz Stockhausen era posseduto da
una smisurata passione per la musica. Dialogava con il pubblico, spiegava didatticamente le sue opere, teneva corsi e seminari e soprattutto rincorreva una assoluta perfezione tecnica. Le sue partiture sono costellate di
norme esecutive, con tempi di prove impro-
grafie, da lui stesso inventate, impone costumi da rotocalco, movimenti televisivi. Il formidabile «scienziato», saggista e speculatore (11 volumi dei Texte purtroppo non disponibili in Italia; Einaudi ne aveva commissionato una traduzione a Bortolotto, ma l’iniziativa non ebbe seguito, anche perché l’autore non accettava una scelta antologica) cedeva sul piano delle immagini a un esotismo
illustrativo.
Con ciò siamo giunti a Licht (Luce), l’immane ciclo teatrale che si appella, credo, al
San Francesco di Messiaen, piuttosto che a Wagner – sette opere corrispondenti ai sette
giorni della settimana – cui Stockhausen ha
dedicato tutte le proprie energie dal 1977 al
2002. Ho visto Giovedì, Sabato e Lunedì da LuEdgard Varèse
ce rappresentati alla Scala tra il 1981 e il 1988
per iniziativa di Abbado, Siciliani e Badini, e
Venerdì a Lipsia nel 1996, in una debole e generica realizzazione
registica. L’intero ciclo di Licht era stato commissionato dal teatro milanese a Stockhausen; ma poi le rappresentazioni vennero drasticamente sospese. Nonostante i limiti teatrali, si è perduta un’occasione unica, perché la musica della Sette giornate è
quasi sempre bellissima: scene come il Canto di Katinka, per flauto di Katinka Pavseer, e sei percussionisti (o nastro magnetico), il
Viaggio di Michael intorno alla terra, per la tromba del figlio Markus e
orchestra, gli innumeri brani per il clarinetto e il corno di bassetto di Susanne Stephens dimostrano come il compositore amasse l’approfondimento di cadenze strumentali dalla incontenibile
ponibili oggi (e nemmeno ieri), nell’età della pianificazione industriale. Dal 1969 aveva
abbandonato la casa Universal di Vienna per
divenire editore di se stesso e della sua produzione discografica. Così poteva controllare personalmente le produzioni concertistiche e teatrali, e spesso contestarle. Era di
una precisione maniacale. Riuscì persino a
trascrivere con una notazione analitica anche brani elettronici, soprattutto lo Studio n.
2 del 1954. La sua esigenza di prove esorbitanti e spesso inattuabili corrispondeva però a ben radicate convinzioni etiche, alla ricerca di una tonalità esecutiva. Di Stockhausen ho presentato per la prima volta in Italia Carré e Venerdì da Luce in forma di concerto. I rapporti non furono facili, i contrasti talvolta aspri (due mesi di prove per il coro e dieci giorni per l’orchestra non li riteneva, in Carré,, sufficienti), ma il compositore era anche molto amichevole, entusiasta, comunicativo. Lo ritenevo «immortale» per l’impetuosa vitalità e per la perenne ricerca come ipotesi celeste: con lui si viveva vicino alle stelle. ◼
speciale
percussionisti, due esecutori al microfono e due registi del suono. Mai la musica ha svelato con altrettanta invenzione la fonicità inesplorata.
Mi limito infine a ricordare, dello sterminato catalogo, Stimmung (Stato d’animo) del 1968 per sestetto vocale, come un’immota liturgia medievale che arresta il tempo in un minimalismo armonico trasfigurato. E ancora: il ciclo liederistico per
due voci Indianer Lieder (1972), su frammenti poetici di indiani
d’America, 12 canti che traducono il gesto in melodie multiple.
Le monumentali Hymnem segnano l’esplicita indagine sulla figura in una posizione antinomica rispetto all’astrattismo e all’armonia delle sfere di tante pagine dell’autore, allucinante metamorfosi distorta di inni nazionali citati, sovrapposti, contaminati
con convulsa violenza. Tuttavia dopo le tensioni drammatiche alla fine si afferma nelle Hymnem una palingenesi cosmica. Il musicista ha sempre creduto nei messianici momenti liberatori come fiducia in un trascendente universalismo. Inori (Preghiera) segna
invece un momento di involuzione: nel 1974
a Donaueschingen era imbarazzante vedere
due danzatori-mimi che si agitavano sul podio durante le esorbitanti maree orchestrali. Il creatore di un’eversiva «composizione
del suono», che anticipa la musica «spettrale» rivela invece qui i limiti di una convenzionale sensibilità visiva e di una attardata idea
di teatro anche sul piano librettistico. Si eserOlivier Messiaen
cita in un orientalismo decorativo, in coreo-
*Courtesy by Classic Voice
L’articolo è stato pubblicato nel numero 104
(gennaio 2008) del mensile diretto da Andrea
Estero.
— speciale
novecento / parte seconda
Luigi Nono
e Bruno Maderna
Hermann Scherchen. Il musicista tedesco, che nel 1912, appena ventenne, aveva tenuto a battesimo il Pierrot Lunaire di
Schoenberg, aveva da poco rimesso piede in Germania dopo
quindici anni di esilio a causa delle sue simpatie comuniste e
del suo impegno di musicista a sostegno dell’arte «degenerata».
di Veniero Rizzardi
Al corso di Scherchen partecipavano Bruno Maderna, Luigi
Nono, insieme ad altri musicisti veneziani, e di tutto il mondo.
UANDO, NELL’EUROPA degli anni successivi alla fine
Maderna e Nono avevano 28 e 24 anni. Le loro storie, fino
della seconda guerra mondiale, gli sforzi della ricoa quel momento, erano state molto diverse. Bruno aveva un
struzione si
curriculum accadeestesero
mico solido, come il
alla riorganizzaziosuo mestiere di comne della vita culturapositore, e una carle, qualunque iniziariera di direttore già
tiva venisse presa, in
avviata (per non diqualunque ambito o
re dell’infanzia «prodisciplina, la princidigiosa» che lo aveva
pale, implicita convisto sul podio delsegna, era quella di
l’Orchestra della
contrastare ogni riScala di Milano a nosorgenza nazionave anni di età), «Gilistica. Sullo sfongi» invece, dopo un
do agiva certamente
poco convinto pasuna speciale attensaggio in Conserzione delle potenvatorio, su suggerize vincitrici nei conmento di Gian Franfronti dei paesi «licesco Malipiero aveberati», fino a poco
va appena ripreso a
prima dominati dalstudiare proprio con
Luigi Nono e Bruno Maderna a Darmstadt, 1952
le dittature fasciste;
Bruno, il quale molti
speciale
Q
g
A
tuttavia, almeno fino ai primissimi anni cinquanta, Italia e Germania in particolare si aprirono improvvisamente a una
stagione di scambi di esperienze che, con tutte le contraddizioni immaginabili,
avviò in breve una profonda trasformazione del sentir
re comune.
rn
be
ol d
Nell’ambito della vita musicaSchoen
le italiana il Festival di Venezia, che
per la verità non aveva mai deposto la
sua vocazione internazionale nemmeno sotto il fascismo, risorse con una programmazione di nuovo respiro, e tra le altre cose nel
1948 promosse
un’iniziativa di scarso impatto spettacolare ma
H
che si saen r
i
rebbe rivelata importantissima: l’affidamento di
un breve corso intensivo di direzione d’orchestra, presso il Conservatorio «Benedetto Marcello», a
anni dopo dirà: «Si era accorto di aver studiato male e ricominciò tutto daccapo […] ma si applicò con una tale violenza che in
pochi anni fece con me tutto il contrappunto, ed è in possesso
di una tecnica favolosa».
Il sodalizio che i due avevano formato in quei pochi anni di
studio e di amicizia, si sviluppò in brevissimo tempo in una
«scuola» nel senso di una vera e propria bottega di stampo rinascimentale, in cui prese forma un nuovo approccio, coltissimo e antiaccademico, alla composizione musicale. L’insegnamento di Scherchen andava ben oltre la tecnica di direzione, riguardava infatti l’analisi, la storia della musica e in generale un
approccio umanistico all’arte del comporre, fondato sullo studio del Cinquecento, di Bach, e insieme delle esperienze più recenti. Maderna oltrepassò di
slancio lo stile seguito fino a quel momento,
ispirato a Hindemith e Malipiero, e insieme
a Nono, che invece aveva messo giù appena qualche esercizio, sviluppò uno stile
che si poneva spontaneamente in sintonia
con le esperienze europee più avanzate,
eppure dotato di un forte, specifico accento locale, proprio veneziano. E sarà Scherchen,
nel giro di un paio di anni, a favorire il
r
eu
loro debutto sulla scena internazionale introP o u ss
ducendoli agli ormai leggendari corsi estivi della
cittadina tedesca di Darmstadt, punto d’incontro di
tutti i giovani compositori europei più impegnati.
In Maderna e Nono, fin dall’inizio di questa nuova fase, è viva soprattutto l’attenzione alla voce umana, all’intreccio contrappuntistico, alla concretezza della musica come una cosa che
speciale —
novecento / parte seconda
speciale
accade, e che nasce non da un progetto scritto sulla carta, ma
si stabilmente in Germania e intensifica, senza affatto abbandall’ascolto, dal concreto vibrare delle voci e degli strumenti in
donare la composizione, la sua attività direttoriale e le sue scouno spazio dato – come gli antichi maestri sapevano perfettaperte in ambito elettroacustico. Nono invece rimane italiano,
mente. Della loro musica, almeno per tutti gli anni cinquanta
anzi veneziano, giudecchino, e si impegna in modo radicale a
– ma anche oltre – si potrebbe dire con una battuta che è come
trasferire le sue preoccupazioni civili e il suo impegno politise Gabrieli o Monteverdi fossero tornati in vita quattrocento
co nel lavoro di composizione – una scelta che, nel pieno delanni dopo per impiegare a modo loro la tecnica dodecafonica
la guerra fredda, gli varrà l’ostracismo delle istituzioni culturadella scuola di Schoenberg. E, al di là di quanto suggerisce la
li e delle case editrici tedesche prima, non poche difficoltà in
costellazione storica e biografica in cui si trovano i due giovaItalia poi, e in definitiva un’allontanamento dalla comunità arni compositori, non
tistica dell’avanguarmancano consistendia, Maderna comti prove documenpreso. Eppure quantarie che potrebbero
do nel 1963 prende
giustificare, proprio
forma alla Biennaal livello delle tecle l’idea di una seraniche compositive,
ta di teatro in cui pol’esistenza di quella
trebbero compari«nuova scuola venere insieme (ma non
ziana» che Madersuccederà) due lavori
na si compiaceva di
di Maderna e Nono,
avere raccolto attorl’entusiasmo e il senno a sé: al punto da
so di superiorità nei
auspicare persino, in
confronti degli altri
un momento di encolleghi si riaccentusiasmo, di sostidono, e i due tornatuire questa dicitura
no a sognare «finalalla firma del singomente la famosa selo compositore. Sorata de teatro!!! Ti e
no gli anni, per Mami. E staltri i sta foLuigi_Nono (foto Asac – Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia)
derna, delle Improvvira a scoltar e meditar.
n
H
sazioni e delle Composizioni per orchestra, degli Studi per il processo
E i mona i pol pure pensar a “die
di Kafka e, per Nono delle Variazioni canoniche sulla serie dell’op.41
Kölner Schule” perché la scuodi Schoenberg, della Composizione n.1, di Polifonica-Monodia-Ritmica
la tua venessiana la xé alme(in parte ispirata a Edgar Varèse, e che introduce l’impiego di
no come quea dei Gabriei e
un ritmo folklorico brasiliano).
di Monteverdi […]». A MaQueste loro specificità incontrarono in modo naturale le riderna non rimarranno più
cerche condotte indipendentemente, e con analoghe motivache una decina d’anni di vizioni, da altri giovani musicisti destinati a divenire in breve dei
ta, spesi a muoversi febbrilpunti di riferimento di una comunità internazionale in rapimente per il mondo, a dirigeB
da crescita: come Pierre Boulez in Francia, Henri Pousseur in
re,
e a comporre nei ritagli di
a
ru
no M a dern
Belgio, Karlheinz Stockhausen in Germania. Tutti accomunatempo alcune delle più belle pati dall’ambizione di condurre a compimento la missione
gine orchestrali del Novecento. A
di una evoluzione storica, avvertita come necessaNono invece sarà concessa una stagioria, del linguaggio musicale, attraverso opere
ne più lunga, conclusa da uno straordinario decennio
che il filosofo Theodor Adorno, esegeta delin cui tutto sarà nuovamente rimesso in discussiola musica di Schoenberg e alfiere del penne, i ruoli del compositore,
siero dialettico, ammetterà di non riuscidell’interprete, delre (più) a seguire.
lo spazio acuLa strada seguita da Maderna e Nono
stico, lo stesper molti anni è la medesima: e benchè la
so concetto
personalità di ciascuno si renda perfettadi partitumente evidente all’ascolto di poche battute
ra… La sua
e
er
soltanto di ogni loro musica, sappiamo pemusica
tra il
h
c
ma
n n S c h er
rò che molto spesso alla base dei loro procedi1980 e il 1989, in
menti c’è la medesima, elaborata, tecnica di comcui voci e strumenposizione, ci sono gli stessi «segreti», appunto, di botti entrano in un dialogo
tega, come quei «quadrati magici» che servono a produrre, con
necessario con i loro «dople loro permutazioni, una specie di proliferazione controllata
pi» elettroacustici, è ancora
del materiale «grezzo» con cui mettere in atto la composiziooggi, e lo sarà in futuro, una
ne. Ma in seguito tutto cambierà: Maderna decide di trasferirvera e propria via segnata. ◼
— speciale
novecento / parte seconda
uciano Berio (1925-2003) e Italo Calvino (1923-1985).
Due protagonisti della cultura italiana del secondo Novecento: di quella cultura musicale e letteraria capace di
assumere – come il grande cinema e il grande teatro, come
le arti figurative – respiro internazionale. Non c’è dubbio
che le radici più profonde di
quella cultura e le ragioni della sua stessa forza propositiva risalgano alle straordinarie energie intellettuali e creative scatenatesi all’indomani della seconda guerra mondiale. Se si volge uno sguardo
retrospettivo, negli anni cinquanta e sessanta l’Italia della neonata repubblica e della costituzione ammirata in
tutto il mondo, l’Italia della
ricostruzione, dello sviluppo economico, delle speranLuciano Berio
ze e delle utopie, della palpi-
Francia, vivono sebbene in modi diversi i traumi dello scorcio
della guerra (Calvino partecipando alla lotta partigiana, Berio disertando dall’esercito della Rsi). Tutti e due si affermano
negli anni cinquanta, dopo che si sono trasferiti in una grande
città per studiare (Berio a Milano, in Conservatorio; Calvino
a Torino, all’Università). In questo decennio, per Berio c’è, tra
l’altro, l’avventura dello Studio di fonologia musicale della Rai;
per Calvino, oltre alla scrittura, l’impiego presso Einaudi. Tutti e due, ancora, trascorrono nel corso degli anni cinquanta e
sessanta fondamentali periodi all’estero: Berio soprattutto negli Usa, Calvino a Parigi.
Su questa falsariga si potrebbe andare avanti sino alle Lezioni americane che entrambi furono chiamati a tenere alla Harvard University
(quelle di Calvino, programmate per il 1985-1986, non
ebbero luogo per l’improvvisa scomparsa dello scrittore e
furono edite nel 1988 da Garzanti; quelle di Berio, risalenti al 1993-1994, le ha pubblicate Einaudi nel 2006). Ma al
di là delle analogie e delle corrispondenze tra i due percorsi biografici, destinati a incrociarsi più volte dalla fine degli anni cinquanta alla morte di Calvino, sono piutto-
tante passione civile non meno che dei
violenti conflitti politici e ideologici appare scenario di una stagione culturale e
artistica vivacissima e, per molti aspetti,
entusiasmante.
Oggi può sembrare sin troppo facile sostenere che Berio e Calvino erano
predestinati a incontrarsi e far interagire le loro personalità, nel caso anche attraverso la contrapposizione dialettica di
conv i nzion i
propriamente musical i ov vero
letterarie.
Eppure sin
dalle circostanze bioEdoardo Sanguineti
grafiche apparentemente
più esteriori le esperienze del musicista e dello scrittore sembrano legate da analogie e corrispondenze. Pressoché
coetanei, entrambi originari di quell’angolo di
Liguria incastrato tra
il Piemonte, il mare e la
sto le convergenze di poetica o quanto
meno le assonanze artistiche e intellettuali a dare il senso di un comune terreno d’incontro (e, all’occasione, pure di
amichevole scontro). Se si considerano
le opere dell’uno e dell’altro, anche indipendentemente da quella che fu la storia della loro collaborazione, che in fondo conobbe il momento cruciale piuttosto tardi, tra gli anni settanta e ottanta,
si scopre che Berio e Calvino avevano
molto in comune oltre agli influssi recepiti di portata generazionale (come per
esempio lo strutturalismo e la semiologia); forse più di quanto fossero disposti
ad ammettere.
Si pensi alla concezione, della musica
e della letteratura, come laboratorio di
sperimentazione e costruzione formale;
al gusto della rilettura, riscrittura e rielaborazione degli archetipi e dei miti culturali e dunque al gusto per la proiezione intertestuale; all’idea del prodotto artistico come costrutto in cui è possibile articolare e riconoscere più livelli di lettura. E si pensi, ancora, all’accento posto sulla concretezza – quasi artigianale – del lavoro creativo, del processo che trasforma
i materiali di partenza in qualcos’altro; all’inclinazione per una
giocosa leggerezza del fare artistico; all’interesse per la cultura popolare (è sufficiente ricordare al riguardo due soli titoli:
Fiabe italiane di Calvino e Folk Songs di Berio). Condivisa era pu-
Luciano Berio
e Italo Calvino
speciale
L
di Cesare Fertonani
speciale —
novecento / parte seconda
per Berio come per gli altri grandi compositori della sua generazione); in ogni caso, rifiutando recisamente la definizione di
«opera» per insistere su quella di «azione musicale», Berio voleva sottolineare il ruolo decisivo del
processo musicale nella drammaturgia e l’assenza di una narratività
intesa in senso lineare. Intessuti su
fitte trame intertestuali (ma dominano soprattutto le ombre del Trovatore e di Tristan und Isolde nella Vera storia, il soggetto della Tempesta di
Shakespeare in Un re in ascolto), entrambi i lavori manifestano, al di là
dei molteplici livelli di lettura, una
densità strutturale che poggia, ancor più che sull’integrazione, sull’intreccio e sulla sostanziale autonomia di testo e musica. Non è casuale, come indicò lo stesso Berio
in un dialogo con Umberto Eco
del 1986, che nella Vera storia (sviluppata da un’idea del compositore) il testo di Calvino si sia adattato
a un progetto musicale già definito, mentre la genesi di Un re in ascolto (scaturito da un’idea dello scrittore) sia stata assai più tormentata;
tanto che se alla fine Berio utilizzò
soltanto in parte il libretto preparaItalo Calvino
to da Calvino questi ne rielaborò a
vrapposizione o anche
di distaccata interpolazione). A quanto si dice, Calvino non aveva
particolari inclinazioni
musicali. Per lui, benché in quegli anni avesse già scritto il libretto
dell’atto unico La panchina (1956) di Sergio
Liberovici e poi, prendendo parte alle iniziative del gruppo Cantacronache anche il testo
di alcune canzoni (Dove
Umberto Eco
vola l’avvoltoio, Oltre il ponte, Canzone triste e Il padrone del mondo sempre per Liberovici, Sul verde fiume Po per Fiorenzo Carpi), l’incontro con Berio segnò l’inizio di una nuova
esperienza. D’altro canto, per il compositore che nella sua produzione assimilava con voracità pressoché onnivora suggestioni e sollecitazioni letterarie diversissime, la collaborazione
con Calvino rappresentò, accanto a quella con Edoardo Sanguineti, un riferimento fermo e tenace.
Dopo Allez-hop sarebbero venuti i due capitoli portanti della collaborazione di Berio con Calvino: le «azioni musicali» La
vera storia (1977-1978; prima rappresentazione 1982) e Un re in
ascolto (1979-1983; prima rappresentazione 1984). Due lavori
di ampio formato che inevitabilmente implicano il rapporto
con il genere dell’opera lirica (un rapporto molto problematico
sua volta l’idea originaria in un racconto omonimo pubblicato in Sotto il sole giaguaro (1986). E
proprio nella vividezza e nell’autenticità di
questo rapporto, nelle scintille di una continua tensione e media-
speciale
re l’idea di un’arte nuova e complessa che tuttavia conservasse un’immediatezza comunicativa e, in sostanza, un’accessibilità di linguaggio, una godibilità verrebbe da dire che poi spiega, non da ultima, l’ampia diffusione internazionale delle loro opere e
ha reso ben presto Calvino e Berio,
per usare una formula, due «classici contemporanei»: due artisti celebri per la tensione sperimentale così come per la comprensibilità delle loro opere da parte di un vasto
pubblico. Del resto non è un caso
se alla maestria verbale e combinatoria di Calvino corrisponde quella
di Berio nel trattamento, nella proliferazione e nella trasformazione
dei materiali musicali.
La collaborazione tra i due artisti
avvenne nell’ambito del teatro musicale. Il primo incontro risale al lavoro intorno al «racconto mimico»
Allez-hop (1952-1959; prima rappresentazione 1959), così intitolato dal
grido con cui un domatore di pulci
dà inizio allo show dei suoi insetti e
dove tra la musica e l’azione scenica s’instaura un rapporto di molteplice funzionalità (che può essere,
di volta in volta, di trasfigurazione,
rappresentazione, commento, so-
zione dialettica è probabilmente da cogliere il significato più profondo della collaborazione tra Berio e Calvino: uniti nella convinzione che musica e linguaggio verbale siano forme espressive ed esperienze irriducibili l’una all’altra e, perciò, irrimediabilmente divisi. ◼
— speciale
novecento / parte seconda
«Attraverso»
Mallarmé
cerca di Pierre Boulez, con una continuità che non
si limita al «ritratto» di Pli selon pli. Boulez ha sottolineato il modo casuale in cui questo ciclo ha preso forma; ma
questa imprevedibile casualità si rivela necessaria all’interno
di un rapporto ininterrotto:
Pierre Boulez
appartiene peraltro alla poetica del compositore francese il
rifiuto dei progetti rigorosamente predeterminati, il seguire percorsi che si
vengono via via
delineando. Dal
sogno, vagheggiato intorno
al 1950, di una
composizione
legata al Coup de
sti di Poésie pour pouvoir (1958). Pli selon pli, il ciclo composto tra il
1957 e il 1962, rende omaggio a Mallarmé rivendicando implicitamente la «contemporaneità» della sua ricerca. Boulez (nelle
conversazioni del 1972 e 1974 con Célestin Deliège, Per volontà
e per caso, nel capitolo sulle «Nuove convergenze con la poesia»)
ebbe a dire: «Al punto a cui ero allora mi sedusse in Mallarmé
la straordinaria densità formale dei suoi poemi. Non soltanto il
contenuto è davvero straordinario – hanno una mitologia particolarissima –, ma mai la lingua francese è stata portata così
lontano dal punto di vista della sintassi [...]. Mallarmé ha cercato di riesaminare i dati fondamentali della grammatica francese. Nelle sue poesie lo ha mostrato in modo straordinariamente denso. Anche
le sue prose, che
sono meno condensate, anche le
sue conferenze,
rivelano la traccia di questa ossessione di rifare
una lingua francese con una sintassi lievemente diversa. È ciò
che mi ha più
influenzato in
Mallarmé. […]
Mi sono interessato all’idea di
trovare un equi-
dés, alla Terza Sonata, al secondo libro delle Structures per due
pianoforti a Éclat-multiples ad altri lavori strumentali la riflessione sul rigore di Mallarmé («si è di fronte a un blocco minerale», ha detto Boulez ad Albéra, in una intervista del 2003) e
l’idea di trascriverne l’esperienza e la tensione al limite in altra materia artistica (non una corrispondenza testuale, ma una
transustanziazione) accompagnano i percorsi di Boulez. Proponendo qualche pagina della ancora inedita corrispondenza
tra Boulez e Stockhausen, Albéra cita un passo che rivela ragioni di natura non puramente estetica per l’incontro di Boulez con Mallarmé, con la sua esperienza del Nulla, con la concezione rituale della poesia. Nell’ottobre 1954, discutendo con
Stockhausen sul progetto che questi aveva di scrivere una messa o della musica sacra (il Gesang der Jünglinge è del 1955-1956),
Boulez lo invita amichevolmente a desistere, dichiara di non
credere, parla di vertigine del nulla e della sconfinata ammirazione che nutre per Un coup de dés.
Non sorprende dunque che Pli selon pli, cui qui ci limiteremo,
abbia un ruolo centrale nel catalogo di Boulez. Anche prima
Boulez aveva riflettuto in diverse occasioni sui rapporti musica-testo, proponendone una concezione che andasse oltre il
semplice «mettere in musica» una poesia, e che non si
facesse condizionare dalla immediata comprensibilità della parola intonata, per instaurare un insieme complesso di relazioni di natura strutturale. I primi capolavori vocali di Pierre Boulez,
dal Visage nuptial al Marteau sans maître, sono legati ai versi di René Char, dunque
ad un contemporaneo, come
Henri Michaux, autore dei te-
valente musicale, poetico e formale alla sua poesia. Ecco perché ho scelto, da Mallarmé, delle forme molto rigorose, per innestarvi un processo di proliferazione musicale a partire da
una forma pure rigorosa; ciò mi ha permesso di riprodurre in
musica delle forme cui non avevo mai pensato, tratte dalle forme letterarie che egli stesso ha impiegato».
Anche nel breve testo su Pli selon pli che scrisse nel 1969 per la
prima registrazione del ciclo, Boulez sottolinea in Mallarmé la
«fusione del senso e del suono, in una estrema concentrazione
del linguaggio». E osserva: «L’esoterismo che molto spesso si
è voluto attribuire a Mallarmé, altro non è che la perfetta aderenza del linguaggio al pensiero che non ammette nessuna dispersione di energia».
Un assoluto riserbo Boulez ha mantenuto sul significato che
hanno ai suoi occhi i testi scelti per le tre Improvisations e il ciclo
nel suo insieme. Le difficoltà di interpretazione dei testi non
impediscono di cogliere il significato generale della convergenza del poeta e del musicista nel riflettere e nell’interrogarsi sulla creazione artistica, sui temi della sterilità, della morte,
dell’assenza. Nelle citate conversazioni con Deliège, parlando
dei diversi livelli di convergenza tra testo e musica (da quello
più semplice e diretto, «plus émotionnel», alle corrispondenze strutturali più o meno complesse), Boulez ebbe ad osservare, a proposito della «convergenza poetica che ho cercato di
raggiungere con certe equivalenze di sonorità»: «Così, quando Mallarmé parla di vetro, di merletto, d’assenza, ecc., c’è proprio una data sonorità musicale legata direttamente a tali idee:
per esempio, certi suoni molto lunghi, molto tesi che fanno
parte di questa specie d’universo non immobile, ma straordinariamente “vetrificato”. È questo piano emozionale, questo
D
di Paolo Petazzi
speciale
AL 1946 LA riflessione su Mallarmé accompagna la ri-
speciale —
novecento / parte seconda
to accordo in fortissimo, che si estingue lentamente (un gesto
che sembra evocare lo slancio dell’atto iniziale della creazione):
subito dopo il soprano intona «a mezza voce» il primo verso
di Don du poème, in una enunciazione chiara e diretta, che funge da iscrizione programmatica: «Je t’apporte l’enfant d’une
nuit d’Idumée!»
In Don, nel suo carattere introduttivo, nel procedere a
frammenti, aperto e sospeso,
Boulez sembra quasi evocare
la nascita dei materiali musicali
del ciclo, ci fa assistere alla nascita di una musica in una condizione di sterilità e di riflessione, a partire dalla pagina bianca, dalla «nuit d’Idumée». Nella terza sezione, la voce intona
molto liberamente, in un clima
sospeso, parole della III, della
II e della I Improvisation, preannuncio di ciò che seguirà. Nota Boulez: «Le citazioni musicali sono motivate dal titolo di
Mallarmé: don du poème che qui
diventa don de l’oeuvre. Non sono letterali, ma astratte dal loro contesto, e sono intraviste al
tratto di Mallarmé».
Nucleo iniziale del ciclo furono le prime due Improvisations
sur Mallarmé. La prima fu composta nel 1957 per soprano, arpa, vibrafono, campane e strumenti a percussione di altezza indeterminata (4 esecutori), e fu presentata in prima esecuzione
insieme con la seconda, anch’essa del 1957, il 13 gennaio 1958
ad Amburgo con Ilse Hollweg sotto la direzione di Hans Rosbaud. L’organico strumentale della seconda Improvisation è affine a quello della prima con l’aggiunta di pianoforte e celesta,
e i due pezzi possono essere eseguiti insieme o isolatamente.
Nel 1959 si aggiunse la terza Improvisation, che fu presentata il 10
giugno 1959 a Baden-Baden da Rosbaud con Eva-Maria Rogner e l’orchestra del Südwestfunk. Sempre nel 1959 fu iniziato
il pezzo conclusivo, Tombeau, eseguito in forma parziale il 17 ottobre 1959 a Donaueschingen e in forma completa soltanto tre
anni dopo, all’interno dell’intero ciclo. Del 1960 è una versione
provvisoria del pezzo d’apertura, Don, anch’esso portato a termine nel 1962. Infine della prima Improvisation Boulez scrisse
nel 1962 una seconda versione, con organico più ampio, da eseguire solo all’interno del ciclo completo, che fu diretto da Hans
Rosbaud a Donaueschingen con Eva-Maria Rogner e l’Orchestra del Südwestfunk il 20 ottobre 1962. La terza Improvisation
fu sottoposta a revisione e presentata in una nuova versione nel
1984: la partitura definitiva è uscita soltanto nel 1990, e differisce sensibilmente dalle versioni registrate in disco da Boulez
nel 1969 e nel 1981. Anche Don è stato riscritto, riveduto e ampliato nel 1989, senza mutarne la sostanza musicale.
Due pezzi per orchestra con brevissimi interventi della voce racchiudono le tre Improvisations che si dispongono in ordine
di durata e di complessità crescente. Don inizia con un violen-
futuro». È l’unico pezzo di Pli selon pli che non può essere eseguito isolato dal resto.
Dopo le tre Improvisations l’orchestra ritorna unica protagonista nella maggior parte del quinto pezzo, Tombeau, che si configura come una grande progressione, con un drammatico crescendo fino alla pagina conclusiva: qui in una atmosfera sonora trasparente e sospesa, la voce (in contrappunto con il corno) intona l’ultimo verso del Tombeau che Mallarmé scrisse nel
1897, nel primo anniversario della morte di Verlaine: «un peu
profond ruisseau calomnié, la mort»1. Ai tesi arabeschi sulle
prime parole del verso segue, nella penultima battuta, la parola chiave, mort, che deve essere «parlé sans timbre, uniquement
sur le souffle». Un violento accordo in fortissimo conclude la
partitura e l’intero ciclo, che sullo stesso accordo era iniziato.
Le tre Improvisations formano il nucleo centrale di Pli selon
speciale
Stéphane Mallarmé visto da Paul Gauguin
piano diretto, che mi ha fatto scegliere dei poemi piuttosto che
altri. Non è solo perché scriveva sonetti che ho scelto Mallarmé, ma perché la sua poesia aveva per me un significato ben
preciso».
Il riferimento implicito è alla seconda Improvisation, Une
dentelle s’abolit; ma ora è opportuno ricordare i dati essenziali
sulla genesi e sulla articolazione complessiva del ciclo.
Il titolo, Pli selon pli (Piega dopo piega) proviene dalla conclusione della prima quartina
di un sonetto del 1890, Remémoration d’amis belges: «...je sens
/ Que se dévêt pli selon pli la
pierre veuve» (sento / svestirsi
piega dopo piega la pietra vedova). Commenta Boulez alla fine del suo testo su Pli selon pli:
«Il titolo... indica il senso, la direzione dell’opera. Nella poesia l’autore descrive così il modo con cui la nebbia, dissolvendosi, lascia progressivamente
scorgere le pietre della città di
Bruges. Analogamente affiora,
via via che si svolgono i cinque
brani, piega dopo piega, un ri-
1 Il ruscello che il poeta morendo ha attraversato non è profondo, e la morte è «calunniata», perché la gloria poetica di Verlaine è immortale.
2 La tradizione esegetica vede in questo sonetto immagini di impotenza e sterilità, intendendo il cigno-poeta bloccato dalla superficie gelata del «lac dur». Nel 1969 Stefano Agosti
(nel saggio Il cigno di Mallarmé) ha mostrato le incongruenze della lettura tradizionale, e partendo dalla interpretazione di «lac dur» come tomba in cui è imprigionato un poeta defunto («un cygne d’autrefois») attraverso una analisi di cui non posso riassumere la ricchezza intende il sonetto in modo assai diverso: «Il fenomeno della morte, il quale esclude ogni forma di sopravvivenza sia fisica sia spirituale, esclude, nel caso di Mallarmé, anche la sopravvivenza nell’arte
giacché la poesia mallarméana non è celebrazione della vita del poeta,
ma solo il segno di una nozione non comunicata, ossia, in ultima analisi, soltanto il segno di sé. Parafrasando ancora: verificatosi il fenomeno della morte,non sidà nessuna speranza disopravvivenza se questa non è stata – come non è stata – riposta nell’arte.Il poeta è chiuso, ad un tempo,
nella tomba e nel proprio libro, entrambi catafratti» (pp. 56/57).
— speciale
novecento / parte seconda
speciale
pli. Si è già detto che punto di partenza del ciclo fu la prima Imsuona assai diversa rispetto alla tradizione impressionista) è
provisation sur Mallarmé, che ha come testo il celebre sonetto del
prevalentemente (anche se non esclusivamente) dedicata una
cigno, pubblicato nel 18852. Soltanto una decina di anni fa
conferenza di Boulez del 1961 ((Construire une improvisation,
Boulez ha raccontato le circostanze occasionali, che
pubblicata in Points de repère
repère).
hanno determinato la genesi del pezzo: per salAnche nella seconda Improvisation sur Mallarvare una musica composta per la radio su
mé si alternano sezioni vocali e strumentaun testo tradizionale cinese tradotto in
li in costante divenire, seguendo la strutmodo insoddisfacente, aveva adattatura del sonetto; ma il pezzo è più lunto la parte vocale a Le vierge, le vivace
go e più complesso. Nella parte voet le bel aujourd’hui.. La genesi in realcale si presentano due tipi di scrittà è ancora più complessa, perché
tura: una scrittura fortemente orin quella musica convergeva una
namentale, melismatica, che difmusica di scena per l’Orestiade,
Orestiade,
ficilmente consente la percezioscritta quando collaborava con
ne della parola, cristallizzata in
la compagnia di Barrault e poi
mirabili arabeschi (si veda, dotrasformata in un pezzo per
po la breve introduzione struflauto che rimase inedito.
mentale, la prima quartina del
Il rapporto della musica di
sonetto, in tempo «lento, flesBoulez con la struttura del sosibile»); e un’altra assolutanetto del cigno appare leggibimente sillabica, che il soprano
le con immediatezza: il testo è
deve cantare «senza tempo», il
intonato sillabicamente o con
più lentamente possibile ma inmelismi piuttosto brevi (nelle
tonando ogni frase in un solo restrofe centrali), sottolineando la
spiro (seconda quartina, tranne
divisione del sonetto in quartine e
l’ultimo verso). C’è un rapporto diterzine (il bianco che le separa nelretto con le immagini poetiche, cola pagina corrisponde a interludi strume primo spunto per una più commentali), rivelando una sensibilissima atplessa «trascrizione»: nella prima strofa
tenzione al ritmo dei versi grazie alla sottile
gli arabeschi vocali sono suggeriti dal «denPierre Boulez
flessibilità ritmica e alle cesure nella parte vocatelle», nella seconda si evoca la fissità del vetro1.
le, proponendo in modo allusivo corrispondenze musicali alle rime. Le sezioni vocali presentano fra loro una evidente continuità, e così pure le sezioni strumentali che ad esse regolarmente si alternano. Il primo e il secondo interludio riprendono
musica tratta da una geniale opera giovanile di Boulez stampata solo nel 1980, rispettivamente dal quinto e dal nono pezzo
delle Notations (1945) per pianoforte solo (oggetto da molti anni di ripensamento come punto di partenza per la serie, ancora
incompiuta, delle Notations per orchestra).
Nelle prime due Improvisations colpiscono anche ad un primo
ascolto le suggestioni timbriche, le sonorità gelide, trasparenti o magiche e arcane che l’invenzione di Boulez crea intorno
ai versi di Mallarmé. In rapporto all’insistenza delle immagini
poetiche di Mallarmé sul gelo, sul bianco, sulla trasparenza e
l’assenza, le corrispondenti scelte strumentali di Boulez rivelano una sua predilezione (riconoscibile anche in altre opere) per
strumenti che non possono prolungare la durata dei suoni prodotti, ma al massimo lasciarli risuonare fino all’estinzione: se
ricordiamo la sua dichiarazione a Deliège sul significato personale che aveva per lui la scelta di certi testi poetici, in nome di
una convergenza diretta, possiamo forse immaginare che un
sonetto come Une dentelle s’abolit lo attirasse anche per la
possibilità di usare la sonorità chiara di strumenti
capaci di evocare una risonanza vitrea. Alle nuove sonorità create attraverso le combinazioni del
peculiare organico strumentale (simile a quello
della versione cameristica della prima Improvisation)) e all’originalità del trattamention
to di determinati strumenti (ad
esempio l’arpa, che in Boulez
Nella seconda quartina ogni verso è isolato, è separato dal seguente da un intenso episodio strumentale: come se, una volta intonato il verso (dove ogni sillaba è percepibile) si avesse
un respiro, una transizione strumentale dove la suggestione di
quel verso si prolungasse nel silenzio della voce, in pagine dove
indugi contemplativi si alternano a pulsazioni incalzanti. Nelle terzine i due tipi di scrittura vocale si mescolano e compenetrano: Boulez si attiene alla disposizione delle rime, passando dallo stile arabescato a quello sillabico. La forma della poesia gli ha suggerito di usare i due stili in modo intrecciato nelle
terzine. Non senza varianti: lo stile melismatico può essere accompagnato da contrappunti o da una serie di accordi, quello
sillabico può fissarsi su un monolito ritmico o essere associato
a echi o divagazioni, perché le due nozioni vanno intese come
orientamento di scrittura più che come costrizione. Di per sé
la durata della seconda Improvisation (poco più del doppio della
prima) fa intuire la maggior complessità che comporta una più
profonda integrazione e fusione della poesia nella musica.
Una complessità ancora maggiore presenta la terza Improvisation. La disposizione delle tre Improvisations sur Mallarmé in realizzazioni musicali sempre più complesse corrisponde anche,
secondo Boulez, ad una difficoltà crescente nella interpretazione del testo poetico. Per inciso va osservato che nella partitura stampata il primo verso è scritto in modo da eliminare
l’ambiguità della grafia di Mallarmé, À la nue accablante tu, con
la prima parola accentata, esplicitamente intesa come preposizione e non come verbo, interpretazione su cui oggi c’è una so1 Scostandosi dal vetro il merletto della tendina di una finestra lascia scorgere una stanza
vuota, una «assenza di letto». Nelle terzine si sogna una nascita impossibile dal «cavo musico nulla» del ventre di una mandola.
novecento / parte seconda
speciale —
me di grandi blocchi, la voce dilata l’intonazione dei singoli
versi, o canta a bocca chiusa, o comunque in modo che diviene
impossibile la comprensione delle parole (che divengono così «assenti», pur costituendo il «centro» da cui si irradia in tutti gli aspetti la concezione del pezzo). Il testo sembra «naufragare» nel contesto strumentale. Boulez ha
t rasformato
tutte le pagine
che nelle versioni precedenti prevedevano un certo grado di indeterminazione «aperta», e
da queste nella stesura definitiva sono nati episodi brevi che si alternano ai grandi blocchi formali quasi come parentesi, in percorsi imprevediStéphane Mallarmé visto da Édouard Manet
bili, in un gioco di forme
sono stati eliminati gli aspetti «aperti» della scrittura, fra i quali l’interprete poteva operare delle scelte, ed è stato recuperato
per intero il testo poetico, che nella prima versione era limitato
a tre versi. Nelle prime versioni il pezzo cominciava con un vocalizzo senza testo, che nella stesura definitiva è stato sostituito dalla intonazione completa del sonetto. Essa ha però il carattere e il significato di una presentazione, come se il testo venisse letto per intero prima di proporne una ampia e parziale
elaborazione musicale. Si tratta di una specie di lettura in musica, proposta in modo assai lavorato e ornato, con significativi interventi strumentali, e con intensa suggestione; ma senza
tradire il fondamentale carattere di una lettura che fa conoscere il testo prima che ne venga iniziata l’elaborazione musicale. Dopo tale lettura il testo si limita ai primi quattro versi, perché, dichiara Boulez, se ogni verso fosse elaborato come questi, la terza Improvisation sur Mallarmé assumerebbe una lunghezza sproporzionata rispetto alle pagine precedenti e all’intero ciclo. L’idea centrale è di far corrispondere ogni verso a un tipo
formale di invenzione in un gioco di forme che si intrecciano
e si compenetrano.
La iniziale «lettura» pone in luce l’ardua costruzione sintattica del sonetto: le due quartine sono cantate senza interruzione,
e si inserisce soltanto un breve interludio prima delle terzine,
anch’esse cantate senza cesure in uno stile intensamente ornamentale. Poi Boulez si confronta con il testo verso per verso,
in modo che ad ognuno dei primi quattro, corrispondano idee,
forme, invenzioni specifiche. All’interno di ampie sezioni, co-
intrecciate.
Questa sommaria descrizione del ciclo non basta a far comprendere la varietà di materiali, caratteri e percorsi a cui si apre
nel prender forma senza alcun piano prestabilito. La sua compattezza e coerenza stilistica convive con molteplici aperture,
accoglie materiali da precedenti opere di Boulez, ma soprattutto rivela, in diversi aspetti della concezione del suono e nel
rilievo che in alcune pagine assume l’eterofonia, un significativo (e dichiarato) rapporto con tradizioni musicali extraeuropee, senza esotismi, senza rinunciare a logiche strutturali di altro carattere. Non è un dato nuovo nel pensiero di Boulez; ma
contribuisce in misura notevole agli aspetti visionari della concezione del suono. Confrontandosi con un’esperienza al limite
come quella di Mallarmé, Boulez (come ebbe a dire ad Albéra)
pone in atto l’esigenza non di andare oltre, ma di «passare attraverso»: «Bisogna considerare le grandi opere come schermi
che si devono attraversare, al modo in cui, nel teatro giapponese, si fanno passare i morti attraverso schermi di carta…» ◼
speciale
stanziale convergenza.
Nella terza Improvisation l’organico strumentale, sensibilmente più ampio che nelle precedenti, comprende 4 flauti, 5 violoncelli, trombone tenore, 3 contrabbassi, 3 arpe, mandolino, chitarra, celesta e sette esecutori di percussione2. La riflessione di
Boulez sul sonetto del naufragio lo porta a costruire
una forma che
stabilisce con
la poesia un legame complesso, assai stretto, ma al tempo
stesso in grado
di allontanarsi
dal testo in una
cost r u z ione
notevolmente
ampliata. Non
per caso la genesi del pezzo è
stata molto tormentata, dalla
prima versione
del 1959 a quella definitiva del
1984. Nella versione definitiva
2 L’organico sembra riflettere la contrapposizione tra alto e basso, tra superficie celeste e
marina, che è determinante nel testo.
— speciale
novecento / parte seconda
Sintesi interculturale
e tempo teatralizzato
no abilmente immaginazione musicale, interculturalità, interessi scientifici e suggestioni estetiche tra le
più varie, che donano vita a universi sonori intrecciati saldamente alla tradizione, ma a un tempo proiettati verso un orizzonte futuro che si tinge di tratti utopici e visionari.
Gli Études pour piano, premier livre, opera cruciale della produzione ligetiana, pubblicata nel 1985, incarna emblematicamente lo stile stratificato del Maestro ungherese, giunto in quegli
anni alla piena maturità creativa.
Dopo il primo periodo di formazione nella terra di origine
– ove, pur in un’atmosfera culturalmente e politicamente repressiva, opera ancora con estrema vitalità la feconda lezione
di Bartók e Kodaly – e la scoperta rivelatoria, negli anni cinquanta, delle più recenti intuizioni di Cage, Boulez e Stockhausen – a propria volta suggestionati dalla pubblicazione del Livre di Mallarmé, avvenuta nel 1957, la cui eco si trasmette ben
oltre l’ambito letterario – Ligeti inizia a maturare, tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta, un proprio percor-
tura e innovazione della tecnica pianistica, uno dei capolavori
della letteratura musicale del secondo Novecento.
Il ciclo si compone di sei brani, parti di un organismo unitario, frutto della prodigiosa capacità di sintesi ligetiana che riesce ad amalgamare in uno stile personale i modelli estetici ereditati dalla tradizione musicale colta (in particolare Chopin,
ma anche Liszt, Schumann, Brahms, Debussy, Ravel, Bartók),
gli spunti tratti dal folclore ungherese, rumeno, balcanico, portoricano e africano, la conoscenza delle opere per pianoforte
meccanico realizzate da Conlon Nancarrow, il linguaggio jazzistico e le suggestioni maturate a contatto con le teorie scientifiche di quegli anni.
Se la raccolta di Studi per Player Piano di Nancarrow rappresenta una sfida avvincente per realizzare, nei limiti imposti a
un interprete umano, le sovrapposizioni e progressive gradazioni di velocità raggiunte dal compositore americano con i
pianoforti meccanici grazie all’utilizzo di una particolare perforatrice, saranno soprattutto le teorie esposte da Simha Arom
nei saggi etnomusicologici dedicati alle poliritmie sub-sahariane a rendere possibile, grazie all’uso sistematico e diffuso dell’hemiolia, la sovrapposizione di periodi musicali complessi, la
cui unità di fondo viene garantita dalla continuità di una pulsazione isocrona.
A tali desuete fonti di ispirazione, Ligeti unisce l’attrazione
esercitata da alcune fondamentali intuizioni matematiche e fisiche di quegli anni: il pensiero generativo del computer (da
cui sorge l’idea di dare vita a forme musicali «vegetali»), la teoria del caos (che propone un’ermeneutica dei fenomeni caotici fondata sulla progressiva alternanza di ordine e disordine) e
il fascino evocato dalla geometria frattale, sorta di arte astratta
so espressivo in cui la liquidazione della serialità integrale – così affine nei propri esiti estremi alle realizzazioni aleatorie – si
associa alla ricerca di nuove architetture compositive che ripensano alla radice i parametri del tempo e dello spazio sonoro. Lo sperimentalismo prosegue con la gestuale drammaticità di Aventures (1962) e Nouvelles Aventures (1965), alle quali si affiancano le disperate meditazioni del Requiem (1963-65)
e di Lux Aeterna (1966) e l’illusionismo sonoro di Ramifications
(1968-69), Continuum (1968) e Kammerkonzert ( 1969-1970), ove
l’infrazione improvvisa e inaspettata nei confronti di un ordine ritmico precostituito si rivela motore generatore della forma. Con i lavori dei primi anni settanta si approfondiscono
la ricerca micropolifonica e l’interesse per le componenti melodiche e ritmiche, elementi caratterizzanti l’indagine ligetiana, giunta a un nodo decisivo durante il periodo di riflessione
compreso tra il 1978 e il 1982.
Il ritorno critico alla tradizione, da intendersi in senso blochiano, si intreccia ora a una prospettiva
metacognitiva e a una curiosità sempre più versatile che riesce a connettere tra loro riflessioni estetiche e scientifiche. Ne scaturiscono le
Drei Phantasien su testi di Hölderlin e il celebre
Trio per violino,corno e pianoforte, dedicato alla memoria brahmsiana
(opere entrambe del 1982);
tre anni più tardi viene pubblicata la prima raccolta degli Études per pianoforte,
considerati unanimemente, per originalità di scrit-
capace di restituire visivamente la sensazione di un tempo incantato, quasi congelato.
Nonostante Ligeti dichiari di avere voluto realizzare, con la
prima collana di Studi, brani di carattere eminentemente virtuosistico, estranei a ogni categoria stilistica predeterminata,
è possibile comunque delineare alcuni dei principi estetici e
compositivi che caratterizzano l’intera raccolta.
Emerge innanzitutto una concezione creaturale del suono,
inteso come realtà vibratoria significante che fa appello a un
tempo alla seduzione dei sensi, alle facoltà cognitive e a quelle
mnestiche. L’attenzione rivolta alla globalità dell’aspetto percettivo rivela una sottile affinità con la concezione schilleriana dell’impulso del gioco, capace di armonizzare tra loro, grazie alla bellezza, le facoltà sensibili e intellettuali. Effetto ottenuto dall’autore attraverso l’elaborazione di un oggetto sonoro
complesso, sorto dalla impurità generata dalla sintesi di parametri tra loro eterogenei (timbro, altezza, ritmo), connessi organicamente in una struttura di tipo reticolare.
Il suono appare allora come forma in movimento, soggetta a
un processo di trasformazione continua, sospeso in trame spaziotemporali di tipo multiplo, senza centro né gerarchie, simili a sistemi infiniti e aperti. Il ramificarsi di forme in espansione
verso architetture sempre più complesse può essere assimilato a un processo di cristallizzazione, durante il quale lo sfumare di una sezione nell’altra appare sempre estremamente morbido, in ossequio al principio di massima gradualità descritto
dalla teoria del caos. L’illusionismo sonoro generato dalla variazione continua delle cellule musicali germinali riverbera come un’eco delle zone più subliminali della coscienza, traccia
preziosa di un tempo interiore divelto dal tempo cronologico
Gli «Études pour piano,
premier livre» di György Ligeti
N
di Letizia Michielon
speciale
EL LINGUAGGIO POLIEDRICO di György Ligeti si fondo-
novecento / parte seconda
speciale —
su cui si regge la Bildung del materiale tematico.
Il tempo che si autodistrugge, confondendosi con il silenzio,
si trasforma, in Fanfares, in un tempo che diventa spazio denso
di compresenze. L’intuizione goethiana dell’istante capace di
concentrare in sé la totalità dell’Essere si concretizza in questo
contesto attraverso un gioco di specchi che moltiplica le identità tematiche. Giocando sulla rotazione dell’ostinato costruito
sulla successione ritmica di 3+2+3 crome, la sequenza tematica affidata alle due fanfare appare teatralizzata in una polispazialità che irrora il suono di luce e leggerezza, avviando alle rarefazioni meditative di Arc-en-ciel (Arcobaleno), apice contemplativo dell’intera raccolta.
Le soluzioni ritmiche e armoniche ispirate al jazz generano
infatti in questo brano un tessuto sonoro ove gli accordi appaiono simili a raggi di luce trascolorante che si rifrangono in
cristalli purissimi. Si rimane incantati da questa atmosfera assolutamente libera da ogni rete concettuale preordinata, sospesa in una beatitudine immateriale, fuori del tempo e dallo spazio.
Al fascio di luce iridescente che sfiora lievemente il tempo cristalizzato di Arc-en-ciel , segue il lamento di Automne à Varsovie,
ultimo tassello del polittico ligetiano, emergente dallo sfondo
di una pioggia incessante, simbolo di un pianto infinito, in cui
si consumano volti, identità, desideri. La progressiva saturazione delle velocità sorge da una cascata di ramificazioni ritmiche
incastonate l’una sull’altra, rese possibili dall’uso generalizzato
del principio dell’ hemiolia. L’implosione dello spazio acustico
approda inesorabilmente al crollo finale: il ciclo che si era aperto con le spirali ascensionali di Désordre si conclude con il cedimento a una forza dal potere oscuro che magnetizza l’energia
di diversi livelli di velocità.
In Cordes à vide la ricerca sul fenomeno della turbolenza si concentra nell’esplorazione delle più intime profondità dell’inconscio, in un’indagine quasi bergsoniana del flusso di coscienza
e della memoria. La complessità ritmica dona ora voce alle misteriose sovrapposizioni del tempo interiore, nutrito di desideri, sogni, ricordi, ansietà, silenzi, attese. Presente passato e
futuro convivono e si intersecano all’interno di un amalgama
psichico equoreo, cangiante, connesso grazie ai tenui fili tracciati dai percorsi mnestici.
La dimensione dell’ascolto, dilatato fino a sfiorare le soglie di
udibilità più sottili, si approfondisce ancor più nel terzo studio
(Touches bloquées), costruito sul geniale intarsio di suoni e silenzi, ottenuti percuotendo alternativamente con una mano alcuni dei tasti tenuti abbassati dall’altra. Ne scaturiscono grappoli di cellule ritmico-melodiche che germinano espandendo il
materiale tematico grazie all’utilizzo di note di volta e di voci in
contrappunto libero. La quinta sezione (battute 72-91), l’unica a non presentare tasti bloccati, rivela, con le sue vertiginose
pause, il senso recondito del brano e insieme dell’intero ciclo: il
processo trasformativo del materiale tematico evoca per analogia le metamorfosi dei processi vitali che, privi di una precisa destinazione teleologica, precipitano tragicamente nell’abisso del nulla e del vuoto. Il silenzio rappresenta così l’esito del
processo autosoppressivo del suono e contemporaneamente
l’ombra preziosa che consente l’accrescersi dell’intero organismo compositivo. Le note mute suonate fin dalle prime misure evocano infatti spettri annichilenti che se da un lato consumano il suono, dall’altro ne rendono possibile l’evoluzione, incarnando il principio negativo necessario alla dialettica polare
del suono e la ingoia vorticosamente nel buio del nulla.
L’ultima maschera indossata dal tempo, sintesi estrema di
un pensiero compositivo che sorge sullo sfondo di un orizzonte umano e culturale sconfinato, conduce dunque paradossalmente al collasso nell’indifferenza e alla tragica autonegazione dell’identità sonora: riflesso drammatico, forse, di una civiltà contemporanea che non sempre sa rispettare le diversità e che ha scoperto nella distruzione uno
dei principi polari su cui si regge lo sviluppo della vita. ◼
speciale
e immerso in una mescolanza fluida ove si fondono Erlebnis e
proiezioni immaginative fantastiche.
In questa sorta di mondo virtuale, dove nulla si crea e nulla si distrugge, in un continuo trasparire di presenze-assenze
che emergono e si riassorbono nel silenzio, il tempo sembra ingoiato, staticizzato in un divenire immobile popolato da figure dalla latente drammaturgia. La teatralizzazione del tempo,
con le sue diverse maschere, si rivela così il tema nascosto dell’intera raccolta, dinamizzata dal conflitto innescato grazie alla polarità ordine-caos.
Tutti i sei studi, infatti, iniziano con formule musicali molto
elementari che progressivamente si complicano approdando a
una dimensione caotica.
L’apparente kosmos con cui si apre il primo studio (Désordre),
si allontana sempre più dall’ordine attraverso il sapiente utilizzo del décalage (ovvero lo slittamento prodotto dalla sottrazione o aggiunta progressiva delle pulsazioni che sorreggono il
continuum ritmico di crome), la biforcazione dei registri attuata tra le due sequenze melodiche affidate alla mano destra (sui
tasti bianchi) e alla mano sinistra (sui tasti neri) e il crescendo
irresistibile che sfocia nel finale. Il disordine, inteso come deviazione imprevedibile all’interno di un percorso infinitamente ripetitivo, è vissuto come una necessaria discontinuità che
genera nuova energia e nuove possibilità di vita, proiettate verso un universo immaginario ove convivono armoniosamente Essere e Divenire. Ne scaturisce un effetto acustico spiraliforme che coniuga in sé la dimensione spaziale – frutto dell’interazione tra un divenire di tipo «orizzontale», la circolarità innescata dall’eterno ritorno dell’uguale e la spinta ascensionale
– e la dimensione temporale, articolata in una sovrapposizione
Bibliografia di riferimento
György Ligeti, Études pour piano, premier livre, in AA.VV., Il pianoforte in ventidue
saggi, Longanesi, Milano 1994.
György Ligeti, Form in der neuen Musik, «Darmstädte Beiträge», n.10, Mainz,
1966, Schott.
György Ligeti, Träumen Sie in Farbe? Györg y Ligeti in Gespräch
mit Ekhard Roelcke,, Paul Zsolnay Verlag, Wien 2003, trad.
it. Lei sogna a colori? Györg y Ligeti a colloquio con Ekhard Roelcke , a cura di A. Peroni, Alet Edizioni, Padova 2004.
Alessandra Morresi, Györg y Ligeti: «Études pour piano,
premier livre». Le fonti e i procedimenti compositivi
compositivi, EDT,
Torino 2002.
AA.VV., Ligeti, a cura di Enzo Restagno, EDT, Torino 1985.
Ivanka Stoianova, Entre détermination et aventure. Essais sur la musique de la deuxèmie moitié du XXéme
siècle, L’Harmattan, Paris 2004.
— speciale
Hans Werner
Henze
novecento / parte seconda
poli, Roma, Castel Gandolfo, Marino. Non lontano dal quale, sulle rive del Lago di Nemi, si svolge, nella finzione scenica,
l’atto II della più recente sua fatica teatrale, la Konzertoper Phaedra,
tenuta a battesimo a Berlino nel 2007 e già riproposta, tra l’altro, a Bruxelles, Francoforte, Vienna, Firenze (un’altra peculiadi Jacopo Pellegrini
rità di Henze consiste nella larga fortuna delle sue «creature»).
RA I PADRI NOBILI della musica europea del NovecenMentre la prima parte ripercorre le tappe ben note del mito trato, Hans Werner Henze (Gütersloh, 1926), quantunsposto in tragedia da Sofocle, Euripide, Seneca, Racine, d’Anque tuttora vispo venunzio, vale a dire l’amore ingeto e in piena attività – e che
cestuoso e mortifero per il figli dei ce lo conservino a lungliastro Ippolito (dedito esclugo col suo humor insinuante,
sivamente al culto di Artemila testa pronta vivace bizzarde e alla caccia) concepito da
ra, l’amore per la vita in tutFedra su istigazione di Afrote le sue sfumature –, vanta il
dite, una variante latina delprimato della fecondità. La
la vicenda, tramandataci da
sua vena teatrale, un teatro
Virgilio e Ovidio, sta alla bada intendersi nel senso più
se del quadro seguente: Artevario e allargato del termimide, ricomposte le membra
ne, comprende 14 opere vedilaniate di Ippolito, conduce
re e proprie, 6 lavori di teatro
l’eroe, ora ribattezzato col nomusicale (di cui uno cancelme di Virbio, sulle sponde del
lato dal catalogo), 15 balletti
Lago di Nemi, dove viene in(3 dei quali revisioni di veccoronato re dei boschi.
chi spartiti), 4 imprese sceniL’orizzonte meridionache collettive, 11 colonne sole, prediletto da generazioni
nore di film e 2 per la radio,
d’intellettuali-viaggiatori ca8 musiche di scena, 5 trascrilati dai paesi germanici, ricezioni-adattamenti di partituve infine il meritato omaggio,
Scene di Phaedra, Berlino 2007 (foto di Ruth Walz )
re dal Sei all’Ottocento, perdopo essere stato trasposto in
speciale
T
sino i titoli di testa di una serie televisiva, sopravanza i lasciti, pur abbondantissimi, di autori iperprolifici quali Richard
Strauss e Benjamin Britten, ed è lì lì per rivaleggiare con gli operisti dell’Ottocento,
di quando cioè il melodramma occupava
una posizione dominante nel sistema culturale dell’Occidente capitalista e borghese (l’espressione valga come semplice dato di fatto, sottratta a qualsiasi giudizio di
valore). Anzi, una conoscenza appena più
approfondita della sua produzione attesta
l’esattezza d’una definizione, coniata dallo
stesso Henze a proposito del suo modo di
«fare musica», Imaginäres Theater
Theater, teatro immaginario.
Al cuore della vita quotidiana e spirituale del
Nostro troneggia un sentimento totalizzante
del paesaggio, la natura quale polo dialettico
del mondo urbano-industriale moderno.
Siffatta prospettiva, se non acquisita (se
ne trovano accenni nel radiodramma Ein
Landarzt,, ispirato a Kafka, e in Boulevard
Landarzt
solitude,, ennesimo adattamento della Masolitude
non di Prévost – si pensi alle voci
bianche, ovvio simbolo d’innocenza), venne certo rafforzata e
chiarificata dal contatto coll’Italia: giuntovi nel ’53, Henze non
l’ha più lasciata, risiedendo di
volta in volta a Ischia, Na-
luoghi antichi o fiabeschi (Re Cervo, Bassaridi, Venere e Adone) ovvero evocato per contrasto (il cupo ferrigno del Principe di Homburg, le cime alpine di Elegia per giovani amanti, l’oceano tempestoso – più nordico che
giapponese – del Mare sdegnato, da Mishima, fattosi incredibilmente placido e rassicurante – mediterraneo? – una volta che
l’opera è stata trasposta – pochi anni orsono – in giapponese). In precedenza, piuttosto, questa Sehnsucht nach Süden, l’attrazione per il sud, s’era manifestata tra le pieghe
umide e ombrose di pezzi vocali, grondanti sensualità e calore, per solista e strumenti
(Cinque canti napoletani per baritono – modellato sui mezzi di Fischer-Dieskau – e orchestra, Notturni e arie per soprano e orchestra: duplice riflessione sul Lied mahleriano, portato però a una
temperatura torrida; Ariosi per soprano violino e orchestra, su
testi del Tasso; Being beauteous per soprano leggero, arpa e quattro violoncelli) o di brani destinati alla danza (Undine, un ballet
blanc – nel taglio dei numeri, nella plasticità dei disegni ritmici
e melodici – minato alla radice dall’«ambiguità» della disposizione armonica). Tutto un mondo che pareva trascorso, ed invece era destinato a rivivere, qualche tempo fa, nei Canti arabi
per tenore e pianoforte.
Adesso, con Phaedra, l’approdo italico della collocazione scenica, unico luogo «reale» per l’artista che si dedichi al teatro,
non significa solo proclamare in pubblico le ragioni del cuore,
ma si riflette anche sulla drammaturgia, laddove l’ossequio infine rivolto alla terra adottiva comporta, inevitabile, un ripen-
speciale —
I versi, concettosi al limite dell’ermetismo (hölderliniani li ha
definiti Henze), dettati dal poeta e teologo tedesco Christian
Lehnert, delineano una drammaturgia interiore, quale s’addice a una Konzertoper: i due umani (Fedra e Ippolito) sono muniti
d’un doppio divino (Afrodite e Artemide, rispettivamente); tutti, in qualche modo misterioso, fanno capo alla figura anch’essa doppia del Minotauro, solo evocato a parole nel Quartetto
iniziale, presente in scena nell’episodio conclusivo. Nessuno,
però, dialoga o si confronta;
anche quando cantano insieme (capita sovente alle coppie omologhe, soprattutto a
quella Fedra-Afrodite), i cinque si limitano a monologare, rimuginando i propri pensieri sentimenti ed emozioni:
non a caso, ciascuno di loro si
esprime attraverso uno specifico stile vocale, e volentieri
sono accompagnati da timbri
determinati (legni per Ippolito, ottoni per Fedra, ecc.).
Si ripropongono pertanto
situazioni già esperite in Boulevard (parzialmente), Elegia e
Bassaridi: l’incomunicabilità
come morbo mortale. Senonché, il secondo atto celebra a
chiare note la faticata eppur
trionfale conquista dell’au-
zione ritmica di semiminima, da una dodecafonia rigorosa (Henze è sempre stato
e resta un compositore «a base» seriale) ma
non dogmatica (un po’ come il nostro Dallapiccola), da una scrittura contrappuntistica (germanica) tanto intricata all’apparenza quanto concepita secondo un sistema di
«velature» sovrapposte, che, nel mentre garantisce ariosità al tessuto musicale, esalta
l’iridescenza preziosa dei singoli interventi strumentali, il contrasto di atmosfera sonora tra le due ambientazioni non potrebbe essere maggiore. Nel I, dunque, la Grecia mostra tratti severi, fin duri nel suo crudo tono tragico: vi domina una cupa vena espressionista (passi in Sprechgesang, accostamenti a Berg), nella quale vengono ruminati lacerti wagneriani (il declamato del Ring, il cromatismo
del Tristan, già esplorato nell’omonimo lavoro per pianoforte,
nastro magnetico e orchestra). Il II, tutt’al contrario, è all’insegna d’un’allegria spensierata, schiettamente comica e non esente da derive grottesche: un clima tinnulo, da Flauto magico (Fedra
Afrodite e Artemide intorno a Ippolito simili alle tre Dame intorno a Tamino), arricchito di spezie varie, suoni ed effetti naturalistici preregistrati, inflessioni jazzistiche o curve melodiche da song politico, alla Weill, frequenti ritmi di danza (tango,
bolero), persino, in un punto, un’eco, senza dubbio involontaria, dell’odiatissimo Richard Strauss (che Henze mi perdoni se
ho osato scriverlo!).
A colore musicale diverso corrisponde, in ciascun quadro,
una diversa impostazione dei rapporti tra i personaggi agenti.
todeterminazione da parte dell’uomo, in
questo caso da identificarsi, forse, coll’artista: Ippolito, infatti, si sottrae al principio d’autorità materna, inteso sia nell’accezione sacra – il redivivo, pronto a divenire
re, infrange le statue delle dee –, sia in quella umana – Fedra, la madre-amante. Qualcuno, in vena di scandaletti, potrebbe leggervi una rivendicazione dell’omosessualità, magari quella dell’autore stesso. Piuttosto, ricorrendo ancora una volta ai mezzi dell’allegoria fiabesca, Henze eleva un
inno all’umanità, alla libertà alla fantasia e
all’amore che ne rappresentano gli aspetti
migliori e imperituri. Da Re Cervo
Cervo, la prima opera musicata e (indirettamente: deriva da una commedia di Gozzi) dedicata all’Italia, a Phaedra, l’ultima, per
ora, opera musicata in Italia e ad essa espressamente dedicata, un cerchio si chiude.
Molti commentatori hanno messo in luce un legame tra Phaedra e la gravissima
malattia che colpì l’autore durante la sua
composizione. Il legame esiste, eccome;
ma è di segno opposto a quello
che si pensa: non contemplazione della morte, bensì incitamento alla vita e alla bellezza. Come a dire, l’alfa e l’omega
del Credo professato da Henze vita natural durante. ◼
speciale
samento di tutta quanta l’esperienza professionale maturata in
loco. Di qui, il carattere retrospettivo, di summa che si avverte quasi ad ogni pagina dell’opera: l’organico strumentale cameristico (23 musicisti: 4 archi «opposti» a 14 fiati – tutti, salvo
trombe e tromboni, chiamati a misurarsi con due strumenti –,
pianoforte, arpa, celesta e due percussionisti alle prese con una
trentina di aggeggi diversi), adottato in più occasioni, evoca
Elegia per giovani amanti (il rilievo assicurato agli strumenti idiofoni) e Cimarrón (le percussioni in genere); il soggetto mitico segna un ritorno a Bassaridi
e Venere e Adone, la componente fiabesca a Re Cervo e Upupa.
La memoria come nutrimento estetico e stimolo creativo
non si limita a scavare nel proprio passato, ma si esercita anche sulla Storia.
Nel Diario di lavoro su Phaedra (Wagenbach, Berlino;
parzialmente tradotto in italiano nel programma di sala per l’allestimento al Maggio musicale fiorentino 2008)
Henze dichiara di essersi posto come obiettivo principale il distinguere gli atti tra loro. In effetti, nel quadro d’un
organismo unitario, edificato
a partire dalla costante pulsa-
— speciale
novecento / parte seconda
Lo sradicamento
radicale
Appunti per un’interpretazione
di Xenakis
N
di Dino Villatico
ON SI NASCE greci per caso. Si potrebbe forse dire lo stes-
speciale
so di qualunque popolo. Ma per un greco nascere greco ha un peso può darsi superiore al peso di qualsiasi altra appartenenza. Si potrebbe anche rovesciare l’affermazione e
dire che anzi è per caso che si nasce greci, ma da quel momento
la nascita è irreversibile. Sembra un gioco di parole: ma tutta la
nostra interpretazione del mondo si fonda sulle parole, cioè sul
linguaggio, come aveva visto bene già Aristotele. E quando il
linguaggio verbale si rivela insufficiente o inadeguato, ecco che
ci si costruisce altri strumenti d’interpretazione, per esempio la
matematica. In ogni caso, però, la realtà non è compresa se non
attraverso la griglia di un’interpretazione. La stessa esperienza,
la sensazione, l’emozione, come insegna e dimostra la moderna neurobiologia, non è mai l’immediata percezione di qualcosa, bensì la rappresentazione, consapevole o inconsapevole, di
uno stato del corpo, registrata dal cervello. Viene da pensare che
Parmenide avesse ragione. Il mondo è un’apparenza di cui l’essere registra le apparenti mutazioni. Tutto sta a vedere da quale
punto di vista ci si pone, se dell’essere o dell’apparenza, del divenire. Eraclito, allora, non sarebbe l’opposto di Parmenide, ma la
si distinguono, perché dovunque c’è il divino come dovunque il
divino si manifesta attraverso il linguaggio. «… i suoni che sono nella voce sono simboli delle affezioni che sono nell’anima,
e i segni scritti lo sono dei suoni che sono nella voce» scrive Aristotele nel De Interpretatione. Il peso del pensiero che interpreta
la realtà, qualunque realtà, e qualunque pensiero, verbale, geometrico, matematico, musicale, figurativo (pittura e scultura),
architettonico, è dunque il peso che caratterizza da millenni la
cultura greca, anche quando diventa cristiana. C’è nel centro di
Atene, proprio vicino a piazza Syntagma, una piccola, e bellissima, chiesa bizantina, purtroppo sormontata da un orrido palazzo degli anni sessanta. È dedicata alla Madonna. Ma mentre un
occidentale latino l’avrebbe chiamata semplicemente Nôtre Dame, il greco l’ha chiamata, in neogreco, Αγία δύναμη της Παναγίας: santo potere della madonna. Del resto la chiesa patriarcale di
Costantinopoli, dedicata alla seconda persona della Trinità, cioè
al Cristo, si chiama Αγία Σοφία, Santa Sofia, che non è una santa, ma la Sapienza, il Logos, cioè Gesù, il Cristo. E Λόγος in greco non è, come potrebbe insinuare la traduzione latina vulgata,
Verbum, la parola, bensì il linguaggio. La definizione che Aristotele dà dell’uomo non è dunque di «animale razionale», secondo l’altra traduzione latina che rende logos con ratio, ma di
«animale che parla, che ha il logos, il linguaggio». Per Aristotele tutti gli esseri viventi hanno un’anima, anche le piante. Ma le
piante non parlano, come non parlano i cavalli. L’uomo parla.
Ed è questo che lo distingue dagli altri viventi (il termine greco
Ζϖον indica il vivente più che l’animale).
Ma c’è anche un altro aspetto da tenere presente, quando si affronta la figura di Xenakis. La Grecia è un piccolo paese, ma tre
dei suoi poeti sono tra i più grandi del secolo scorso: Kavafis, Se-
visione complementare: dal punto di vista del divenire, e cioè dell’apparenza. Aristotele, educato dall’intuizione di Platone che la realtà è linguaggio
(in senso molto particolare, ma anche letterale), pone il tassello definitivo, che potremmo
ritenere decisivo fino al geniale svelamento di
Spinoza, che la realtà è unica, e la distinzione
tra spirito e materia, un mito, una bugia religiosa. Credo che Spinoza abbia colto nel segno. Il tassello aristotelico è l’unità della natura, fisica e intellettuale. «La natura non fa salti
come una cattiva tragedia«, c’è già Darwin. Che
Xena
infatti gli rende omaggio, nel suo libro più famoso. Natura in greco si dice φύσις , e naturale φυσικός.
La Fisica, perciò, è la scienza che studia la natura, tutti i
fenomeni naturali. Aristotele era infatti anche un grande biologo, si pensi che dobbiamo a lui la classificazione degli animali in vertebrati e invertebrati. Il suo allievo e genero Teofrasto ne
completa l’opera nel regno delle piante. Il termine Fisica ha dunque, nel greco antico, un significato più ampio che nella scienza moderna. Lo spiega bene la sua etimologia. Φύσις viene dal verbo φύω
φύω, che ha lo stesso radicale del sanscrito
bhu bhvati
bhu,
bhvati,, essere, e del latino fui, futurus, e significa produrre, mettere fuori, fare crescere, generare. La Natura è perciò concepita dal greco come una sorta di utero da cui nascono le cose. Il mito dell’uovo d’argento deposto dalla Notte nel Vuoto ((Χάος, chaos) da
cui poi Eros estrae tutte le cose è un mito orfico, ma
chiarisce assai bene la concezione di materia vivente
che il greco ha della natura. Natura e Divino non
feris ed Elitis. Siamo ai livelli di Eliot, Achmatova,
Blok, Cvetaeva, Valery, e del nostro Montale. La
borghesia greca è inoltre mediamente più colta
della borghesia italiana, e in ogni caso poliglotta. In verità anche il tassista di Atene conosce
almeno l’inglese. Si può dire lo stesso dei tassisti milanesi o romani? Le università greche
sono inesorabilmente selettive. E hanno il
numero chiuso, chiusissimo. Gli studenti greci che vengono a studiare in Italia non ci vengono perché le università italiane siano migliori, ma perché non sono riusciti ad entrare in una
s
università
greca e le università italiane non attuano
i
k
uno sbarramento serio d’ammissione. I migliori studenti greci, infatti, non vengono in Italia, ma, dopo essersi laureati in Grecia, vanno a Parigi, in Inghilterra, a Berlino,
per approfondire i propri studi. È in un simile contesto cosmopolita che va collocato Xenakis, che non a caso comincia la sua
carriera non come musicista, ma come architetto, assistente di
Le Corbusier. È suo, e non di Le Corbusier, il padiglione Philips dell’Esposizione Universale di Bruxelles nel 1958. Lo slancio
visionario verticale della struttura, una specie di glissando di corde, mostra già l’invadenza, si direbbe la prepotenza spaziale della sua musica: non a caso la struttura è affine al glissando di corde di Metastáseis, metastasi, mutazioni. E già qui si può notare la
perfetta simbiosi di disegno e musica. Ma non nel senso, di molti compositori, soprattutto italiani (penso a Bussotti), di una sovrapposizione tutto sommato compiaciuta ed estetizzante, decorativa, tra la scrittura musicale o supponentesi tale, e l’effetto
sonoro che ne dovrebbe derivare. Si resta insomma sulla super-
novecento / parte seconda
speciale —
speciale
ficie olegrafica della scrittura, perfino in Maderna, ma forse no
l’Ars Nova e poi dei compositori francofiamminghi. Di astratin Nono, che possiede anche lui una percezione materica e comtezze simili sono intessute anche le composizioni di composiplessa del fenomeno suono. In Xenakis la struttura è già insieme
tori successivi, per esempio Beethoven o Liszt. Gli ultimi cindisegno e musica. Ma a differenza dei compagni di viaggio franque quartetti beethoveniani sono generati da un’unica cellula di
cesi e tedeschi, la struttura non nasce dal prosciugamento razioquattro note ricavate dal nome Bach, si bemolle la do si naturanalistico della scrittura, bensì si sforza d’inglobare, e in maniera
le, ma non si presentano mai in questa disposizione, subiscono
più radicale, meno estemporanea, soprattutto meno empirica,
mutazioni, trasporti, inversioni, retrogradazioni; la disposiziodi Cage, l’imprevedibile. Il caso, l’alea, insomma, non è né l’acne più vicina alla cellula originaria si ha all’inizio del Quartetto op.
cidente, l’imprevisto, anzi, forse, l’indeterminato, della musica
130, che infatti è in si bemolle maggiore, si bemolle la la bemoldi Cage né l’addomesticamento combinatorio, e dunque semle sol, il semitono originario do si è abbassato di una terza. Ma
plificatorio, di un Boulez. Il probabile può essere oggetto di stuanche Liszt, da bravo allievo di un allievo di Beethoven, Czerdio, anche se non di scienza esatta, come la matematica, già in
ny, non scherza. La sua Sonata in si minore è di fatto costruita su
Aristotele: ma riguarda l’accadere umano, il territorio dell’Etica,
un unico motivo, variamente trattato dal punto di vista ritmico.
non gli eventi della Natura. Diviene, invece, oggetto di scienza
Dahlhaus suggerisce addirittura che il procedimento lisztiano
esatta con il calcolo delle probabilità di Pascal e il calcolo infipossa avere influito sulla concezione seriale di Schoenberg.
nitesimale di Leibniz. Calcoli, senza i quali, non sarebNon è difficile immaginarlo, dato che tra otto e novebe possibile una teoria dei quanti. Ciascun ascoltacento Liszt era tra i compositori maggiormente esetore di musiche delle avanguardie degli anni dai
guiti e ammirati. Oggi lo si suona molto di meno,
quaranta ai sessanta, e forse ancora dei settaned è un male: senza Liszt risulterebbe per esemta del secolo scorso, avrà subito la sgradevole
pio incomprensibile un Ravel. Ma forse perfiimpressione di ascoltare un miscuglio sonono Stockhausen, almeno quello dei Klavierstücro informe, imprecisato e imprecisabile e anke. Ma siamo andati troppo lontano. Riprencora più sgradevolmente si sarà sentito incadiamo il filo. Oggi il ruolo di Cage nel disorpace di distinguere non solo un compositore
dinare il mondo fintamente ordinato dei radall’altro, ma una musica dall’altra dello steszionalismi europei è riconosciuto da tutti. Asso compositore. Proprio in quegli anni Aldo
sai meno è riconosciuto il ruolo di un ripensaClementi tenta infatti l’avventura dell’informamento integrale del rapporto della musica con
le anche in musica. Xenakis vuole guardare più
il mondo, della forma musicale con l’esperienza
Ar
a fondo, o meglio da un’altra prospettiva. L’effetto
della sua percezione in un’esecuzione, che è il granis t o t e le
caotico di molte musiche capillarmente programmade rinnovamento di pensiero, anche di pensiero musi-
te a tavolino con il tormentone della serializzazione integrale gli
pare non un risultato imprevisto e soprattutto indesiderato, ma
la logica conseguenza di un pricipio matematico, per il quale la
massima determinazione produce un effetto d’indeterminazione, di caos. Si chiama processo stocastico. La sua definizione è
la seguente: un processo stocastico è una famiglia di variabili casuali che dipendono da un parametro t (tempo). Per comprendere la portata di procedimenti simili, si pensi che per esempio
in una sonata di Beethoven le elaborazioni tematiche sono variabili causali, vale a dire previste e volute da Beethoven, mentre
gli eventuali errori del pianista sono variabili casuali. Più complesso il discorso sulle dinamiche: comportano valori prevedibili e imprevisti. In ogni caso intervengono su una traccia prefigurata dal compositore. Le avanguardie del secondo dopoguerra ubbidivano a un intento utopistico: predeterminare sulla pagina l’evento sonoro. In realtà questo si dimostrò possibile solo con la musica registrata su nastro. A scombinare l’utopia intervenne Cage. Già Boulez faceva uso di serie incomplete e si
chiese tra i primi che senso avesse pianificare 12 valori dinamici, 12 modi d’attacco e così via. La serie di dodici altezze sembra
più plausibile, perché è calcolata all’interno di un’ottava e copre
tutti e 12 i semitoni del sistema temperato equabile. Ma non si
tratta in realtà di dodici suoni, come farebbe supporre il termine
dodecafonico, che a Schoenberg non piaceva: l’altezza viene infatti
considerata la stessa in qualunque registro venga intonata, se rispetta il grado dell’ottava impostato. Un do, insomma, resta un
do in qualunque ottava, del registro medio, alto o basso, io decida d’intonarlo, e già questo è un limite, o piuttosto un’astrattezza, del principio seriale. Niente di male, su principi ugualmente
astratti (Xenakis direbbe atemporali) si reggeva la polifonia del-
cale, attuato da Xenakis. È accaduto con lui, quello che nel confronto con Schoenberg e Webern, dal punto di vista delle avanguardie, era accaduto per Bartók. Bartók è tra i compositori fondanti della modernità, allo stesso titolo di Stravinskij e di Schoenberg. Così Xenakis apre una via di valore, e soprattutto d’incidenza, non inferiore alle vie aperte da Boulez, Stockhausen e
Cage. Vediamo perché.
Nella penultima sezione delle sue Lezioni di estetica, Hegel cerca di precisare il rapporto che esiste tra la musica e il tempo. Fonda poi proprio sulla percezione del flusso temporale articolato
dalla musica il carattere particolare della musica stessa come arte
dell’interiorità, in quanto inconcepibile e incomprensibile senza l’uso della memoria. Il suono è fenomeno, infatti, dell’istante, solo la memoria può ricostruire i percorsi ritmici, armonici
e melodici di una musica. In sé non esistono, ogni suono svanisce non appena emesso, o subito dopo che ha cessato di durare. Nessun legame fisico lo lega al suono che lo ha preceduto o a quello che segue, né tanto meno ai suoni emessi simultaneamente. I legami, armonici, melodici e ritmici tra i suoni sono posti dall’ascoltatore, registrati nella sua memoria. Ecco
perché per comprendere e dunque godere di una musica
è indispensabile un ascolto consapevole, non immediato. Anche l’ascolto che sembra istintivo, immediato,
per esempio nelle musiche popolari, si avvale di una
fitta e complessa rete di conoscenze introiettate con
l’educazione o ricevute per tradizione orale. Quindi un ascolto ingenuo di una musica non esiste. Un
giovane ascoltatore di musica rock sa benissimo che
cosa sta ascoltando, lo sa molto meglio di un medio
ascoltatore di Mozart o di Schubert. Esiste, infat- ▶
— speciale
novecento / parte seconda
mente non omogenei. Per esempio, noi accettiamo il presupposto che il tempo sia irreversibile. Ma la fisica dei quanti ci fa conoscere un tempo retrogradato, retrogradabile. «Facciamo ancora un passo. Visto che lo spazio non è percepibile se non attraverso l’infinità delle catene di trasformazioni energetiche, potrebbe davvero non essere che un’apparenza di queste catene».
La teoria delle superstringhe finisce per dire questo. E la relazione con la musica sarebbe allora strettissima. Ma c’è inoltre una
complicazione. Che rapporto esiste, infatti, tra la nostra concezione di realtà e la realtà oggettiva di cui la nostra concezione sarebbe l’interpretazione? Xenakis finisce con il formulare un’ipotesi quasi spinoziana. «Lo stato attuale delle conoscenze sembra essere una manifestazione dell’evoluzione dell’universo da
circa quindici miliardi di anni. Voglio dire con questo che tali
conoscenze sono una secrezione della storia dell’umanità prodotta da questo grande lasso di tempo. Ammettendo tale ipotesi, tutto ciò che il nostro cervello individuale o collettivo sforna come idee e teorie o competenze, non è altro che l’output delle sue strutture mentali formate dalla storia degli innumerevoli
movimenti delle sue culture, nelle sue trasformazioni antropomorfiche, nell’evoluzione della terra, in quella del sistema solare e dell’universo. Se questo è vero, allora un dubbio fondamentale pieno di brividi ci è permesso riguardo all’“oggettività vera”
di queste conoscenze e competenze». Qui si pone il problema
della memoria e del rapporto tra il fluire del tempo e l’estraneità
al tempo del pensiero. «È un fatto primordiale che i fenomeniriferimenti abbiano lasciato una traccia nella mia memoria, altrimenti non esisterebbero. Il postulato sottinteso è che il tempo, nel senso del flusso impalpabile di Eraclito, non ha significato che in rapporto all’essere che osserva, a me. Non esisterebbe,
chi guarda una chiesa o un tempio greco e a chi ascolta una musica di provare l’emozione, il piacere, che storicamente è venuto ad associarsi a quel procedere formale. Di nuovo, non esistono una visione o un ascolto ingenui: comprende davvero l’opera solo la visione e l’ascolto consapevoli, gli altri tipi di visione e
di ascolto sono soltanto ignoranti. Anche se chi ascolta o vede si
crede una persona colta.
Ma quale tempo? E che cos’è il tempo in rapporto alla musica?
Ce lo dice lo stesso Xenakis.
«Il tempo non è semplicemente una nozione-epifenomeno
di una realtà più profonda? Quindi un’illusione che accettiamo
inconsciamente dalla più tenera infanzia e fin dalla più remota antichità?»
È l’attacco d’uno scritto sul tempo1.
La meccanica quantistica ha cambiato la nostra concezione
del tempo, ha cambiato anche la concezione dello spazio-tempo della relatività. «Ma che significato potrebbe allora avere un
tempo-spazio quantificato in cui la contiguità fosse abolita? Come sarebbe il lastricato dell’universo con dei buchi tra le lastre
riempiti del nulla ed inaccessibili?» L’ascoltatore di Xenakis
dovrà abituarsi a questo linguaggio insieme scientifico
e alquanto oscuro. La sua musica è il prodotto di questo pensiero, o piuttosto è la manifestazione di questo pensiero. Anche Stockhausen ci ha lasciato pagine mirabili sul tempo, ma in tutt’altra direzione. La
contiguità non viene abolita, ma anzi ispessita. Ciò
che invece Xenakis vuole comprendere è la possibilità di conoscere la relazione tra fenomeni apparente-
diversamente, alcun senso. Anche nell’ipotesi di un flusso del
tempo oggettivo, indipendente da me, la sua percezione da parte di un soggetto umano, dunque da parte mia, dovrebbe passare attraverso fenomeni-riferimenti del flusso, prima di tutto percepiti, poi iscritti nella mia memoria». Ciò che aveva già intuito Hegel. Ma in questo modo il flusso temporale viene registrato in qualcosa che sta fuori del tempo, che anzi concepisce un
tempo, perché ha il concetto di anteriorità. Anche quando l’anteriorità è astratta, puramente mentale, e dunque fuori del tempo. Per esempio, la cellula di quattro note, ricavate dal nome Bach, che sta alla base della costruzione musicale degli ultimi quartetti beethoveniani, non viene prima della musica, anzi nemmeno la si ascolta nella sua forma pura, ma solo calata nella struttura tematica dei quartetti. È un modello di riferimento della musica che procede mentre la si ascolta. Ma il modello sta fuori della musica, o meglio si cala e si nasconde nel farsi della musica.
«Sembra che le nozioni di separazione, di contorno, di differenza, di discontinuità, che sono profondamente legate tra loro, siano prodromi della nozione di anteriorità. Perché esista l’anteriorità, è allora necessario poter distinguere entità che permettano di “andare” dall’una all’altra. Il continuum liscio, quindi, abolisce il tempo, o piuttosto il tempo nel continuum liscio è illeggibile,
inaffrontabile». Lo diceva già Aristotele. «Il continuum è dunque
un tutto unico che riempie sia lo spazio sia il tempo. Ritroviamo
Parmenide. Perché lo spazio è inserito nell’illeggibilità? Ebbene,
a causa della sua non-rugosità. Senza separabilità, né estensione, né distanza. Lo spazio dell’universo si troverebbe, così, condensato in un punto matematico senza dimensione. Infatti l’essere di Parmenide e l’eternità non è che un punto matematico assolutamente liscio». È la separabilità che rende comprensibile sia
speciale
ti, l’ascolto ignorante, cioè quello che scambia per immediato,
istintivo, il riferimento alle superficiali, scarse e confuse conoscenze delle regole che agiscono nella musica che si sta ascoltando. Ciò vale soprattutto per l’ascoltatore di oggi. Chi rifiuta
la musica contemporanea, per rifugiarsi nell’ascolto della musica del passato, crede di conoscere quella musica solo perché vi
riconosce i parametri, pochi, che riesce a individuarvi: la continuità melodica, la regolarità ritmica, e poco altro. Ma già l’ascolto di un canone fiammingo e dei brani più spericolati di Beethoven gli procurerebbero problemi e solo il rispetto per il nome
consacrato gl’impedirebbe d’insultare la «porcheria cacofonica», per esempio, della Grande Fuga op. 133. Ho fatto l’esperimento con un ascoltatore di musica classica che ignorava quest’opera
di Beethoven. All’inizio della prima esposizione, dissonantissima, del soggetto della fuga, l’ascoltatore è saltato sulla sedia, indignato, esclamando: «Ma che cosa mi fai ascoltare! Togli questa
porcheria moderna!» «È Beethoven», gli ho detto. Allibito, si arrampicava sugli specchi: «Non capisco, proprio non capisco. Sarà solo un esercizio scolastico riuscito male». «Era il Finale previsto in un primo tempo per il Quartetto op.130». «Ah, ma vedi:
l’ha tolto!» «L’ha tolto l’editore. Beethoven avrebbe voluto mantenerlo. Si è arreso oggi si direbbe all’editing, ma ha preteso che
comunque la Fuga venisse pubblicata almeno come pezzo a sé.
Ci teneva moltissimo, la considerava una delle cose migliori che
avesse scritto». «Bah, se lo dici tu». Ma, ritornando all’intuizione
hegeliana, la musica è dunque rappresentazione del tempo interiore, che l’ascoltatore rivive al momento dell’ascolto. Hegel aggiunge inoltre un’osservazione assai acuta: la musica divide con
l’architettura la caratteristica di avere per contenuto la propria
forma. Solo la percezione dei procedimenti formali permette a
1 In Xenakis
Xenakis,, di autori vari, a cura di Enzo Restagno, Torino, edt, 1988, pagg. 271-280.
novecento / parte seconda
speciale —
se anche l’accettato la convenzione – perché di questo comunque sempre si tratta – di un’avanguardia estrema. Mai troppo
estrema, per Xenakis, fino a che rispetta le regole della tradizione, anche quando si propone d’infrangerle: ma senza oltrepassare mai il limite dell’omogeneità per così dire linguistica, in ogni
caso di riferimento a un modello musicale unico. E se invece
la forma potesse essere generata non da un’idea, da un modello, ma da un insieme matematico di idee e di modelli? Il caso calcolato saprà trovarne la soluzione. La vertigine allora, e se si vuole perfino l’aspra bellezza di questa musica, la sua scontrosa tenerezza, nasce proprio dal rischio di precipitare nel nulla, nel buco
nero di un’implosione irreversibile, in un rumore che non provoca nessun bing bang, non riesce a esplodere e a diventare musica, cioè suono organizzato. Xenakis evita quasi sempre di caderci. Ma il corpo a corpo con la forma, la lotta è senza esclusione di colpi. Sta qui la singolarità della sua proposta. Nel procedere per accumulo, per associazioni, per contiguità, per esplosione di eventi imprevisti, piuttosto che deduttivamente, come accade perfino in Cage. Il suo è un mettersi ogni volta ai ferri corti
con la forma, e dunque con la vita, almeno della musica. La ferita
sulla guancia infertagli dai fascisti greci ci dice però che il corpo
a corpo è con il senso della vita, e dunque configura aristotelicamente anche un atto politico: l’arte non a caso è più universale
della storia. Il risultato gli dà ragione, e l’effetto è di una tale forza d’impatto che si crede, ascoltando la sua musica, o assistendo
alle sue installazioni, che non sia possibile un altro modo di procedere, che anzi è questa la musica che assimila in un unico fenomeno una molteplicità di esperienze, una musica nella quale
l’immobilità e l’impenetrabilità dell’essere parmenideo si manifesta, si sarebbe tentati di dire si rivela, nel flusso inarrestabile del
un coro. «Idmen» è la prima persona plurale del verbo che significa sapere, quindi «sappiamo». Lo pronunciano le Muse all’inizio della Teogonia di Esiodo: «Sappiamo dire menzogne che
sembrano verità e verità che sembrano menzogne». Del testo
esiodeo Xenakis utilizza solo alcuni fonemi intonati dal coro,
al quale si associano le percussioni. È un pezzo strepitoso, anche qui l’impatto emotivo è violentissimo. La struttura musicale in Xenakis ha qualcosa di biologico: nasce da intricate e complesse riflessioni teoretiche, ma si esplica poi con una forza d’urto quasi primigenia, come un minerale, o una pianta. Sta qui la
novità e l’interesse della sua musica. Appunto nel generare una
contiguità senza vuoti tra pensiero e azione, tra razionalità della concezione e forza ipnotizzante dell’evento sonoro. La contiguità ottenuta mescolando eventi inaccostabili fa pensare alla sostanza unica di Spinoza, all’essere di Parmenide, appunto,
o all’idea che Aristotele ha della Natura: un tutto contiguo in
cui la vita si esplica in molte specie e individui, dall’erba all’albero, dall’insetto all’uomo, ma la cui forma è unica, appunto il vivere, il βίος, la vita, che va dal filo d’erba al pensiero che regola il
mondo, il Pensiero del Pensiero, conosciuto solo dall’uomo che
si dedica al βίος θεορετικός, alla vita speculativa. E tuttavia già in
Aristotele, quello che nella scolastica, senza rotture, senza traumi, diventerà il principium individuationis, il concretizzarsi dell’essere in un individuo, è presentato come una rottura, uno sradicamento, un’estasi dell’essere, un uscire fuori da sé. Non è questo il luogo per approfondire lo sconvolgente concetto aristotelico, che drammatizza il divenire, ma indubbiamente nella musica di Xenakis l’individuarsi della forma si presenta come uno
strappo, una rottura, un uscire fuori dalle regole. Uno sradicamento radicale dal convenuto, dal conforme, dall’accettato, fos-
divenire eracliteo. Che dal di fuori, dalla nostra grigia quotidianità di individui abituati e quasi consenzienti al sopruso di qualunque potere, sembra casuale, ma entrandoci, e lasciandocene
possedere, se ne avverte la necessità, e dunque la razionalità. Ma
soprattutto se ne respira l’illimitata libertà. È come se nell’esilio
parigino il greco Xenakis, sradicato dalla sua terra natale, si ricongiungesse alle radici del pensiero greco e, nel Paradiso della Ragione, come Cesare Macchia chiama la Francia, riscoprisse l’esplosione vitalistica di Dioniso, l’umore che genera la vita,
sperma, sangue, vino, acquitrino. L’estasi dell’essere. E proprio
in questo germinare, pullulare, apparentemente casuale, si fondasse il senso, e dunque la razionalità di una forma, di una vita,
di un’opera, di un pensiero. Ogni ascolto di un’opera di Xenakis
diventa così la scoperta, e forse la riscoperta, della vera sostanza
del pensiero, che non è né razionale né irrazionale, ma semplicemente è. Il linguaggio e la musica hanno in comunque l’uso dei
suoni. Ma i suoni non sono né razionali né irrazionali, semplicemente sono. La loro organizzazione li fa diventare linguaggio,
musica, pensiero. Non abolisce però la loro sostanza di esistenza come essere,, semplice sostanza, anteriore, non solo logicamente anteriore, all’organizzazione in linguaggio, musica,
pensiero, il che ne fa di volta in volta un’opera conclusa, una singola opera conclusa. Xenakis ci fa toccare,
infatti, ogni volta, questa trasformazione. Che il linguaggio, ciò che per Aristotele distingue noi uomini dagli altri esseri viventi, è sì un dato di fatto che ci
viene consegnato all’atto della nascita, quello e non
un altro, ma che diventa pensiero solo se si ha il coraggio, la forza, e la capacità di reinventarlo da capo. ◼
speciale
il mondo che la musica. «L’ordinamento e l’anteriorità non ammettono buchi, vuoti. Occorre che un’entità separabile sia contigua alla successiva, pena la confusione del tempo. Due catene
di eventi contigui senza anelli comuni possono essere sincrone
o indifferentemente anteriori l’una all’altra, il tempo è di nuovo
abolito nella relazione temporale di ognuno degli universi rappresentati dalle due catene. Gli orologi locali tengono il posto di
catene senza buchi. Ma soltanto localmente. Anche il nostro essere biologico ha sviluppato orologi locali ma non sempre efficaci e la memoria è una traduzione spaziale delle catene temporali (causali)». Ne consegue che «il flusso è, oppure non è. Poiché noi siamo, quindi esso è. Non si può concepire l’arresto del
tempo, al momento. Tutto ciò non è una parafrasi di Descartes
o meglio ancora di Parmenide, è una frontiera attualmente non
superabile. Dunque, parafrasando questa volta Parmenide, superabile: “il pensare stesso è anche essere”».
Su questa via Xenakis arriva a progettare le complesse relazioni delle sue installazioni, o come lui le chiama, politopi. Ma già
nelle sue opere, soprattutto strumentali, la coesistenza di fenomeni eterogenei genera strutture musicali di grande complessità eppure di impatto emotivo immediato. Si pensi a una pagina impressionante come Thallein, per 14 strumenti, del 1984.
Il verbo θάλλειν significa fiorire. E veramente i fenomeni musicali sembrano fiorire gli uni dagli altri. O Pleiades, per strumenti a percussioni, del 1978, diviso in quattro movimenti: nel primo sono combinati insieme tutti i tipi di strumenti a percussione, nel secondo solo quelli a tastiera, nel terzo i metalli e nel quarto le pelli. La forza generatrice del ritmo è qui esaltata con effetti stupefacenti per delicatezza, raffinatezza ed evidenza strutturale. In un brano come Idmen si aggiunge anche la voce umana,
— speciale
I vulcani spenti
di Lachenmann
novecento / parte seconda
norama confuso della contemporaneità, dove sempre
più disorientante affiora il senso della perdita dei mordenti delle avanguardie storiche e l’inclinare non meno distratto verso zone compromissorie, con una forza e un’originalità
indiscutibili, che affondano le radici nella profondità – non
poco utopica anche, ma proprio per questo avvincente
– dell’assunto, problematico indubbiamente, teso più
che a un’ideale tabula rasa,, quale sognavano negli anni
cinquanta i protagonisti della Nuova Musica, a una
rimozione del passato a livello di coscienza, di ascolto. Non a un annullamento dei materiali, dunque,
ma a una loro diversa qualificazione, per «riscoprire
un suono che si conosce già» e ricomporlo secondo
altre logiche, un po’ come aveva immaginato
Borges con la sua «biblioteca cinese».
Dopo una prima fase più duramente
eversiva, quella da lui qualificata come «concreta», Lachenmann è parso
sempre più immergersi nella riscoperta di questo suono conosciuto e
di tale percorso è avvincente testimonianza un brano come Mouvement (vor der Erstarrung), ossia mo-
primario la sua fisicità, debordante a volte da quelli che sono i
convenzionali argini di ogni singolo strumento per toccare la
provocante zona oscura del rumore. Un processo di trasformazione che il materiale sonoro va subendo nel corso dell’esecuzione, quasi sospinto da un’energia occulta e pur inevitabile,
che diventa rivelatore di una condizione profonda vissuta e insieme di una prospettiva insospettata.
Comprensibile anche la sensazione di smarrimento che può
provare l’ascoltatore di fronte alla musica di Lachenmann: il
quale a chi un giorno gli chiedeva di fornirgli la chiave d’accesso rivolse il suggerimento di «guardare» alla sua musica «come
si guarda un temporale, un formicaio», un evento della
natura, insomma.
Abbiamo avuto occasione di conversare col grande musicista in occasione di un seminario tenuto
presso il Conservatorio di Parma. Nel corso della lezione Lachenmann si era soffermato su alcune pagine del Canto sospeso di Nono svelandone con stupefatta lucidità la più intrinseca essenza poetica, riconducibile a quella vocazione ideale cui il compositore veneziano ha improntato il
suo rapporto con la società. E sul tema Nono, appunto, ha proseguito la conversazione concessaci amabilmente da Lachenmann nell’intervallo. Il percorso di Helmut Lachenmann ha
avuto una singolare sollecitazione dall’incontro con Nono, incontro destinato, pur tra forti contraHelmut Lachenmann
sti, a lasciare un segno ben rico-
vimento prima dell’irrigidimento, dove appunto si ha la
sensazione che ogni suono,
nel modo stesso di produrlo, assuma una nuova significazione nel momento in
cui questa sembra scontrarsi con strutture del passato,
che, pur con la loro tangibilità, quasi esplicita nel rievocare il movimento estremo di una vita che sta per
chiudersi nell’irrigidimento, appaiono ormai come
Anselm Kiefer, Margarete, 1981
larve brulicanti; oppure as(Saatchi Collection, Londra)
sistendo a quella fantomatica Danza degli spiriti beati (così
si intitola il secondo Quartetto) dove ogni beatitudine sembra
annichilita entro un quadro sonoro devastato, addirittura nell’intonazione degli strumenti, sottoposti alla fine a una «scordatura selvaggia», per ritrovare con pienezza la forza di quella
sua radicalità; e ancora considerando
il terzo Quartetto, il cui titolo, Grido, può suggerire la tensione da cui
si viene progressivamente avvolti
attraverso una trama strumentale
– concepita, appunto, in termini di
materiale rinnovato, destoricizzato, proprio in quanto se ne abbia coscienza – che ripropone come fatto
noscibile sulla sua produzione, senza peraltro condizionarne la peculiarità dell’approccio con il materiale sonoro e soprattutto senza toccare quella così singolare tensione che lo innerva.
Si trattò infatti piuttosto di
una convergenza di pensiero che andò consolidandosi attraverso un’intensa frequentazione trovando poi
un accrescimento di fronte a quel mutamento di linguaggio, apparso allora non
poco disorientante, che Nono operò agli inizi degli anni ottanta, quando la improvvisa rarefazione del materiale pareva riflettere un tipo di interrogazione più strenua e più segreta del suono stesso, i cui esiti altissimi si potevano cogliere nell’esperienza straordinaria del quartetto d’archi Fragmente-Stille,
an Diotima, con quel singolare quanto raro presentimento rappresentato dal brano pianistico «...sofferte onde serene ...». Chi vedeva tale svolta come uno sconcertante atto di disimpegno veniva rassicurato dalle parole del compositore: «Non sono affatto cambiato; anche la tenerezza, anche il privato ha il suo lato
collettivo, politico. Perciò il quartetto d’archi non è espressione di una mia nuova linea retrospettiva, ma del mio attuale livello di sperimentazione: voglio ottenere il massimo dal messaggio di ribellione con il minimo dei mezzi». Indicazione che
L
di Gian Paolo Minardi
speciale
A FIGURA DI Helmut Lachenmann emerge oggi dal pa-
novecento / parte seconda
speciale —
versazione sulla musica di Lachenmann, partendo dal modo di
rivivere il rapporto con la storia in maniera affatto personale,
come se la storia fosse stata travolta da un’alluvione, lasciando
rivivere solo rari frammenti, del tutto denaturati, fossili senza
significato, affioranti dal magma misterioso del suono. Mi viene in mente, propongo, la pittura di Kiefer, dove la storia è come impressa in modo annichilito. Il suono, dunque come scrigno roccioso da cui liberare una nuova coscienza. Ma suono significa tante cose: rumore, ma pure analisi sottile (come mostra l’estrema ricerca di Nono) che tocca anche la parola
(e quindi il teatro ); infine l’apparente contrario, il silenzio. Forse la domanda è posta in termini troppo stringati, così che Lachenmann, pur d’accordo, allarga il respiro: «Credo che la nostra storia rifletta il conflitto tra lo spirito dell’artista
e il bisogno della società di sentirsi protetta, di sottrarsi alla realtà. Credo che, pensando all’arte europea e soprattutto alla
musica, potremmo parlare di un “servizio di magìa”, cosa che ritroviamo in tutte le culture, con varie finalità, rituale, religiosa, militare e via dicendo. L’arte europea ha rotto questa magia nel nome di
uno spirito creativo, con tutti i contrasti conseguenti: Bach che non
veniva riconosciuto in quanto
aveva armonizzato liberamente i corali di Lutero,
poi Mozart rifiutato dalLuigi Nono
la società perché troppo
quelle di Beethoven, e così i
timpani, le campane. C’è un
pathos, non nel senso banale, commerciale, totalmente puro» che, come Lachenmann ha mostrato analiticamente durante la lezione,
penetra nel profondo delle strutture e che la società
ha compreso: «Comprendere, s’intende, non vuol dire essere d’accordo» ma anche in Germania ha lasciato un segno provocatorio,
Anselm Kiefer, Nigredo, 1984
«ancor più che quello del(Philadelphia Museum of Art)
la musica di Stockhausen e
di Boulez, in quanto questi
musicisti rappresentavano un mondo “surrealista”, di fantasia, che non è ostile alla società, mentre l’appello della musica di Nono toccava nel profondo; e in modo nuovo, perché se
l’appello della musica di Wagner e di Beethoven è ancora presente, ma come ruinae, quello della musica di Nono è risultato
più bruciante, e questo è bene perché in una società che mette sempre la testa sotto la sabbia quella musica rappresentava
un richiamo alla coscienza, un disturbo alla gente che è pigra.
Ciò ha fatto sì che Nono avesse amici e anche falsi amici che
pensavano a questo gesto come un fatto manieristico, ma credo che Nono sia stato sempre un uomo di struttura, nell’autenticità della sua utopia».
Il tema della ricerca di un’autenticità di segno sposta la con-
complesso, entrambi oggi divenuti oggetto di magia. Ugualmente si può dire
per Schoenberg. Come oggi la società è consapevole
dei problemi dell’ambiente,
della difesa della natura così mi auguro che l’arte venga
intesa non tanto come magia ma come mezzo dello
spirito. L’arte deve cercare
l’etica del sentimento, bellezza, intensità, complessità; non soltanto chiedersi se
questo è bello ma che cos’è.
C’è una storia dietro di noi e
l’antenna della società deve
sensibilizzarsi più intensamente per evitare il puro “intrattenimento”, l’idillio». Idillio e magia sono termini ricorrenti nell’universo immaginativo e così lucido di Lachenmann, «cose da evocare e poi rompere. Quando mi siedo al tavolo davanti al pentagramma sono già nella
società, diviso tra accondiscendere o cambiare, affrontando un’avventura che la società sente come
una minaccia, perché interrompe la magia. Credo tuttavia che intendendo la musica in quest’ultima accezione vi siano ancora possibilità di dare un entusiasmo». ◼
speciale
certamente ha fornito a Lachenmann uno stimolo; nel modo
di rapportarsi in maniera originale con la storia, i cui reperti accoglie come residui lavici di un vulcano che sembra aver cessato la propria attività e che tuttavia emana pur sempre il senso di un’energia sotterranea, e tuttavia due percorsi affiancati più che dipendenti; affini in effetti, nel modo con cui Lachenmann va spremendo le più sottese virtualità del suono, in
una pagina, ad esempio, come Eco-Andante nello sforzo di ricreare dalle risonanze del pianoforte una subliminale polifonia, mentre nel più ampio Serynade è la suggestione della sonorità delle ultime Sonate di Beethoven, tutta giocata sulle zone estreme della tastiera, a guidare
la più strenua esplorazione.
Alla domanda di quale sia stato il senso
reale della sua lezione raccolta dal musicista veneziano, al di là di quel contrasto tra la critica sociale che Nono rivendicava in maniera così vistosa e la difficoltà del suo linguaggio sonoro, Lachenmann risponde di non credere a quella
contraddizione, perché «il gesto enfatico di questa musica è talmente puro, anche se è chiaro che si tratta di
un’enfasi, di un appello di un altro
mondo, quasi utopico. E questa –
chiarisce – è la grande differenza tra Nono e gli altri esponenti dell’avanguardia:
le trombe di Nono fanno ancora appello come
— speciale
novecento / parte seconda
John Cage e
l’espressionismoastratto
dri bianchi” vennero per primi: il mio pezzo silenzioso venne più tardi». I quadri bianchi, così come quelli neri, erano di
Robert Rauschenberg. Lo racconta Cage nell’Autobiografia:
«Un giorno Bob venne da me e mi portò
un dipinto che aveva appena finito. Era un
John Cage
nuovo quadro dei “black paintings”. Ebbi il
dubbio che si aspettasse da me maggior entusiasmo. Avevo sempre avuto la massima
ammirazione per il suo lavoro e poteva aver
pensato che fossi in qualche modo deluso.
Mi accorsi subito che era terribilmente turbato, quasi sul punto di piangere. Mi chiese se secondo me c’era qualcosa che non andava nel dipinto. Lo rimproverai per questo,
dicendogli semplicemente che non doveva
dipendere dall’opinione di nessuno, che non
avrebbe mai e poi mai dovuto cercare quel
tipo di appoggio da un’altra persona».
C’è un diletto per la pittura in Cage, ma anche una maniera di valutarla che sembra farne un’arte un poco minore nei confronti della musica. Non è la sua semplicità: «Credo
metrica che allora m’interessava. [...] Quello che abbiamo nel caso di Tobey, nel caso della superficie del marciapiede, e nel caso di
gran parte dell’espressionismo astratto è proprio una superficie
assolutamente priva di qualsiasi centro d’interesse. [...] Possiamo
guardare prima una parte e poi un’altra, e per quanto ci è possibile
avere un’esperienza dell’insieme. Ma quest’insieme è tale che non
sembra delimitato dalla cornice. Sembra che possa proseguire,
espandendosi oltre la cornice. In altre parole, è come se non stessimo parlando di pittura, ma di musica, di un’opera che non ha inizio, né parti intermedie, né fine, ed è priva di punti focali».
Cos’altro serve a spiegare Tacet, o 4’33”? Cage non gli ha mai dato
un titolo, lo chiama «il pezzo silenzioso», dicendo che di fatto ciò che lo spinse a scriverlo non fu il coraggio, ma l’esempio di Robert
Rauschenberg, dei suoi suoi «white paintings». «Non appena li vidi mi dissi: Sì devo farlo, altrimenti rimango indietro, altrimenti la
musica rimarrà indietro».
Potrebbe stupire il fatto di non incontrare
in Cage una presa di posizione contro il nome «espressionismo astratto»: tutto ci dice
che il sostantivo non dovesse toccare le sue
corde; l’aggettivo porta una correzione che
costituisce quasi un ossimoro nei confronti
di ciò che qualifica. A John Cage l’espressione non piace, gli piacciono le esperienze che
può fare, gode delle modifiche ch’esse portano in lui. È attentissimo all’atto esecutivo:
il caso può avere contribuito a costituire il testo, ma esso va eseguito tale qual è, con peri-
che le arti visive contemporanee ci forniscano numerosi esempi
di situazioni che vengono ricondotte a una straordinaria semplicità. Mi vengono in mente, a esempio, i “white paintings” di Robert Rauschenberg che sono assolutamente privi di immagini». È
il semplicismo cui si applica, per esempio, Jackson Pollock, ed esso ha una rilevanza che è significata dallo scarto che s’interpone
nella valutazione di Cage tra quest’ultimo e Mark Tobey.
Con Pollock è in atto, infatti, un automatismo comportamentale che, secondo Cage, produce un ripiegamento su se stessi, sulle
proprie sensazioni, che è proprio ciò da cui ognuno dovrebbe liberarsi. Tutto l’espressivo è un qualcosa dell’io che risulta limitante, nocivo, alla produzione artistica: surrealistico o espressionistico che sia, esso porta la soggettività nell’opera.
Non si tratta solo di insensibilità nei riguardi dell’umanesimo
e di quanto lo ha seguito fino al romanticismo, ma in Cage è attiva una sorta di continua attenzione a respingere il progetto umano di farsi misura delle cose e del mondo, di creare dei o demoni a
propria immagine e somiglianza, di antropomorfizzare la natura. Uscito da una mostra di Tobey alla Willard Gallery «mi trovai – racconta – all’angolo della Madison Avenue ad aspettare l’autobus e mi accadde di guardare la superficie del
marciapiede, e mi resi conto che si trattava della stessa
esperienza che avevo avuto guardando i dipinti di Tobey. Esattamente la stessa, così come il piacere estetico
che mi procurava era altrettanto alto». Con le sue parole, «era un dipinto che non raffigurava nulla [...], era per
così dire completamente astratto. Non aveva riferimenti simbolici. Si trattava di una superficie che
era stata completamente dipinta: Ma non era stata
dipinta in modo da suggerire quell’astrazione geo-
zia e applicazione. Contesta, per esempio a Pollock una grossolanità che non vede in Tobey. Forse, se se ne conosca l’arte solo in riproduzione, i due potrebbero facilmente venir confusi l’uno con
l’altro. Non è il caso di John Cage. Anzi, parlando delle tele del più
giovane, quindi di Pollock, egli ci dice che, proprio in virtù d’una
certa familiarità con le tele dell’altro, «osservando una delle grandi tele di Jackson Pollock era facile capire che aveva preso cinque
o sei barattoli di vernice, senza neppure prendersi la briga di modificare il colore della vernice che colava dal barattolo, lasciando
più o meno meccanicamente – con gesti in cui, ovviamente, credeva – che questa vernice colasse sulla tela». In quel modo, il colore non poteva interessarlo, perché non cambiava. «Se invece si
guardano i Tobey, si può vedere che ogni pennellata ha un bianco
leggermente diverso. E se guardiamo la nostra vita di ogni giorno, possiamo accorgerci che non viene fatta sgocciolare da un
barattolo».
Il dripping gli sembra dunque un buttar lì le cose.
La distanza tra arte e vita è superata dallo svolgersi di un’esperienza. Questa non può consistere per il libero arbitrio anarchico nel farsi prendere per mano e farsi guidare a comprendere. Cage non tanto imputa di fare ciò ai movimenti realistici, sìmbolici/
surrealisti, quanto li dice poco o affatto interessanti perché questo
fanno. Egli vuole che si sviluppi la coscienza personale e si modifichi nell’esperienza sensibile, come nel caso raccontato del marciapiede all’angolo della Madison. Per sé vuole crescere con le sue
proprie esperienze, farsi. Vuole frequentare Duchamp e imparare
a giocare a scacchi. Duchamp gli chiede se già sa come si muovano i pezzi e, data la risposta positiva, cominciano a frequentarsi attorno alla scacchiera. Mai dalle parole di Cage risulta una sua crescita in qualche modo eterodiretta.
J
di Giampiero Cane
speciale
OHN CAGE (1961): «A chiunque possa interessare: I “qua-
novecento / parte seconda
speciale —
go, Thelonious Monk e Cecil Taylor, il primo sostituendo al suono le sue danze, volutamente goffe, da orso, attorno al pianoforte, il secondo immettendo l’immagine del proscenio della danza nell’azione sulla tastiera, con l’azione corporea nell’avvicinarsi
spesso furtivo al pianoforte, nel declamare le sue poesie, suonandole con la voce.
Torna in evidenza il momento dell’esperienza, della propria e
di quella che coinvolge il pubblico. Il bello non c’entra mai, come in Dada non è qualcosa cui miri l’artista o l’arte. Cage liquida
un po’ tutti insieme i pittori della Pop Art, «poco interessanti come il Surrealismo», anche se non è un surrealismo dell’individuo,
ma della società.
Nella prima gioventù John Cage aveva apprezzato e amato particolarmente Ad Reinhardt, ma la scoperta dei monocromi, con
l’effetto che gli fanno, lo obbliga a un salto: «Niente soggetto, niente immagine, niente gusto, niente oggetto, niente bellezza, niente talento, niente tecnica (niente perché), niente idea, niente intenzione, niente arte, niente sentimento, niente nero, niente bianco
[...] Alleluuia! Il cieco può di nuovo vedere, l’acqua è limpida». Il
niente è quel che Reinhardt non coglie quando anch’egli dà corpo
ai suoi monocromi, nei quali il senso è però quello di un rovesciamento del precedente espressionismo.
Preso atto del salto, quel che emerge dal silenzio è una sorta di
contraddizione che Cage non ha mai apertamente affrontato.
Che senso ha ricorrere all’analisi e battersi per la lettura della sua
musica come fa James Pritchett, qualora si condivida il sospetto di
Joseph Kosuth che «per Cage la musica fosse un luogo di lavoro
piuttosto che qualcosa di utile all’esecuzione»?
C’è una certa vicinanza tra Kosuth e Cage, anche nella differenza dei metodi arbitrari di scelta all’interno del lavoro. Nessuno dei
Il luogo in cui, più che altrove, aspetti visiJackson Pollock
vi e sonori si sono trovati a mescolarsi in una
situazione che li accomunava è da considerare la compagnia di danza di Merce Cunningham. Vi hanno spesso collaborato Jasper Johns e John Cage dando vita a progetti d’allestimento che non chiedevano affatto
la convergenza nell’integrazione tra immagini, suoni e azioni coreografiche. Erano figli di una lezione di Marcel Duchamp, quella per cui l’evento si consegna allo spettatore,
il quale col dargli un senso lo finisce. Dal punto di vista dell’opera è quel protendersi verso l’altro, quel tendergli la mano di cui scrisse Renato Barilli, certo non ignaro di Duchamp, ribadito da Cunningham che giudica ottimale la risposta di spettatori «capaci di completare dentro di sé, ciascuno a suo
modo, lo spettacolo che viene loro offerto.
Quello che io penso della danza – continua il coreografo –, cioè
del movimento del corpo umano nello spazio e nel tempo, è che
essa non nasconde nulla dietro di sé, e che consiste semplicemente in ciò che si vede, così come la musica in ciò che si sente. E se si
ha la capacità di guardare alla complessità degli elementi che nella danza hanno luogo contemporaneamente alla musica o ad altri eventi, allora la danza stessa può presentarsi come un’esperienza, con cui si deve entrare in contatto. Attraverso di essa la nostra
sensibilità può essere aperta al mondo attorno a noi; ed è quanto, a mio parere, tutta l’arte contemporanea può fare». A ciò erano arrivati a loro modo, indipendentemente da Duchamp riten-
due pensa che l’arte consista in forme e colori/suoni. Le singole opere non sono che
esempi di un processo più ampio. Bisognerebbe poter sondare il silenzio tra un’opera e
l’altra, il pensiero durante le pause. Se riusciamo a cogliere il lavoro negli intervalli, cogliamo il lavoro reale. «Le singole opere – dice
Kosuth – troppo facilmente diventano un
luogo di interpretazione, uno specchio per
le richieste di significati di altri». Serenamente, sia Kosuth che Cage, non trovano però
ostacoli in questo loro essere utili.
Del resto Cage non s’è mai fatto scrupolo
di tradurre l’I Ching in uno strumento che
gli serviva per nuovi significati all’interno
della cultura occidentale, ignorando, o fingendo d’ignorare che l’utilizzava come una
metafora funzionale a una nuova cosa, la sua
musica, e astraendo dal senso che a esso è
proprio nella sua territorialità.
«I sensi non assistiti – ha scritto Cage – ci permettono di percepire, diciamo, il cinque per cento di quello
che esiste. Mediante il micro-questo, micro-quello, tele-questo, tele-quello esploriamo il resto. Ora, benché
angosciati dalla povertà, abbiamo avuto un’impressione
di abbondanza. Non possiamo supporre con una certa sicurezza, ora che abbiamo più di quanto possiamo utilizzare, che qualunque cosa è, in qualunque
luogo, in qualunque momento, per chiunque?». ◼
speciale
Così di fronte al quadro. Esso non ha uno scopo, ma è l’occasione per guardare. «Guardando il Large Glass [di Duchamp], la cosa che mi piace così tanto è che posso focalizzare la mia attenzione dove voglio. Questo mi aiuta a rendere indistinta la separazione tra arte e vita e produce una sorta di silenzio nel lavoro stesso.
Non c’è nulla in esso che mi richieda di guardare in un posto piuttosto che in un altro, o addirittura proprio nulla che mi richieda
di guardarlo».
Anche se nell’opera di Duchamp, i dati immediati della sensazione, il guardare dell’occhio è reso inconsistente sia dalla trasparenza dell’oggetto che, e soprattutto, dalla necessità di trascorrere
dalla percezione visiva a quella intellettuale, Cage non valuta per
questo negativamente quell’arte, ma elabora una strana teoria per
la quale «per la musica vale il contrario di ciò che è vero nelle arti
visive». «In altre parole – ci dice Cage – ciò di cui si aveva bisogno
nell’arte quando Duchamp fece il suo ingresso sulla scena non era
attinente alla fisicità del vedere, mentre ciò di cui si sentiva la necessità nella musica, quando io feci il mio ingresso, era l’esigenza
di una fisicità relativa all’atto di ascoltare».
Può darsi che in questo caso ci si trovi di fronte a un processo di
razionalizzazione, ma per quel che riguarda le sue partiture grafiche, che vennero esposte per la prima volta per un concerto alla
Town Hall che celebrava, con un po’ di ritardo, i venticinque anni del musicista, il coinvolgimento del piacere visivo sembra da
connettere soltanto con la necessità di una scrittura che permettesse di avere suoni di altezza non determinata, cosa che col pentagramma non s’accorda. Più tardi però, dedicandosi un poco ad
acquarelli o inventandosi materiali e tecniche, come artista Cage
non s’avvicinerà affatto a Duchamp, la sua astrazione non darà vita anche a una possibilità di astrazione dal vedere.
— speciale
novecento / parte seconda
Minimalismo
S
di Giordano Montecchi
speciale
fogliando le cronache dell’arte, sembrerebbe proprio che
quanto più la denominazione di una corrente artistica si
diffonde e si radica nell’opinione pubblica e nella cultura,
tanto più viene rifiutata con decisione dagli artisti ai quali viene applicata. È certamente casuale, ma è altrettanto certamente curioso che, a un secolo esatto di distanza, due termini come impressionismo e minimalismo abbiano ripercorso tappe analoghe. Originariamente riferiti alle arti visive e poi estesi alla musica, entrambi hanno
avuto enorme fortuna incontrando una vasta diffusione nel lessico corrente. Al tempo
stesso, pur andando incontro a un’autentica inflazione nelle cronache giornalistiche
e nella letteratura critica, sia l’impressionismo, sia il minimalismo, forse anche in ragione del significato implicitamente ridutttivo di entrambi i termini, hanno riscosso
una generalizzata presa di distanza da parte dei loro protagonisti, siano stati essi artisti
visivi o musicisti.
Quanto al minimalismo, il termine che
qui ci interessa trattare, nella sua polivalente applicabilità a diversi ambiti creativi, esso
si sfalda in una molteplicità di connotazioPhilip Glass
ni eterogenee e spesso contraddittorie. Basti
Art o il Concept che spalancano l’opera su dimensioni potenzialmente illimitate. Ed è stato proprio Donald Judd, uno dei
padri della minimal art, a progettare nel deserto del Texas il gigantesco centro espositivo della Chinati Foundation, sfruttando i 32 capannoni dell’ex base militare di Fort Russell dislocati su 150 kmq.
Quasi a giustificare le frequenti riserve degli artisti, in molte delle sue manifestazioni il concetto di minimal è dunque in
gran parte un paradosso o, meglio ancora, un ossimoro, a partire dal celebre aforisma di Mies van der Rohe «Less is more». Ma
ossimorica è la stessa idea che presiede all’indiscutibile prodromo della minimal music: le oggi celebri Vexations (1893) di Eric
Satie, una breve frase musicale della durata
di pochi secondi da ripetere 840 volte, ma,
avverte il compositore, solo dopo una preliminare opportuna preparazione di severe
immobilità nel più assoluto silenzio.
Generazioni dopo, ecco John Cage con un
altro celebre aforisma protominimalista di
ispirazione zen: «Se qualcosa ti annoia per
due minuti, provalo per quattro. Se è ancora
noioso, provalo per otto, sedici, trentadue e
così via. Alla fine scoprirai che non è affatto
noioso ma molto interessante».
L’apparente contraddizione fra minimalismo e ripetizione, dilatazione, si scioglie se
però mette a fuoco quell’elemento che, in
effetti, la poetica del minimal nelle sue varie
accezioni tende a ridurre tendenzialmente
a zero. Questo elemento è la nozione stessa
pensare all’ambiguo interscambiarsi di due
di «poetica», ragione per cui il minimalismo
categorie come minimalismo e ripetitività, tecnon è affatto una poetica, ma una condotta
nica quest’ultima ricorrente, anche se non
razionale derivante dalla decisione di riduresclusiva, dell’arte minimalista. Una prima
re al minimo, fino ad azzerarla, la presenza
contraddizione si lega al fatto che la ripetiingombrante dell’artista e della sua interiorizione produce una crescita, uno sviluppo
tà individuale.
quantomeno dimensionale, per cui la musiSol Lewitt, altra figura chiave dell’epopea
ca e l’arte dette ripetitive, proprio in quanminimal, nei suoi Paragraphs on Conceptual Art
to basate sulla ripetizione, sono portatrici
(1967) scrive: «L’artista sceglierà la forma badi un’intrinseca negazione di ogni tensione
silare e le regole che governeranno la soluverso la riduzione, verso il minimo possibizione del problema. Dopodiché, meno sale. E invece il più delle volte le due categorie
ranno le decisioni prese nel corso del comvengono di fatto identificate.
pletamento dell’opera, meglio sarà. VerranIn circolazione già dagli anni trenta, fu sono in questo modo eliminati il più possibile
lo nella seconda metà degli anni sessanta che
gli arbitrî, i gesti capricciosi e soggettivi».
il termine minimalism entrò nell’uso abituaCome nello strutturalismo europeo, ma
le della critica d’arte, per essere poi applicaanche sull’onda lunga dell’anti-romanticiSol Lewitt, Untitled, 1992
to, all’esordio dei settanta, anche alla musica
smo parigino primo novecentesco, targato
ad opera di Michael Nyman e di Tom Johnin pari misura Satie e Cocteau e, infine, in
son, critico musicale del «Village Voice», rianalogia con le motivazioni della chance music
guardo ai quali ancora talvolta si perde tempo a discutere su chi
di Cage, ciò che si vuole minimizzare o sopprimere è per l’apfu il primo.
punto la troppo ingombrante individualità dell’autore in quanSia nelle arti plastiche e visive, sia in ambito musicale, il minito artista o poeta.
mal ha dato luogo ad alcune delle creazioni singole più ampie
Regole, procedure, automatismi, meccanicità, materiale, riper estensione e per durata che mai siano state concepite. Basti
petizioni, moltiplicazioni, simmetrie, sfasature, geometrismo,
pensare alle cinque ore di Einstein on the Beach, opera che è vista
rigorismo, astrazione. Nel minimalismo, si tratti di installaziocome un manifesto della minimal music, oppure alle composini, creazioni pittoriche o musicali, c’è quasi sempre tutto quezioni di LaMonte Young o a certe sue installazioni la cui durata
sto. Tranne qualche dettaglio (ma proprio a Mies van der Rohe
è virtualmente infinita. Quanto alle arti visive l’idea minimalisi attribuisce l’affermazione che «Gott ist im Detail»), il cocktail
sta è strettamente connessa a tendenze artistiche quali la Land
è il medesimo di quasi tutte le incarnazioni delle avanguardie
novecento / parte seconda
speciale —
speciale
novecentesche che, da Stravinskij al postwebernismo, hanno
le e come tema di una aperta ribellione al mondo accademico.
ripudiato il principio espressionista, conseguendo però risultaNelle mani di Reich, Glass, Riley e di altri autori più giovani
ti evidentemente e profondamente diversi fra loro e, in buona
(Adams, Torke, Bryars, ecc.), minimalismo diviene uno stile fasostanza, apertamente inconciliabili, almeno in prima istanza.
miliare, basato sulla ripetizione di brevi, semplici cellule sottoSul terreno pittorico, l’area della Minimal Art ha confini tanposte a lenti processi di trasformazione che si offrono all’ascolto variegati quanto sfuggenti. Ai suoi vari punti cardinali, il mitatore chiaramente percepibili e afferrabili. Un tessuto musinimal confina e si confonde con l’arte concettuale, con la Pop
cale regolarmente pulsante, armonicamente statico e non diArt, col New Dada e anche con l’espressionismo astratto rirezionale, si trasforma gradualmente davanti ai nostri «occhi»
spetto al quale il minimal reagisce e si distanzia. Un compositoguidandoci per mano attraverso questo lento mutamento.
re come Morton Feldman, in così profonda sintonia con artisti
Il meccanismo minimal spesso ha in sé qualcosa di inesorabiquali Rothko, Kline, De Kooning o Guston, vale a dire i massile, eppure l’effetto che ne risulta è fortemente attrattivo e rassimi esponenti dell’espressionismo astratto,
curante per l’ascoltatore. Certo, questa muviene a buon motivo definito minimalista
sica rifiuta di darsi un marchio autoriale diin virtù del suo stile dalle sonorità prosciustintivo. Ma questa disumanizzazione sul
gate, rarefatte e dilatate del tempo. E quepiano teorico, viene ampiamente compensto nonostante le sue composizioni parlisata dal riportare finalmente il compositono una lingua diversissima da quella di Terre davanti al suo pubblico in vesti di perry Riley, Philip Glass o Steve Reich, lo storiformer alla testa del suo ensemble. In ultico terzetto che ha divulgato e ha decretato
ma analisi ciò che viene ridotto al minimo
il successo della minimal music e l’affermaè la tradizionale complessità sintattica della
zione del suo stile compositivo come uno
musica colta, sostituita da una spiccata semdei tratti più fortemente caratteristici della
plicità e trasparenza del processo, incessannuova musica di fine secolo.
te e, a suo modo, capace nei risultati miglioIn Feldman, come nell’espressionismo
ri di eccitare l’attesa per la trasformazione
astratto, il senso minimale di un’opera è lein corso. Sequenze paratattiche in luogo di
gato piuttosto ai minuti o minutissimi incostrutti ipotattici: una elementarità interterventi sul materiale, sul diradarsi degli
pretabile come abbruttimento o come rivoelementi in gioco e sulla loro tendenza alluzione, come sovversione di un pensiero e
la staticità. Nell’uno e nell’altro sono invece
di un linguaggio plurisecolari.
Mark Rothko, Orange
ben presenti il segno e il carattere dell’opeIl successo del minimalismo musicale è
rato e della presenza dell’artista, presenza
espressiva e anche lirica. Al contrario, nel
minimalismo più strettamente inteso questa presenza è accuratamente neutralizzata.
La geometria modulare, le forme industriali, nette e levigate prendono il posto delle superfici screziate e finemente tormentate, così come l’introversa contemplatività di Feldman lascia il campo al programmatico anonimato dei processi graduali, del phase shifting, della pulsazione costante, della regolarità tecnologica di una macchina da presa
che sgrana uno dopo l’altro i suoi fotogrammi: alla lontana, infatti, si intravedono ancora le sequenze fotografiche di Muybridge e il
nudo che scende le scale di Duchamp.
Il rigore inesorabile di Robert Morris, Dan
Flavin o Sol Lewitt, anche se era fortemenMorton Feldman
te interessato ai meccanismi percettivi del
pubblico, non aveva certo alcuna intenzione di «piacere» nel senso tradizionale. Eppure la Minimal Art piacque, forse perché quelle opere, anche
se in modo più intellettuale e sottile della Pop Art, esorcizzavano la sottile angoscia generata dallo stereotipo perfetto e dal
sempre uguale della produzione industriale, declinandolo e nobilitandolo in arte.
Per Glass e compagni invece il problema della distanza fra
il pubblico da un lato e l’accademia dall’altro, di ciò che Kyle
Gann ha chiamato «the Gap», individuandolo come elemento chiave della nostra epoca musicale, si poneva come centra-
stato certamente superiore alle stesse aspettative dei suoi autori. Un successo che l’altra
parte del mondo musicale, quella che Feldman chiamava l’academic Avantgarde, non
gli ha mai perdonato. La minimal music e i
suoi derivati, ampiamente intrecciati con le
tendenze più intellettualizzate e sperimentali della popular music (trance, ambient,
drum&bass, new age, ecc.), e spesso inclini
alla maniera stilistica, sono stati e sono ancora additati talvolta quale emblema di una
resa dell’arte a un’eccessiva semplicità e faciloneria per riconquistare il favore del pubblico, come un tradimento di quella complessità di pensiero e di scrittura che per lungo tempo, in musica più ancora che altrove,
è stata invece eletta a incarnazione stessa del
valore estetico. Si tratta di una collocazione
decisamente asimmetrica rispetto al campo
delle arti visive, dove il minimalismo ha rappresentato uno dei coté più rigorosi e severi
nel novero delle recenti tendenze pittoriche statunitensi. Proprio per questo, certi giudizi liquidatori sulla minimal music
sembrano scambiare la causa con l’effetto, laddove si insinua
che il successo di pubblico sia stato il movente anziché il risultato. La minimal music nei suoi esempi migliori e ormai storici si
caratterizza anch’essa per un rigore costruttivo e una coerenza
esemplari. Che poi essa sia divenuta moneta corrente, trasformandosi in stilema prelibato per jingles pubblicitari o per l’industria discografica, è il miglior elogio per un’avanguardia. ◼
— speciale
novecento / parte seconda
L’elettroshock rock:
industria
e modello giovanile
da ricostruire e una grande spinta tecnologica. La vittoria di inglesi e americani nel conflitto e la fine del modello autarchico nei paesi europei occupati o sconfitti cambiò anche i parametri culturali della società.
La musica neroamericana è stata sicuramente la grande novità del XX secolo. Il blues, il jazz, sono penetrati nella cultura
popolare americana ed europea affiancandosi alla tradizione e
contaminando o sostituendosi alle forme preesistenti.
La presenza militare americana nelle basi inglesi, francesi e
italiane portò a una contaminazione anche della musica popolare e di intrattenimento che vi veniva suonata. A Napoli come
a Liverpool, porti verso l’Atlantico e sedi di basi militari americane, i militari americani sbarcando portavano anche la loro
musica e chiedevano di ascoltarla nelle sale da ballo e da intrattenimento. Ma se in America la divisione fra musica di origine
afroamericana e musica per i bianchi era ancora netta e con due
mercati che non si contaminavano, in Europa questa divisione
razzista non aveva presupposti e i musicisti si orientarono indifferentemente verso qualsiasi forma musicale per loro nuova
e lontana dalle memorie di guerra. In più l’Europa liberata dal-
ca per lato.
Il rock’n’roll e il nuovo supporto
si integrarono alla perfezione.
Musica veloce, ritmata, dedicata a
un pubblico di teenager, il 45 giri era maneggevole, robusto e
per nulla ingombrante. La
seconda guerra mondiale di
fatto decompose il modello
standard di società e di famiglia. A differenza del periodo precedente in cui il
giovane era solo un
preadulto che doveva
conquistarsi il proprio posto nella società degli adulti imparandone quanto prima
e imitandone forme e formalismi, gli anni cinquanta
furono caratterizzati da
una gioventù insofferente agli schemi e che cercava una propria identità autonoma. In
questo senso i l
Elvis Presley
rock’n’roll divenne la musica che
rompeva gl i
schemi ed era fat-
la guerra aveva fame di novità e divenne un’occasione straordinaria per i musicisti americani, in particolare i neri, le orchestre
jazz, i solisti blues. I primi trovarono teatri e locali accoglienti a
Parigi, i secondi spazi interessanti a Londra.
Fino agli anni sessanta, la musica popolare o industriale nelle
sue varie forme si poteva considerare ancora solo e puro intrattenimento. Ma con delle nuove caratteristiche. La trasformazione dell’industria
bellica e il trasferimento delle tecnologie portò fra l’altro all’evoluzione del
supporto discografico, con l’invenzione del microsolco e del disco
di cloruro di polivinile (vinile), composto chimico introdotto nel 1943. Il disco da 17
cm di diametro a 45 giri è
ideale, per il
t rasporto e l’immagazzinamento,
e per la
d iff usione di canzoni singole di
circa tre minuti di durata. La sua
versione a lunga durata, da 30
cm e 33 giri e 1/3 è perfetto invece per contenere più brani fino
a un massimo di 25 minuti cir-
ta direttamente da teenager che si rivolgevano a teenager con il
loro linguaggio e raccontando il loro mondo. Da un punto di
vista strettamente musicale, il rock’n’roll fondeva elementi
preesistenti di musica popolare americana come il blues elettrico, il country & western, le melodie pop. Si trattava ancora di
musica di intrattenimento dai testi ingenui ma che faceva proprie alcune delle novità dell’epoca, come la chitarra elettrificata, e la fusione dei generi, anche se la comunità nera continuava a usare la propria musica e a rivolgersi al vecchio mercato dei
78 giri e dei Race Records e molti dei brani di autori e interpreti neri erano ripresi da interpreti bianchi e «edulcorati» nell’interpretazione e nell’arrangiamento per renderli «accettabili» ai
genitori dei ragazzi bianchi di buona famiglia. Tutto questo
finché in televisione, l’elettrodomestico attorno a cui si raccoglieva ogni sera l’intera famiglia, non
comparve all’improvviso Elvis
Presley. «Trovatemi un
bianco che canti come
un negro», aveva detto il produttore e discograf ico Sam
Phillips, «e farò un
milione di dollari». Elvis era quel
bianco. La società
a misura di teenager aveva anche
un’altra caratteristica, quella di mostrare in un mondo
L
di Giò Alajmo
Ch
u
ck
Be
rry
speciale
A FINE DELLA seconda guerra mondiale lasciò un mondo
speciale —
novecento / parte seconda
in ricostruzione e impoverito dalla guerra, che i giovani con
scarse prospettive potevano trovare da sé una forma di espressione e di guadagno immediato nella musica. Va da sé che si
trattava di un modo effimero e incolto, ma che sicuramente
metteva in discussione ancora una volta le forme organizzative della società preesistente. A questo si aggiunse un altro tassello. Se il problema della Gran Bretagna era di essere stata dissanguata e semidistrutta dalla guerra, l’America si trovava ad
affrontare per la prima volta il ruolo di superpotenza mondiale con in mano un potenziale bellico distruttivo impressionante. Dover fare i conti con la Bomba atomica e i desideri di
speciale
The Beatles
con la svolta elettrica di Dylan, nel’70 le sue varianti «hard»,
«metal» e «prog» (tra Deep Purple, King Crimson e Yes), e alla
fine del decennio il punk (Clash, Sex Pistols) come reazione alla nascita del «classicismo» rock e della disco music e dell’ingresso massiccio di strumentazioni elettroniche e computer
nella produzione musicale e l’influenza sempre più pesante dell’industria discografica, che portarono anche, come reazione,
a un clamoroso interesse per il reggae giamaicano (Bob Marley, Peter Tosh) in cui si riconoscevano alcuni elementi comuni alla cultura hippy degli anni sessanta, e il successivo dissolvimento delle forme musicali nell’hiphop nato nei ghetti urbani
neri d’america, tutto ritmo e parole con rime interne. Una cosa
certa è che tutti questi generi hanno un progenitore comune o
con cui devono fare i conti. Il blues. Il Blues è la chiave di lettura del Novecento musicale. Il blues e il rock’n’roll sono alla base della musica britannica degli anni sessanta, quella dei Beatles e dei Rolling Stones. Ma non ci sarebbero stati né gli uni né
gli altri se a Liverpool e poi a Londra non fossero sbarcati con i
soldati americani anche i dischi di rock’n’roll, di jazz e di blues
portati da questi ultimi. I ragazzi facevano a gara per impossessarsene, studiare a orecchio armonie, ritmo, melodie e parole e
riprodurli in concertini o sale da ballo. Il blues (o «i blues», ma
noi teniamo la dizione per genere), aveva la caratteristica di essere molto espressivo e molto semplice da suonare. Cantare i
blues significava cantare il proprio animo, ma anche sesso,
droga, alcool, violenza, prostituzione, temi cari alle bettole dov’erano nati. E per esprimere uno stato d’animo le parole potevano esser superflue, bastava il suono degli strumenti. I blues
nascono come forma musicale essenziale. La tecnica di base è
ridotta al minimo. Lo schema ripetitivo e semplice consente a
espansione di altre potenze non amiche come l’Unione Sovietica e la Cina aveva portato gli americani a combattere nuovamente in Corea e ad affrontare con scarse prospettive di accomodamento la successiva crisi in Indocina. Alle tensioni esterne si aggiungevano poi quelle interne giocate interamente sulla battaglia per i diritti civili, minacciati dal maccartismo e dal
razzismo che ancora segregava negli stati del sud i neri. I movimenti di protesta e per i diritti civili negli anni cinquanta avevano avuto tra le loro conseguenze la rinascita di una forma di
canzone politica e sindacale che serviva a esprimere e divulgare il dissenso e a denunciare le storture, gli abusi e le ipocrisie
del sistema di potere americano. La canzone di protesta aveva
un suo parallelo nella letteratura e nella poesia che si stavano
sviluppano negli anni del rock’n’roll. Le visioni anticonformiste, pacifiste, erotiche, libertarie, visionarie e controcorrente
dei poeti e degli scrittori Beat, da Jack Kerouac a Allen Ginsberg, ebbero una considerevole influenza nella cosiddetta
controcultura americana degli anni cinquanta. E sebbene la loro visione della musica fosse più orientata verso i mantra indiani e buddisti e il jazz, erano destinate ad avere una considerevole influenza sulla cultura giovanile e sugli artisti del periodo,
anche se l’invito espresso dai poeti beat di provare ad «allargare la mente» fu inteso in maniera più lisergica che culturale. I
critici e gli storici della musica popolare hanno suddiviso comunemente la musica pop della seconda metà del Novecento
in una catena di grandi filoni più o meno collegati fra loro. Si
concorda che a metà degli anni cinquanta si sviluppò il
rock’n’roll, che ebbe in Elvis Presley e Chuck Berry i suoi esponenti più rilevanti, nei primi anni sessanta il «beat» con Beatles
e Rolling Stones, e il folk revival con Bob Dylan, nel ‘65 il rock
chiunque di entrare facilmente nell’esecuzione di altri e con
qualunque strumento, lasciando ampi spazi al virtuosismo.
Dal blues nasce il ragtime, il jazz, le contaminazioni di Gershwin, ed è alle radici della musica inglese degli anni sessanta
che abbiamo chiamato negli anni beat, pop, rock. Soprattutto
quello che Muddy Waters ha trasformato in blues elettrico nel
1948 a Chicago, terminale della lunga strada che dal delta del
Mississippi aveva portato i neri dai campi di cotone verso l’inurbamento nelle più ricche e liberali città del nord degli Stati Uniti. Il rock’n’roll nella sua forma essenziale è una specie di blues
veloce, tanto che in origine era difficile distinguerlo dal blues
elettrico e ritmato degli artisti neri se non per il fatto che artisti
bianchi e pubblico bianco ne erano rimasti coinvolti. Musica
da ballo e da intrattenimento derivata dal boogie, forma di
blues veloce con tutte le note di basso ostinato raddoppiate a
sedicesimi e in voga già negli anni trenta. Esplode con il 45
The Rolling Stones
— speciale
novecento / parte seconda
speciale
giri e la nuova generazione dei teedinali, necessari per comprendenager del Dopoguerra, ma le sue
re o rappresentare l’innovazione
radici avevano già penetrato il
musicale della seconda metà del
terreno in passato. Quando il
‘900 sono sicuramente il poenero Chuck Berry mescola la
ta rock americano Bob Dylan,
forma canzone con il blues
e probabilmente il chitarrista
elettrico, inventa uno stile chidi Seattle Jimi Hendrix. Questi
tarristico scarno ed efficace che
quattro «elementi», due inglesi,
diventa il suo marchio di fabbridue americani, interagendo fra
ca, caratterizzato da brevi riff inidi loro si trovano a influenzare e
ziali che si ripetono prima delle
modificare l’intero panorama mustrofe e da assoli strumentali inseriti
sicale. L’intuizione di Dylan è utilizall’interno dei brani, e offre ai giovani
zare la tradizione del cantastorie folk
chitarristi dell’epoca uno stile con cui conper
raccontare i propri tempi con un lins
T h e Ya r d b i r d
frontarsi per decenni. Nello stesso periodo in
guaggio diretto ironico e poetico. Dylan si ricui il rock’n’roll erutta dalle radio e dai dischi, in
fà alla tradizione folk americana bianca e nera, utilizAmerica si scopre la musica classica indiana grazie alla collabozando linee melodiche popolari, ballads e talking blues, scrirazione fra Yehudi Menuhin e il sitarista Ali Akbar Khan. Quevendo canzoni politiche, di protesta e inni generazionali che
sto porta nel 1959 il pregevole sitarista Ravi Shankar, fratellaaccompagnano le marce di Martin Luther King e dei seguaci
stro di Ali Akbar Khan, a prendere la via dell’Occidente. La
del movimento pacifista. Nel 1965 la sua prospettiva cambia,
curiosità e la voglia di ricerca di nuove strade per i musicisti desi unisce a una band di blues elettrico e rende improvvisamengli anni sessanta è straordinaria. Shankar si trova a collaborare
te adulto il mondo musicale giovanile aggiungendo alla forma
con Miles Davis e poi con i padri del minimalismo americano,
del rock’n’roll il contenuto di un pensiero poetico e letterario
da Terry Riley a Philip Glass, offrendo di fatto una via per uscinello stile dei poeti Beat. Le origini di questo cambiamento sore dalle convenzioni occidentali, a partire dalla musica. Sopratno probabilmente da ricercarsi tra Liverpool e Londra. I Beatutto la nuova musica popolare si dimostra perfetta per le aptles sono quattro ragazzi di Liverpool, città florida per la musiplicazioni dell’elettricità e delle nuove tecnologie. Il sogno dei
ca giovanile proprio per la sua caratteristica di approdo militafuturisti come Luigi Russolo che nel 1913 preconizza il `900
re per le navi americane. In circa otto anni diventano il punto
come secolo dei rumori, e inventa le macchine «intonarumodi riferimento degli anni sessanta. Cultura, estetica, moda, speri», le intuizioni di Ferruccio Busoni che nel 1907 preconizza
rimentazione, tecnologia, mercato, strategie di marketing, al-
l’uso di dissonanze e suoni elettrici nelle composizioni trovano
applicazione già negli anni trenta con l’invenzione del primo
magnete per amplificare la chitarra da parte di Adolph Rickenbacker, e dell’organo elettromagnetico di Laurens Hammond.
La chitarra elettrica all’inizio è solo una chitarra normale a cui
sono stati applicati dei magneti. Lo scopo è quello di consentire al chitarrista di farsi sentire in una sala affollata o in un’orchestra dominata dai fiati. Per i musicisti blues a questo scopo
era stata ideata una particolare chitarra metallica con un grande risuonatore sulla cassa che fungeva da amplificatore naturale. Il problema di evitare i rumori fastidiosi provocati dalle interferenze fra cassa e magneti è risolto da Leo Fender che nel
1953 inventa la chitarra elettrica a corpo solido. La chitarra elettrica diventa
lo strumento del rock. E l’elettricità
diventa la portante della nuova
musica.
Beatles e Rolling Stones sono
due punti cardinali per la musica popolare contemporanea. Il loro stile, le loro sperimentazioni e il periodo in cui si
sono trovati a operare hanno consentito
loro di fissare come dei parametri operativi, dei termini di confronto o di essere fonti di
ispi razione
per la musica venuta dopo
di loro. Gli altri due punti carBob Dylan
lucinogeni, cinema, filosofia, religione, economia. Quasi tutto
passa o attraversa il mondo dei Beatles.
Beatles e Rolling Stones possono considerarsi assolutamente complementari per quello che in forme diverse, una specie
di Yin e Yang, hanno rappresentato nell’evoluzione della musica a partire dagli anni sessanta. I Beatles hanno caratterizzato la loro musica con felici impasti vocali, cori a due, tre, quattro voci, armonie originali e inedite e una continua ricerca sul
suono, innovativa per l’epoca considerato che la tecnologia del
tempo non offriva molto. I Rolling Stones sono stati (sono tuttora) il prototipo ideale della rock band dal vivo, un cantante,
un basso, due chitarre, una batteria. La loro gavetta è stata diversa da quella dei Beatles, ma non dissimile da quella dei tanti gruppi rock’n’roll dell’epoca. Per entrambi i gruppi la prima
esperienza è stata la riproduzione di brani di rock’n’roll americano. Ma a differenza dei Beatles – che si rifacevano allo stile
dei gruppi vocali americani di Doo Wop, e sostenevano piuttosto una rivalità con i Beach Boys – gli Stones possono vantare una scuola musicale di puro stampo blues che deriva dalla frequentazione di uno dei grandi palcoscenici blues inglesi,
quello di Alexis Korner. I Rolling Stones e i Beatles sono gruppi, band, «complessi» come si diceva all’epoca. Non possiedono una cultura musicale accademica. Non sanno scrivere musica e non conoscono regole di armonia tradizionali. Presi singolarmente non sono neppure tecnicamente dotati in maniera
rilevante. Di nessuno dei componenti i Rolling Stones o i Beatles si può dire sia o appaia come uno straordinario virtuoso
del proprio strumento. Ma questa è la loro forza. Per quel che
riguarda i Beatles, l’assenza di una cultura musicale accademica è compensata dalla grande fantasia che li porta a cercare so-
novecento / parte seconda
percorsi paralleli
armonizzati.
Luigi Nono diceva che «la musica non è mestiere, non è artigianato, la musica è pensiero». Il pensiero che è alla base
della musica dei gruppi degli anni
sessanta, come Beatles e Rolling Stones è che questa deve essere il prodotto
casa propria. In questo caso Jimi Hendrix, il nostro «quarto
elemento». Invece in Inghilterra comincia a farsi sentire presto
l’influenza del minimalismo. I raga indiani di Ravi Shankar, le
composizioni di Terry Riley e Steve Reich, di Philip Glass sono esperimenti interessanti nell’Inghilterra psichedelica che
cerca una colonna sonora per viaggi allucinati, ma anche per
giovani musicisti come Soft Machine o Pink
Floyd che cercano di uscire dallo schema
canzone dei Beatles, con McCartney che è
invece affascinato da Karlheinz Stockhausen, oltre ad apprezzare Magritte. La fine
dell’attività concertistica, poco più di tour massacranti da un palco all’altro a tentare inutilmente di urlare contro l’urlo continuo di folle in delirio, porta i Beatles a
diventare nel 1966 un gruppo da studio lasciando a film e arcaici videoclip il compito di diffondere la propria immagine in
tutto il mondo. A Abbey Road, cominciano a cercare una nuova strada oltre il beat. Il terreno di scambio culturale nella metà degli anni sessanta è fertile e complesso. Le ricerche sull’elettronica cominciano a produrre i primi sintetizzatori basati su
oscillatori, e artisti pop come Andy Warhol in America o Mario Schifano in Italia cercano un rapporto diretto con la musica, più aleatorio quello di Schifano, più articolato quello di
Warhol che interverrà nella produzione e promozione dei Velvet Underground di Lou Reed disegnando fra l’altro la copertina del loro primo album (una banana sbucciabile in campo
bianco) e aggiungendo alla formazione la modella-cantante e
più tardi, realizzando un paio di copertine di album dei Rolling
Stones, i jeans con cerniera di «Sticky fingers», le foto incerottate di «Love you live». Il rock entra prepotentemente anche
di un insieme, di una collaborazione, di un contributo collettivo. La musica diventa figlia di un «autore collettivo». Il successo commerciale dei Beatles e in misura minore dei Rolling Stones spinge una quantità enorme di giovani a percorrere la stessa strada. Il successo planetario sembra rispondere a un’esigenza sociale e generazionale a dispetto delle convenzioni e delle autorità costituite. Certamente, ben orchestrate campagne
promozionali fanno dei Beatles il primo fenomeno mediatico «globalizzato» che si ricordi e aprono il vaso di Pandora dell’identità giovanile. Ma la Beatlemania nella prima metà degli
anni sessanta ha anche l’effetto di diffondere uno stile musicale comune e originale a tutto il mondo occidentale e di portare all’attenzione dell’America bianca la musica originale dei neri americani, sia pure filtrata dalle personali interpretazioni di
giovani bianchi europei.
L’incontro tra Bob Dylan e i Beatles in America nel 1964 fu
fondamentale per l’evoluzione della musica pop contemporanea. Dylan si convinse che i suoi temi potevano essere efficacemente trasferiti su un territorio musicale di rock elettrico e i Beatles, circondati dal mondo effimero dei fan, si resero conto
che era possibile espandere il loro stile con una cura maggiore
per i testi e i suoni, meditando l’inserimento di parti orchestrali e di strumenti esotici come il sitar indiano. Lo «scambio» culturale musicale fra Gran Bretagna e Stati Uniti produce anche
un altro effetto. Di ritorno dagli Stati Uniti il bassista degli Animals – una della quattro prime grandi band britanniche dei
primi anni sessanta, con Beatles, Stones e Yardbirds – porta
con sé a Londra un giovane chitarrista nero. Al suo ritorno negli Stati Uniti gli americani si accorgeranno di aver avuto ancora una volta bisogno degli inglesi per accorgersi dei talenti di
nel grande cinema, grazie a Michelangelo Antonioni che affronta lo scontro generazionale in Zabriskie Point musicato dai
Pink Floyd e la swingin’ London in Blow up in cui compaiono in
un cameo gli Yardbirds che imitano la distruzione simbolica e
rituale degli strumenti, mutuata dagli Who. La tecnologia degli anni sessanta era piuttosto rudimentale. Niente computer,
niente transistor, registratori a nastro piuttosto
ingombranti sulle cui bobine potevano essere incise al massimo 4 tracce, 8 in America, negli studi più evoluti. Se fino al
1965 la registrazione dei brani era effettuata praticamente in diretta, scegliendo l’esecuzione migliore, ed effettuando
eventualmente poche sovraincisioni a
causa della perdita di qualità di ogni passaggio in un continuo ping pong
da una traccia all’altra, la scelta
dei Beatles di usare lo studio di registrazione come
un ulteriore strumento
portò a vari esperimenti. McCartney era solito girare per le strade
e registrare ogni tipo di suono, rumori di traffico, uccelli, da utilizzare
successivamente.
In assenza di computer i lavori di
speciale
luzioni armoniche o timbriche sempre diverse e imprevedibili, coadiuvati in questo da George Martin, produttore della Emi che ha invece una cultura classica e una grande disponibilità al nuovo.
Se i Beatles danno il loro meglio in studio, i Rolling Stones
hanno la loro forza nell’equilibrio delle parti e nel rispetto del
brano, che si trasforma dal vivo in un rapporto di grande impatto nei confronti del pubblico e in una solida costruzione
strumentale. Gli Stones hanno anche il pregio di restituire al
blues la sua fisicità, la sensualità ruvida e radicale della musica
delle origini. Con i Rolling Stones prende sempre più forma l’idea blues di una musica strumentale con uso di
voce, in cui le due chitarre
si alternano nelle parti ritmiche e soliste
creando anche
speciale —
Jimi Hendrix
— speciale
novecento / parte seconda
speciale
taglio e collage erano affidati ad abili tecnici dotati di forbici e
lavora molto con il volume. Tutta la storia del rock’n’roll è donastro adesivo. Altri esperimenti erano compiuti facendo giraminata da una ricerca di fisicità, si rapporta con il movimento
re nastri al contrario o creando dei loop, dei cicli continui, o
del corpo, il sesso, la ribellione alle convenzioni. Hendrix inmettendo in collegamento più registratori. Gli «effetti speciacarna tutto questo. Il suo rapporto con lo strumento è fisico e
li» disponibili si limitavano ad apparecchi per la creazione di
sessuale, la sua esibizione eccita e turba facendo sfoggio di un
eco o riverbero, e la saturazione del suono delle chitarre creata
repertorio circense, i suoi assoli sono accompagnati con il cordalle valvole degli amplificatori spinti oltre il limite. Presto il
po quasi a condurre fisicamente le note verso l’obiettivo desiparco giochi del chitarrista si sarebbe arricchito di distorsori,
derato. E in questo rapporto fisico cercato nella musica del
fuzz, wah wah, utilizzati dai Rolling Stones per il riff di Satisfactempo è componente essenziale il volume di suono. Il rock
tion ideato da Keith nel 1966 a imitazione di una sezione di fiati
(che in inglese evoca la roccia ma anche lo scuotersi) diventa
R&B e da Jimi Hendrix, vero maestro dell’esplorazione estrecon Hendrix qualcosa che colpisce duro come una roccia e
ma del suono nei quattro anni di carriera che precedetscuote ma al tempo stesso sa perdersi nei sogni e nelle
tero la sua morte nel settembre 1970. Ma già nel
malinconie del blues. Il volume è usato da Hen1968 gli esperimenti di Robert Moog sui sindrix per scuotere e produrre dalla chitarra
tetizzatori elettronici di suono avevano
sonorità estreme grazie all’innesco causaprodotto un album dimostrativo assoto dal suono sui magneti dei pickup.
lutamente innovativo, Switched on BaCon l’uso controllato dei larsen, dei
ch di Walter Carlos – oggi Wendy – a
controlli di fase, delle distorsioni,
dimostrazione di come la frontiera
della tensione delle corde la chitardel suono potesse essere ulteriorra di Hendrix diventa uno strumente abbattuta. A rendere pomento che suona come nessuno
polare questo strumento – già
aveva immaginato prima. E mai
usato sperimentalmente da alcucome in lui la chitarra diventa un
ni gruppi dell’epoca come gli Who,
oggetto di culto che finisce per
fu soprattutto l’uscita nel 1971 del
bruciare in scena in una specie di rifilm di Kubrick Arancia meccanica,
to voodoo. Nondimeno Hendrix è
poco dopo la diffusione sul mercato
un grande musicista che ha il blues e lo
del Minimoog, versione portatile delsviluppa immergendosi nella cultura vil’«armadio» dai mille cavi del ‘68. L’uso delvace e colorata della Londra psichedelica.
The W ho
l’amplificazione e dell’elettricità in se stessa
Dai Beatles acquisisce la curiosità per l’uso del-
modificano il rapporto fra il musicista e il pubblico e fra il musicista e il suo strumento. L’amplificazione consente di raggiungere platee molto più vaste, e di sottrarsi ad alcune «necessità»
dell’era musicale precedente. Se il teatro d’opera necessita di
voci impostate, corpose sezioni di violini e sale risuonanti per
farsi ascoltare, con la musica elettrica tutto ciò diventa superfluo. Come dice Riccardo Cocciante a proposito delle sue opere popolari «Adesso c’è il microfono», che consente di cantare
con maggiore espressività, di usare modi colloquiali e sussurrare. Un’intera sezione di archi può essere sostituita da una sola chitarra elettrica, strumento che – sostiene il violinista Nigel
Kennedy – è molto più affine per tecnica e suono al violino che
alla chitarra tradizionale che – afferma – è più imparentata con
il clavicembalo. Jimi Hendrix estremizza il modo di suonare la
chitarra elettrica e cambia radicalmente la visione che si ha dello strumento. E lo fa in trio. La sua tecnica è totalmente non
convenzionale a partire dall’utilizzo
di uno strumento rovesciato
che gli consente di intervenire più facilmente sui
controlli di tono e volume e sulla leva del
tremolo e variare
anche brutalmente la tensione del le
corde. Hendrix utilizza
pochi effetti
speciali ma
lo studio di registrazione come vero e proprio strumento. Ma
alcune sue rivisitazioni di brani di Bob Dylan chiudono alla
perfezione il cerchio fra comunicazione poetica e forma strumentale. La ricerca sonora di Hendrix è simbolo di un periodo,
la fine degli anni sessanta, che cerca in ogni modo di superare i
limiti della musica popolare, di espandere la conoscenza, di
rapportarsi con un pubblico sempre crescente che fa della musica un catalizzatore e la propria principale forma di espressione. A questo mondo finisce per rivolgersi anche il jazz con Miles Davis che compie, come Dylan nel ‘65, la sua svolta elettrica in Bitches Brew riunendo attorno a sé l’intera nuova generazione di jazzisti, da John McLaughlin a Herbie Hancock, da Chick Corea a Joe Zawinul e Wayne Shorter. L’album comincia a
essere inciso proprio il giorno successivo all’esibizione di Jimi
Hendrix a Woodstock, quella in cui il chitarrista trasferì con il
suo strumento nell’inno nazionale americano l’intero dramma
sonoro della guerra in Vietnam.
L’influenza di Hendrix e del suo stile chitarristico chiusero il
tempo dell’adolescenza musicale e aprirono la strada alla ricerca e alla contaminazione di un rock (non più solo rock’n’roll)
adulto e tecnicamente più elevato, così come l’influenza di Bob
Dylan (più volte candidato al Nobel della Letteratura e recentemente vincitore del Pulitzer) aprì la strada alla cosiddetta
«canzone d’autore». Le strade erano tutte aperte e l’industria
dello spettacolo aveva ormai preso possesso della nuova forma di divertimento di massa facendo della musica popolare
una forma di arte industriale, con tutte le sue contraddizioni.
Ciò che viene dopo, con l’avvento dei computer e la diffusione dell’elettronica, delle macchine da musica più o meno automatiche, appartiene ancora più alla cronaca che alla storia. ◼
novecento / parte seconda
Un oscuro, incerto,
fragile, forse unico
varco d’uscita
speciale —
ella presunzione di esser ascesi su una vetta e di osservare dall’alto, ci si domanda: «Che cosa ci ha dato il secolo
XX?». La domanda potrebbe essere assennata, se prima ci si ponesse un altro, più importante quesito: «Che cosa ci ha
sottratto, il Novecento?» Avvertiamo con disagio, e ammettiamo di malavoglia, che il saldo è negativo. Il Novecento ci ha elargito tanti utili oggettini, e ci ha derubati subdolamente di beni incomparabilmente preziosi: ha ridotto a un margine irrisorio la libertà individuale, ha coartato e imprigionato nella gabbia del culturalmente corretto (dell’eticamente corretto,
del politicamente corretto, del religiosamente corretto, del linguisticamente corretto…) ciò che in un passato prossimo, ma tanto perduto da
sembrare remoto, era il λόγος critico
e maieutico. E sarebbe ancora il male minore, poiché l’etica, la politica, le
norme civiche, sono strumenti utiThe Invaders, 1961
li ma rozzi, approssimativi, empiri-
mi cento anni. Ed ecco, oggi, il miserando spettacolo, il rigurgito
bigotto, arrogante, sovente delinquenziale della peggiore intolleranza, per giunta camuffata con i panni populistici e terzomondistici della «solidarietà», della «carità», di un questuante «non abbiate timore di aprire le porte», di una «accoglienza» che maschera un furbastro tornaconto da magliari e ciarlatani. Lo zerbino su
cui pulirsi le scarpe è l’universale Paura, la virtuosa e «non violenta» Santa Tremarella di un potere vile e laido, preoccupato soltanto di conservare sé e i propri organi di riproduzione, e mascherante il tutto sotto le sembianze di «apertura» e «democrazia». All’intorno, il querulo, tronfio, pacchiano, ostentato fasto di vecchi e
nuovi culti e riti che rendono infernale la qualità di vita dei cittadini; masse esagitate, salmodianti, cantillanti, ululanti e annitrenti.
Su tutto, il trionfo del Brutto.
Varianti di quest’ultimo sono i tristi trionfi celebrati dal Novecento su altre vittime sacrificali. Avrei dovuto dire, forse, «dal secondo Novecento», poiché la fase cosiddetta «storica» del secolo XX, ossia la sua prima metà o quasi, fino alla seconda guerra mondiale, non lasciava prevedere con certezza i futuri
desolanti fenomeni. Ma la desolazione, epifania innegabile nella seconda
metà del secolo e oltre, fino ad oggi, e
oggi protesa verso più crudeli approdi, era già nelle premesse, anche se ne
erano consapevoli soltanto rarissimi chiaroveggenti. Fra essi, Ferruccio Busoni (Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, 1906), e stranamente
ci, meri puntelli o rattoppi, per non dire della religione che è sciocchezza puerile, da respingere per decenza e per buona creanza se
soltanto si sia adulti. No, il male maggiore è la goffaggine recente
dell’esteticamente corretto, e questo è davvero il vulnere mortale inferto a una civiltà che ha, non foss’altro, il merito di avere prodotto
Tristan und Isolde e la Divina Commedia, la Politeia e le Duineser Elegien, il
Pervigilium Veneris e Also sprach Zarathustra. È il colpo di grazia, poiché l’estetica è il più alto criterio di giudizio, anzi, l’unico possibile, l’unico nobile e onorevole. Quel vulnere, quel colpo di grazia,
quella misericordia la cui lama trafigge a tradimento di notte sulla
sponda di un maleodorante canale, è il laido trionfo dello Stato e
della Chiesa, della burocrazia e dell’usura (in senso poundiano...),
del poliziotto e della toga d’ermellino sull’intelligenza, sulla libertà di pensiero, sul concetto di superiorità e inferiorità che dovrebbe esser il sacro fondamento di ogni società, anzi, dell’Essere in sé,
laddove di quel concetto, dell’esistenza di una superiorità e di un’inferiorità, il legislatore e il prete, il giudice e il gendarme, il ricco e il potente hanno fatto strame. Lo dico con un animo opposto a quello con cui Tacito si accingeva a narrare gli Annales: non «sine ira et
studio», bensì con odio e con ira. E con desolazione. Il secolo XX
si era annunciato in un’aura confortante: nell’anno 1899 erano venuti alla luce Die Traumdeutung di Freud e Verklärte Nacht di Schönberg, nel 1900 Max Planck formulò la teoria dei quanti studiando
la radiazione elettromagnetica, nel 1906 Albert Einstein presentò la teoria della relatività in forma ristretta, le donne si preparavano ad ottenere i diritti civili in Occidente. Persino in Italia, da quasi duemila anni fiaccata dal’insanabile piaga di Amfortas, dall’incunearsi del potere clericale al centro del suo corpo vivo, la superstizione religiosa era finalmente screditata e derisa. Una ragione
laica e austera, elegante e sobria, prometteva d’illuminare i prossi-
il suo avversario Hans Pfitzner Futuristengefahr, 1917; Neue Ästhetik
der musikalischen Impotenz, 1919), insieme con Walter Benjamin (Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 1936) e con
la sinistra profezia espressa da Theodor W. Adorno in vari suoi
scritti (soprattutto in Einleitung in die Musiksoziologie, 1962): l’imminente estinzione della musica d’alta tradizione occidentale, ossia
della musica d’autore, rigorosamente scritta e fissata secondo norme immutabili per la prassi esecutiva, autoreferenziale e fondata
su un’estetica del tutto autonoma, a (triste) conclusione di un ciclo
durato più o meno cinque o sei secoli. A parte questi vividi lampi
di preveggenza, il primo Novecento continuò a rivestire la grande
musica di splendidi apparati scenici: compositori acclamati e venerati come eroi nazionali (Wagner, Čajkovskij, Brahms, Johann
Strauss jr., Verdi, Puccini, Elgar, ma anche Giordano e Mascagni,
e persino Lauro Rossi di cui si ricorda la memorabile traslazione
di salma lungo la nostra penisola con incredibile concorso di folla
in ogni stazione ferrovaria toccata dal convoglio funebre), direttori, cantanti, strumentisti di riconosciuta grandezza divinizzati e
sommersi dalla ricchezza acquisita con la loro arte, arroventato interesse e attesa spasmodica (non senza l’accendersi di bellicose fazioni) per le nuove musiche, teatri d’opera considerati i templi laici della civiltà occidentale.
Il secondo Novecento ha detronizzato i teatri d’opera e ha impoverito di spazio e d’ossigeno la grande musica strumentale. I teatri
d’opera hanno perduto la propria centralità e primalità nella sfera
dello spettacolo teatrale e musicale, e oggi sono un’opzione marginale, di minoranza, e (ciò è il peggio del peggio) riguardano il gusto residuo delle generazioni anziane. Sono «roba per vecchi». Ciò
è avvenuto lentamente e impercettibilmente dopo la prima guerra mondiale, gradualmente e con più sensibile accelerazione ne-
speciale
N
di Quirino Principe
— speciale
novecento / parte seconda
speciale
gli anni quaranta e cinquanta, rovinosamente e velocissimamente
si il permesso di controllare quel passo, gentilmente ma con la nadagli anni sessanta in poi (guarda caso, a partire dalla fase culmituralezza delle cose ovvie egli mi porse la partitura, e fui appaganante dell’era di Darmstadt). Ha perduto pubblico, e soprattutto
to e felice. Felice, ma non incredulo: non mi pareva una miracolopubblico giovane, con una caduta a picco accertata da innumeresa coincidenza quell’incontro. Non mi pareva, badate, allora, nelvoli statistiche. Forse questo non è stato un male: in parallelo con
l’aprile 1978. Ma certo: quella sera c’era a Milano un concerto imquesta perdita di spazio, di respiro e di udienza il teatro d’opera si è
portante, si supponeva che se non proprio folle oceaniche almeanche liberato da un’immensa e spuria zavorra di pattume e di lino un cospicuo flusso di giovani e meno giovani (studenti di Conquame, espellendo masse di melomani chiassosi, volgari e ignoservatorio, universitari, persone di buona cultura… ma sì, Milano
ranti, e volgendosi a una élite. Dico «volgendosi» almeno potennon era forse una delle città musicalmente più colte e più attive in
zialmente... ancora oggi ci sarebbe da realizzare una drastica puItalia, con tante orchestre, quella della RAI, quella dell’Angelicum,
lizia, soprattutto in occasione delle serate inugurali di stagione in
quella dei Pomeriggi, quella della Scala… ahimé, sto parlando di
teatri come la Scala o il San Carlo o il Metropolitan, dove alla pricenere e di foglie secche, «mais ou sont les neiges d’antan?») si dirima assoluta di apertura accorre la (ricchissima e potentissima) fecgesse in fretta al Conservatorio. Una supposizione, allora, perfetcia della società: i padroni del vapore, oppure i variopinti esemtamente realistica; un fenomeno, allora, dato per scontato. Anche
plari del genere «grand commis» di Stato. Tuttavia, se il fenomeil giovanottone non si stupì affatto della richiesta a lui rivolta da un
no suddetto non è interamente negativo, a parte il pauroso invecquarantatreenne signore sull’autobus.Anch’egli dava per scontachiamento del pubblico che soltanto che Milano fosse piena di giovani
to in minima parte riproduce il terrie meno giovani attratti dalla Seconda
ficante invecchiamento della popodi Mahler e incontrabili su qualsiasi
lazione, è anche vero che la visione di
mezzo pubblico.
teste esclusivamente candide o calTutto questo, oggi, sarebbe imposve in platea osservabili dal loggione è
sibile, ed è impensabile. E il 1978,
qualcosa che stringe il cuore.
nella coscienza e nella memoria di
La «reductio ad minimum» della
chi appartenga alla mia generazione
musica non operistica, il disintereso a quella dei miei figli, è l’altro ieri,
se delle nuove generazioni per quelè dietro l’angolo. Ho libri acquistati
l’incomparabile tesoro che è il repernel 1978 che non ho ancora utilizzato
torio strumentale e vocale in ambicompletamente, in casa mia si usano
to sinfonico, cameristico, pianistico,
aggeggi domestici acquistati nel 1978
Max Planck con Albert Einstein
corale (liturgico e profano), liederi(o prima) i quali funzionano perfet-
stico, madrigalistico, polifonico, medievale, è avvenuta in tempi
più recenti. Il fenomeno è stato tanto insidioso da coglierci di sorpresa. Io stesso me ne sono accorto veramente quando tutti i buoi
erano fuggiti dalla stalla. Ancora negli anni settanta, una numerosissima presenza di giovani e giovanissimi ravvivava le sale di concerto. Giovani, tra i 18 e i 30 anni, erano i sessantottini e post-sessantottini che andavano in massa ad ascoltare Pollini interprete di
Beethoven o di Boulez e polemizzavano con le sue dichiarazioni
politiche oppure le condividevano. Ho viva memoria dei ragazzi
che alla fine degli anni settanta e al principio degli ottanta correvano ad ascoltare Matacić dirigere la Nona di Bruckner, o Ceccato
che ci faceva ascoltare da par suo la Quarta di Schubert e Verklärte
Nacht di Schönberg. Nella primavera del 1978, a Milano, mi trovai
su un autobus, diretto al Conservatorio, con la meravigliosa prospettiva di ascoltare la Seconda di Mahler diretta da Aronovič. A
metà del percorso, con grande disappunto mi accorsi di avere dimenticato a casa la partitura tascabile della sinfonia mahleriana:
a quei tempi, coltivavo l’abitudine un po’ infantile (e oggi abbandonata) di portare sempre con me, andando ad ascoltare un qualsiasi concerto, le partiture o gli spartiti di ciò che avrei udito. Naturalmente, fui colto da un’ossessione, analoga a quella del fumatore anche non del tutto dipendente dal vizio, il quale mentre è in
viaggio si accorge di non avere con sé le sigarette, i fiammiferi, la
pipa, il tabacco… Fui invaso dalla smania di verificare sul pentagramma l’orchestrazione e la sintassi armonica di un certo passo dello Scherzo, ed è probabile che quella smania non mi avrebbe assalito se avessi avuto con me il mio amato tascabile «Philharmonia». Ed ecco, all’improvviso vidi nell’autobus un giovanotto
grande e grosso dalla barba nera mal rasata che teneva in una mano proprio il «Philharmonia» n. 395: la Seconda di Mahler. Gli chie-
tamente, e in casa li sentiamo come «nuovi», «moderni». Rapidissima, vertiginosa è stata la metamorfosi con cui i pubblici poteri (il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario), vuoi per ottusità vuoi
per odio deliberato nei confronti di tutto ciò che è intelligenza,
cultura superiorità intellettuale, hanno demolito ciò che io chiamo «musica forte» (un’aggettivazione di cui rivendico il brevetto e
l’esclusiva) e che altri impropriamente chiamano musica «classica» o «colta» o «seria», riservando al fin troppo noto pattume sonoro la qualifica altrettanto impropria di musica «moderna», qualora prediligano il pattume suddetto, e tali sono per esempio le ragazzotte da spiaggia e da discoteca balneare, o i candidati alla Presidenza del Consiglio, o tanti giovani e meno giovani preti e suore
(ma perché «moderna»? forse Boulez e Ligeti sono medievali, o
liberty…?), oppure la qualifica non meno assurda di musica «leggera» (perché, Vivaldi e Chopin e Offenbach e Johann Strauss jr.
e Ravel sono «pesanti»?). Con errore di pari calibro, coloro che invece detestano il suddetto graveolente pattume lasciano intendere, parlando di musica «colta» o «seria», che il pattume sonoro sia
musica «incolta» e «ignorante» oppure «poco seria» o «tutta da ridere», ciò che evidentemente non è, poiché le varie rock stars che
raccolgono questa volta sì folle oceaniche nelle piazze consacrate
ai comizi di quei formidabili rivoluzionari che sono i sindacalisti
espongono, nei testi delle loro creazioni, velleità nientemeno che
civili e politiche, e in genere assumono i toni della lamentazione
perenne e lacrimante al succo di cipolla. Poiché io mi sforzo (almeno mi sforzo…) di onorare il λόγος e la logica, giudico pertinente
definire il succitato pattume acustico «musica debole», e ciò in riferimento ai suoi connotati di ripetitività, di lagna sedativa e diuretica, di appiattimento delle sensazioni anche là dove ci sarebbe la
velleità di produrre chissà quali «scosse» o «pugni nello stomaco»,
novecento / parte seconda
speciale —
gli strumenti per coglierli. Perché non li possiede?
Rispondere in misura esauriente e in maniera convincente a
questa domanda sarebbe già un primo passo per affrontare l’angosciosissima crisi che la musica sta attraversando oggi in occidente, mentre in culture «altre» per quanto assimilate o assimilabili (per favore, evitiamo l’odiosa parola «globalizzazione»), fra cui
spiccano quelle dell’Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea, in
parte anche l’Asia sud-orientale), la musica forte d’impronta occidentale sembra godere di diversi destini, e per ragioni che sarebbe
facile e persino confortante analizzare: ma qui, l’analisi c’imporrebbe una deviazione. Ritorniamo perciò alla domanda cruciale:
perché il pubblico occidentale d’oggi non possiede gli strumenti
per capire e accogliere i significati della musica forte che nasce nella
nostra contemporaneità, e nasce, quasi dopo un misterioso peccato originale, «partorita con dolore»?
Una risposta molto illuminante è stata certamente quella di
Hans Sedlmayr in Verlust der Mitte
(1948), uno dei sommi saggi d’estetica del secolo XX: ¨le arti, un tempo costrette a convivere nello stesso ambito sia spazio-temporale (l’architettura di una cattedrale, il tempo
sacro) sia mentale (la preghiera, la liturgia, i referenti cristiani), si proteggevano e nutrivano a vicenda, anche
se i vincoli della convivenza soffocavano o quanto meno rallentavano gli
sviluppi di ciascuno dei vari linguaggi artistici preso in sé. La pittura per
eccellenza era la pala d’altare o l’affre-
musica forte è vittima di una sorta di sacrificio umano, a vantaggio
della musica debole che, quasi interamente oramai, ne ha usurpato
gli spazi, i tempi e i ruoli.
L’aspetto più vistoso del lascito è riassunto nella constatazione
di Adorno: il pubblico del Settecento ascoltava quasi soltanto musica del Settecento, il pubblico dell’Ottocento ascoltava quasi soltanto musica dell’Ottocento, il pubblico del Novecento ha ascoltato quasi soltanto musica del Settecento e dell’Ottocento. Nel secolo XX, nessuno saprebbe dire esattamente quando né dove né
come né per opera di chi né a partire da quale oggetto specifico, il
giocattolo si è rotto. Lo splendido gioco delle perle di vetro non è
stato più giocato, e si è svolta soltanto la ripetizione dei giochi precedenti, prima con ebbra fiducia di scoprire la nuova vena aurea,
poi con stanco sconforto o con cupa rassegnazione o con la freddezza del baro.
Ciò che genera maggiore tristezza è il fatto indubbio che nell’intero arco cronologico del Novecento è nata moltissima grande
musica, grazie al lavoro di compositori di grande talento e di ammirevole onestà intellettuale che alla musica hanno donato i loro forzi generosi e talvolta eroici, male ripagati e soprattutto non
compresi. Ciò è avvenuto poiché è nel destino della musica occidentale imporre ai significati tanta ricchezza e tanta tensione da
gonfiarli e tenderli al di là del possibile, sino a farli esplodere frantumandoli. L’interruzione del rapporto di comprensione e d’intesa (vorremmo dire: «di complicità», «d’amicizia») tra la maggioranza dei compositori del Novecento e il pubblico dei loro contemporanei, più che un problema di gusto, è una difficoltà di natura semantica. I significati della musica occidentale nata negli ultimi decenni non soltanto esistono, ma sono anche forti e pieni di
un λόγος implicito. Il pubblico non li coglie poiché non possiede
sco nella navata o nella cappella o il mosaico nell’abside, la scultura per eccellenza era l’effigie marmorea o lignea di un santo sepolto nella chiesa stessa, la poesia per eccellenza era la litiurgia (oppure la sua dissacrante parodia, come avvenne nei Carmina Burana),
la musica per eccellenza era il cantus firmus liturgico, il teatro per eccellenza era la sacra rappresentazione, dapprima collocata accanto all’altar maggiore, poi sul sagrato. Più tardi, le arti si separarono: la pittura trasmigrò nelle pinacoteche o nei palazzi regali e signorili, la scultura nelle gliptoteche, negli atri e nelle piazze solenni, la poesia nei palazzi nobiliari, nella Accademie, nelle Università dove divenne disciplina didattica, poi sulle riviste specializzate e nelle case editrici. La musica fuggì anch’essa nei palazzi del
potere laico, poi nei teatri pubblici e negli auditorii di varia natura,
nonché nei salotti dei nobili e nelle ricche case borghesi, e anch’essa infine nei Conservatorii, nella pubblicistica specializzata e nell’editoria musicale. Il teatro seguì, in parallelo, una strada simile a
quella della musica, e le due arti s’incontrarono nel teatro d’opera:
fu un connubio ricchissimo di esiti insperati, straordinari, lungo
un prodigioso sviluppo che dall’austera Rappresentazione di anima e
corpo di Emilio de’ Cavalieri e dalla seriosa Dafne di Peri giunge fino al peccaminoso, dionisiaco e luciferino approdo del Sublime
in Tristan und Isolde di Wagner.
Separate, autonome, libere di respirare in vasti spazi e in tempi secolarizzati, le arti si sono irrobustite, hanno trovato gratificazioni imprevedibili, al di là di ogni speranza; ma non si sono
più nutrite a vicenda. Illanguidita la parentela, esse si sono immalinconite, e hanno perduto a poco a poco la capacità di parlarsi e
di comunicare. Troppe volte si sono decontestualizzate (brutta
parola, lo so!), o hanno corso il rischio di esserlo definitivamente. Oggi è urgente una ricontestualizzazione (parola addirittu-
speciale
di miserevole povertà. Tutto questo va detto in opposizione logica e terminologica a «musica forte», senza alcun intento offensivo
e con un richiamo analogico all’opposizione tra pensiero forte e
pensiero debole in filosofia.
Le opzioni terminologiche che precedono le ho formulate, questa volta sì, «sine ira et studio». La definizione, rispettosissima, di
«musica debole» dovrebbe esserne garanzia, poiché si appella a un
aggettivo d’ambito né etico né estetico e neppure utilitaristico
ma soltanto a un grado d’intensità dinamica, a un meccanismo
di priorità e posteriorità. Dire «pattume» è indicare non qualcosa di ripugnante, ma un effetto residuale, ossia ciò che avanza, un
di più e di troppo, qualcosa d’inutile poiché c’è già l’elemento forte
che adempie a tutte le funzioni necessarie. Lo stesso sarebbe parlare di «liquame»: una materia restante che infastidisce con il suo
«di troppo» e con la sua mistura, ma nulla d’immorale e neppure
di brutto: infatti non di brutto si tratta, ma d’insignificante. Tuttavia, se è vero che il mio giudizio non
assolve né condanna ma constata, è
altrettanto vero che la constatazione è desolata. Nel suo insieme, lungo
le due sequenze che sul terreno della
musica percorrono il Novecento storico (mirabile metamorfosi, proliferazione delle possibilità, moltiplicazione di linguaggi e stili diversi, crisi)
e il secondo Novecento (crisi, allontanamento dal pubblico, autoreferenzialità, separazione dal pubblico, incubo «adorniano»), il secolo XX ci
Theodor Adorno
ha lasciato un asse ereditario in cui la
— speciale
novecento / parte seconda
infestano la «casa» entro un ambito sfruttatissimo dal cinema, gli
enigmi della corruzione di potere politico e polizia, l’orrore «archeologico» alla maniera delle avventure di Indiana Jones celebrate da Harrison Ford. La fenomenologia or ora descritta è tutt’altro
che superficiale: declinare in musica, secondo diversi casi e tempi e modi, un iper-tema vasto e complesso, ricchissimo sia emotivamente sia figurativamente sia narratologicamente, dà modo
al compositore per film di farsi le ossa e di affilare gli strumenti di
lavoro. La straordinaria musica per The Invaders, che precede cronologicamente tutti i film prima citati e dotati di musiche goldsmithiane, è in verità un prodotto di genio. Rispetto alle svariate e
abilissime contaminazioni che incontriamo in Planets of the Apes o
in Alien o in Chinatown eccetera, essa è pura, radicale, originalissima invenzione d’avanguardia musica, la più dura a digerirsi per le
orecchie di un vasto pubblico dei secoli XX-XXI. Eppure, organizzata in The Invaders e ricontestualizzata figurativamente, narrativamente e culturalmente, quella
musica «passa», e l’ascoltatore medio
la capisce perfettamente, e non certo perché gli elementi extramusicali «spieghino» o «raccontino» un discorso di suoni organizzati che altrimenti nessuno intenderebbe. No:
semplicemente, a contatto con gli altri elementi del film (tema, soggetto,
sceneggiatura, movimento, sequenze…) è come se una bacchetta magica sciogliesse la lingua a quella musica asperrima inducendola a guardarci in faccia e a parlarci.
seri che hanno invaso la sua dimora da incubo. Si scopre alla fine
una mezza verità: la donna (?) combatte contro alieni giunti da un
altro pianeta, e ne ha orrore. Ma la verità intera emerge alla fine: gli
alieni sono terrestri, siamo noi, ed è la creatura «altra» e vagamente femminile l’essere di un altro pianeta gelido e tenebroso. Questo cortometraggio ha per colonna sonora la musica di Jerrold G.
Goldsmith, nato a Los Angeles nel 1929 e autore, fra l’altro, delle musiche per film come Lonely Are the Brave («Solo sotto le stelle»,
1962) di David Miller, Planet of the Apes («Il pianeta delle scimmie»,
1968) di Franklin J. Schaffner, Tora! Tora! Tora! (1970) di Richard
Fleischer, Chinatown (1974) di Roman Polanski, Alien (1979) di Ridley Scott, The Omen («Il presagio», 1976, Oscar per la musica) di
Richard Donner, Poltergeist (1982) di Tobe Hopper, L. A. Confidential (1997) di Curtis Hanson, The Mummy («La mummia», 1999) di
Stephen Sommers. La musica di Jerry Goldsmith segue uno stile diverso per ogni diverso film, e questo induce a definire il musicista californiano come eclettico, versatile, mimetico, adattabile.
Tuttavia nei diversi stili circola un’aria di famiglia poiché i soggetti
stessi (e i significati) dei nove lungometraggi che ho citato convergono verso un canale collettore: l’angoscia dinanzi all’ignoto, declinata nella sue varianti. Nell’ordine con cui abbiamo nominato i
film citati: la desolazione della solitudine in spazi immensi, lo stupore folle dinanzi all’improvvisa apparizione del diverso (si noti che
Rod Serling, ideatore della serie The Twilight Zone, è anche uno degli
sceneggiatori di Planet of the Apes), la tensione in seguito a un attacco tremendo e improvviso di un sanguinario nemico, un sinistro
intrico d’inconfessabili misteri familiari, la fantascienza e l’orrenda presenza aliena (un’area narrativa affine a quella di The Invaders),
il Diavolo nel mondo moderno secondo il filone ideativo esaltato da Rosemary’s Baby e da The Exorcist), i fantasmi e gli scheletri che
È recente la riflessione, intrisa di umor funereo, che con rara intelligenza ci comunica Goffredo Fofi (Memorie al presente, in «Film
TV», XVI, n. 6, 29 giugno - 5 luglio 2008, pp. 24-25). Osserva Fofi: finita l’epoca delle rivoluzioni e della speranza del futuro, tornano ad essere importanti gli autori che hanno ragionato in termini
sovrastorici: Dreyer, Buñuel, Fellini, Kubrick. Per il resto, in Italia e altrove impera la «frenesia damsiana», i critici cinematografici
sono diventati professori, che fanno al massimo autopsie di cadaveri, oppure i critici-funzionari, che non campano più con i giornali, ma con festival, rassegne, trasmissioni, oppure gli assessori
alla cultura e il loro modello, il veltronismo. «Il cinema è morto, è
morta la funzione democratica e progressista che ha rappresentato nel Novecento».
Le parole di Fofi valgono in pieno nel momento presente. Tuttavia, ci permettiamo di aggiungere che il cinema, grande valore culturale in sé e grande lascito del Novecento, può svolgere anche un compito ausiliario e propellente senza perdere autonomia. Il cinema può essere l’oscuro, incerto, fragile, forse unico varco d’uscita dalla crisi che investe arti di esso più antiche per
nascita storia, ma non forse per destino segnato ab origine, negli
archetipi dell’invenzione riservata agli artisti. Certo, la musica è
linguaggio assoluto, e i suoi significati possiedono un’eloquenza integrale. Eppure – ed è un innegabile paradosso – le innumerevoli occasioni in cui la musica si associa ad altri linguaggi danno esiti di grande bellezza e di profondo significato, e aggiungono «qualcosa in più». Forse il paradosso non è più tale se osserviamo che quegli altri fattori linguistici aggiungono qualcosa non alla musica bensì al destinatario del’associazione tra linguaggi: a noi
che ascoltiamo. La musica è comunicazione assoluta di significati, ab aeterno: noi siamo relativi e perennemente incompleti. ◼
speciale
ra orrenda, ma comunque ci siamo capiti…) delle arti. Ne abbiamo le prove. Per esempio, un linguaggio musicale che provenga
dall’avanguardia dartmstadtiana pone seri problemi di significato alla maggioranza del pubblico, ma diventa accettabile e persino emoziona quando si leghi a un testo incisivo nel quadro di un
melòlogo. Ma l’esempio più convincente mi sembra quello del cinema. Già nel 1930 la Begleitmusik für eine Lichtspielszene di Arnold
Schönberg si configurò, pur con tutta la sua difficoltà di accoglimento da parte del pubblico di allora, come modello di efficacissime e graditissime colonne sonore di film dal tema orrorifico o
misterioso o angoscioso. Vorrei limitarmi, avviandomi alla conclusione, a un esempio dal quale, a suo tempo, fui molto colpito.
Mi riferisco alla serie di cortometraggi The Twilight Zone ideata da
Rod Serling e realizzata negli Stati Uniti da Cayuga Productions,
e in particolare a un lavoro geniale, The Invaders, diretto da Douglas
Heyes e trasmesso per la prima volta da un’emittente americana
venerdì 27 gennaio 1961. Il soggetto è di Richard Matheson, e mette in
scena un unico personaggio che abita in un «non luogo», un tugurio che
più squallido e pauroso non potrebbe essere su una landa gelida e perennemente buia. Il personaggio unico
è una donna (?), interpretata da una
splendida attrice, Agnes Moorehead
(pseud. di Agnes Robertson, 19001974), la quale per un’intera notte (ma
notte e giorno sono tutt’uno, poiché
le tenebre sono eterne) deve combatPlanet of the Apes, 1968
tere contro orrendi e microscopici es-