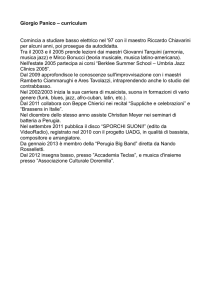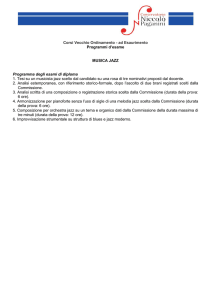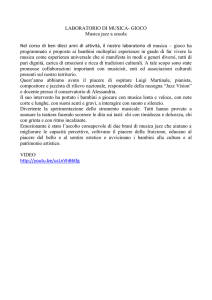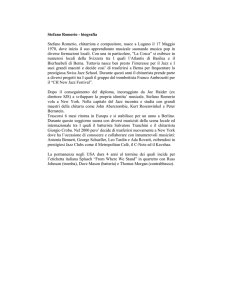Jazzmoment
42%.4!. . )$)*!::!,3 !) .4,/5 )3
JAZZ MOMENT
Il Saint Louis è una grande realtà culturale giunta ai giorni nostri
attraverso un lungo periodo storico denso di rivolgimenti artistici
e mutamenti sociali. Frutto e al tempo stesso amplificatore della
istintiva e prorompente esuberanza a dir poco rivoluzionaria degli
artisti figli degli anni Settanta, il Saint Louis ha vissuto e sofferto
la crisi creativa degli anni Ottanta che, tra nostalgiche autocitazioni del decennio passato ed un uso smodato di elettronica –
alla ricerca di qualcosa che di nuovo aveva ben poco – è approdata, alla fine del millennio, ad un’apparente riscoperta della tradizione, ad una dimensione di creatività pura e colta al tempo
stesso, ad un rinnovato gusto di vivere il Jazz non più in fumosi
Club semi-interrati, ma in teatri e sale da concerto.
Dal 1976 il Saint Louis ha cavalcato, spesso condotto, a volte indirizzato il fenomeno jazz verso obiettivi e linguaggi nuovi, talvolta errando, altre volte precorrendo avveniristiche correnti
artistiche; un visionario tempio della musica che ha saputo accogliere con lo stesso spirito i primi veri pionieri del Jazz, musicisti
e pubblico, ma anche coloro che negli anni vi si sono avvicinati a
volte per tendenza modaiola o per curiosità, a volte spinti da un
sano interesse, fino alle moltitudini che nel nuovo millennio fanno
la fila – più o meno composta – ai botteghini.
Oggi il Saint Louis è Scuola di Jazz con oltre millequattrocento
allievi provenienti da tutta Italia ed alcuni Paesi europei, con tre
sedi nel cuore di Roma, ma è anche agenzia artistica e di management, etichetta discografica “Jazz Collection”, nonché editore
di una collana didattica e di “Italian Jazz Real Book”, la prima
antologia di partiture di Jazz italiano distribuita in tutto il mondo.
In questa pubblicazione abbiamo raccolto suoni e immagini inedite, alcune firmate da professionisti altre da improvvisati testimoni, inconsciamente consapevoli di vivere un fuggente attimo
che nessun media sarà mai in grado di riprodurre, un momento
musicale dove la creazione estemporanea dell’artista si è alimentata della percettibile energia di un pubblico sincero, un momento
ispirato e travolgente, un momento di Jazz.
Stefano Mastruzzi
ACURADI
!DRIANO-AZZOLETTI
-ARCO-OLENDINI
3TEFANO-ASTRUZZI
Jazzmoment
4 2 % . 4 ! . . ) $ ) * ! : : ! , 3 ! ) . 4 , / 5 ) 3
1
Jazzmoment
4 2 % . 4 ! . . ) $ ) * ! : : ! , 3 ! ) . 4 , / 5 ) 3
Organizzazione e coordinamento:
Francesca Gregori, Giorgia Mileto
Interviste di:
Rossella Azzone, Marta Bragantini, Ilaria Cardegna,
Silvia Circelli, Marina Conti, Anna Ferrari,
Rossella Gaudenzi, Valentina Giosa, Claudio Mannello,
Caterina Monti, Corinna Nicolini
In copertina:
DIZZY GILLESPIE
foto Paolo Soriano
Foto di:
Livio Anticoli, Mario D’Agati, Marco Mancini, Andrea Muti,
Napolitano e Giambaldo, Andrea Pacioni, Fabrice Parfait,
Stefano Ragni, Andrea Sabatello, Paolo Soriano,
Antonio Stracquacursi
Jazz
Adriano Mazzoletti TRENT’ANNI DI JAZZ A ROMA...
5
...E AL SAINT LOUIS
7
Marco Molendini
Mario
CIAMPÀ
Roberto
GATTO
Enrico
RAVA
Danilo
REA
Enrico
PIERANUNZI
Marcello
ROSA
Giovanni
TOMMASO
Maurizio
GIAMMARCO
Paolo
FRESU
Antonello
SALIS
zmoment
3
8
18
26
36
46
52
68
78
88
94
TRENT’ANNI DI JAZZ A ROMA...
Adriano Mazzoletti
ai come negli anni Sessanta e
Settanta, Roma è stata visitata
dai grandi del jazz. Tutto era iniziato a cavallo fra il 1949 e il ’50 quando,
uno di seguito all’altro, erano giunti Louis
Armstrong con Jack Teagarden, Earl Hines e
Cozy Cole, Duke Ellington con la sua orchestra dove suonava Don Byas che aveva sostituito un giovanissimo Charlie Rouse, che arrivò al Sistina qualche anno dopo con il quartetto di Thelonious Monk ed infine Benny
Goodman con Zoot Sims, Toots Thielemans,
Roy Eldridge e il pianista Dick Hyman, che
sarebbe poi approdato alla corte di Woody
Allen come autore o meglio coordinatore
delle musiche che Allen inserisce nei suoi
film.
E poi la “grande bouffe” con tutti. Jazz at the
Philarmonic, quante volte! Ricordo una sera
al Sistina una jam incredibile fra Coleman
Hawkins, Sonny Stitt e Stan Getz che “ci davano dentro” a più non posso. Tanto che
Norman Granz, straordinario impresario,
M
5
ma con una mentalità un po’ teutonica, irruppe sul palco facendo smettere quei tre
sassofonisti tenori che si stavano “sfidando”
all’ultimo chorus. Granz li fece smettere perché avevano superato il tempo che lui, il capo assoluto, aveva messo a loro disposizione.
Le duemila persone che affollavano il teatro
insorsero e se Garinei non avesse chiamato
una paio di pattuglie di P.S., Granz sarebbe
finito molto male.
Probabilmente con un bagno nella fontana
del Bernini. Granz promise di non mettere
mai più piede nella Città Eterna. Promessa
che mantenne per molti anni.
Ma i grandi del jazz continuarono ad arrivare e l’elenco sarebbe enorme. Ricordo, la prima volta di Sarah Vaughan in un teatro semideserto.
Un genio come Phineas Newborn jr. accoppiato chissà perché ai Mills Brothers, così
come Lucky Thompson, Oscar Pettiford,
Kenny Clarke, Martial Solal e Stéphane
Grappelli abbinati a Paul Anka, nello stesso
concerto al Brancaccio. Intanto Roma si popolava di jazz club, che ospitavano musicisti
italiani e stranieri. E le jam session fiorivano
ogni notte o quasi. Una sera da Bricktop, il
locale che la celebre entertainer, che nel
1922 aveva lanciato Ellington a New York e
nel 1934 il Quintetto dell’Hot Club di Francia a Parigi, aveva aperto a via Veneto, fu
teatro di una notte indimenticabile dove allo stesso tavolo, per meglio dire un tavolinetto, dato che il locale di Bricktop era piuttosto angusto, si ritrovarono Louis Armstrong
appena rimessosi da una brutta broncopolmonite che lo aveva colpito a Spoleto, Ella
Fitzgerald, Roy Eldridge e Dizzy Gillespie a
Roma con il Jazz at the Philarmonic, prima
che a Granz gli girassero.
Il pianista Tom Fornari, il chitarrista Angelo
Baroncini e il contrabbassista Franco Pozzi,
che suonavano regolarmente in quello
straordinario posto, dove ogni notte succedeva qualcosa, si trovarono improvvisamente a dove accompagnare alcuni fra i più
grandi musicisti del secolo. Poi arrivarono i
concerti jazz radiofonici alla Sala A di via
Asiago che poteva contenere al massimo
centocinquanta persone.
Facevo i salti mortali per convincere l’intendente di palazzo e soprattutto i Vigili del
Fuoco che in quella sala potevano anche entrare trecento persone… magari un po’ stipate. E a via Asiago suonarono tutti, da Lionel Hamton ad Ornette Coleman, da Dexter
Gordon a Hampton Hawes, Johnny Griffin,
Kenny Clarke, Slide Hampton, Art Farmer,
Mary Lou Williams, Don Byas, Carla Bley
che con Gato Barbieri, Aldo Romano, J.F.
Jenny Clarke, Mike Mantler, all’epoca fidanzato abbastanza geloso della bellissima pianista, avevo fatto scritturare per quindici
giorni in sostituzione di Earl Hines, al ristorante Meo Patacca a Trastevere.Vennero an-
che Sergio Mendes, Max Roach e Steve
Lacy. I loro accompagnatori più o meno regolari, anzi, più che meno, erano Giovanni
Tommaso appena tornato dagli Stati Uniti,
Franco D’Andrea, Gegè Munari e Bruno Biriaco. Roma era veramente una della capitali del jazz europeo. Poi nel 1976 nacque il
Saint Louis. Club di jazz certo, ma anche
scuola di musica assai prestigiosa.
Le interviste contenute in questo bel libro
che esce, per il trentesimo anniversario del
Saint Louis Music School, sono a testimoniarlo.
Il cd omaggio che in poche copie è allegato
al libro contiene alcune tracce dei concerti
che fra la fine degli anni Settanta e all’inizio
del decennio successivo, Mario Ciampà, ha
organizzato nel suo locale. Testimonianze
per non dimenticare.
...E AL SAINT LOUIS
Marco Molendini
in quegli anni Settanta, gli anni
in cui nacque il Saint Louis, che
il jazz cominciò a diventare in
qualche modo romano. Nel senso che il
rapporto con la città cominciò a farsi
stretto, non più un fatto occasionale e
quasi carbonaro per pochi appassionati
incalliti e pronti a tutto.
Certo, c’era già il Folkstudio, piccolo grande
luogo d’incontro per ogni genere di musica
fin dagli anni Sessanta.
C’era il Music Inn del principe batterista Pepito Pignatelli, epico tentativo di trovare
una prima casa per il jazz.
Arrivò l’Estate romana di Renato Nicolini
che cominciò a mescolare le carte con i suoi
grandi appuntamenti all’aperto, a chiamare
appassionati ma anche curiosi, orecchianti,
semplici presenzialisti. Perfino l’Accademia
È
7
di Santa Cecilia, allora impenetrabile, ebbe
un sussulto aprendo una cattedra di jazz con
Giorgio Gaslini (il sussulto fu presto domato e il corso soppresso). I club, così, crebbero e si moltiplicarono.
La cooperativa Murales a Trastevere, il Mississippi dei fratelli Toth a due passi dal Vaticano. Lo stesso Saint Louis che a differenza
degli altri (le panchine di cemento del Music
Inn, l’umidità del Murales) aveva una cura
estetica assolutamente insolita, perfino sorprendente.
A quei tempi il problema principale era
non pestarsi i piedi, perché la coperta del
pubblico, nonostante tutto, era corta: se
c’era un nome importante da una parte,
regola voleva che nessuno provasse a fare
concorrenza all’altro, pena il dimezzamento della platea, il cui zoccolo duro era
decisamente limitato. Eppure, passo passo, proprio in questo modo il jazz e i suoi
eroi (allora erano ancora vivi) hanno cominciato a diventare di casa a Roma:
Chet Baker fra i più assidui, sempre in disperata caccia di soldi, Charles Mingus
che svernò per alcune settimane durante
la registrazione della fantastica colonna
sonora di Todo Modo (che poi non fu utilizzata), il dandy Dexter Gordon, lo spaziale Sun Ra, Dizzy Gillespie con la sua
tromba periscopica, quel genio di Ornette
Coleman.
Proprio così il jazz è diventato di casa, abituando il pubblico ad ascoltarlo e permettendo a una forte generazione di musicisti
di ascoltare e imparare fino a formare una
vera e propria Roman Jazz Wave i cui frutti si vedono (e si ascoltano) oggi.
Mario
CIAMPÀ
Come nasce l’idea di fondare il Saint Louis?
Da alcuni giovani musicisti che suonavano
in una cantina e frequentavano il Music Inn,
il primo locale di jazz a Roma. Da loro nacque l’esigenza di aprire uno spazio più grande con prezzi più ragionevoli, molto orientato verso un pubblico giovanile. Mi chiamarono per ristrutturare un grande locale che
avevano trovato in via del Cardello. Un teatro di 450 mq abbandonato da più di un anno dopo aver subito gravi danni in seguito
ad un incendio. Quando andai a fare un sopralluogo, il primo impatto fu negativo: non
c’era luce, tutto bruciato ed umido, insomma
si doveva ricreare completamente.
Dopo più di un anno di lavori, fatti in economia con l’apporto fisico dei singoli soci, riuscimmo a metter su una specie di grossa cantina con poche sedie e un banco del bar rimediato. Poiché non potevano pagare il mio lavoro di
architetto, mi fecero entrare in società con loro.
Non ricordo i nomi dei musicisti. All’epoca
c’erano due anime nel jazz, una che amava il
jazz tradizionale alla New Orleans e l’altra
rappresentata da un gruppo di giovani musicisti che voleva suonare il bop, l’hard-bop.
Questo creava dei forti contrasti, una parte accusava l’altra di non suonare jazz e alla fine litigarono scindendosi in due parti contrapposte. Il club rimase chiuso per più di un anno
perché nessuno decideva come gestire il locale. Allora indicarono me come “paciere” ma il
tentativo fallì. Il locale restò chiuso altri quattro mesi e alla fine, per salvare il mio lavoro di
architetto, acquistai tutte le quote per dare
corso a quest’impresa.
Sebbene conoscessi poco di jazz, nelle dispute
tra jazz tradizionale e bop capivo che quel tipo di organizzazione non avrebbe funzionato.
Infatti, far suonare autodidatti e vendere una
birra a pochi soldi non era impresa remunerativa. Occorreva una conoscenza del settore,
del jazz in Italia e a Roma in particolare dove
esisteva un solo jazz club, con prezzi alti ma
con programmi di livello internazionale. Compresi che poteva nascere qualcosa di buono
Mario Ciampà con
Dizzy Gillespie
anche con musicisti locali ma affermati ed organizzando concerti di livello internazionale.
In poco tempo il Saint Louis Jazz Club divenne uno dei locali più importanti di Roma e poi
d’Italia, con musicisti come Eddie Jones, Archie Scheep, Max Roach, che all’epoca riempivano le piazze di Umbria Jazz.
Ho scoperto un mondo nuovo, affascinante,
ho scoperto la vita notturna, uno spirito diverso. A Umbria Jazz vedevo folle di giovani che riempivano le piazze, che dormivano
a terra, con alle spalle un movimento politico affine a quelle che erano le mie ideologie dell’epoca. Venivo dal Sessantotto, ho
trovato uno spirito sociale che dava forza al
jazz.
A differenza di altri che rimanevano chiusi
nei loro Club, ho iniziato a studiare, a capire, ad ascoltare, a prendere contatti a livello
internazionale. Per dare respiro a un locale
di 450 mq dovevo uscire dal guscio protettivo del Club. I compensi non erano quelli di
oggi, gli artisti venivano pagati in dollari
quando il dollaro era una moneta forte e i
prezzi dei biglietti erano politici per invogliare i giovani. I margini erano minimi ma
fu un successo, raggiungendo fasce di pubblico che non potevano permettersi locali
più cari.
Chi ha scelto il nome Saint Louis?
Sono stato io. Mi sono riferito al movimento
di avanguardia di Saint Louis. Molti credono
che il nome sia legato a “Saint Louis Blues”
un famoso pezzo jazz o a Louis Armstrong.
Invece mi sono riferito all’Aacm, il movimento dell’avanguardia afro-americano che prese
piede proprio dalla città di Saint Louis. Pochi
l’hanno capito ma ha funzionato perché il nome della città si ricordava facilmente.
9
Il Saint Louis presentava anche un design
particolare...
Il locale aveva inizialmente l’aspetto della
cantina. Andava bene così per un pubblico
che si accontentava, non chiedeva confort
ma solo buona musica. La cosa che fece
scalpore all’epoca furono delle poltroncine
acquistate in un vecchio teatro quando tutti i locali avevano sedie in legno piuttosto
scomode. Finalmente si offriva al pubblico
qualcosa di nuovo, un luogo diverso dove
rilassarsi, ascoltare buona musica e bere
una birra.
L’atmosfera al Saint Louis era rilassante ma
il clima in città molto meno, quali riflessi ha
avuto nella gestione del locale?
Il clima in città era molto duro, siamo agli
anni Settanta con le Brigate Rosse e le contestazioni.Via Cavour era centro di manifestazioni violente. In alcuni concerti abbiamo subito degli sfondamenti, c’erano grup-
pi di giovani che contestavano il fatto che
per la musica si dovesse pagare. Succedeva
un po’ dovunque. Cosa incomprensibile:
eravamo un club privato, senza finanziamenti pubblici, perché contestarci?
La Scuola è nata dopo diverse dispute.
Molti sostenevano che il jazz non si potesse insegnare perché è una tradizione essenzialmente orale con improvvisazione non
codificata e quindi non trasmissibile, ma
avvertivo l’esigenza di molti giovani musicisti che avrebbero voluto imparare dai più
grandi.
Così cercai di fare questa “connessione”, utilizzando i musicisti che venivano a suonare
al club, chiedendo di fare dei corsi nello stesso locale. I corsi di tenevano nel pomeriggio,
utilizzando pannelli per separare i vari ambienti, che poi venivano tolti a sera rimettendo le poltrone e allestendo il bar.
Si è andati avanti per un paio d’anni finché, per soddisfare le molte richieste di
corsi, decisi di aprire una vera e propria
scuola.
Mario Ciampà con
Stephane Grappelli
Elvin Jones
Quanto ha influito su questa scelta la chiusura in quel periodo del corso di jazz al Conservatorio di Santa Cecilia?
Molto poco. Contemporaneamente a noi nacque anche la Scuola di Testaccio. C’era un
movimento creato dai musicisti stessi, fino ad
allora un po’ in ombra, che mirava a diffondere il linguaggio jazzistico. Gaslini fu un faro nella nebbia, perché grazie a lui si capì che
il jazz si poteva insegnare, ma mentre lui
scelse la via accademica tanti altri musicisti,
che uscivano dalle accademie, volevano essere liberi d’improvvisare. Quindi no, la chiusura del corso jazz a Santa Cecilia non ebbe
influenza sulle nostre scelte, il movimento era
già abbastanza forte, in quel periodo la musica era un fatto sociale, un motivo di aggregazione per ascoltare e suonare insieme.
C’è una persona che le è stata d’aiuto in questa avventura?
Sì, è stato Bruno Tommaso, grande didatta
con ottime doti di organizzatore. Tommaso
era una persona preparata, veniva da Testaccio. In quel periodo c’era un’atmosfera diversa rispetto ad oggi, tra le varie scuole c’era collaborazione, ci si aiutava. Solo successivamente il Saint Louis si è distinto dalle altre scuole per l’imprenditorialità e la qualità
dei corsi. La scuola di Testaccio era nata come una cooperativa, un collettivo di musicisti che si autogestivano, il Saint Louis aveva
invece un proprietario che organizzava i corsi e pagava gli stipendi agli insegnanti.
All’inizio ci furono contestazioni e importanti dibattiti sul fatto che la musica fosse
un patrimonio popolare, ma alla fine si capì
che la strada giusta per una scuola duratura
nel tempo era quella indicata da noi, puntando sulla qualità dell’insegnamento anche
11
se i prezzi dei corsi erano più alti rispetto a
quelli delle altre scuole.
Ha parlato di collaborazione tra le varie
scuole, tra i locali il rapporto era lo stesso?
Direi di no. Il Music Inn, fino ad allora in regime di monopolio, non vide di buon occhio
la nascita del Saint Louis. Il proprietario,
Pepito Pignatelli, suonatore di batteria, aveva legami d’amicizia con i più grandi musicisti jazz. Tutti andavano al Music Inn, che è
stato il capostipite della nascita del jazz a
Roma e forse in Italia.
Di conseguenza il Saint Louis, un locale molto più grande che poteva contenere fino a 300
persone, fu visto come un forte concorrente,
anche se c’erano buoni rapporti tra me e Pepito. Poi sono nati il Big Mama, da un idea di
Marco Triemmi, un allievo del Saint Louis,
appassionato di blues che aprì un locale specializzato in quel tipo di musica, mentre noi
facevamo jazz, e dopo l’Alexander Platz. Ma
non ci dispiaceva la nascita di nuovi spazi per
la musica. La programmazione nei primi dieci anni è stata intensa. Sono passati moltissimi musicisti da quelli che suonavano il jazz
tradizionale a quelli che facevano swing. Io
non volevo dare un etichetta precisa al locale,
il pubblico era vario, non mi sembrava giusto
tenere aperto tutti i giorni proponendo un solo stile. Pertanto, ho sempre cercato di variare. I miei musicisti sono stati Dizzy Gillespie,
Max Roach, Elvin Jones; con alcuni di loro
c’è stata anche una grande amicizia. Poi ci sono stati Lester Bowie, Joe Pass e tanti altri
ancora di questo calibro.
Ricorda tutti con lo stesso entusiasmo?
Si, perché comunque si creava un rapporto
particolare, è molto diverso organizzare con-
certi in un club, vai a prendere i musicisti alla stazione o all’aeroporto, li porti con te,
mangiano con te.
Ricordo che una volta andato a prendere
Dizzy Gillespie all’aeroporto, al parcheggio
mi chiese di fermarmi un attimo, ha tirato
fuori un cannone e si è messo a fumare.
Poco dopo, una signora, vedendo la macchina piena di fumo, ha bussato al finestrino gridando “State andando a fuoco!” Gillespie con tranquillità è sceso dalla macchina e la signora è rimasta a guardarci allibita. Insomma si creavano dei rapporti
diretti con i musicisti, a volte rapporti di
amicizia, ci si sentiva al telefono, ed ho
sempre cercato di avere contatti diretti con
musicisti e agenzie americane.
Era più facile allora?
Era molto più facile. Potevi andare a prendere Max Roach con la Fiat 850 e nessuno
ti diceva niente. Oggi i musicisti, anche
quelli non molto famosi, ti chiedono la Limousine.
Era molto più facile, non c’era ancora un
grosso business dietro questo tipo di attività. Sarà per questo che ricordo tutti con
molta simpatia.
Perché poi chiuse il locale e tenne aperta la
scuola?
Avvenne nel 1996, quando finì il travaso
diretto tra chi frequentava il locale e chi si
iscriveva a scuola per un corso. Però prima
di questo momento il Saint Louis ha avuto
molto successo, per anni siamo stati sulla
bocca di tutti.
Ovunque andassi c’era un frequentatore del
Saint Louis e si era creato una specie di stile che io chiamavo dei “Saintlouisiani”.
Sam Rivers e Dave Holland (1980)
foto Andrea Muti
13
Cosa caratterizzava lo stile “Saint Louis”?
Lo stile Saint Louis era giovane con target
culturale medio alto. Erano studenti universitari, giovani professionisti con una certa
capacità di spesa, tanto che poi il Saint
Louis venne trasformato, si aprì il ristorante,
due cocktail bar. Insomma, io lo chiamavo lo
stile del “vorrei ma non posso”. La gente voleva comodità, mangiare e bere bene, ascoltare buona musica senza spendere troppo e
senza lusso sfrenato, in un contesto confortevole e piacevole.
Si era formato una specie di gruppo omogeneo, tutti della stessa estrazione socioculturale, amanti del jazz, con voglia di parlare e
discutere. Non si entrava al Saint Louis solo
per mangiare o ascoltare musica, si creavano
legami d’amicizia, di conoscenza, c’era uno
scambio umano e i musicisti questo lo sentivano e sentivano il calore della gente, c’era
entusiasmo nei concerti, ma anche critiche
quando sbagliavo programmazione. Tutto
questo è stata l’esperienza del Saint Luois
che ho cercato poi di portare nella scuola.
Venti anni di successi?
Si, con qualche curva in ribasso legata all’andamento del jazz. Il problema era rinnovarsi, la gente ogni anno desiderava qualcosa di nuovo, anche magari solo una parete
dipinta. C’è stato un periodo in cui il jazz
non andava molto e allora proponevo feste e
concerti a tema. Questo mi ha permesso di
restare sulla cresta dell’onda, adeguandomi
ai tempi.
Anche la scuola si è adeguata ai tempi, introducendo corsi di musica rock. Molti mi
hanno criticato, accusandomi di aver trasformato il locale in un luogo glamour. C’è
stato un periodo, dopo la ristrutturazione, in
Art Ensemble of Chicago con
Lester Bowie (1979)
foto Andrea Muti
15
cui venivano molti personaggi importanti, si
organizzavano mostre d’arte, sfilate di moda, insomma era diventato un locale molto
richiesto, anche perché si offriva un servizio
di qualità elevato per la Roma di allora e anche la clientela nel corso del tempo era cambiata, venivano professionisti dello spettacolo e persone con un maggior reddito.
Il Saint Louis era diventato chic?
Si, anche negli arredi e nel servizio. Avevamo
tre bar, ognuno con stile diverso, uno latino
con musica salsa, uno per la visione di video
clip e l’altro tradizionale per il jazz. Anche i
menù erano particolari, era sempre tutto
personalizzato, una vera e propria operazione di “restyling” che fu effettuata e che diede
i suoi frutti. Il Saint Louis divenne uno dei
locali migliori di Roma fino a quando non
esaurii la mia vena creativa.
Perché ha chiuso il locale ma non la scuola?
Per la scuola sono stato fortunato perché ho
trovato Stefano Mastruzzi, una persona capace di portare avanti un certo tipo di stile,
per il locale non ho trovato nessuno per cui
ho preferito chiuderlo, sarebbe stato negativo per il nome del Saint Louis.
Il nuovo direttore era ed è una persona competente, volenterosa, con idee nuove e voglia
di investire, per cui ho capito che la scuola
poteva andare avanti e crescere. Sono stato
contento di averla ceduta visti i risultati ottenuti.
In venti anni di successi non ha mai pensato di chiudere?
Ogni anno dicevo basta. Troppo sacrificio.
Tutte le sere si faceva tardi, con mille proble-
mi da risolvere, quattro chiusure per problemi di licenze, disturbo della quiete pubblica,
proteste dei vicini. Gestire un locale di quelle
dimensioni, con i gruppi dal vivo tutte le sere,
dieci persone che lavorano tra chef, aiuto
chef, camerieri e barman è un’impresa difficoltosa per una persona sola. Troppo stress,
tra l’insegnante assente perché malato, lo studente che protestava per la mancata lezione,
e così via tutti i giorni per un compenso che
era alla fine solo un onesto stipendio.
Come vede il futuro del Saint Louis?
Il jazz sta abbastanza bene in Italia, i ragazzi degli anni Settanta sono cresciuti e sono
diventati famosi anche all’estero dove abbiamo un’immagine del jazz italiano molto
buona. I nostri musicisti spesso lavorano più
all’estero che in Italia, hanno recensioni sulle grandi riviste internazionali. Il jazz italiano vive un periodo d’oro e questo si rifletterà
sia sui club che sulle scuole. Il Saint Louis ha
raggiunto picchi d’affluenza che non aveva
mai avuto prima. E cresce di anno in anno.
Ciò che paga è sempre la qualità, è necessario inventarsi nuovi corsi, allargare le opportunità.
Se tornasse indietro rifarebbe tutto quello
che ha fatto?
Si, perché è stata una splendida avventura
che mi ha dato una grande libertà, alla quale non rinuncerei mai. Ho deciso, ho fatto, ho
creato, ecco, creato: come architetto avevo
bisogno di creare, come posso creare una
barca, progettarla e vederla finita così ho
creato un locale, un nome, un’attività, questa è stata la grande soddisfazione. Sì, non
ho niente da rimpiangere, è stata veramente
una grandissima avventura!
Anthony Braxton (1979)
foto Andrea Muti
17
Roberto
GATTO
Batterista e compositore, Roberto Gatto debutta nel 1975 con il Trio di Roma (Enzo
Pietropaoli e Danilo Rea).Vanta numerose e
prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Steve Lacy, Phil Woods, Tony Scott,
John Scofield, Billy Cobham, Pat Metheny e
tanti altri. Ha all’attivo ben nove album.
Quando ha suonato per la prima volta al
Saint Louis?
A metà degli anni ‘70 quando la sede era in
Via del Cardello e il locale funzionava da jazzclub, ma soprattutto da scuola di musica. Io
allora facevo parte del corpo insegnanti.
C’è qualche particolare episodio che la lega
a questo posto?
Non uno in particolare, ma tanti episodi legati ai concerti. Quello era un momento importante per il jazz italiano; c’era una situazione politicamente molto difficile, era l’epoca degli “anni di piombo” per cui anche l’ondata musicale di allora era molto rivoluzionaria e il locale ha prodotto, oltre ai progetti più tradizionali, anche molta avanguardia.
C’era, comunque, una bella programmazione e, insieme al Music Inn e al Folkstudio, il
Saint Louis era il locale che proponeva le co-
se più interessanti a Roma. Per buona parte
degli anni ‘80 è stato un punto di riferimento per la musica oltre che per la didattica.
Poi le cose sono cominciate a cambiare come pure le esigenze delle persone; di conseguenza anche la scena musicale ha avuto un
rallentamento ed il locale è stato costretto a
chiudere. È rimasta però la parte didattica
ed oggi il Saint Louis si distingue nel produrre buone cose attraverso l’ insegnamento.
Quali sono i più bei concerti che ricorda e i
musicisti con cui ha suonato con maggior
piacere?
Sono tanti, in particolare ricordo che allora
la grandissima orchestra “Grand’elenco musicisti” che vantava la presenza del meglio
del jazz a Roma: oltre al direttore Tommaso
Vittorini c’erano, fra gli altri, Maurizio
Giammarco, Eugenio Colombo, Danilo Rea,
Enzo Pietropaoli. Era un’orchestra molto
divertente che ha operato principalmente al
Saint Louis.
Quanto è cambiato il pubblico di jazz da
trent’anni ad oggi?
Direi molto. Negli anni ‘70 il jazz veniva vissuto come una sorta di “carboneria”, nei lo-
Roberto Gatto
foto Livio Anticoli “Master Photo”
19
cali c’erano sempre le stesse facce mentre
adesso i club sono pieni di turisti. Il pubblico è incuriosito dal jazz italiano perché negli ultimi tempi fa parlare molto di sé, spingendo la gente a partecipare. Si tratta di un
pubblico giovane che però segue questa scena musicale anche un po’ per moda. Inoltre,
molti locali offrono un’ampia parte legata
alla ristorazione mentre una volta si faceva
solo musica, senza camerieri che servono ai
tavoli, né rumori di bar, di bicchieri....
quando cominciava la musica c’era silenzio
assoluto. Di sicuro oggi il pubblico è aumentato e noi musicisti riusciamo a riempire un auditorium di 1.500 persone “paganti” con molta più facilità. Questo ci rende
giustizia ripagandoci del pionierismo di
quegli anni difficili.
Quale la ragione fondamentale di questo
cambiamento?
Non è cambiato solo il pubblico, c’è molto
di più. Sono subentrati il benessere, i nuovi
mezzi di comunicazione; la gente si stanca
con molta più facilità, usa meno la “fantasia”, perché ha tutto a portata di mano. Una
volta, quando c’era scarsezza di mezzi ci si
ingegnava in qualche modo, evadendo con
il pensiero, c’era una sorta di “magia” sorprendendosi ogni volta che si scoprivano
cose prima non conosciute che risultavano
essere grandi novità. Ecco, questo di quegli
anni manca e mi manca.
Quali locali potrebbero oggi considerarsi
eredi degli storici Saint Louis, Music Inn,
Folkstudio?
Mi viene in mente solo l’Alexanderplatz.
Ora stanno nascendo nuovi piccoli posti rivolti soprattutto ai musicisti giovani, mi
vengono in mente il Charity e il Gregory’s
che dedicano ampia parte della loro programmazione alle jam session con cui siamo cresciuti noi da ragazzi. Pagano molto
poco i musicisti, ma funzionano da vere e
proprie palestre.
Roberto Gatto, Enrico Rava,
Luca Bulgarelli, Enrico Pieranunzi
foto Andrea Pacioni
Roberto Gatto
foto Andrea Pacioni
21
Max Roach
foto Stefano Ragni
Seminario con
Dizzy Gillespie (1984)
foto Andrea Muti
23
Jim Hall
foto Andrea Muti
Seminario con Max Roach,
Lilian Terry e Amedeo Tommasi
foto Andrea Muti
25
Enrico
RAVA
Trent’anni di carriera, oltre sessanta incisioni, il torinese Enrico Rava, trombettista, flicornista e compositore è fra i jazzisti italiani
più conosciuti a livello internazionale. Suona in Italia e poi a New York, Londra, Buenos Aires collaborando con prestigiosi musicisti come Gato Barbieri, Lee Konitz, Don
Cherry, Carla Bley, Cecil Taylor, Michel Petrucciani, Joe Anderson, John Abercrombie,
Roswell Rudd. Attualmente dirige il quintetto “Electric Five”.
Quest’anno il Saint Louis festeggia trent’anni di attività. Lei quando vi ha suonato per
la prima volta?
All’incirca negli anni ‘80 quando era ancora
scuola di giorno e jazz-club la sera. Un locale molto bello e ricordo che si suonava bene,
all’epoca se ne occupava Mario Ciampà.
Qual è il più bel ricordo che la lega al Saint
Louis?
Oltre ad un bel concerto in cui ho suonato
personalmente con il mio quartetto, ricordo
in particolare una serata in cui c’era anche
Gil Evans che si trovava a Roma per lavorare con l’Orchestra della Rai e la sera era venuto al Saint Louis. C’era veramente un
gran clima, sembrava di essere a New York!
Crede che oggi sia molto cambiata la scena
jazz romana rispetto a quegli anni?
Mah, io non credo sia cambiato molto, l’unica differenza è che il pubblico si è praticamente moltiplicato e, se oggi si possono fare
dei concerti in posti che ospitano migliaia di
persone, all’epoca ciò non era pensabile fatta eccezione per il Festival dell’Unità dove il
pubblico però era un pubblico casuale, di sicuro non legato alla musica. Inoltre all’epoca la Rai dedicava molto spazio al jazz soprattutto alla radio.
Aveva ospitato Gil Evans ma non solo: Archie Shepp, Carla Bley, Albert Mangelsdorff... una volta ci ero andato anch’io con
alcuni miei arrangiamenti per orchestra.
Oggi invece alla radio o in televisione non
c’è nulla, di jazz si parla davvero poco, ma in
compenso c’è una scena molto più vivace e
Seminari Roma Jazz’s Cool 2005
con Enrico Rava
foto Andrea Pacioni
27
se allora si poteva contare solo su Saint
Louis e Music Inn, oggi ci sono l’Auditorium, il Conservatorio di Santa Cecilia, i festival che durano mesi come “Villa Celimontana”, le rassegne insomma. L’attività è dieci volte più intensa che allora.
Prima accennava al fatto che il pubblico di
jazz ha avuto un forte incremento negli ultimi
anni. Qual è secondo lei la ragione principale?
Probabilmente ha a che vedere con il fatto
che è aumentata di molto la presenza di
musicisti americani in Italia ed è migliorata la qualità di quelli italiani che oggi per
l’appunto vantano un pubblico molto ampio. Musicisti come Stefano Bollani, Stefano Di Battista, Rosario Giuliani o io stesso
siamo riusciti a crearci un “nostro pubblico” ed è strano che ci siano dei giovani appassionati di jazz che conoscono noi e non
sanno invece chi siano Clifford Brown o
Winton Kelly.
Nella sua carriera lei vanta esperienze musicali internazionali, ha vissuto otto anni a
New York, a Londra, Buenos Aires, ha collaborato con artisti del calibro di Carla Bley,
Cecil Taylor, Steve Lacy, Don Cherry... cosa
pensa della scena romana di oggi?
Più che di “scena romana” parlerei di una
ricca “scena italiana” che ha trovato il suo
fulcro a Roma e questo anche grazie al sindaco Walter Veltroni che, appassionato di
jazz, ha dato un impulso pazzesco alla divulgazione e lo sviluppo di questo genere, grazie ai numerosi festival e rassegne presenti
nella città.
Per questa ragione molti giovani musicisti
italiani vivono a Roma, che dopo Parigi è la
città europea più vicina al jazz.
Enrico Rava
foto di Andrea Pacioni
29
Sam Rivers e Dave Holland
foto Andrea Muti
Rosario Giuliani
foto Andrea Pacioni
31
Terri L. Carrington
foto Andrea Pacioni
Seminari Roma Jazz’s Cool 2005
con Paolo Damiani
foto Andrea Pacioni
33
Roberto Gatto e Rosario Giuliani
foto Andrea Pacioni
Woody Shaw (1977)
foto Andrea Muti
35
Danilo
REA
Quali sono state le sue prime esperienze al
Saint Louis?
Il mio primo ricordo risale al ’76, quando il
direttore era Mario Ciampà. Ero piccolo ancora, suonavo come giovane pianista al
fianco di Al Corvini, trombettista argentino
dell’orchestra della Rai. Era straordinario.
Ricordo che dietro al palco c’era un grande
specchio dove controllavo continuamente
se la posizione delle mani sul piano era corretta.
Suonare jazz negli anni Settanta era una
esperienza avventurosa, ma non bastava per
vivere. Come riuscivate a mantenervi?
Vivevamo a casa dei nostri genitori, all’inizio l’aiuto delle famiglie è stato fondamentale. Io iniziai a suonare a 16 anni. A quei tempi c’erano i festival delle scuole. Roberto
Gatto suonava al S. Leone Magno con un
amico che si chiamava Paolo Marocco. Un
giorno mi chiese se potevo sostituirlo, così
debuttai con lui, da quel momento abbiamo
suonato insieme per trent’anni. Ho suonato
spesso al Saint Louis con varie formazioni
come il Trio di Roma assieme a Roberto
Gatto e Enzo Pietropaoli e con molti altri
musicisti romani. La gestione poi è cambia-
ta, ed ho iniziato a suonare in altri ambienti, perdendolo un poco di vista. Mi sono riavvicinato quando Stefano Mastruzzi ha creato la scuola di jazz così come è attualmente.
Ha insegnato nella scuola?
Pianoforte, ma per poco: non avendo basi
teoriche facevo fatica. Già a quell’epoca era
una scuola con moltissimi iscritti. Comunque è stata una bella esperienza umana, in
ogni classe ho trovato vari personaggi. Alcuni avevano un po’ di presunzione, altri
venivano lì per imparare veramente. Il jazz
si può apprendere fino ad un certo punto,
bisogna capire il punto di vista di chi insegna, essere interessati alla personalità di
chi insegna.
Quanto ha inciso sulla vostra musica il contesto storico-politico di quegli anni?
Lo vivevamo molto. Ad esempio alla base
del free jazz c’era l’idea di fare qualcosa fuori dagli schemi, una sorta di rivolta contro il
pericolo che il jazz diventasse musica di consumo. Quelle sono state le ultime battute del
jazz di quegli anni, un discorso che si è ripreso solo ultimamente. Sono trascorsi una ventina d’anni di apatia propositiva.
Danilo Rea
foto Marcello Di Leonardo
37
Duke Giordan (1981)
foto Andrea Muti
Seminario con
Paul Motian (2000)
Quanti concerti facevate allora, rispetto ad oggi?
All’epoca molto pochi, si suonava soprattutto nei club. Ora se ne fanno di più. Prima
della nascita delle scuole i musicisti jazz erano pochi e naif, poi si sono moltiplicati, hanno acquisito molte capacità tecniche, ma a
discapito delle personalità. Essere naif donava forte carisma.
C’erano differenze tra i principali locali dove
si suonava jazz?
Grandi differenze. Il Music Inn era il locale
principe, gestito da un principe, Pepito Pignatelli, batterista e grande appassionato.
Organizzava splendidi concerti: quando arrivavano gli americani (ad esempio Lee Konitz) ci faceva andare con loro in tournèe. È
stato il vero passo in avanti che abbiamo fatto. Al Mississipi sono passati Art Farmer e
Chet Baker, due enormi esperienze. Il Murales era gestito da ragazzi di sinistra, la parte
rivoluzionaria del jazz a Roma, la più attiva.
Ma sono state utili tutte queste esperienze.
Devo molto a Pepito perché da lui ho imparato tanto, ma mi sono divertito in ognuna
di queste realtà. Il Saint Louis era un po’ a
metà, concepito sia come jazz-club che come
Scuola.
E il pubblico? È molto cambiato?
Sting dice che il rock è finito, Miles Davis disse
che il jazz era finito. Da un certo punto di vista
è vero, ma cambiando il pubblico e le generazioni l’interesse si rinnova. C’è però una differenza:
un tempo l’appassionato di jazz era un talebano, un purista, non comprendeva altro che quel
linguaggio e quell’atmosfera, tutto il resto non
era accettabile. Ora il pubblico è più aperto e
questa libertà abbraccia anche la critica.
39
Alberto Corvini e Stephan Grappelli
Seminari Roma Jazz’s Cool 2006
con Marvin Stamm,
foto Andrea Pacioni
Seminario con Marc Johnson
foto Andrea Pacioni
Seminaro con
Dizzy Gillespie (1984)
foto Andrea Muti
43
Gabriele Mirabassi
foto Andrea Pacioni
Enrico Rava ritratto da
Andrea Pacioni
Enrico
PIERANUNZI
Enrico Pieranunzi, lei è un musicista importante del jazz internazionale. Come è avvenuta la scelta di fare il musicista?
Avere un padre musicista, chitarrista jazz
ed esperto di musica romana, ha fatto sì
che io crescessi in una casa “nutrito” di dischi jazz. Per certi versi, il mio percorso di
avvicinamento alla musica lo definirei quasi da autistico.
Il suo strumento è da sempre il pianoforte:
quali sono stati i suoi primi passi?
Ricordo di aver cominciato a suonare in
pubblico a partire dal ’67/68: le persone interessate al jazz erano veramente poche, non
esistevano scuole, solamente qualche musicista sparuto. Suonavo spesso concerti di piano solo in piccoli locali di Trastevere, soprattutto in un locale che oggi non esiste più
chiamato “Il Nocciolo”. Fu lì che venne a
sentirmi una sera il grande trombonista
Marcello Rosa, mentre suonavo repertorio
bop di Bud Powell e Wes Montgomery e mi
chiese di far parte di un quartetto. A Marcello mi lega da sempre un amore comune,
quello per il blues.
All’epoca ero più spettatore che attore, ma
quella particolare fase storica nel jazz creò il
movimento free. Nel jazz esistevano due partiti: uno “conservatore”, legato al Dixieland,
e l’altro “progressista” rappresentato dal free
jazz. Io mi trovavo al centro di esse. Suonavo il bop.
Si poteva vivere suonando soltanto jazz?
Era impensabile. Credo che la prima scossa
risalga al 1969, quando Pepito Pignatelli
aprì, per soli due anni, un locale chiamato
Blue Note. Prima, e attorno, c’era solo un
deserto, jazzisticamente parlando; saltuariamente, qualche concerto al Teatro Eliseo. La
svolta avvenne nel ’73 con l’apertura del
Music Inn, sempre ad opera di Pignatelli. Il
maggiore merito di quest’uomo fu di portare per la prima volta i grandi musicisti americani a Roma. Creò un pubblico che non
esisteva. Ascoltare dal vivo il violino di Jean-
Seminari Roma Jazz’s Cool 2005
con Enrico Pieranunzi,
foto Andrea Pacioni
47
Paolo Silvestri ed
Enrico Pieranunzi
foto Andrea Pacioni
Seminari Jazz’s Cool 2005
Claudio Corvini
foto Andrea Pacioni
Luc Ponty, il sax tenore Lucky Thompson,
essere lì presenti è stata per noi una scuola
incredibile. Ed io ho suonato con loro a partire dal 1974, Pepito Pignatelli mi dette
grande fiducia.
E dal punto di vista della didattica, c’erano
scuole per i giovani musicisti?
Di alcuni locali si può dire che abbiano
aperto come club, cui hanno affiancato in seguito le scuole: la prima è stata quella ”Popolare” di Testaccio, nel ’75 ed io sono stato
tra i fondatori. È stata realmente una grande novità: i musicisti si sono resi conto che
altre forme di conoscenza della musica alternative ai conservatori erano possibili e necessarie. Per di più a prezzi politici (la
“Scuola Popolare di Testaccio” nacque dall’occupazione di una banca!) e accessibili.
Importantissima è stata l’idea di insegnare il
49
jazz. Prima eravamo tutti autodidatti che si
formavano sull’ascolto e sullo studio dei dischi. Questa novità ha implicato due conquiste: che il jazz potesse esser insegnato e che
la scuola potesse essere un veicolo valido per
lo sviluppo della musicalità. In questo flusso
collocherei il Saint Louis.
venivano insieme. Tutto ciò era fonte di una
forte emozione: ci imbarcavamo in una sorta di mare infinito, e chissà dove ci avrebbe
portati.
Che rapporto c’è stato tra lei ed il Saint Louis?
Nel 1983 ho suonato per una settimana in
duo con Jim Hall: una grande appassionante sfida per me. Contemporaneamente avevo
dei turni di registrazione per musiche da
film con Ennio Morricone. A sorpresa, una
di quelle sere, mentre suonavo, me lo sono
ritrovato davanti. E neppure amava il jazz…
Tra il 1981 e il 1984 ho insegnato con continuità presso il Saint Louis; precedentemente ho tenuto concerti con una certa frequenza al jazz club. Il Saint Louis nacque per volontà di Mario Ciampà con un’impostazione
didattica, da subito. E le emozioni più belle
di quel periodo le ricollego proprio agli anni
di insegnamento: inventavo esercizi, improvvisavo patterns.
Le lezioni talvolta le preparavo, ma spesso le
improvvisavo con gli allievi e le scoperte av-
Ricorda un particolare aneddoto legato al
Saint Louis?
Cos’è il jazz per Enrico Pieranunzi?
Dissipazione. Suonando il jazz ci si deve dissipare. Il jazz è come il flusso della vita, non
ha senso fare calcoli.
Sam Rivers
foto Andrea Muti
Roberto Gatto ritratto da
Andrea Pacioni
51
Marcello
ROSA
Al Saint Louis, l’aula in cui Marcello Rosa
insegna storia del jazz è gremita di giovani
che non gli danno tregua con le loro domande, curiosità e timori per il proprio futuro da
musicisti. D’altra parte non è cosa da tutti i
giorni avere come docente un uomo che, più
che un insegnante di storia del jazz, del jazz
è un pezzo di storia.
Marcello Rosa è stato in tournée con Lionel
Hampton, ha diviso il palco con Earl Hines
e Peanuts Hucko, il trombone con Slide
Hampton e Trammy Young, per citarne solo
alcuni. Per lui, trombonista, compositore,
arrangiatore, autore e conduttore di programmi radiofonici, non è inusuale avere davanti tanto pubblico.
Nato ad Abbazia, oggi croata ma allora
italiana, il 16 giugno 1935, Marcello Rosa
trova nella Roma degli anni Sessanta l’ambiente più favorevole allo sviluppo della
sua straordinaria versatilità artistica.
Gli studenti di musica Jazz tendono a scegliere strumenti come il pianoforte, il sax o
la tromba, difficilmente scelgono il trombone. Lei, invece, da 55 anni vive in simbiosi
con questo strumento. Come è nata questa
passione?
La mia fortuna è stata di avere una madre
che suonava molto bene il pianoforte. È stata lei, quando avevo solo 5 anni, a regalarmi
le prime lezioni, naturalmente di piano. Mi
fece prendere lezioni dalla sua ex insegnante, una vecchia amica di famiglia.
Malgrado avessi studiato molto seriamente,
a 12 anni ebbi quella che ho chiamato “la
crisi del settimo anno”, una sorta di rifiuto
per il pianoforte classico. Non volevo più
sentir parlare di musica, o, meglio, iniziai a
capire che la musica che mi interessava era
altra. La fine della guerra aveva lasciato dietro di sé la scia delle sonorità degli america-
Marcello Rosa
53
ni e fu allora che scoprii che esisteva un’altra musica e che questa, il jazz, mi stimolava
molto di più rispetto a quella che mi veniva
severamente impartita dalla mia anziana insegnante.
Dopo un paio di anni iniziai a prendere lezioni di chitarra classica, ma la vera rivelazione avvenne a 16 anni, quando mia madre
mi regalò il disco di un trombonista jazz.
Ascoltando quel 78 giri mi chiesi: “Ma cos’è
questo suono scuro e malinconico?” Qualunque cosa fosse, di qualunque strumento si
trattasse, avevo capito che quello doveva essere il mio suono. Era il trombone di Kidory
che intonava “Savoy Blues”. Tutto è cominciato da lì.
E dopo tante esibizioni da giovane pianista
forzato, a 19 anni finalmente l’esordio con
quello strumento dalle sonorità malinconiche, che sarebbero diventate per sempre il
timbro della sua poetica…
Sì, infatti era il 1954 quando tenni la mia
prima esibizione come trombonista. Sempre
in quell’anno ascoltai nel giro di pochi mesi
tre grandissimi trombonisti di jazz.
Il primo, Bill Harris, era il più moderno dell’epoca, il secondo era Trammy Young, trombonista degli All Stars, la band stabile di
Louis Armstrong.
Il terzo era proprio Kidory che con “Savoy
Blues” già mi aveva mostrato la via. Dei tre
Kidory era il più antico, il padre di tutti i
trombonisti jazz.
Si può dire, quindi, che io abbia studiato la
storia dei trombonisti jazz al contrario: dal
più moderno al più antico.
Questa è stata la mia fortuna perché in tal
modo sono stato educato in maniera globale, senza mai privilegiare uno stile piuttosto
che un altro.
Ero affascinato da tutte le possibilità del
trombone jazz, che fosse moderno, antico,
d’avanguardia o tradizionale, non mi importava nulla. Anche in futuro non mi sarei mai
lasciato limitare dalle cosiddette etichette di
genere.
Il jazz nei suoi 100 anni di vita ha cambiato
etichette decine di volte: ogni 10 anni c’è
stato un movimento o una corrente nuova.
Si tratta di una normale evoluzione, ma come si può pensare che l’una debba eliminare l’altra?
Ma quale avanguardia, ma quale tradizione:
il jazz è uno solo!
Che ricordo ha del Saint Louis, storico locale di via del Cardello?
Il Saint Louis fu la creazione di Toht, un
trombettista romano il cui nome di battesimo era Luigi, di qui la scelta del nome del
locale. Luigi Toht era davvero un grande appassionato, tanto che dopo il Saint Louis
avrebbe fondato anche il Mississipi Jazz
Club e poi addirittura l’Alpheus.
Toht era un sognatore ma seppe realizzare
tre pilastri fondamentali, tra i quali, in fondo, solo il Mississipi non ha resistito nel tempo: il Saint Louis, infatti, è sopravvissuto
trasformandosi in scuola di musica.
Al locale Saint Louis suonai molto, ma
non si ascoltava solo il jazz, sul palco si alternavano moltissimi artisti di qualunque
stile.
L’avvio di tutto quel fermento artistico lo
aveva dato il Music Inn, locale entrato nella
storia; però il Saint Louis di via del Cardello aveva la possibilità di accogliere una
quantità maggiore di pubblico, dando a tantissima gente l’opportunità di toccare con
mano il vero jazz.
Mi ricordo l’ampia sala, la più capiente e
55
accogliente tra i locali di jazz romani, mi
ricordo le pareti dipinte di nero e il finto
muretto di mattoni rossi. Rispetto agli altri locali di jazz, il Saint Louis era senz’altro il più curato a livello scenografico, infatti l’altro fondatore, Mario Ciampà, di
professione architetto, ebbe cura di realizzare personalmente una bellissima scenografia. Era una vera soddisfazione per noi
suonare in quell’ambiente davanti a tanto
pubblico!
Ricorda qualche personaggio in particolare
tra i grandissimi che hanno suonato al Saint
Louis?
Il Saint Louis ha organizzato tournée dandomi la possibilità di suonare con personaggi che per me erano nel mito, ad esempio
Bud Freeman, il primo vero sax tenore del
jazz.
Bud Freeman allora era già in età, ma era
sempre elegantissimo: vestito di bianco, con
foulard e baffetti, sembrava un colonnello
inglese. Aveva fama di gran viveur e la moglie, che evidentemente sapeva che questa
fama non era senza fondamento, aveva preteso che io, in qualità di leader del gruppo, e
l’allora direttore del Saint Louis, sottoscrivessimo un contratto in cui ci impegnavamo
a tenere il marito, già settantatreenne, lontano dall’alcool e dalle donne!
È cambiato dall’epoca del Saint Louis e del
Music Inn il modo di ascoltare il jazz e il suo
pubblico?
Adesso il jazz lo fanno i ristoranti… formula
un po’ ambigua, ma funziona. Una volta al
Music Inn non c’era altro da fare che spaccarsi il sedere sulle panchette di mattoni e
stare a sentire la musica, poi, una volta tor-
nati a casa, i vestiti bisognava buttarli perché
avevano preso di muffa!
Quello, però, era un momento in cui c’erano ancora i più grandi in attività, dunque
ne valeva davvero la pena. Adesso ci sono
posti infelici in cui se non si è seduti tra i
primi dieci sotto al palco, si tende automaticamente a distrarsi e a parlare coi vicini,
specie se davanti c’è una colonna che blocca la visuale!
Ma allora i musicisti per chi stanno suonando?
Forse per quei quattro a portata di colpi di
trombone, che, se non si sta attenti, si finisce
col colpire loro e il cameriere con i piatti all’amatriciana!
E che dire del pubblico? Il pubblico ha fame
di amatriciana, non certo di jazz!
Una sera il trombettista Art Farmer, un nero grosso e robusto, stava suonando la ballata “Body and Soul”, ad un tratto si china
verso un tavolo di spettatori completamente presi dalle loro discussioni private e dice con accento straniero e voce profonda:
“Disturba se suono?”. C’è stato un attimo
di gelo seguito dal doveroso silenzio, che
però dopo le prime quattro battute si è dissolto nuovamente.
Negli anni Settanta, invece, si stava tutti accalcati a gioire soltanto dell’ascolto della
musica. Un chiaro esempio era il Folkstudio
di via Garibaldi: lo chiamavamo “l’autobus”
perché era un corridoio lungo e stretto con le
sedie ai lati, la cassa all’ingresso e in fondo
un palchetto.
C’era Harold Bradley, ex giocatore di football americano venuto in Italia per studiare
il bel canto e dipingere; le persone nell’autobus lo guardavano estasiate quando nelle
domeniche del 1962 intonava canti di lavo-
Umberto Fiorentino
e Francesco Puglisi
foto Andrea Sabatello
ro, alternando ogni strofa ad un vero colpo
di martello!
Lei è stato il primo disc-jockey radiofonico
di jazz. Come ha vissuto questa esperienza?
Ho iniziato a lavorare in radio dopo aver
vinto un concorso nazionale bandito dalla
Rai. Ho sostenuto un esame per programmatore musicale. Con quel concorso in Rai
entrarono assieme a me anche Arbore e
Boncompagni.
Nel 1968, dopo un lungo periodo di tirocinio, debuttai come autore di “Jazz Jockey”,
la prima trasmissione radiofonica di jazz.
Per più di 30 anni ho avuto una rubrica
radiofonica fissa alla Rai. Si è trattato di
un’esperienza eccitante ma difficile perché
è stata una lotta costante.
Ho dovuto fare delle battaglie proprio contro coloro che si dicevano appassionati di
jazz, come ad esempio Leone Piccioni, allora direttore generale della Rai.
Piccioni era un grande appassionato di jazz,
tanto da arrivare fino ad Harlem per sentire
il jazz direttamente dagli afroamericani, ma
riteneva che i radioascoltatori non avessero
gli strumenti per capire quella musica! Ma
allora io che ci stavo a fare? Io ero lì allo scopo di far capire il jazz agli ascoltatori!
Dopo un anno dall’inizio della trasmissione
Piccioni mi chiamò nel suo ufficio e mi disse che il titolo “Jazz Jockey” non andava bene, perché la gente appena sente la parola
jazz cambia immediatamente canale.
Mi opposi fermamente e lo accusai di essere uno snob, ma lui riuscì ugualmente ad
impormi un altro titolo. Da allora la trasmissione si chiamò, parafrasando un pezzo di Ellington, “Un certo ritmo…”.
Non c’era più traccia della parola jazz nel ti-
57
tolo della trasmissione di allora, ma oggi in
radio non c’è proprio più traccia del jazz!
Purtroppo è vero. Il livello dei giovani e la
loro curiosità sono cresciute in maniera
esponenziale, eppure non c’è più uno spazio
dedicato al jazz, né in radio né tanto meno
in televisione!
All’epoca felice del Music Inn ho lavorato a
programmi radiofonici come “Jazz Concerto” di Adriano Mazzoletti.
I gruppi jazzistici americani che arrivavano
in Italia venivano registrati dal vivo, poi la
trasmissione veniva montata in differita e io
facevo le presentazioni.
In televisione c’erano persino intere serate
dedicate al jazz.“Quando i jazzisti si incontrano” fu la prima trasmissione di musica
jazz a colori e gli ospiti erano musicisti del
calibro di Oscar Valdambrini, Franco Cerri,
Gianni Basso, Hengel Gualdi, Amedeo
Tommasi.
Sulla parete di un’aula del Saint Louis c’è
una foto che mi ritrae in uno studio televisivo durante un concerto jazz in onda su Rai
Uno. Ero vestito di bianco e stavo suonando
un brano di Tommy Dorsey; alle mie spalle,
tra i componenti dell’Orchestra della Rai,
c’era Dino Piana, uno dei più prestigiosi
trombonisti italiani.
L’intera scenografia, il vestito bianco, le tre
lettere dipinte sul sipario, volevano essere un
omaggio al trombonista Tommy Dorsey, che
aveva suonato in una posa identica. In questo caso, però, le tre iniziali sullo sfondo erano quelle del mio nome “MRT”: “Marcello
Rosa Trombone”, che era anche il titolo di
quella trasmissione, trasformatosi poi in “E
continuavano a chiamarlo trombone”.
Ma, vera novità nel panorama dell’insegnamento della musica, il Saint Louis di
giorno era una scuola di jazz. Sono stato
chiamato a insegnare sin dal primo anno
di apertura, ma gli allievi che avevano scelto di imparare a suonare il trombone erano solo in quattro, per questo la mia collaborazione durò un anno soltanto. Dal secondo anno mi sostituì il compianto Danilo Terenzi.
Nel 2004 si è fatto vivo l’attuale direttore
Stefano Mastruzzi proponendomi una nuova
collaborazione, che prevede, non solo l’insegnamento del trombone, ma anche classi di
ascolto di musica jazz e laboratori di musica
d’insieme, che, devo dire, mi intrigano molto.
Mentre una volta ero molto critico rispetto
alle scuole, adesso mi rendo conto di quanta
presa abbiano sui giovani e rimpiango di
non aver avuto da ragazzo esperienze simili,
dato che scuole di questo tipo, a quell’epoca,
non esistevano affatto.
Per un giovane che voglia impratichirsi musicalmente in modo non solo culturale, ma
anche professionale, è una fortuna poter
contare su centri di formazione di questo
genere.
Non c’è più, a differenza del passato, solo
l’insegnamento domiciliare, individuale e un
po’ noioso, qui si sta insieme e si gioca con la
musica e il gioco è fondamentale se si vuole
apprendere profondamente.
Credo che la mia esperienza debba essere
messa al servizio dell’allievo per aiutarlo a
trovare il proprio stile, senza ricalcare i suoi
miti, altrimenti si creano dei cloni inutili.
In America oggi vi è tanta gente che suona
in maniera tecnicamente pazzesca, eppure,
una volta, quando si sentiva il suono di un
jazzista, quel suono era immediatamente riconoscibile.
Ogni musicista aveva il suo personalissimo
colore: due strumenti uguali suonavano in
maniera diversa a seconda dell’anima del
musicista che avevano dentro.
Massimo Urbani (1981)
foto Andrea Muti
59
Jim Hall
foto Andrea Muti
Dizzy Gillespie (1984)
foto Andrea Muti
61
Gianluca Petrella
foto Andrea Pacioni
Seminario con
Scott Henderson e
Marco Manusso (2001)
63
Saint Louis Big Band
diretta da Bruno Biriaco
Seminari Jazz’s Cool 2006
con Bob Stoloff
foto Andrea Pacioni
65
Joe Lovano ritratto da
Andrea Pacioni
Charles Tolliver
67
Giovanni
TOMMASO
Il suo primo gruppo si chiamava Quintetto
di Lucca, siamo al jazz italiano degli anni
’50. Che tempi erano?
Il gruppo, nato per iniziativa di mio fratello
Vito, ruotava attorno a una cantina deliziosa dove facevamo incontri, jam session e
concerti.
Ricordo con affetto l’anno in cui riuscimmo
ad organizzare una rassegna di sei artisti, tra
i quali c’erano Armando Trovaioli, Franco
Cerri, Renato Sellani e il clarinettista americano Bill Smith. Fu lui che ci portò a Roma
per il festival del jazz che si svolgeva al Teatro Quirino.
Fu un successo. Andammo al festival del jazz
di Sanremo, vincemmo la Coppa del Jazz. Mi
dedicai interamente alla musica, facendomi
le ossa in una nave da crociera che viaggiava fra New York e i Caraibi.
Al ritorno in Italia c’era Chet Baker che si
innamorò del nostro gruppo.
Poi si trasferì a Roma.
Era il ’67, suonavo jazz quando e come potevo e mantenevo la famiglia lavorando come
turnista o alla radio con Adriano Mazzoletti.
Negli anni ’70 il boom del jazz rock contagiò
anche l’Italia e il Perigeo ebbe grande successo.
Il Perigeo nacque nel ‘72 ed ebbe cinque anni felici di vita. Era un periodo vivace, anche
se era l’epoca della contestazione anche ai
concerti. Spesso capitava che eravamo noi a
dover pagare i danni del nostro pubblico.
Ma ricevemmo molti riconoscimenti ed ancora oggi i dischi del Perigeo continuano a
vendere. Ci penso ancora, tanto che sto progettando un nuovo gruppo, gli Apogeo con
evidente riferimento a quell’esperienza.
Lei ha suonato praticamente in tutti i locali
romani. Quali ricordi conserva?
Seminari Jazz’s Cool 2006
con Giovanni Tommaso,
foto Andrea Pacioni
Il Folkstudio era eroico. Al Music Inn ero
molto legato per l’amicizia verso Pepito Pignatelli. Fui io a organizzare l’ultima stagione di concerti, dopo la morte sia di Pepito
che della moglie Picchi. Poi decidemmo di
cedere il locale ad una persona verso la quale, non posso dimenticarlo, nutro un certo
rancore. Si era infatti impegnato a continuare la tradizione del locale e noi ci credemmo.
Un anno dopo ne fece una pizzeria...
Com’è stato il suo rapporto con il Saint Louis?
C’è un aneddoto che ricorda in particolare?
Lo frequentavo spesso, aveva una programmazione più aperta verso le contaminazioni
del jazz rispetto al Music Inn. Ricordo, da
musicista, una rassegna straordinaria che fu
organizzata al Saint Louis con Kenny Clark,
Massimo Urbani e Amedeo Tommasi. Oggi il
Direttore della Scuola, Stefano Mastruzzi,
mi invita spesso a svolgere dei seminari.
69
Paul Motian con Francesca Gregori e
Diego Bongiorno
Stefano Mastruzzi e la B.I.M. Orchestra di
Giuseppe Tortora (2006)
foto Andrea Pacioni
71
Copertina “Italian Jazz Real book” (2005)
Luciano Linzi e Stefano Mastruzzi,
presentazione di “Italian Jazz Real book”
alla Casa del Jazz
foto Fausto Franceschini
73
Seminario di Robben Ford (2001)
David Murray Trio 1979
foto Andrea Muti
75
Susanna Stivali ritratta da
Andrea Piacioni
Joe Pass
foto Andrea Muti
77
Maurizio
GIAMMARCO
Sassofonista e compositore, Maurizio Giammarco gode ormai di una carriera ultratrentennale maturata al servizio del jazz. La sua
formazione, cresciuta tra i club e i viaggi
d’oltreoceano, lo connota tuttora in una posizione di costante confronto tra la tradizione classica jazzistica e una raffinata ricerca
di sintesi formale del jazz contemporaneo.
Tra i suoi progetti musicali, un quartetto col
pianista americano Phil Markowitz e il
quintetto dei Megatones.
Quando è iniziato il suo rapporto con il
Saint Louis?
Credo sin dagli esordi. Ho un ricordo indelebile dei miei concerti al Saint Louis, e della
formazione con cui andavo a suonare dalla
fine degli anni Settanta, quando ho avuto
l’opportunità di inserirmi nel calendario dei
concerti del Jazz-Club, un importante punto
di riferimento per la crescita del jazz a Roma e per la nostra crescita personale di mu-
sicisti. All’epoca, i locali erano il Music Inn,
il Murales e il Saint Louis. Era soprattutto il
Saint Louis ad offrire più spazio ai musicisti
della mia generazione.
Come musicista jazz come descriverebbe il
clima musicale a Roma negli anni Settanta?
Ne ho un ricordo splendido. Fu un periodo
in cui il jazz era da considerarsi una musica
per un pubblico “di nicchia”.
Oggi è diverso, viviamo un momento storico di grande riconoscimento dell’attività
che noi stessi abbiamo portato avanti per
molti anni.
All’epoca il jazz era “la carboneria” più totale. Il nostro lavoro si basava su passione
ed entusiasmo. In linea di massima allora
si suonava meno rispetto ad oggi, anche se
a Roma, grazie alla presenza del Saint
Louis e di altri locali, non ci potevamo lamentare.
Il Saint Louis ha passato varie fasi: una
Seminari Jazz’s Cool 2006
con Maurizio Giammarco
foto Andrea Pacioni
79
prima fase “da battaglia”, in cui il locale
era un pretesto per ascoltare la musica.
Negli anni Ottanta, grazie alla ristrutturazione voluta da Mario Ciampà, ci si poteva
anche mangiare. Di quel locale resta la
Scuola che, vedo, ha grande successo.
Negli anni Novanta il jazz ha visto nascere
un nuovo pubblico di appassionati. Personalmente, Lei come ha vissuto questa nuova
fase di musica jazz?
Il jazz è una musica che raccoglie un pubblico trasversale a livello di età. Solo che man
mano che si cresce, si è meno disponibili ad
andare ai concerti per questione di tempo e
di impegni. Negli anni Novanta ho percepi-
to un po’ di crisi rispetto al decennio precedente Ottanta e degli anni Settanta che sono
stati invece momenti felici per la musica in
generale a livello mondiale.
La musica è qualcosa di fluido che vive sul
momento, con belli e brutti concerti, a prescindere dalle fasi storiche nelle quali si vive;
dipende dal clima, dal luogo, dai musicisti,
dal pubblico.
Cosa caratterizzava nei decenni passati la
musica jazz e come viene vissuta attualmente?
Negli anni Settanta e in gran parte degli Ottanta, la musica era un fatto importante sotto l’aspetto ideologico e spirituale.
Seminario con
Peter Erskine (2001)
Eddy Palermo,
Lee Konitz e Jim Hall
81
Seminari Jazz’s Cool 2005
con Fabrizio Bosso
foto Andrea Pacioni
James Moody,
foto Napolitano e Giambalvo
Oggi invece si apprezza lo spettacolo e la
professionalità. Io ho nostalgia della passione con cui si viveva la musica allora. In un
certo senso gli anni Novanta hanno rappresentato un periodo di declino.
Attualmente il jazz vive di buona salute anche se appare una musica “modaiola” spesso
recepita in modo superficiale ed epidermico
da parte di un pubblico che vi si accosta per
la prima volta, spesso privo di basi serie per
goderne di più.
Ricorda un episodio particolare riferito alla
sua esperienza musicale con il Saint Louis?
Sì, ho un ricordo indelebile quando suonammo con il Grande elenco musicisti di Tommaso Vittorini, tra la fine degli anni Settanta
e l’inizio degli Ottanta. È un aneddoto rivelatore del clima di quegli anni; durante un
concerto, nel bel mezzo tra un pezzo e l’altro, fummo interrotti dall’intervento di uno
spettatore che chiese spiegazioni sul significato della musica che stavamo suonando. Un
episodio oggi impensabile.
Lo spettatore chiese l’apertura di un dibattito sul brano che si stava suonando. La risposta di Tommaso Vittorini fu molto scherzosa,
fece un’analisi musicale del pezzo che aveva-
83
Massimo Pirone
foto Andrea Pacioni
Rosario Giuliani
foto Andrea Pacioni
mo appena suonato, come per dire “la musica si spiega da sola”.
Nel suo vissuto personale, come definirebbe
il Saint Louis, come Club e come Scuola, e
quali impressioni ha maturato a riguardo?
Il Saint Louis ha cambiato faccia molte
volte come Club, e da qualche anno ha
inaugurato un nuovo stile di gestione.
Mentre anticamente i locali cercavano
sempre di rimanere fedeli a se stessi, il
Saint Louis invece ha sempre provato a
rinnovarsi, ad andare oltre.
In questo senso è stato anticipatore del
trend attuale, in cui i locali vivono magari solo una stagione e poi chiudono, inseguendo anche un po’ i furori del pubblico.
A me piacciono i locali che mantengono
un loro assetto specifico, tuttavia, riguardo alla Scuola, sono molto soddisfatto dei
corsi che il Saint Louis organizza in estate, queste master class cui partecipo come
docente.
Si è rinsaldata una mia collaborazione con
la Scuola, cosa che mi fa molto piacere
perché, sinceramente, reputo il Saint Louis
una delle realtà didattiche più importanti
che abbiamo in Italia.
85
Maria Pia De Vito
foto Antonio Stracquacursi
Lee Konitz e Martial Solal
foto Andrea Muti
87
Paolo
FRESU
Paolo Fresu, considerato fra i trombettisti
italiani artisticamente più completi, ha alle spalle un enorme bagaglio di esperienze
professionali.
Fra le tante collaborazioni con grandi musicisti del panorama jazz italiano ed internazionale, da ricordare quelle con il percussionista Trilok Gurtu, Roberto Gatto, il
pianista-fisarmonicista Antonello Salis,
Dhafer Youssef ed il contrabbassista Furio
di Castri.
Le sue collaborazioni si estendono anche
in ambito poetico ricordando l’album “Ossi di seppia” del 1991, in cui si fa chiaro riferimento ad Eugenio Montale, e quelle
con la poetessa Patrizia Vicinelli ed il romanziere Stefano Benni. Legato al mondo
delle colonne sonore, Paolo Fresu ha composto quelle per i film “Il Prezzo” di Rolando Stefanelli, “L’Isola” di Costanza Quatriglio, “Te lo leggo negli occhi” e “Sonos e
Memoria” di Gianfranco Cabiddu e “La seconda notte di nozze” di Pupi Avati.
Lei è uno dei trombettisti italiani più apprezzati, pur giovanissimo ha alle spalle notevoli esperienze professionali con grandi
maestri del Jazz e molte esibizioni in vari
luoghi d’Italia e del mondo. Ricorda la sua
prima volta al Saint Louis?
È stato circa 15 anni fa, insieme a Bruno
Tommaso e Paolo Damiani. Poi ricordo di
aver suonato con Ettore Fioravanti in un
gruppo riunito per l’occasione, un progetto
che però non era mio. Sempre in quel periodo ho tenuto una Master Class sull’improvvisazione e il linguaggio jazz.
L’esperienza al Saint Louis ha contribuito in
qualche modo a farla conoscere nell’ambiente musicale o vi è arrivato già da artista
affermato?
Il mio quintetto italiano è nato nel 1984, che
è l’anno in cui ho ricevuto il premio Radio1
come miglior talento jazz italiano. In quegli
Paolo Fresu e Stefano Mastruzzi
89
anni mi stavo formando musicalmente. Le
mie partecipazioni al Saint Louis, come negli altri locali romani di allora, come il Music Inn e il Folkstudio, erano in funzione delle mie trasferte romane, durante gli anni del
mio apprendistato fra l’83 e l ‘88.
C’è molta differenza con il clima musicale
di oggi?
La qualità del pubblico in Italia è cresciuta
in pari misura con la qualità dei musicisti. Il
jazz italiano non ha mai avuto tanto successo come negli ultimi dieci-quindici anni. C’è
più maturità e determinazione. Ci siamo allontanati dai modelli americani da cui dipendevamo totalmente.
C’è un grande pubblico del jazz che gira nei
numerosi locali e nei teatri ma non compra i
dischi perché preferiscono l’esibizione live
dell’artista. C’è sempre più voglia di ascolta-
re i musicisti dal vivo e di condividerne l’esperienza.
Lei ha mostrato interesse per i più diversi
territori artistici, dalla poesia con Patrizia
Vicinelli al romanzo con Stefano Benni, con
il cinema e le colonne sonore di vari film. C’è
ancora qualche territorio che ha voglia di
esplorare?
Spero che ci sia. È vero che ho fatto tante cose ma non per cavalcare il successo. È fondamentale fare sempre cose diverse, la nostra
capacità di rinnovamento sta nella nostra
capacità di guardarci intorno. Se ci chiudiamo in noi stessi è finita, non si arriva mai da
nessuna parte.
Rossana Casale
Parafrasando il titolo di un suo album – colonna sonora del film di Gianfranco Cabiddu “Sonos e Memoria” – se dovesse abbinare
foto di Livio Anticoli “Master Photo”
Seminari Jazz’s Cool 2006
con Sylvain Luc,
foto Andrea Pacioni
un pezzo ai ricordi che ha del Saint Louis,
quale potrebbe essere?
Sceglierei un pezzo romano, forse più un
mood in realtà, un odore di suono, perché in
quegli anni arrivavo a Roma dalla Sardegna
e mi sentivo un po’ spaesato. Mi chiedevo come mai musicisti come Bruno Tommaso e
Paolo Damiani telefonassero a me che ero in
Sardegna per venire a suonare a Roma.
Ricordo la casa all’Eur di Ettore Fioravanti
che aveva ricavato una sala prove utilizzando un catalogo di maniglie di porte preso dal
negozio dei genitori.
Ho un ricordo sordo di questa sala prove.
Sceglierei, pertanto,“Roccellanea” con Paolo
Damiani e Gianluigi Trovesi, che è stato quasi il mio primo disco registrato e le collaborazioni molto particolari insieme a Bruno
Tommaso, come la colonna sonora per il film
muto di Buster Keaton “Steamboat Bill, Jr”.
91
Stefano Mastrangelo
foto Andrea Pacioni
Freddie Hubbard
foto Andrea Muti
93
Antonello
SALIS
Antonello, lei è uno dei talenti più originali
del panorama jazzistico italiano, le sue origini sono sarde e ai primi anni ’70 risale l’arrivo a Roma del trio Cadmo: Antonello Salis
al piano, Riccardo Lay al basso elettrico e
Mario Paliano alla batteria. Come fu il suo
impatto con la scena jazzistica della Roma
anni Settanta?
dai club, quasi come zingari! Del Music Inn
ricordo l’incontro con musicisti importanti,
quali Charlie Mingus, Ornette Coleman,
Dexter Gordon. Quanto al Saint Louis non
ricordo di aver mai visto un luogo tanto bello in cui suonare jazz. Il jazz era legato alle
cantine (lo stesso Music Inn lo era), a spazi
piccoli.
Col trio Cadmo arrivammo a Roma nel 1974
con immenso entusiasmo e fortissima emozione. Ci eravamo fatti le ossa in Sardegna
con la musica da ballo.
Ma volevamo suonare la musica che ci piaceva, avevamo trascorso anni nelle cantine a
studiare e scrivere pezzi nostri che spaziavano dal rock progressivo al free jazz.
Avevamo una passione per la musica di tutti i tempi, soprattutto attrazione per quella
contemporanea, per la sua turbolenza.
Fare il musicista jazz in quegli anni era difficile, anche economicamente?
A Roma negli anni ’70 c’era il Music Inn,
poi arrivò il Saint Louis...
Abbiamo cercato di suonare ovunque, anche
accampandoci con furgone e fornellino fuori
Facevamo realmente la fame, ma vivere la
realtà romana rappresentava di per sé una
fortuna: attorno, per i musicisti, c’era solamente una landa desolata.
Ricorda molti musicisti di talento, ripensando a quegli anni?
Massimo Urbani è stato uno dei primi grandi
musicisti incontrati a Roma. Poi, man mano,
abbiamo collaborato con i jazzisti stranieri di
talento: ricordo ancora l’emozione della prima volta in cui ho affiancato Enrico Rava per
partecipare ad un suo lavoro. Poi Lester
Antonello Salis
foto Roberto Cifarelli
95
Seminario con Robben Ford (2002)
Joey Baron ritratto da
Andrea Pacioni
Bowie, l’Art Ensemble of Chicago e Pat
Metheny, avvicinandoci ai tempi più recenti.
Lei ha esperienza di insegnamento?
Non ho mai insegnato e sinceramente non
saprei da dove iniziare, non mi sono mai
sentito all’altezza. Ho partecipato esclusivamente ad incontri sulla musica che definirei
“chiacchierate”: in tal caso mi fa molto piacere parlare della mia musica, soprattutto se
mi pongono domande intelligenti. Ma anche
parlare a ruota libera permette di capire più
a fondo chi hai di fronte.
Mi viene in mente un singolare concerto al
Saint Louis di Sun Ra, piano solo. Il primo
giorno accanto al piano c’era una batteria su
cui era seduto un ragazzo di colore.
È stato imbarazzante: non suonava nulla,
ogni tanto metteva mano alla batteria e Sun
Ra lo zittiva. Mi sono sempre chiesto cosa
fosse successo, quella sera…
Oggi si avverte la mancanza di jazz-club come il Saint Louis. È infatti emozionante ritrovare in Europa quei cinque-sei locali “storici” inossidabili, che nel tempo non sono
cambiati.
Si respira un clima che ti fa fare un salto nel
passato, quello dei club alla vecchia maniera, che in Italia non esistono più. Purtroppo
a livello globale i costumi sono cambiati: la
gente frequenta i locali dove si suona il jazz
quasi esclusivamente per andarvi a mangiare, dando l’impressione che il jazz faccia da
sottofondo.
Forse non è sbagliato parlare di un’epoca
nella quale si confezionano prodotti di poca
sostanza e qualità in tutti i settori. Arte compresa, purtroppo.
Il tornaconto economico innanzitutto, quindi soldi… per questi oggi si venderebbe l’anima al diavolo.
97
Stefano Mastruzzi ritratto da
Andrea Pacioni
Rosario Giuliani
foto Andrea Pacioni
99
Charles Tolliver
Seminario con Dizzy Gillespie
in primo piano Massimo Nunzi (1984)
foto Andrea Muti
101
Seminario Jazz’s Cool 2006
con Marcus Miller, Giorgia Mileto,
Gianfranco Gullotto e Stefano Mastruzzi
foto Andrea Pacioni
Saint Louis Big Band (2004)
diretta da Gianni Oddi
foto Andrea Pacioni
103
Saint Louis College of Music,
sede di via Urbana, Roma
Peanuts Hucko e Alberto Corvini
105
Stefano Di Battista,
inaugurazione seconda sede
del Saint Louis (2002)
Tiziana Rivale
foto Antonio Stracquacursi
107
Gegè Telesforo
foto Livio Anticoli “Master Photo”
Steve Lacy Quintet con
Irene Aebi (cello),
Kent Carter (contrabasso) e
Steve Rotts (sax)
foto Andrea Muti
109
Giampaolo Ascolese
Stefano Sabatini
foto Max Pucciariello
111
Foto Andrea Pacioni
Seminario Jazz’s Cool 2005
con Roberto Gatto
foto Andrea Pacioni
113
Seminario con Dave Holland (2001)
David Murray
foto Fabrice Parfait
115
Salvatore Bonafede (1995)
foto Mauro D’Agati
Seminario Jazz’s Cool 2006
con Kenny Werner
foto Andrea Pacioni
117
Seminario Jazz’s Cool 2005 con Enrico Pieranunzi
foto Andrea Pacioni
Seminario Jazz’s Cool 2006 con Dedé Ceccarelli
foto Andrea Pacioni
119
Steve Lacy (1980)
foto Andrea Muti
Joey Garrison (2001)
foto Marco Mancini
121
Seminario con Frank Gambale (2003)
tra Marco Manusso e Stefano Mastruzzi
Lee Konitz
foto Vitaliano Napolitano
123
Seminario Jazz’s Cool 2005 con
Mark Murphy
foto Andrea Pacioni
Enrico Rava
foto Andrea Pacioni
125
Seminario con John Taylor (2002)
Seminario Jazz’s Cool 2006
con Marcus Miller
foto Andrea Pacioni
127
Enrico Pieranunzi ed Enrico Rava
foto Andrea Pacioni
Andrew Cirille Quartet (1980)
foto Andrea Muti
129
Amedeo Tommasi
foto Andrea Muti
Philip Wilson Trio (1979)
foto Andrea Muti
131
133
Tratto da “Il Messaggero”
del 9 Marzo 1988
135
137
139
Kenny Clarke (1978)
foto Andrea Muti
PROGETTOGRAFICOARJUNAROMASTAMPA,ITOGRAFICA)RIDESRL 2OMA