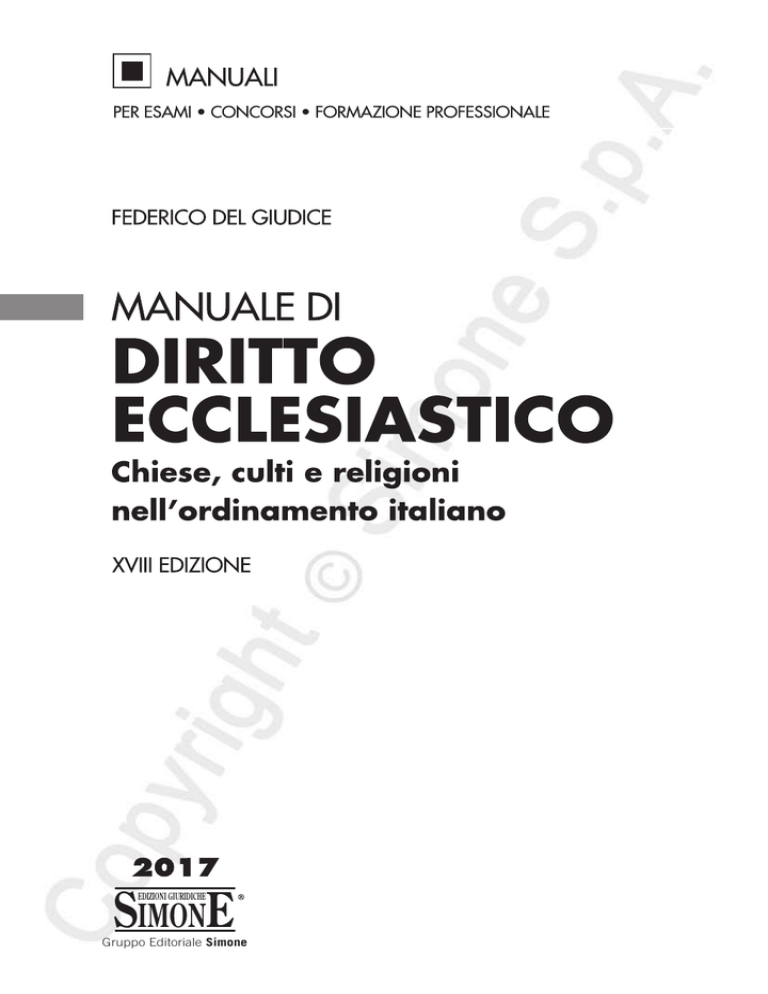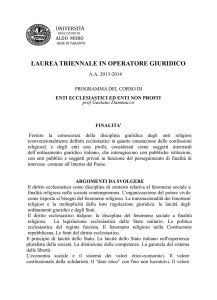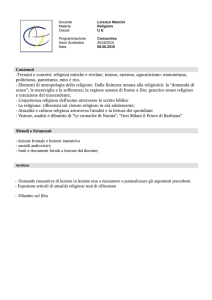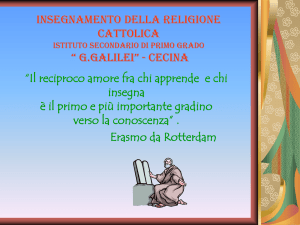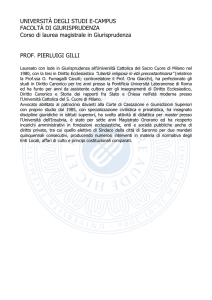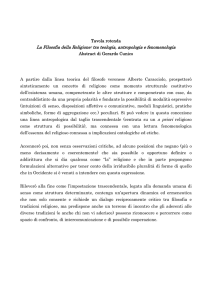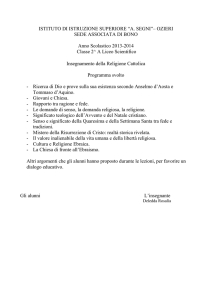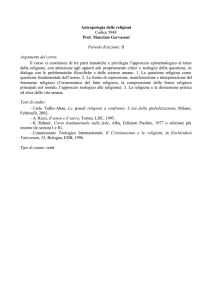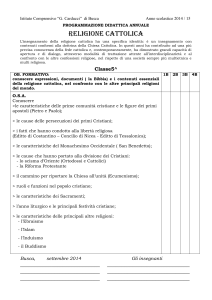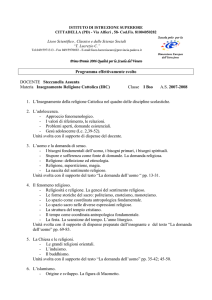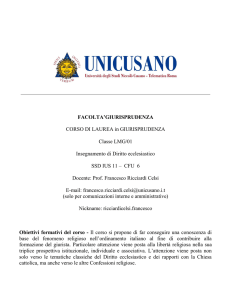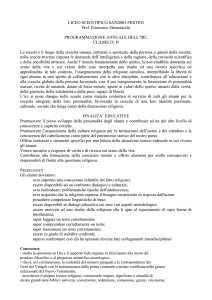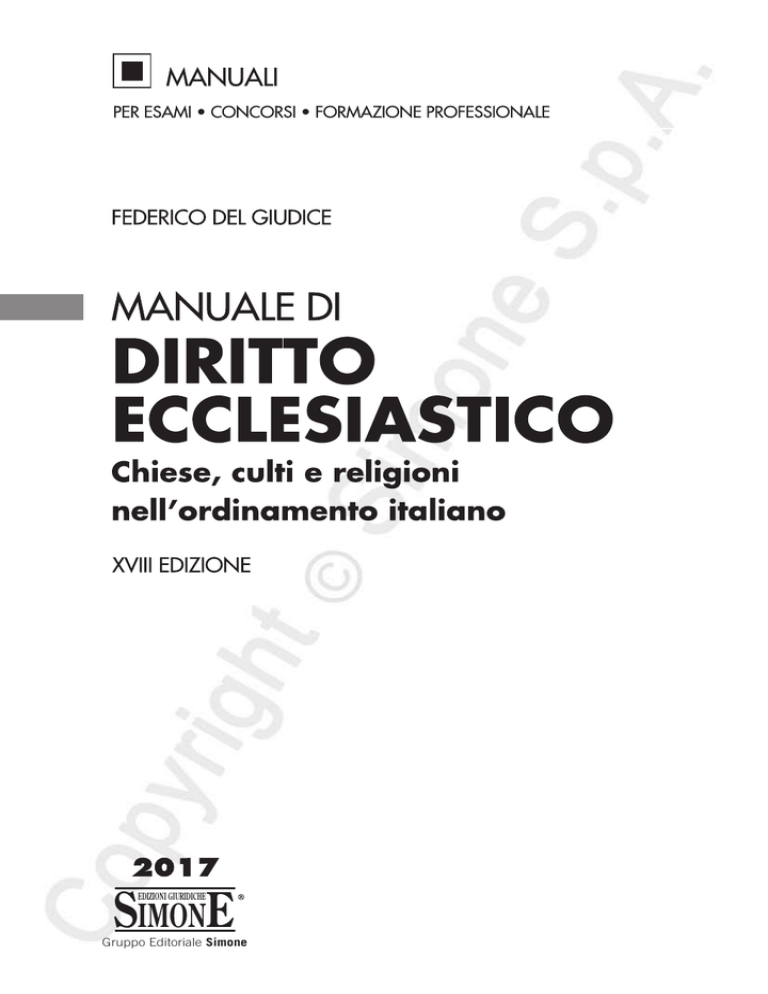
SIMONE
EDIZIONI GIURIDICHE
Gruppo Editoriale Simone
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Vietata la riproduzione anche parziale
Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera
appartengono alla Simone S.p.A. (art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)
E5 • La Costituzione Esplicata
a cura di F. del Giudice
XVI edizione • pp. 384 • @ 17,00
La “Costituzione esplicata” consente di focalizzare l’attenzione sul testo di ogni norma, sul significato di ciascun
comma e delle singole parole chiave, rivelandosi particolarmente utile per la preparazione di esami universitari, concorsi e abilitazioni professionali, nonché di rilevante interesse
per avere un quadro chiaro e sintetico delle modifiche attualmente in corso.
Il volume è completato da Appendici con lo Statuto Albertino e la Carta dei diritti fondamentali del­l’Unione europea, entrambi corredati da brevi note di commento.
Simone: una garanzia nella didattica universitaria
Ogni anno le Edizioni Simone si presentano sempre più aggiornate e migliorate grazie all’esperienza quarantennale che
contraddistingue la Casa Editrice.
Per saperne di più sugli originali «metodi di studio Simone» chiedi al tuo libraio e a coloro che oggi sono funzionari,
magistrati, notai, avvocati etc., che hanno formato la loro preparazione sulle nostre pubblicazioni, sempre imitate, mai
eguagliate.
Ha collaborato a questa edizione il dott. Pietro Emanuele
Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it
Finito di stampare nel mese di maggio 2017
da «CBL Grafiche s.r.l.» - Napoli
per conto della SIMONE S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - Napoli
Grafica di copertina di Giuseppe Ragno
Premessa
Il «diritto ecclesiastico» nel nostro ordinamento è una dizione da tempo superata che andrebbe sostituita con «diritto delle religioni e dei culti», più conforme al dettato costituzionale.
La disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha superato l’empasse che in
passato non ha consentito l’affermazione del principio di laicità, in quanto in Italia quel
residuo di Stato confessionale non è stato del tutto cancellato anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione (1948).
La componente politica democristiana (soprattutto durante la prima Repubblica) ha rallentato tale transizione e solo grazie alla costante attenzione della Corte costituzionale sono
stati «picconati» gli ultimi residui di confessionismo presenti nel codice Rocco e nella legislazione ereditata dal fascismo.
La libertà di religione e il principio di non-discriminazione in base al culto, anche attraverso il parallelo ricorso alle intese con le religioni acattoliche, hanno consentito una metamorfosi di questo ramo del diritto pubblico, ormai scevro da discriminatori ammiccamenti ad
un antistorico «confessionismo di Stato».
Anche l’opera di rinnovamento iniziata da Papa Francesco, per una Chiesa più solidale e
meno gerarchizzata, ha consentito una rilettura globale delle relazioni fra individuo, coscienza e fede alla luce dei principi del Vangelo, che ha dato una diversa impronta ai rapporti fra
Stato e Chiesa. L’azione pastorale di Francesco è tesa anche a sviluppare un dialogo di più
ampie vedute con gli altri culti monoteisti, in particolare quelli fondati sui «grandi libri»
(come Torah e Corano) che presentano numerosi caratteri comuni.
L’autorevolezza di Francesco, super partes nella politica, nell’economica e nelle religioni,
ci fa ben sperare in un futuro migliore sia per il pianeta che per i rinnovati rapporti tra individuo e credo religioso che nella nostra società, a causa del massiccio fenomeno migratorio,
ha assunto nuove dimensioni multiculturali e multietniche.
Di questa nuova visione non può che giovarsi il «diritto dei culti» che sta rendendo effettivo il principio di non-discriminazione tra le diverse religioni.
Parte I
Introduzione al diritto ecclesiastico
––––– Capitolo 1
Concetto e definizione del diritto ecclesiastico pag. 6
––––– Capitolo 2
Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico pag. 16
––––– Capitolo 3
Le fonti del diritto ecclesiastico pag. 38
––––– Capitolo 4
I principi costituzionali del diritto ecclesiastico pag. 48
––––– Capitolo 5
Organi statuali con mansioni inerenti ai culti pag. 63
Edizioni Simone - Vol. 32 Diritto ecclesiastico
Capitolo 1
Concetto e definizione del diritto ecclesiastico
Sommario
1. Il fattore religioso e l’interferenza con lo Stato. - 2. Diritto dei culti ed evoluzione del diritto ecclesiastico italiano.
3. I rapporti tra diritto ecclesiastico, diritto canonico e scienze affini.
4. La collocazione sistematica del diritto ecclesiastico (dei culti) tra le scienze giuridiche.
1.Il fattore religioso e l’interferenza con lo Stato
A) Generalità e definizione
L’essere umano ha da sempre avvertito la necessità di credere in una entità superiore che
ne ispirasse la coscienza e le regole di vita, condizionando, in nome del suo credo, modi di
essere e di pensare, nonché atteggiamenti e comportamenti da tenere nei confronti dei suoi
simili e della divinità.
Il fattore religioso interferisce con l’ordinamento giuridico in quanto mette a confronto la
comunità sociale (i sudditi di uno Stato) con quella religiosa (i fedeli di una determinata
religione).
Da questo doppio legame (autorità civile e religiosa) può sorgere un singolare contrasto
nella coscienza di ogni individuo che viene messo dinnanzi ad una scelta: obbedire allo
Stato da «buon cittadino» o al proprio credo da «scrupoloso praticante»?
Lo Stato si trova, quindi, ad affrontare e risolvere i rapporti tra potere civile e fattore religioso per evitare contrasti tra:
—norme giuridiche e norme religiose i cui comandi, però, spesso coincidono (es.: il precetto «non ammazzare» costituisce nello stesso tempo sia un peccato che un reato);
—diversi credi religiosi che coesistono nell’ambito dello stesso corpo sociale e che lo
Stato è tenuto a tutelare senza, però, tradire i suoi valori fondamentali: libertà, eguaglianza, non discriminazione etc.
Differenza tra «chiese» e «religioni»
Le «chiese» sono composte da comunità di essere umani che si riuniscono per praticare un credo
comune.
Le religioni, invece, hanno un carattere più ampio e fanno spesso capo a una serie di testi sacri
(Bibbia, Corano, Torah), credenze, principi e regole che le singole chiese sono tenute a rispettare.
Sulla base delle citate affermazioni si può definire il «diritto ecclesiastico» in generale
(meglio definibile «diritto dei culti») come il complesso di norme che, partendo dal
dettato costituzionale (artt. 2, 3, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a tutela dei principi
supremi) si intersecano con il fenomeno religioso la cui disciplina è dettata sia da fonti
unilaterali (Stato-governo) che bilaterali (Concordato/intese).
Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico
7
B) Modelli teorici e atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso
Nel corso dei secoli, la legislazione dei singoli Stati, nei confronti delle diverse confessioni
religiose, ha assunto uno dei seguenti atteggiamenti:
a) favoritivo, che conduce ad un sistema confessionistico. Lo Stato, cioè, sceglie una religione come propria (ad esempio lo Statuto albertino qualificava come religione di
Stato quella cattolica; l’Iran si definisce Repubblica islamica) e informa prevalentemente il suo ordinamento ai principi da essa espressi;
b) avversativo, che da vita ad un sistema statale laico anti-ecclesiale (si pensi al fenomeno dell’ateismo di Stato professato dalla Rivoluzione Francese e nell’ex Unione Sovietica);
c) indifferente, in cui l’ordinamento ignora il fenomeno religioso e si atteggia a «Stato
separatista» mettendo sullo stesso piano «libertà di coscienza» e «di culto» per cui
considera le diverse associazioni religiose presenti sul suo territorio alla stessa stregua
delle altre forme associative.
In sintesi, uno Stato si definisce:
— confessionista, se manifesta un atteggiamento di favore nei confronti di una determinata confessione religiosa, pur accettando (o tollerando) la presenza di altre forme di culto;
— unionista, quando il potere temporale e quello religioso sono concentrati nelle mani della medesima autorità. Il «principio di unione» può, inoltre, condurre sia alla teocrazia, quando è il potere
statuale ad essere subordinato a quello religioso, sia al cesaropapismo, quando è l’autorità religiosa a seguire il potere statuale (es.: Regno di Italia);
— separatista, se tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione speciale del fenomeno religioso, né favorevole né limitativa (così fu la Costituzione federale
degli Stati Uniti del 1787 che sanciva all’art. VI, comma 3, che nessuna dichiarazione di fede può
costituire condizioni per ottenere un ufficio o incarico pubblico);
— laico, che accoglie la distinzione fra sfera temporale e sfera spirituale e riconosce e garantisce il
pluralismo confessionale senza nessuna forma di preferenza o dissenso.
La nostra Repubblica come tutti i paesi democratici è uno Stato laico in quanto l’art. 3 Cost.
stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione,
mentre l’art. 8 Cost. afferma che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Lo Stato italiano non assume, però, un atteggiamento indifferente nei confronti del fenomeno
religioso, in quanto ha stipulato un «concordato» che regola i rapporti con la Chiesa cattolica
mentre con le altre religioni presenti sul territorio ha dato vita ad una serie di «intese».
C) Il principio di laicità
La normativa relativa ai culti trova, negli ordinamenti democratici, la sua norma base,
intesa come «fonte delle fonti», nel principio di laicità che presenta prevalentemente carattere negativo in quanto più che prescrivere comportamenti positivi (che sono oggetto
specifico di «concordati» e «intese») rappresenta un limite alla violazione, in nome di un
credo religioso, dei principi di eguaglianza, libertà e non discriminazione.
Il principio di laicità, dunque, è da considerarsi una «qualificazione di sistema» che non
può definirsi «separazione piena e completa», ma «separazione coordinata».
8
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
L’ordinamento italiano, a differenza degli altri ordinamenti democratici, per motivi storicopolitici, si trova in una situazione anomala in quanto i rapporti con la religione cattolica
sono disciplinati da fonti internazionali, i Patti Lateranensi, la cui modifica, ex art. 7 Cost.,
richiede una «procedura rinforzata», al contrario degli altri culti i cui rapporti sono invece
regolati mediante legge ordinaria sulla base di «intese» (art. 8 Cost.).
D)Conclusioni
In Europa, nel corso della storia, prima dell’entrata in vigore delle Costituzioni moderne,
l’atteggiamento degli Stati ha assunto carattere quasi sempre confessionale soprattutto
negli Stati assoluti, ove il Sovrano rappresentava l’arbitro dei destini del suo popolo vigendo il principio «cuius regio, eius religio», ossia si dava prevalenza al credo religioso professato dal re e dalla sua dinastia mentre gli altri culti erano tollerati se non osteggiati.
Peraltro, per tutto il medioevo e l’età moderna, Papa e Imperatore, definiti da Dante nel
De Monarchia i «due soli», hanno rappresentato i vertici delle comunità che formavano la
Respublica Christiana, costituendo una «diarchia» che generava potenziali conflitti tra
potere religioso e potere civile in tutto l’occidente cristiano.
Con il Trattato di Westfalia (1648) tale bipolarismo è venuto meno in quanto i singoli
Stati europei spezzarono il loro cordone ombelicale che li legava all’Imperatore d’Occidente (che rimase per secoli solo una carica formale attribuita all’imperatore asburgico) e con
il Papa.
Da allora cominciarono ad affermarsi, accanto alla nascita degli Stati nazionali (che diedero vita ad una comunità internazionale composta di Stati in posizione «paritaria» cioè superiorem non recognoscit), anche le diverse chiese nazionali che non sempre rimasero legate all’autorità del Pontefice (es. Chiesa anglicana in Inghilterra, luterana in Germania che
interpretavano il cristianesimo con criteri diversi (1)).
Attualmente il fattore religioso, come nota Botta, ha accresciuto notevolmente il suo peso nel mondo contemporaneo in quanto, dinnanzi alla crescente «desolazione morale della società» e alla diffidenza degli individui
verso la deriva negativa della globalizzazione, la sua presenza apre nuove strade tra tutti i principali «credi»
religiosi (2) verso una generale solidarietà fra tutti gli esseri umani (v. §2, lett. E).
2.Diritto dei culti ed evoluzione del diritto ecclesiastico italiano
Il rapporto tra Stato e fenomeno religioso è oggetto del «diritto ecclesiastico» che, come
detto, andrebbe definito «diritto dei culti» per ricomprendere qualsiasi culto alla luce dei
principi costituzionali vigenti (Gherro-Miele).
Ciò perché uno «Stato pluralista e multirazziale» non può riferirsi ad una unica ed esclusiva fonte di carattere spirituale, ma è tenuto ad osservare una condotta aperta e, comunque,
(1) Coloro che si allontanano dalla Chiesa sono detti:
— apostati, se si limitano solo a prendere le distanze dal Cattolicesimo;
— eretici, se professano differenti interpretazioni dei testi sacri;
— scismatici, se fondano comunità religiose autonome che fanno capo, nello stesso credo, a principi e valori differenti da
quelli canonici.
(2) Di tale importante svolta si è reso protagonista Papa Francesco che ha dimostrato una sorprendente apertura verso le
«genti del libro» (cioè cristiani, musulmani ed ebrei citati da tre libri in molte parti similari che professano analoghi principi
di solidarietà umana).
Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico
9
laicista improntata sul riconoscimento degli intangibili principi della «libertà di culto» e
dell’«eguaglianza in materia di credo religioso».
Tuttavia, la dottrina italiana, legata alla storica tradizione confessionale, continua a definire il rapporto Stato-confessioni religiose col termine di «diritto ecclesiastico» la cui deriva
neo-confessionalista resta ideologicamente legata alla prevalenza della Chiesa cattolica
sugli altri culti in virtù del fatto che il suo credo è stato ed è (sebbene oggi in misura molto
minore), patrimonio condiviso dalla maggioranza dei cittadini.
A) Le fasi del diritto ecclesiastico italiano
Dall’Unità d’Italia (1861) il diritto ecclesiastico ha attraversato tre fasi:
—un primo periodo «liberale» (1861-1929);
—un secondo periodo, incentrato sui «Patti lateranensi» (1929-1948);
—un terzo periodo, caratterizzato dall’avvento della «Costituzione repubblicana» e dalla contrattazione bilaterale ispirata al principio pattizio (artt. 7-8 Cost.).
La legislazione del periodo liberale si caratterizza, in un primo momento (Statuto albertino),
per il riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato e per la tolleranza
verso gli altri culti conformi alla legge.
Si deve, comunque, sottolineare che soprattutto ad opera di Cavour, per combattere la mano
morta, furono promulgate dal Regno d’Italia una serie di leggi eversive per ridimensionare
il patrimonio ecclesiastico esistente in Piemonte (grazie ai copiosi lasciti fatti alla Chiesa
dai fedeli), che generarono forti contrasti con lo Stato pontificio tanto che l’Italia dopo
l’Unità si trovò costretta ad emanare la cd. «legge delle Guarentigie» (1871).
Tale legge, dopo aver riconosciuto al Pontefice immunità, rendite e privilegi in cambio della precedente sottrazione (eversione) di beni (soprattutto immobili), disciplinava in maniera unilaterale i rapporti fra Stato e Chiesa, cercando di chiudere la questione romana apertasi con la presa di Roma da parte delle truppe italiane il 20
settembre 1870. Il Papa, tuttavia, non accettò mai questa legge e ruppe le relazioni diplomatiche con l’Italia
che non erano basate su un rapporto «paritario», ma disciplinato unilateralmente dal solo Stato e, quindi, in
qualsiasi momento modificabili senza il suo consenso.
Dopo la fine della prima guerra mondiale, la Chiesa e il regime fascista, al fine di incrementare il consenso popolare, concorda una soluzione della questione romana diversa da
quella unilaterale offerta dalla legge delle Guarentigie.
Così, dopo lunghe trattative, si pervenne alla stipula, l’11 febbraio 1929, dei Patti Lateranensi, che segnavano il ricorso allo strumento pattizio che, attraverso una contrattazione
paritaria della disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica chiuse definitivamente la
cd. «questione romana».
Nello stesso anno fu approvata anche una legge per disciplinare i «culti ammessi», cui seguì
nel 1930 un regolamento di attuazione.
L’avvento della Costituzione del 1948 ha segnato il consolidamento, alla luce dei valori
costituzionali garantiti da una Carta «rigida», di alcuni principi fondamentali in materia
religiosa quali:
—la libertà di religione, riconosciuta sia in forma individuale che associata;
—l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose e il principio di non discriminazione;
—il riconoscimento del principio pattizio nei rapporti fra Stato e confessioni religiose;
10
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
—la conferma di una differenziazione ai limiti della «costituzionalità» fra la posizione
della Chiesa cattolica, basata sui Patti lateranensi, ossia su atti di diritto esterno stipulati fra soggetti di diritto internazionale (lo Stato italiano e lo Stato della Città del Vaticano), e quella delle altre confessioni, basata su semplici intese, cioè su atti di diritto
interno;
—il disconoscimento del principio della religione di Stato e l’affermazione del principio
di laicità dello Stato (non «formalmente» sancito nella Carta).
Emergeva, con il passare degli anni, la necessità di rivedere le norme concordatarie per
armonizzarle ai principi costituzionali, facendo venire meno quelle norme in contrasto con
la nostra «legge fondamentale».
Questo processo di revisione concordata, culminò con l’accordo di Villa Madama del 18
febbraio 1984, definito Accordo di modificazione del Concordato lateranense che ha modificato, alla luce del principio (e dei suoi corollari) di non discriminazione e di libertà religiosa, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.
Nel frattempo fu aperta anche la contrattazione bilaterale con le confessioni acattoliche
in attuazione dell’art. 8 Cost.
B) Identità culturale e fenomeno religioso
La recente dottrina (Botta) ha osservato che oggi il rapporto tra Stato e comunità religiosa
vive una nuova stagione di maggiore dialogo e minore irrigidimento.
Nelle società multiculturali contemporanee, la presenza di più religioni e le diverse identità numerica di esse sono più marcate e ciascun credo rivendica ambiti sempre più ampi di
autonomia.
Questa situazione, se non disciplinata almeno nelle sue linee generali, può condurre a gravi
conflitti ideologici e religiosi, in cui ciascuna istituzione religiosa tenta di condizionare le
scelte dello Stato a partire dal rispetto della propria tavola di valori.
Il problema fondamentale di ogni società statale è quello di trovare un corretto e democratico equilibrio tra le diverse comunità religiose presenti sul suo territorio.
Per tale motivo, è necessario un intervento significativo del legislatore volto al soddisfacimento degli interessi religiosi di tutti i cittadini.
Dottrina
Lo Stato, dunque, ha l’obbligo di tutelare il sentimento religioso ad un doppio livello:
— a un primo livello, lo Stato si trova davanti a fattispecie in cui il sentimento religioso coinvolge
profili di identità personale e collettiva dei singoli fedeli. In questi casi lo Stato deve solo garantire
la libertà religiosa, attraverso norme unilaterali ispirate a principi di eguaglianza, non discriminazione, libertà e proporzionalità.
— a un secondo livello, il fattore religioso assume un rilievo di connotazione specifica, in quanto
vengono in rilievo differenti profili di identità e appartenenza ad una determinata confessione. In
tal caso lo Stato interviene utilizzando lo strumento della contrattazione negoziata della disciplina,
dei rapporti Stato-comunità religiosa, introducendo anche particolari forme di trattamento che,
però, non possono intaccare in nessun caso i principi fondamentali del sistema, tra cui, in primis,
il principio laicista.
Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico
11
C) Lo status giuridico delle diverse confessioni religiose
Nel nostro Paese lo status delle confessioni religiose si fonda su due livelli:
1. l’ordinamento costituzionale che afferma il principio della secolarizzazione, neutralità e laicità dello Stato e del rispetto di tutte le fedi religiose compatibili con i principi
costituzionali e che non violino il principio del buon costume. Dunque, come vige il
principio di libertà di pensiero (di cui la libertà di coscienza e di culto rappresentano due
corollari), così pure è riconosciuto il principio di libertà di adesione, pratica e proselitismo per tutti i culti indistintamente;
2. il regime degli accordi (concordato ex art. 7 Cost., intese ex art. 8 c. 3 Cost.) tra Stato e culti.
In conclusione, a tutte le confessioni religiose, indipendentemente dall’aver stipulato un
accordo con lo Stato italiano, viene riconosciuta in base al principio di separazione un’autonomia originaria riconosciuta e riconoscibile.
D)Il principio di non ingerenza dello Stato nell’esercizio dei culti
La Repubblica riconosce a tutte le religioni piena libertà nell’esercizio del proprio culto
(art. 19) senza imporre la sua ingerenza in condizioni di reciprocità (nel senso che un
provvedimento di una autorità appartenente ad una confessione religiosa, non può essere
mai lesivo degli interessi dello Stato).
Tale libertà si estende anche alla nomina dei ministri del culto e a tutti coloro che rientrano nella gerarchia e nell’organizzazione religiosa che, nei confronti dello Stato godono
tutti di uno status paritario.
Nell’esercizio del loro ministero agli stessi viene riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d’ufficio (es. confessione) non in base al concordato o a specifiche intese, ma in relazione alle tutele contenute nel codice di procedura penale.
E) Il favor religionis
Come nota Dalla Torre, emerge da una lettura più attenta della Costituzione (sia «materiale» che «vivente») il riconoscimento del principio del favor religionis e un disfavore
verso l’ateismo come risposta agli interrogativi ultimi della vita dell’uomo.
L’attenzione del Costituente al «fattore religioso» (sia nella dimensione individuale che collettiva, sia positiva che negativa) si concreta nella negoziazione e nel confronto con i diversi
culti e nel rispetto delle loro statuizioni nei limiti dei principi del nostro ordinamento.
Viene, così, superato il regime di «separazione» di stampo cavourriano dinanzi all’aspirazione e alla promozione dei principi relativi alla libertà e dignità dell’uomo che trova conferma nel valore riconosciuto e non discriminato dell’adesione al credo religioso più vicino
alla coscienza del singolo.
3.I rapporti tra diritto ecclesiastico, diritto canonico e scienze affini
A) Definizione e scopo del diritto canonico
Il diritto canonico può essere definito come «l’insieme delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica», norme secondo le quali «la Chiesa è organizzata e che regolano l’attività dei fedeli in relazione ai fini della Chiesa stessa» (Del Giudice V.).
12
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Da tale definizione si rileva che scopo del diritto canonico è l’organizzazione e la regolamentazione della comunità dei credenti battezzati in Cristo (cd. populus fidelis per universum orbem dispersus), società che costituisce, nella sua struttura istituzionale, la Chiesa
cattolica (societas iuridice perfecta, in genere suo suprema).
Dottrina
Per Tedeschi il diritto canonico costituisce un modello unico per una grande religione comune a
tutti i cristiani. Le sue norme riguardano anch’esse il fenomeno religioso sebbene siano applicabili ai
fini della determinazione del contenuto delle fattispecie ecclesiastiche ed assumono rilievo solo se
esplicitamente richiamate dal nostro ordinamento.
Ribadisce Dalla Torre che l’indipendenza e la sovranità riconosciute alla Chiesa, ex art. 7 Cost., significano soltanto che lo Stato non è legittimato a sindacare gli interna corporis dell’istituzione ecclesiastica. Pertanto la Chiesa può legittimamente, all’interno del suo ordine, porre atti giuridicamente
vincolanti, indipendentemente dall’efficacia che questi atti ricoprano nell’ordinamento italiano.
In sostanza, quindi, il diritto canonico è costituito da quell’insieme di norme che (Hervada):
a) creano i rapporti giuridici canonici, cioè i legami che collocano i fedeli in una determinata situazione giuridica all’interno del corpo sociale della Chiesa e in ordine ai suoi fini;
b) regolano tali rapporti nell’ambito della Chiesa cattolica;
c) organizzano la gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività;
d) valutano e regolano i comportamenti dei singoli fedeli.
B) Il diverso significato del «diritto ecclesiastico» nella dottrina canonistica
La dottrina «canonistica» definisce «ecclesiastico» il «diritto della Chiesa» che comprende:
—jus sacrum (diritto canonico di origine divina);
—jus pontificium (diritto canonico derivante dall’autorità del Papa e che si esplicita attraverso le fonti tradizionali pontificie es. bullae etc.);
—jus ecclesiasticum (diritto canonico riguardante le materie residuali).
Il termine «diritto ecclesiastico», quindi, nell’accezione canonistica, indica una branca, un
suo ramo residuale, mentre nel «diritto statuale» indica il complesso delle norme che riguardano la posizione della Chiesa cattolica entro l’ordinamento statuale. Quest’ultimo diritto,
nella terminologia canonistica, viene detto, invece, «jus publicum externum».
Dottrina
Secondo Jemolo, la differenza fondamentale fra i due ordinamenti giuridici deriva dal fatto che:
— le norme del diritto canonico sono originarie ed autonome perché fatte valere da uno Stato, come
ha riconosciuto l’art. 7 della Costituzione;
— il diritto ecclesiastico, invece, è un complesso di norme che, per avere efficacia, deve essere
concordato e riconosciuto dall’ordinamento statuale in quanto costituisce un ramo del diritto interno italiano e fa parte del diritto pubblico.
C) Differenze tra diritto ecclesiastico e scienze affini
Il diritto ecclesiastico non solo non può essere confuso con il diritto canonico, ma neanche con:
— la storia del diritto canonico, che si riferisce a duemila anni di vita giuridica della Chiesa;
— la storia dei rapporti tra Stato e Chiesa, che riguarda i modelli di relazioni esterne tra i due poteri (ad es.
lo Stato unionista o separatista);
Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico
13
— la storia delle istituzioni religiose, perché le strutture ecclesiastiche e gli ordini religiosi hanno sempre
avuto nel tempo una rilevanza tale da influenzare anche la legislazione di diritto comune;
— il diritto ecclesiastico comparato, poiché i movimenti religiosi riguardano quasi sempre più Paesi e quindi più ordinamenti giuridici. La comparazione deve essere effettuata da un punto di vista interno, e non
esterno, all’ordinamento che si considera per non commettere errori di valutazione.
4.La collocazione sistematica del diritto ecclesiastico (dei culti) tra le
scienze giuridiche
A) Definizione
Il diritto ecclesiastico (3) costituisce quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per
oggetto la disciplina del fenomeno religioso (Tedeschi), che abbraccia il complesso delle
credenze e delle convinzioni umane in una visione fondata sull’idea del sacro e del divino.
Il fenomeno religioso non coinvolge soltanto l’individuo ma interessa anche le formazioni
sociali in cui si sviluppa la dimensione religiosa della personalità umana rappresentate
dalle comunità di credenti delle diverse fedi.
Negli edifici di culto (Chiese, Moschee, Sinagoghe) il culto diventa un momento collettivo
quando i fedeli si riuniscono nella preghiera o si associano a diversi fini (es.: assistenza,
proselitismo).
Le norme del «diritto dei culti» non costituiscono un corpo organico unitario, ma si ritrovano in
tutti i settori nei quali si articola l’ordinamento giuridico:
— diritto internazionale (al quale appartengono, ad esempio, le norme delle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo);
— diritto costituzionale (che enuncia i principi fondamentali in materia);
— diritto civile (disciplina degli enti ecclesiastici, matrimonio religioso);
— diritto penale (tutela penale del sentimento religioso);
— al diritto del lavoro (rapporto di lavoro nelle organizzazioni di tendenza);
— diritto amministrativo (edilizia di culto, beni culturali di interesse religioso).
Altra peculiarità è rappresentata proprio dalla presenza di fonti non solo unilaterali ma anche di
derivazione pattizia, ossia frutto dell’accordo fra lo Stato e le diverse confessioni religiose.
Il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico
anche se in alcuni paesi (Italia, Spagna, America latina) assurge, per la centralità che assume la Chiesa cattolica, a disciplina «autonoma». Si parla, così, di autonomia scientifica e
didattica.
Fino al Concordato del 1984 essa è stata oggetto di numerosi interventi della Corte costituzionale in tema di
libertà religiosa, matrimonio, rapporti fra Patti lateranensi e principi costituzionali nonché ha segnato l’evoluzione legislativa del diritto di famiglia in tema di matrimonio ed educazione religiosa dei figli. Da ultimo nel
diritto tributario è stato istituito l’otto per mille, il cinque per mille etc.
(3) Stando alla etimologia il termine «ecclesia» andrebbe inteso solo come diritto della «Chiesa cattolica» o, al massimo,
delle chiese cristiane. Nella nostra tradizione invece, storicamente si è fatta sempre confusione tra «diritto dei culti» e «diritto ecclesiastico» che ne rappresenta, invece, una sola parte.
14
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
B) Conclusioni
Il diritto ecclesiastico (dei culti), per sua natura e vocazione, in uno Stato democratico, deve
giovarsi di una struttura policentrica che lo connota diversamente dalle altre scienze giuridiche, in quanto:
a) non fa parte del diritto internazionale: il diritto internazionale, infatti, (anche se eccezionalmente è richiamato nel Trattato tra Italia e Stato della città del Vaticano) abbraccia solo norme che si indirizzano agli «Stati» e alle organizzazioni considerati come
enti sovrani (ciò non esclude, comunque, che esista un «autonomo» diritto ecclesiastico
internazionale che regoli i rapporti tra la Santa Sede e gli altri Stati che hanno stipulato
concordati con essa) anche se comunque vigono numerose convenzioni multilaterali o
bilaterali (es. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite (1012-1948), Convenzione dei diritti del fanciullo (L. 176/1991), nonché altre convenzioni
sulla libertà religiosa delle minoranze nazionali, di lavoratori migranti etc.);
b) fa parte del diritto interno in quanto trattasi di un complesso di norme che vige all’interno dello Stato;
c) è un ramo del diritto pubblico (con estensioni nel diritto privato), poiché contempla
diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono e operano
nell’organizzazione statale;
d) si relaziona col diritto dell’Unione europea sia convenzionale (trattati) sia non convenzionale (regolamenti, decisioni e direttive) in relazione all’incidenza del fattore religioso sui principi europei.
Si ricordi che le istituzioni dell’Unione europea sono poste ad un livello separato, ma
preferenziale (cd. primauté del diritto dell’Unione), rispetto ai singoli ordinamenti nazionali finiscono per influenzare sia i rapporti tra singoli Stati che i singoli culti.
La perdita di sovranità dei Paesi membri dovuta al depotenziamento dei rapporti esclusivi Stato-cittadini crea una convivenza forzata tra i due soggetti sovrani sia in relazione
ai rapporti tra «Parlamenti» (nazionali ed europei) sia tra Ministri nazionali e Consiglio
dei Ministri europei sia tra le diverse «corti» in campo giurisdizionale.
Tutto ciò ha determinato una crescita dei punti di accesso e di contatto dei singoli culti
e dei singoli fedeli nei confronti degli organi burocratici nazionali e sopranazionali per
la tutela dei propri diritti;
e) non è presente in tutti gli ordinamenti nazionali: la materia dei rapporti Stato-confessioni religiose è prevalentemente collocata nell’ambito del diritto costituzionale e riguarda la disciplina relativa alla discriminazione in materia di credo religioso, alla libertà di
coscienza, di culto, di associazione e riunione etc. Ciò, però, non esclude che in presenza di comunità sovranazionale il fenomeno religioso possa essere «ignorato» dai singoli Stati.
Il metodo del diritto ecclesiastico differisce da quello di altri settori dell’ordinamento in
funzione del suo oggetto peculiare. Gli interessi religiosi, infatti, differiscono significativamente dagli interessi economici o materiali in genere, anche per il loro carattere immateriale la cui presenza risulta importante nel rispetto dei valori più intimi dell’uomo: da ciò
si evince il concetto di favor religionis (v. ante §2, lett. E).
Capitolo 1: Concetto e definizione del diritto ecclesiastico
15
Aspetti odierni del diritto ecclesiastico
Numerosi fattori socio-politici hanno influito sullo sviluppo della disciplina in Italia e nell’Occidente:
— la perdita della centralità della Chiesa cattolica e la conseguente libera crescita di altri credi religiosi (che vanno dal dal laicismo all’ateismo);
— la trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligioso della società, dovuta
ai forti flussi migratori che hanno rotto l’omogeneità etico-culturale-religiosa a favore di un riavvicinamento tra tutte le religioni;
— la frammentazione dei culti che hanno creato, attraverso le «intese», una normativa speciale
differenziata in materia di culti;
— l’importante contributo della giurisprudenza che ha saputo interpretare, nel corso degli anni, il
cambiamento attraverso coraggiose sentenze (e non sempre ben accettate dai poteri tradizionali) in cui la voce del popolo sovrano si materializza e si riconosce!
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
21
5.Il giurisdizionalismo
A) Concetto e forma
Pur rifiutando come «eresie» le tesi dottrinali di Lutero, i prìncipi cattolici fecero proprie le
accuse «di ingerenza» della Chiesa nei confronti dello Stato. Per questo motivo, anche nelle aree di dottrina cattolica si sviluppò una politica di ridimensionamento dell’ingerenza del
potere ecclesiastico e di riaffermazione del primato del potere politico su quello spirituale.
La nuova politica ecclesiastica dello Stato moderno, tendente a sottomettere la Chiesa al
controllo dell’autorità civile (Olivero, Spinelli), va sotto il nome di giurisdizionalismo
(2), anche se nei secoli XVII e XVIII assunse denominazioni diverse in base ai Paesi in cui
veniva adottata.
Dottrina
I movimenti che caratterizzano i rapporti tra Stato e Chiesa furono numerosi e assunsero le seguenti denominazioni:
— regalismo, in Italia e in Spagna (soprattutto con Carlo III di Borbone);
— tanuccismo a Napoli, dal nome del ministro Bernardo Tanucci, promotore, con l’amniraglio Caracciolo, di importanti riforme in materia ecclesiastica;
— febronianismo in Germania, dalle teorie del vescovo Giuseppe Nicola von Hontheim, più noto
con lo pseudonimo latino di Febronius;
— giuseppinismo in Austria, dal nome dell’imperatore Giuseppe II, che si intromise nella legislazione ecclesiastica con una serie di diktat molto dettagliati (non a caso fu denominato «il re sacrestano»);
— leopoldismo in Toscana, dal nome del granduca Pietro Leopoldo, seguace del giuseppinismo e
che, come nota Jemolo, «fu più d’ogni altro Principe sprezzante dell’autorità pontificia»;
— gallicanesimo in Francia, ove più forti si manifestavano le tendenze decentratrici del clero nazionale nei confronti di Roma (v. la celebre Declaratio cleri gallicani ispirata dal Bousset).
Il sorgere del giurisdizionalismo, comunque denominato, derivò soprattutto dall’affermarsi del «principio della sovranità territoriale», che nel campo giuridico rappresentò un vero e proprio diritto
dominicale del Principe sul territorio e sui sudditi (principio sancito dalla pace di Augusta e confermato da quella di Westfalia).
Questo sistema, pur partendo dal presupposto della distinzione dei due poteri, postulava, nei rapporti tra Stato e Chiesa, una prevalenza del primo sulla seconda, in quanto a ciascun Principe (per diritto divino) spettava, il compito di organizzare e ridimensionare il potere della Chiesa all’interno del
territorio da lui governato garantendole, comunque, il formale esercizio del suo potere spirituale.
Con il giurisdizionalismo i sovrani cattolici si ergono «formalmente» a protettori della
Chiesa e delle sue istituzioni, ma i loro veri fini non sono tanto di difesa, quanto di ingerenza negli affari ecclesiastici per limitarne la sfera di influenza e, così, affermare il loro potere di impero.
È importante sottolineare come questi risultati furono perseguiti con l’adozione di atti
normativi ordinari contro i quali l’opposizione del ceto ecclesiastico non possedeva strumenti di contrasto.
(2) Oggi, con il termine giurisdizionalismo si indica quella teoria relativa ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa (cattolica) che
prevede la distinzione tra i due ordinamenti e, nel contempo, il coordinamento tra di essi. Il giurisdizionalismo, in particolare, si contrappone al separazionismo.
22
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Il giurisdizionalismo dette luogo a nuovi istituti, i cosiddetti «diritti maiestatici» (iura maiestatica circa sacra)
che possono essere distinti in due categorie:
a) diritti posti a difesa della Chiesa:
1) ius reformandi: facoltà dello Stato di stabilire le condizioni di vita della Chiesa al suo interno (riformandole, se del caso), affinché essa potesse meglio perseguire le proprie finalità;
2) ius advocatiae o protectionis: secondo il quale lo Stato tutelava la Chiesa contro eresie e scismi e controllava tutti gli affari ecclesiastici;
3) ius supremae inspectionis: una sorta di «polizia ecclesiastica» attraverso la quale lo Stato sorvegliava
l’attività di concili, missioni, ordini religiosi, l’insegnamento religioso e, persino, l’amministrazione dei
sacramenti.
b) diritti posti a difesa dello Stato contro eventuali ingerenze ecclesiastiche:
1) ius dominii eminentis: il Principe imponeva la sua sovranità anche sui beni ecclesiastici, che poteva
sottoporre a tributi, amministrare direttamente (in caso di vacanza) o addirittura incamerare tramite le
cd. leges de amortizando;
2) ius cavendi: diritto dello Stato di difendersi contro le attività antistatuali della Chiesa, mediante l’esercizio di:
— ius nominandi: partecipazione diretta dello Stato alle nomine degli ecclesiastici;
— ius exclusivae: possibilità di dichiarare «non gradita» una persona preposta dalla Chiesa a capo di
un determinato ufficio ecclesiastico;
— placitum regium o exequatur: controllo preventivo sugli atti delle autorità ecclesiastiche (a volte
anche quelle di contenuto dogmatico);
3) ius appellationis: diritto dei sudditi di ricorrere in appello allo Stato contro decisioni delle autorità ecclesiastiche (appellatio ab abusu).
A fianco di questo giurisdizionalismo confessionale, si afferma anche uno nuovo anelito libertario che abbandonava il confessionismo per farsi promotore della libertà religiosa per tutti, della laicità dello Stato e,
sul piano giuridico-pratico, di una legislazione imperniata sulla difesa dei diritti e delle prerogative dello Stato
e delle comunità di fedeli che, così, prendevano le distanze dalla Chiesa di Roma.
6.L’apporto della Rivoluzione francese
La Rivoluzione francese, dapprima con la «Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino» (1789), successivamente con la «Costituzione civile del clero» (12 luglio 1790),
modificò radicalmente il sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa, determinando il crollo del
sistema ecclesiastico tradizionale e dei suoi forti poteri di ingerenza, già compromesso
dalla diffusione del giurisdizionalismo.
Dottrina
In particolare, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo proclama il principio di eguaglianza e riconosce la
libertà religiosa di tutti i cittadini.
La Costituzione civile del clero (1790) trasforma gli ecclesiastici in ufficiali stipendiati dallo Stato, imponendo loro il giuramento di fedeltà alla rivoluzione. Sia i vescovi che i parroci venivano eletti, secondo le nuove disposizioni, rispettivamente dalle assemblee legislative dipartimentali e distrettuali.
La Costituzione civile del clero non fu pacificamente accettata dalle gerarchie della Chiesa: alcuni prelati rifiutarono di prestare giuramento, determinando la scissione tra preti costituzionali e preti refrattari.
Nella seconda fase della rivoluzione, che culmina con il Terrore (1793-1794), si radicalizza ancora di
più lo scontro giungendo alla persecuzione del clero refrattario e alla repressione del cattolicesimo
romano, fino alla sostituzione della religione con il culto pagano della «Dea Ragione».
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
23
Questo atteggiamento antireligioso si attenua con l’ascesa al potere di Napoleone che solo al fine di
conferire una legittimazione sacrale tradizionale al suo potere, si fece incoronare imperatore a
Parigi, dal pontefice Pio VI.
La successiva caduta di Napoleone (1815) e la restaurazione non fecero venir meno del tutto le conquiste del periodo rivoluzionario, e la Francia per lungo tempo fu ancora divisa fra il conservatorismo
cattolico e le tendenze separatiste dello Stato laico.
7.L’affermazione nell’800 del «laicismo» e la «separazione» tra Stato e Chiesa
Per quanto la «restaurazione» delle dinastie spodestate dall’ondata rivoluzionaria e dalle
armate napoleoniche (1815) mirasse a ripristinare gli antichi privilegi del clero e ritornare
all’alleanza tra trono e altare, l’Ottocento è anche il secolo che, in concomitanza con la
progressiva affermazione dei ceti liberali, vede diffondersi ulteruiormente le tendenze alla
separazione tra Stato e Chiesa sotto l’influenza del pensiero dell’Enciclopedia.
La costruzione di un apparato amministrativo fedele alla corona e il tentativo di unificazione legislativa — in base al quale il diritto posto dallo Stato, ovvero la legge, costituisce
l’unica ed esclusiva fonte del diritto che si contrappone alle consuetudini e agli ordinamenti particolari nati con il feudalesimo (compreso quello ecclesiastico) — sono i due elementi
che caratterizzano il processo di formazione dello Stato laico e liberale del XIX secolo.
In questo tipo di ordinamento le scelte di tipo confessionale sono considerate un affare
privato dei cittadini, cui viene riconosciuta la piena libertà di professare una fede, ma anche
di non credere, di aderire o allontanarsi da qualsivoglia confessione o credo senza dover
subire nessuna forma di ritorsione da parte dell’autorità statale.
Si comincia ad affermare un tipo di giurisdizionalismo «liberale» che riconosce indistintamente a tutti la piena libertà religiosa, contrapposto al precedente giurisdizionalismo confessionale che imponeva ai sudditi il credo del principe.
Per quanto riguarda la nostra penisola il passaggio dall’alleanza tra trono e altare alla separazione tra Stato e Chiesa è testimoniato dalla politica anti-ecclesiastica di Cavour nel regno
di Sardegna, prima, del neonato Regno d’Italia, dal 1861 poi (principio cuius regio et cuius
religo).
Sezione Seconda
La formazione del diritto ecclesiastico italiano: 1848-1984
1.La politica ecclesiastica del Regno di Sardegna
I princìpi che ispirarono la politica ecclesiastica di Carlo Alberto tesero da un lato a ridimensionare il potere della Chiesa e, dall’altro, a riconoscerle il ruolo di «religione di Stato».
L’art. 1 dello Statuto del Regno di Sardegna del 1° marzo 1848, riproducendo analoga disposizione del precedente codice albertino del 1837, afferma: «la religione cattolica è la
sola religione dello Stato», precisando poi che «gli altri culti esistenti sono tollerati conformemente alle leggi».
Questo principio statutario fu però attenuato, già nel corso del 1848, con la legge n. 735 del
19 giugno (cd. legge Sineo), secondo la quale «la differenza di culto non forma eccezione
al godimento dei diritti civili e politici o all’ammissibilità alle cariche civili e militari».
24
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Questa disposizione, estesa successivamente a tutto il territorio nazionale, diverrà, come ci
ricorda Spinelli, «una norma basilare dell’ordinamento del nuovo Stato unitario italiano»
che vietava qualsiasi forma di discriminazione in base al credo religioso.
L’evoluzione «laica» della politica ecclesiastica sarda ebbe la conferma, nello stesso 1848,
con la legge n. 777 del 25 agosto (che privò del diritto di associazione i membri della Compagnia di Gesù), nonché da provvedimenti successivi che già anticipavano nello spirito le
successive «leggi eversive» del patrimonio ecclesiastico con cui lo Stato sottraeva progressivamente espropriando alla Chiesa l’enorme patrimonio che nel corso dei secoli aveva
accumulato grazie ai lasciti dei fedeli mirati ad ottenere l’indulgenza plenaria.
Dottrina
Ricordiamo in particolare, in materia ecclesiastica, le seguenti leggi del parlamento subalpino:
— L. 9-4-1850, n. 1013 (cd. legge Siccardi) con cui fu abolito il foro ecclesiastico;
— L. 5-6-1850, n. 1037, che sanciva il divieto per gli enti morali (e quindi anche per la Chiesa e i suoi
istituti) di acquistare beni senza autorizzazione governativa;
— L. 29-5-1855, n. 878 che sopprimeva le case degli ordini religiosi che non attendessero alla predicazione, all’educazione o all’assistenza degli infermi.
I beni di queste case soppresse furono conferiti ad una Cassa ecclesiastica, che rappresentava
persona giuridica distinta ed indipendente dallo Stato.
2.L’unità d’Italia: le «leggi eversive»
Con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861 fu attuata, nei confronti della Chiesa, una
politica restrittiva che incideva soprattutto sugli enti ecclesiastici (le cd. leggi eversive) al
fine di ridimensionare, a beneficio dello Stato, la notevole e mal gestita forza economica.
In particolare:
— con la L. 7-7-1866, n. 3036 fu negato il riconoscimento legale (e quindi la capacità patrimoniale) agli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari nonché ai conservatori e ai ritiri che comportassero vita
comune ed avessero carattere ecclesiastico.
Il patrimonio di tali enti soppressi fu devoluto al demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran
libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore del neo costituito Fondo per il culto (che succedeva, in ogni rapporto, alla previgente Cassa ecclesiastica dello Stato sardo).
Nel contempo, con questa stessa legge, veniva sancita l’incapacità, per ogni ente morale ecclesiastico, di
possedere beni immobili;
— con la L. 15-8-1867, n. 3848, la soppressione, già disposta con la L. 3036/1866 per gli enti regolari, fu
estesa, con modalità analoghe, a tutti gli enti secolari che lo Stato, con propria autonoma valutazione, riteneva superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi statuali.
Esclusi dalla soppressione e dalla conseguente «spoliazione» dei beni furono le parrocchie, gli ordinariati, i canonicati, le chiese cattedrali, i seminari, le fabbricerie, luoghi ritenuti necessari per l’effettiva pratica di culto.
3.La questione romana e la legge delle guarentigie
A) La questione romana
L’avvenuta proclamazione del Regno d’Italia (1861), non poteva considerarsi completa, dal
momento che erano esclusi dal territorio nazionale importanti città e province come Roma
e Venezia.
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
25
Il problema della indipendenza del Papa e della Santa Sede prese il nome di «questione
romana», questione che dopo un decennio di inutili tentativi diplomatici fu risolta militarmente, il 20 settembre 1870, con l’ingresso e l’occupazione di Roma da parte dell’esercito
italiano durata solo pochi minuti, prima della resa dell’esercito pontificio, attraverso la celebre breccia di Porta Pia (3).
In realtà il Regno d’Italia poté approfittare, nella circostanza, della debolezza di Napoleone III, che si era erto
a convinto difensore dell’autorità pontificia.
In precedenza, infatti, le truppe francesi accorse a Roma a difendere lo Stato pontificio, avevano respinto a
Mentana (1867) un tentativo di Garibaldi di risolvere la questione con il consueto «colpo di mano» dei suoi
volontari. Tuttavia, l’andamento disastroso della guerra franco-tedesca e la disfatta del secondo impero di Sedan
(1-9-1870) misero l’imperatore in una posizione di debolezza tale da non poter contrastare l’iniziativa del Governo italiano per portare a termine l’unificazione territoriale conquistando Roma.
Con il R.D. 9-10-1870, n. 5093, nel sancire l’annessione delle province romane al Regno
d’Italia, si rinviò esplicitamente ad apposita legge la determinazione delle condizioni per
garantire «anche con franchigie territoriali» l’indipendenza del Sommo Pontefice.
B) La legge delle guarentigie
Il 13 marzo 1871 veniva emanata dal Regno d’Italia la legge n. 214, che fu detta «delle
guarentigie», poiché si prefiggeva — a tutela della «indipendenza economica della chiesa»
— di garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice.
Il provvedimento si articolava in due titoli ben distinti:
a) il primo, intitolato «prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede», tentava di «garantire» una
certa indipendenza al Pontefice attraverso:
— il riconoscimento del carattere sacro ed inviolabile della persona del Sommo Pontefice e l’estensione
della stessa tutela penale prevista per la persona del Re;
— il riconoscimento della proprietà dei palazzi apostolici vaticano e lateranense, che venivano considerati inalienabili, esenti da tasse o altri pesi e da espropriazioni per causa di pubblica utilità;
— la garanzia delle libertà necessarie per il ministero spirituale della Santa Sede durante la vacanza della
Sede pontificia e le adunanze del conclave e dei concili ecumenici;
— il riconoscimento del diritto di legazione attivo e passivo e la facoltà di corrispondere liberamente con
l’episcopato e con tutto il mondo cattolico;
— la corresponsione di una rendita annua di 3.225.000 lire dell’epoca;
b) il secondo, intitolato «relazioni dello Stato con la Chiesa», comprendeva come disposizioni principali:
— la rinuncia a tutti gli iura maiestatica circa sacra;
— l’abolizione del giuramento al Re dei vescovi;
— il riordino, attraverso una legge successiva, alla conservazione e all’amministrazione delle proprietà
ecclesiastiche del Regno.
Tale atto unilaterale del governo italiano scontentò comunque la Santa Sede che non accettò tale legge poiché «non presentava garanzie di stabilità» in quanto, essendo una legge
interna del Regno, avrebbe potuto essere successivamente abrogata da un’altra legge ordinaria dello Stato (Enciclica «Ubi nos» di Pio IX del 15-5-1871) senza nessuna forma di
accordo con il potere religioso.
(3) Tale evento segnò la fine del potere temporale della Chiesa iniziato nel 728 con la famosa Donazione di Sutri ad opera
dei Longobardi.
26
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Il Regno d’Italia cercò di ovviare solo formalmente, attribuendo alla legge delle guarentigie
il carattere di «legge fondamentale»: dichiarazione che, tuttavia, non toglieva alla legge il
suo carattere unilaterale, giacché il legislatore italiano avrebbe potuto in qualsiasi tempo
trasformare il contenuto della legge stessa senza consultare la Chiesa.
Dal 1870 si aprì, dunque, un’altra epoca di rapporti difficili tra Stato e Chiesa, destinata a
durare fino al 1929.
4.I Patti Lateranensi (1929)
A) Contenuto
Nei primi anni ’20 del Novecento, in Italia prese il potere il movimento fascista con il
sostegno del ceto medio, spaventato dalle rivendicazioni contadine ed operaie derivanti
dalla concessione fatta dal Governo Giolitti del suffragio universale maschile (1915) che
aveva consentito l’estensione del diritto di voto e, a sua volta, la nascita e il consolidamento dei partiti politici di massa (popolare e socialista), rompendo così, l’equilibrio politico
che reggeva lo «Stato borghese».
Il regime autoritario intendeva fare della Chiesa un docile strumento di coesione sociale e
di consenso politico; la Chiesa, invece, vedeva nell’alleanza con il regime la possibilità di
porre un argine sia al liberalismo sia, all’opposto, un argine contro le crescenti forze socialiste.
Sotto la spinta di un clima nazionale più sereno e della concordanza profonda di interessi,
tra Mussolini e le gerarchie ecclesiastiche si addivenne, in data 11 febbraio 1929, alla stipula dei Patti Lateranensi (così chiamati in quanto firmati da Benito Mussolini, capo del
Governo, e dal cardinale Gasparri in rappresentanza del Papa, nel palazzo del Laterano).
Dottrina
I Patti Lateranensi costituiscono per il diritto ecclesiastico italiano una significativa svolta.
Si ripropone, infatti, attraverso lo strumento concordatario, quella forma di contrattazione bilaterale che era stata interrotta nella seconda metà del sec. XIX, ma che sarà recepita nella Costituzione
del 1948 e che per la presenza di numerosi parlamentari cattolici tuttora perdura (Tedeschi).
I Patti constavano di tre distinti documenti:
1) Il Trattato, che risolveva definitivamente la «questione romana» con il riconoscimento della personalità internazionale dello Stato della Città del Vaticano, composto da un
esiguo territorio di 0,44 Km2 su cui si esplica la sovranità esclusiva del Pontefice. In tal
modo fu assicurata agli organi centrali della Chiesa l’indipendenza necessaria per l’esercizio delle loro attività.
2) Il Concordato, che regolava nel dettaglio i futuri rapporti fra Stato e Chiesa in Italia.
3) La Convenzione finanziaria, con la quale furono risolte (almeno sulla carta) le questioni economiche pendenti (e che vedevano il Regno obbligato a risarcire la Chiesa) sorte
dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
27
Il contenuto del trattato fu trasfuso nell’ordinamento italiano con tre leggi di attuazione, tutte datate 27 maggio 1929:
— n. 810, per la piena ed intera esecuzione del Trattato e del Concordato;
— n. 847, cd. legge matrimoniale, per sancire il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato
secondo il diritto canonico e delle sentenze ecclesiastiche di nullità e di dispensa dal matrimonio rato e non
consumato;
— n. 848, sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati ai fini di culto.
B) Il Concordato
Il Concordato pose la Chiesa in Italia in una condizione di privilegio nei confronti delle
altre confessioni religiose.
Per attenuare tale palese diseguaglianza in materia di culto si ritenne di emanare, poco dopo,
la L. 24-6-1929, n. 1159 sull’esercizio dei «culti ammessi» nello Stato e fu riconosciuta la
celebrazione dei matrimoni davanti ai ministri degli stessi culti (v. par. seguente).
Quanto a struttura e contenuto, il Concordato rappresenta una forma di «compromesso»
composto di ben 45 articoli che non prevedono possibilità di intese successive, salvo sancire, all’art. 43, di una generica amichevole procedura soluzione, di comune buon senso, in
caso di eventuali difficoltà di interpretazione.
I punti qualificanti del Concordato del 1929 possono così sintetizzarsi:
a) riconoscimento della religione cattolica quale religione dello Stato (riconoscimento previsto
dall’art. 1 del Trattato);
b) concessione di una serie di privilegi e di esoneri per gli ecclesiastici (es. artt. 3, 4, 7);
c) preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci con cura d’anime
sul territorio nazionale (era previsto anche, per i Vescovi, il giuramento di fedeltà allo Stato italiano) (v. artt. 19-23);
d) riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica
in materia spirituale e disciplinare contro gli ecclesiastici (art. 5 correlato con l’art. 23 del Trattato);
e) particolare regime favoritivo, finanziario e fiscale, riservato agli enti ecclesiastici (art. 29, 3°
comma);
f) particolari forme di intervento finanziario nei confronti del clero (i cd. supplementi di congrua)
(art. 30);
g) riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso (l’art. 34 usa la espressione «sacramento del matrimonio») e riserva alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici le
cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato;
h) l’insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche (eccetto quasi tutte le università) considerato «fondamento e coronamento» dell’istruzione pubblica (art. 36).
C) Il Trattato
I punti principali di questo documento che fa parte della dottrina cristiana sono:
— si riafferma il principio confessionale secondo cui «la religione cattolica apostolica e romana è la sola
religione dello Stato» (art. 1);
— si riconosce l’autonomia degli enti centrali della Chiesa cattolica;
— si riconosce la sovranità internazionale della Santa Sede, il diritto di legazione attivo e passivo, le immunità diplomatiche agli inviati della Santa Sede;
— nasce la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di piazza San Pietro: la sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre all’Italia spetta di provvedere ai servizi pubblici (illuminazione
etc.);
28
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
— si afferma la sacralità e l’inviolabilità della persona del Sommo Pontefice equiparandola a quella del Re;
— dal momento che lo Stato della Città del Vaticano rappresenta un enclave (un piccolo territorio circoscritto
di maggiori dimensioni), lo Stato italiano si impegna ad assicurare il diritto di transito sul proprio territorio
sia ai diplomatici inviati dalla Santa Sede o presso di essa, che alle merci ad essa destinate;
— si assicura anche in Italia l’efficacia giuridica delle sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche riguardanti persone ecclesiastiche o religiose in materia spirituale o disciplinare;
— viene disposto che la Santa Sede è proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili ed istituti pontifici;
— si riconoscono alla Santa Sede il diritto di arbitrato internazionale, in virtù del quale è essa legittimata a
intervenire nelle controversie tra Stati solo su richiesta delle parti in causa, e si afferma la neutralità, nonché
l’inviolabilità del suo territorio;
— si dichiara risolta definitivamente la questione romana (art. 26), e si riconosce il Regno d’Italia con
Roma capitale.
5.La legge sui culti ammessi
Dopo il Concordato, lo Stato italiano approvò la legge n. 1159 del 1929 (v. Parte III) contenente disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato
davanti ai ministri dei culti medesimi, dimostrando una particolare attenzione nei confronti dei culti diversi da quello cattolico.
È opportuno sottolineare che questa legge resta tuttora in vigore per quelle confessioni che
non hanno sottoscritto alcuna intesa con lo Stato e che non sono state modificate dal concordato del 1984.
Gli aspetti essenziali di essa possono essere così sintetizzati:
— libertà di esercizio di tali culti;
— limite dell’ordine pubblico e del buon costume all’esercizio di tutti i culti;
— affermazione del principio che la differenza di culto non costituisce eccezione al godimento dei
diritti civili e politici e all’ammissibilità degli appartenenti alle altre religioni di accedere alle cariche civili e militari;
— riconoscimento degli effetti civili del matrimonio acattolico qualora l’ufficiale di stato civile,
dopo avere accertato che non sussistano cause ostative alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilasci autorizzazione scritta indicante il ministro del culto davanti al
quale ha avuto luogo la celebrazione (v. amplius Parte III, Cap. 1).
Sezione Terza
Dal Concordato del 1984 ai nostri giorni
1.Il movimento per la revisione del Concordato del 1929
Dopo il crollo del regime fascista e la nascita della Repubblica (2-6-1946), in seguito alla
svolta epocale nella ecclesiologia cattolica legata al Concilio Vaticano II, si è avvertita
l’esigenza di una revisione dei Patti Lateranensi, in ossequio al dettato dei principi costituzionali e al mutato costume sociale italiano.
Un processo tutt’altro che semplice, che ha richiesto una completa rielaborazione di più di
35 anni dall’entrata in vigore della Costituzione.
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
29
A) La Costituzione repubblicana
La Costituzione repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, frutto di un compromesso tra le principali forze antifasciste, che pur sancendo i principi inviolabili di libertà
religiosa e non discriminazione in relazione ai diversi culti, non menziona ufficialmente
il principio del laicismo, lasciando, così, sostanzialmente immutata la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sancita dagli accordi del 1929 anche se già quando fu
emanata alcune norme superstiti dell’ordinamento regio apparivano in contrasto con i principi di libertà ed eguaglianza da essa sanciti.
L’art. 7 della Costituzione, infatti, dopo aver riaffermato il principio in base al quale «lo Stato
e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», ha stabilito che, «i loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi», e che «le modificazioni dei Patti, accettate
dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale» (v. infra Cap. 4, §4).
La Costituzione cancella il principio confessionale che era alla base dello Statuto Albertino e dei successivi Patti, in virtù del quale la religione cattolica era religione di Stato.
In particolare, la Costituzione repubblicana accoglie i principi fondamentali della libertà
religiosa (artt. 19 e 20), uguaglianza religiosa (art. 8, comma 1), non discriminazione per
motivi religiosi (art. 3), libertà di pensiero (art. 21), riunione (art. 17) e associazione (art.
18) etc. che cancellano ogni forma di sudditanza tra Stato e Chiesa cattolica.
Ciò spiega perché le successive pronunce della Corte costituzionale hanno dichiarato incostituzionali in più parti le L. 27 maggio 1929, n, 810 e n. 847, nonché L. 4 agosto 1955, n.
848, portando all’abrogazione di numerose norme contrarie alla Costituzione.
B) Il Concilio Vaticano II
Il profondo rinnovamento operato dal Concilio Vaticano II, durato quattro sessioni fra il
1962 e il 1965 sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI, risolse anche la questione
dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato.
L’argomento è stato affrontato nel n. 76 della Costituzione pastorale «Gaudium et Spes»
(1965) sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, uno dei più importanti e coraggiosi documenti del Concilio.
La regolamentazione di tali rapporti deve ispirarsi alle esigenze di una separazione fra
Chiesa cattolica e la comunità politica e, al tempo stesso, instaurare una sana collaborazione tra le due istituzioni garantendo sempre e comunque i diritti fondamentali dell’uomo sia
come cittadino sia come fedele.
Rivoluzionaria, rispetto al passato, appare l’affermazione con cui il n. 76 della citata Costituzione pastorale
si conclude: «Certo le cose terrene e quelle che, nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la sua missione richiede. Tuttavia
essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall’autorità civile. Anzi essa rinunzierà all’esercizio di
certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua
testimonianza o nuove condizioni di vita esigessero un altro ordinamento».
2.L’accordo del 18 febbraio 1984: il nuovo Concordato
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana pose il problema del rapporto, e quindi
della risoluzione delle antinomie tra le norme in essa contenute e quelle pattizie e, più in
generale con la legislazione nazionale in materia di culto.
30
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Sebbene parte della dottrina ritenesse che, alla luce della rigidità della stessa e dell’inviolabilità dei principi costituzionali, i Patti non potessero essere conservati integralmente, si
affermò l’orientamento favorevole ad una loro revisione allo scopo di armonizzarli con i
principi costituzionali e il mutato costume sociale del Paese.
Fu così che nel 1968 fu costituita la commissione Gonella, costituita, però, di soli rappresentanti dello Stato, i
cui lavori durarono poco più di un anno senza approdare a risultati apprezzabili. Ciò spiega perché essa fu
successivamente sostituita da un’altra commissione mista, composta sia da membri nominati dallo Stato che dal
Vaticano, la quale determinò le modifiche del Concordato che in seguito porteranno agli accordi di Villa Madama, del 18 febbraio 1984 (denominato correntemente «nuovo Concordato»).
Il problema più spinoso da affrontare era quello di decidere se procedere alla totale abrogazione dei Patti o
solo alla loro revisione.
I sostenitori della abrogazione affermavano che era necessario individuare un nuovo modello di rapporto tra
Stato e Chiesa, in quanto quello concordatario non era più riproponibile.
I sostenitori della revisione, invece, affermavano che doveva essere rivisto solo il Concordato, e non i Patti
nel loro insieme. Essi ritenevano che il modello concordatario era lo strumento più idoneo a regolare le res
mixtae, dal momento che alla luce degli artt. 7 e 8 della Costituzione non era più legittimo il ricorso al diritto
comune.
Vi era poi chi, come Jemolo, riteneva opportuno conservare il Concordato del 1929 considerando abrogate le
sole norme incompatibili con il nuovo ordinamento costituzionale.
A prevalere, negli accordi di Villa Madama, fu, però, l’orientamento più conservatore e quindi revisionista,
sotto la spinta della Democrazia Cristiana.
L’Accordo di Villa Madama consta di tre elementi:
—il Preambolo, in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire
dalla Costituzione repubblicana e si ricollega ai principi del Concilio Vaticano II per la
mutanda disciplina dei rapporti Stato e Chiesa cattolica;
—il testo vero e proprio, composto da soli 14 articoli, in cui sono sanciti i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa cattolica alla luce della Costituzione Repubblicana;
—il Protocollo addizionale in 7 punti per assicurare, con le opportune chiarificazioni, la
migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modificazioni convenute e per evitare ogni successiva difficoltà di interpretazione.
Va notato che anche se formalmente si parla di modificazioni, tali accordi costituiscono
una vera e propria riscrittura del Concordato del 1929 sia nelle motivazioni di fondo che
nei principi ispiratori più consoni ad uno Stato laico, pluralista e democratico.
Con L. 25-3-1985, n. 121 è stata data piena e intera esecuzione in Italia all’Accordo (e relativo protocollo addizionale), le cui disposizioni sono entrate in vigore il 4 giugno 1985,
data dello scambio delle ratifiche tra le Parti contraenti.
3.Princípi ispiratori del nuovo Concordato
È stato osservato che i Patti Lateranensi non avevano alle spalle una Costituzione «rigida»
quale quella repubblicana del 1948, né le «aperture» intervenute nella Chiesa dopo il Concilio Vaticano II.
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
31
Ecco perché mentre il Concordato del Laterano venne considerato un passo fondamentale
verso la definizione della più che annosa «questione romana» (4), quello del 1984 è stato
un ulteriore passo verso «più democratici» rapporti tra Stato e Chiesa alla luce del mutato
costume sociale, politico e religioso.
L’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi affermò in Parlamento che l’Accordo apriva una fase nuova nei
rapporti tra Stato e Chiesa trasformando i cosiddetti «patti di unione» del passato in nuovi «patti di libertà e
di cooperazione», alla luce delle puntualizzazioni date dal Concilio Vaticano II in ordine ai rapporti tra portere
religioso e comunità politica (v. Costituzione Gaudium et Spes, n. 76).
Si può, quindi, concordare con chi (Spinelli) ha visto nel nuovo Concordato un modello all’italiana di applicazione dei principi di sana laicità dello Stato più volte enunciati dal magistero pontificio e conciliare: principio
di sana laicità che «si riferisce del resto alla stessa distinzione evangelica tra temporale e spirituale e costituisce
una garanzia di non ingerenza da parte dello Stato nell’ambito del religioso e, quindi, una tutela della libertà
della Chiesa nell’esercizio della sua missione».
4.La struttura del testo e i cd. «stralci»
Il Concordato vigente presenta, rispetto al precedente, una forma più agile e come tale risulta maggiormente adattabile alle attuali esigenze concrete di culto e dei rinnovati rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, tant’è che per esso si è subito coniato l’appellativo di concordato-cornice.
Rispetto a ben 45 articoli dell’accordo del 1929, densi di precisazioni storicamente superate, si riscontrano negli accordi di Palazzo Madama solo 14 articoli che esprimono pochi ma
chiari e solenni principi, mentre vengono previsti numerosi «stralci» su materie specifiche,
rinviati ad accordi successivi tra lo Stato e l’autorità ecclesiastica.
Tali «stralci» possono così riassumersi:
— l’affidamento a una commissione paritetica italo-vaticana le norme per la definizione degli enti ecclesiastici e per la revisione della disciplina degli impegni finanziari dello Stato e degli interventi dello Stato
stesso nella gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici (art. 7);
— le decisioni sulle festività religiose con validità civile (art. 6);
— la determinazione dei titoli accademici ecclesiastici riconoscibili dallo Stato (art. 10);
— l’organizzazione dell’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche (art. 9);
— l’organizzazione dell’assistenza spirituale (cappellani) nelle forze armate, nelle carceri e negli ospedali
(art. 11);
— la conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica (art. 12);
— la regolazione di ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa e lo
Stato sia con nuovi accordi tra le due parti sia con intese tra autorità statale ed ecclesiastica (art. 13, co. 2)».
Tedeschi osserva che se si desse piena attuazione al citato art. 13, 2° comma, gli accordi del 18 febbraio
1984 potrebbero durare indefinitivamente e costituire una base di riferimento per tutte le successive forme
di intervento, a prescindere dalla considerazione che la Conferenza Episcopale Italiana, persona giuridica
di diritto pubblico nel nostro ordinamento e pertanto sottoposta alla sovranità dello Stato italiano, viene ad
assumere, solo in base a tali accordi, soggettività giuridica di diritto internazionale. Tutto ciò appare eccessivo solo che si pensi — ad avviso dell’Autore — alla necessità di una revisione dell’attuale Costituzione,
ai diretti rapporti tra le sue norme e il Concordato e al fatto che i concordati sottoscritti successivamente a
quello italiano del 1984 non prevedono analoghe norme di chiusura e forme di intervento.
(4) Dal Preambolo del Concordato del 1929 si desume come esso, definito «necessario completamento del Trattato»,
fosse visto quasi a contropartita del riconoscimento che la Chiesa faceva del nuovo Stato italiano.
32
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Provvedimenti di attuazione
Per l’attuazione del nuovo concordato sono stati emanati alcuni provvedimenti legislativi e amministrativi quali:
— la L. 20-5-1985, n. 222 recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi» (che ha sostituito, abrogandola,
la cit. L. 848/1929 sugli enti ecclesiastici), nonché il regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 13-2-1987, n. 33;
— i D.P.R. 16-12-1985, n. 751, 23-6-1990, n. 202 e 20-8-2012, n. 275 concernenti la «Esecuzione
dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche» cui hanno fatto seguito provvedimenti specifici di attuazione relativamente alla scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione
(D.P.R. 24-6-1986, n. 539, D.P.R. 11-2-2010), alla scuola elementare (D.P.R. 8-5-1987, n. 204 e
D.P.R. 26-2-1988, n. 161) alla scuola media (D.P.R. 21-7-1987, n. 350), alle scuole secondarie
superiori (D.P.R. 21-7-1987, n. 339), al secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale (D.P.R. 20-8-2012);
— il D.P.R. 28-12-1995 relativo al riconoscimento come giorni festivi di festività religiose;
— il D.P.R. 2-2-1994, n. 175 concernente l’Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici;
— il D.P.R. 26-9-1996, n. 571 che ratifica l’intesa tra il Ministero per i beni culturali e la C.E.I. per la
tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche;
— il D.P.R. 27-10-1999, n. 421 recante la «Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al
personale della Polizia di Stato di religione cattolica»;
— il D.P.R. 16-5-2000, n. 189 recante la «Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni e le
attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana» in tema di conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche;
— il D.P.R. 30-3-2004, n. 121 recante l’«Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento
propri dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole d’infanzia», cui sono seguiti
il D.P.R. 30-3-2004, n. 122 relativo alle scuole primarie, il D.P.R. 14-10-2004, n. 305 relativo alle
scuole secondarie di primo grado e il D.P.R. 16-1-2006, n. 39 relativo agli istituti statali e paritari del secondo ciclo;
— il D.P.R. 4-2-2005, n. 78 recante l’«Esecuzione dell’intesa fra il Ministro per i beni e le attività
culturali ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 26-1-2005, relativa
alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche».
5.Gli aspetti più significativi del Concordato del 1984
Rispetto a quello del 1929, il Concordato dell’84 presenta alcuni aspetti che possono considerarsi rivoluzionari in quanto costituiscono applicazioni concrete del più volte menzionato n. 76 della Costituzione Gaudium et Spes che detta «criteri interpretativi dell’accordo
di modificazione nel suo complesso».
A) «Neutralità» dello Stato
L’abrogazione del principio della «religione di Stato» (o del confessionismo statale) (art. 1)
viene a confermare la «neutralità» dello Stato stesso in materia religiosa.
«Neutralità» non sta a significare affatto «agnosticismo» perché dal nuovo accordo con la Santa Sede viene
fuori, come acutamente sottolineato alla Camera dal deputato Rognoni (27-1-84), «uno Stato neutrale ma non
indifferente rispetto alla rilevanza sociale del fenomeno religioso; che non fa una propria scelta di fede, ma
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
33
tiene conto delle ispirazioni ideali della comunità; che non può prescindere dall’ispirazione dell’uomo a vivere
la propria testimonianza religiosa nella dimensione sociale, nella libertà individuale e collettiva».
Tale «neutralità» comporta una maggiore autonomia della Chiesa cattolica nella sua organizzazione.
L’art. 3 sancisce, infatti, la piena libertà della Chiesa nelle nomine a tutti gli uffici ecclesiastici con il solo impegno di comunicare alle autorità civili le nomine avvenute negli uffici rilevanti sul piano dell’ordinamento giuridico italiano (ad es. diocesi e parrocchie).
In quest’ottica «neutrale» lo Stato, nel pieno rispetto della libertà di ciascuno e senza pregiudizio dei diritti degli appartenenti ad altre religioni, assicura ai cittadini di religione
cattolica l’assistenza spirituale e la possibilità di adempiere le pratiche di culto in determinate strutture pubbliche: forze armate, polizia, ospedali, istituti di assistenza e di cura,
istituti di pena e di prevenzione (art. 11).
Tuttavia, secondo Tedeschi non è possibile parlare «di piena neutralità» dello Stato nel nostro ordinamento in considerazione del fatto che:
— manca nella Costituzione una dichiarazione in questo senso;
— ancora non è garantita a tutti una piena libertà religiosa;
— le diverse confessioni non si trovano in posizione paritetica.
B) Disciplina degli enti ecclesiastici e impegni finanziari dello Stato
Nel vigente Concordato vengono a cadere una parte di esenzioni (ma non tutte) e di privilegi accumulati dagli enti ecclesiastici dal 1929 ad oggi in ossequio al principio di egualianza tra laici e chierici.
Viene riconosciuta la personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione e di
culto; agli effetti delle leggi tributarie, per beneficiare di sgravi fiscali, il fine di religione e
di culto viene equiparato ai fini di beneficenza ed istruzione (art. 7), mentre le attività, diverse da quelle di culto e di religione, sarebbero dovute essere soggette alle leggi dello
Stato e al regime tributario previsto dal diritto comune.
Tutta la materia, comunque, è stata rivista da una Commissione paritetica, le cui conclusioni, anche in relazione alla nuova disciplina degli impegni finanziari dello Stato per il
clero e il culto cattolico, hanno formato oggetto della L. 20-5-1985, n. 222 sulla disciplina
degli enti e beni ecclesiastici e sul sostentamento del clero cattolico, legge che comunque
desta parecchie perplessità perché viola in più parti il principio di eguaglianza del carico
tributario (artt. 23, 53).
La Repubblica, comunque, negli anni a seguire, preso atto delle attività assistenziali della
Chiesa cattolica, grazie anche alla presenza nel Parlamento di molti «ferventi» cristiani
(democratici e non) ha proseguito nel supportarla (es.: 8 × 1000 o 5 × 1000) anche oltre il
lecito e consentito (es.: intangibilità dello IOR v. infra).
C) Matrimonio
Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico come sacramento e quindi
ne sanciva il carattere indissolubile (art. 34).
Il vigente accordo, intervenuto dopo la emanazione, nel 1970, della legge sul divorzio, si
limita, all’art. 8, a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del
34
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
diritto canonico; nel contempo viene instaurato un regime di radicale superamento della
riserva di esclusiva giurisdizione ecclesiastica che in precedenza vigeva per le cause inerenti la nullità del matrimonio (v. art. 34, 4° comma del Concordato del 1929).
Le sentenze di nullità del matrimonio dei tribunali ecclesiastici non sono più da considerare indispensabili ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico trascritto (potendo i coniugi avvalersi dell’art. 2 della legge sul divorzio); le stesse possono, comunque, essere dichiarate efficaci nello Stato con le stesse modalità e alle stesse condizioni
previste per ogni altra sentenza straniera.
D)Istruzione religiosa
Con gli Accordi di Villa Madama si è avuto un ribaltamento dell’obbligatorietà dell’insegnamento religioso nella scuola pubblica nel rispetto del principio di libertà di coscienza e
culto.
Con l’art. 36 del Concordato del 1929 «l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la
forma ricevuta dalla tradizione cattolica» era considerato «fondamento e coronamento
dell’istruzione pubblica» e considerato obbligatorio (salvo dispensa).
Con l’art. 9 del nuovo testo, lo Stato, riconoscendo il valore della cultura religiosa e che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua
ad assicurare e garantire l’insegnamento della religione cattolica come materia nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado; è garantito, tuttavia, a tutti nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersi dell’insegnamento predetto.
E) Mantenimento del clero
Sulla base della delega dell’art. 7 degli accordi di Villa Madama è stata concertata e pubblicata la L. 20-5-1985, n. 228 (Disposizioni sul sostenimento del clero cattolico in servizio
nella diocesi) con cui si è abolito il sistema dei «supplementi di Congrua» precedentemente versati ai titolari di enti ecclesiastici con cura d’anime ricorrendo ad un doppio sistema:
la detraibilità del reddito imponibile delle donazioni della Chiesa e la specifica destinazione
della quota dell’8 per mille dei proventi delle imposte pagate dai fedeli in veste di contribuenti (Museli-Tozzi).
Questa soluzione viene adottata anche per i fedeli di altre confessioni, come, ad esempio,
di quella Valdese.
6.Lo sviluppo della legislazione regionale
In Italia, a partire dal 1970, con l’introduzione dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) la
legislazione nazionale, anche sulla scia di quella europea, ha predisposto una serie di mezzi di tutela del fenomeno religioso e del singolo credo che ha trovato la sua piena attuazione nelle singole discipline di settore.
Così dalla mera tutela normativa di tale fenomeno si è assistito al passaggio alla promozione del fattore religioso a garanzia dello sviluppo spirituale dell’essere umano e dei suoi
bisogni primari.
Questa tendenza è stata oggetto di alcune leggi regionali (BOTTA) che hanno interessato
il fenomeno religioso come l’istruzione religiosa, l’assistenza ospedaliera, penitenziaria, il
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
35
volontariato e l’aborto: l’intervento del legislatore regionale ha, così, in parte superato la
dicotomia fonti concordatarie e fonti statali, favorendo lo sviluppo di una legislazione locale extra-concordataria più vicina ai cittadini a tutela del loro interesse religioso.
7.La nuova dottrina di Papa Francesco
Il 19 marzo 2013, dopo un breve conclave (solo 5 scrutini), è stato eletto al soglio di Pietro
il cardinale Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, che ha assunto il nome
di Francesco.
Papa Francesco è succeduto a Benedetto XVI che, con un gesto che non ha precedenti
nella storia moderna, aveva rinunciato (e non solo per motivi di salute) al ministero petrino, rendendo vacante anticipatamente la sede vaticana a partire dal 28 febbraio.
Le linee guida di questo pontificato sono ravvisabili nell’Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium, promulgata da papa Francesco il 24 novembre 2013.
Il documento evidenzia come il compito fondamentale della Chiesa risieda principalmente
nel pieno ritorno alla missione di evangelizzazione e nel progressivo allontanamento dalla
stessa della ricerca dei beni temporali, rompendo, così, la continuità di pensiero con i precedenti pontificati di Wojtyla e Ratzinger.
Poiché tutti hanno il diritto di ricevere e vivere la gioia del Vangelo, i cristiani hanno il
dovere di seguire «nuove strade» e adottare «metodi creativi» consoni ai nostri tempi, consapevoli che la Chiesa deve crescere non per proselitismo (espressione che esprime talvolta modalità aggressive di persuasione), ma per attrazione.
Tutti i cristiani sono quindi esortati a raggiungere tutte le periferie per diffondere la luce
del Vangelo.
La Chiesa, nello spirito di attivismo missionario è tenuta, in primis, a privilegiare i poveri,
gli infermi e quanti sono spesso dimenticati. Per tale motivo, Papa Francesco preferisce
gestire «una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto
che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze».
Nell’«Esortazione», il Papa denuncia la «cultura dello scarto», la «globalizzazione
dell’indifferenza» pur combattendo a livello mondiale, la discriminazione dei paesi poveri, soprattutto a vantaggio delle multinazionali.
La crisi antropologica che riduce l’essere umano al peggiore e insaziabile dei suoi bisogni:
il consumo sfrenato; la speculazione finanziaria, la brama del potere e la supremazia
dell’«avere» sull’«essere».
Da qui, l’esortazione a considerare non l’economia, ma l’uomo come valore prioritario.
Tra le sfide culturali da affrontare, riportate dal documento, si segnalano la difesa dei valori delle religioni dagli attacchi alla libertà religiosa, la lotta ad una diffusa indifferenza
relativista e «l’accelerato deterioramento delle radici culturali con l’invasione di tendenze
appartenenti ad altre culture, economicamente sviluppate, ma eticamente indebolite».
Il documento, inoltre, dopo aver segnalato alle comunità ecclesiali il rischio sia della mondanità spirituale e del maschilismo, invita ad allargare gli spazi per una più significativa
presenza femminile e incisiva nella Chiesa, in particolare nei luoghi dove vengono prese le
decisioni importanti Francesco richiama anche all’urgenza che anche i giovani vivano sulla Chiesa un più ampio protagonismo.
36
Parte I: Introduzione al diritto ecclesiastico
Nell’Esortazione è posto anche l’accento sulla necessità di aprire senza pregiudizi un dialogo con tutte le realtà politiche, sociali, religiose e culturali del mondo, in nome di una
più ampia fratellanza fra tutti i popoli e tra tutti gli altri culti.
In tale dialogo, la Chiesa, dopo secoli di immobilismo, senza non poche resistenze interne,
il suo atteggiamento, è quello di esaminare e sostenere a cuore aperto e libero le relazioni
con le diverse forze sociali facendosi portavoce delle «proposte che meglio rispondono alla
dignità della persona umana e al bene comune».
Come detto papa Francesco in continuità con i due papi che l’hanno preceduto ritiene che
oggi più che mai sia priorità assoluta l’annuncio del Vangelo per porre nuove basi di una
fratellanza religiosa tra tutte le fedi, in primis, ebrei e islamici (religioni monoteiste), credenti nello stesso Dio.
Esiste attualmente una forte resistenza delle gerarchie ecclesiastiche in relazione ai temi
della contraccezione, aborto, divorzio, matrimonio omosessuale, ideologia del «gender»,
eutanasia.
Su tali questioni papa Francesco parla in veste di «figlio della Chiesa» — come ama definirsi — e da fedele testimone della tradizione senza mettersi apertamente in contrasto con
i precedenti papi (Paolo VI, Giovanni Paolo II o Benedetto XVI).
La novità che oggi si ravvisa in questo atteggiamento del pontefice risiede in un approccio
più dialogico con il quale la Chiesa si pone in maniera più aperta e senza pregiudizi nei
confronti dell’uomo e delle nuove problematiche del mondo contemporaneo.
Francesco, manifesta con forza la priorità di riformare la curia romana, il cui totale immobilismo ha angustiato gli ultimi anni di pontificato di Benedetto XVI.
Lo studio di una riforma della curia è, infatti, stato affidato a un consiglio internazionale
di otto cardinali, tutti di sua nomina, i quali a loro volta hanno chiamato a consulto altri
esperti di loro fiducia.
Importante è l’attenzione pastorale sul matrimonio e la famiglia nell’odierno contesto
culturale (almeno per quel che riguarda l’occidente). L’ampia riflessione in materia è stata
aperta nella Chiesa per mezzo di due Sinodi: la III Assemblea generale straordinaria, svoltasi nell’ottobre del 2014, e la XIV Assemblea generale ordinaria, da celebrarsi nell’autunno del 2015.
È oggi punto di vista condiviso da intellettuali progressisti e riformisti che la globalizzazione sta cancellando tutti i valori spirituali dell’uomo, in primis, la misericordia che la
comunità cristiana non può assistere con indifferenza all’inarrivabile ascesa del materialismo esasperato e lo sfruttamento delle classi e dei paesi più deboli e bisognosi.
Avvicinare le grandi religioni in una lotta comune in cui prevalga fratellanza e solidarietà
è l’unica via per sconfiggere l’inarrestabile avanzata del materialismo imperante nel mondo
globalizzato e delle nuove dittature che coinvolgono anche la fede stanno avanzando anche
nei paesi che fino ad ieri si dichiaravano democratici.
La rivoluzione «ideologica» di Papa Francesco
Parlare a tutti gli uomini, di qualsiasi religione, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi ceto sociale, parlare senza confini geopolitici, senza arroccarsi a difesa del solo cattolicesimo sembra essere il tratto
distintivo del Pontificato di Francesco.
Così per Papa Francesco un «genocidio» resta tale, non importa se perpetrato da cristiani, ebrei,
musulmani, a prescindere, cioè, da ogni credo religioso.
Capitolo 2: Precedenti storici e formazione del diritto ecclesiastico
37
Venendo dai confini del mondo, Francesco mostra i segni di sofferte devastanti dittature (si pensi ai
milioni di desaparecidos dell’america latina) e difende «globalmente» e «universalmente» lo spirito
solidale, caritatevole e religioso inteso come patrimonio spirituale comune tutti i popoli.
Per la «chiesa universale» occorre tutelare l’intera famiglia umana senza timori reverenziali verso i
potenti e chi governa il mondo.
Anche se i poteri costituiti «non possono e non vogliono giudicare la storia» per ovvi motivi di equilibrio,
«coesistenza pacifica» etc., ciò non vale per Francesco che non può e non vuole sottacere le stragi
e le ingiustizie perpetrate nel mondo.
A questi compromessi l’umanità e chi crede fermamente in essa non può rimanere indifferente!
Edizioni Simone - Vol. 32 Diritto ecclesiastico
Capitolo Unico
Profili generali della confessione religiosa islamica
Sommario
Premessa. - 1. La rivelazione. - 2. La figura di Muhammad (Maometto). - 3. I cinque pilastri. - 4. I Sunniti. - 5. Gli Sciiti.
6. Il Sufismo. - 7. Brevi note sul pensiero islamico. - 8. Il diritto islamico. - 9. La vita quotidiana.
Premessa
L’Islam presenta peculiarità distinte dalle altre religioni e, al giorno d’oggi, necessita di una
attenzione particolare perché l’interpretazione dei suoi precetti religiosi è spesso in contrasto con il diritto vigente, soprattutto in relazione ad alcuni poteri riconosciuti agli individui
di sesso maschile (ripudio, poligamia, limiti alla vita delle donne).
Nell’habitus mentale degli islamici coesistono norma religiosa e norma giuridica in base
alla doppia appartenenza alla religione e allo Stato.
Questo problema oggi è più che mai sentito a causa della crescente presenza di islamici in
Europa che sovrappongono comando giuridico e precetto religioso identificando «reato» e
«peccato».
A norma dell’art. 8 Cost. l’Islam dovrebbe, come gli altri culti, essere regolato secondo i
propri statuti che vigono nel nostro ordinamento finché non contrastino con esso, per cui la
stipula, mai portata a termine, di una «intesa» è indispensabile, anche se di difficile realizzazione per la mancanza di un organismo centrale islamico che possa fungere da controparte al Governo italiano.
A norma dell’art. 19 Cost. anche gli islamici godono del diritto inviolabile di professare
liberamente la loro fede, farne propaganda e celebrare il loro culto purché non contrastino
con il buon costume.
Sorgono, però, degli interrogativi in relazione all’eventuale detenzione o ricovero in struttura ospedaliera durante le quali si pone il problema, da parte delle strutture di accoglienza,
sulle modalità di somministrazione del cibo, del rispetto del Ramadan, della festività del
venerdì etc.
La mancanza di una intesa conduce ad una frammentazione delle soluzioni che solo in
parte sono risolte a livello locale.
I principali ostacoli ad una intesa, derivano dai seguenti fattori:
— la frammentazione dell’Islam (sunniti, sciiti etc.) e la mancanza di una forma identitaria;
— l’assenza del riconoscimento dei vertici religiosi (es. la pubblicazione di un albo degli iman e degli
altri esponenti di spicco dell’Islam) in grado di svolgere un efficace ruolo di mediazione tra Islam
e ordinamento italiano;
— l’attuale contrasto, nell’ambito dell’Islam, per un’azione unitaria per combattere il radicalismo e il
fanatismo religioso e conseguenti eccessi noti a tutti.
Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica
257
In relazione all’art. 20 Cost., infine, Stato ed enti pubblici non possono introdurre limitazioni legislative o amministrative, come ad esempio «gravami fiscali», che abbiano carattere
discriminatorio nei confronti di qualsiasi religione, compreso l’Islam.
Si noti che nel febbraio 2017 è stato firmato al Viminale il Patto Nazionale per l’Islam
italiano per far sì che la comunità islamica sia aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento italiano.
Ostacolo principale è il superamento e l’accettazione degli apparati culturali attuali islamici, tradizionalmente distanti dal costituzionalismo occidentale (Attolino), per consentire
alle due parti di aprire un tavolo di discussione collaborativo.
Questo passo, a detta del Ministro Minniti, potrà costituire «uno straordinario investimento sul futuro del nostro Paese che produrrà vantaggi anche materiali» confrontandosi soprattutto con gli islamici che sono consolidati da tempo nel nostro Paese ed hanno assimilato i cardini della nostra realtà sociale e giuridica.
Bisogna nei prossimi mesi non confondere le momentanee «pressioni» del fenomeno migratorio con i rapporti tradizionali con l’Islam per giungere ad una risolutiva intesa fra
Stato italiano e Islam.
L’Islam è una religiosa violenta?
Dante mette Maometto all’inferno dando per scontato che tutte le religioni hanno un fondamento di
violenza. L’antropologo René Girard nella sua teoria del «capro espiatorio» spiega in termini antropologici come il binomio violenza-religione sia tipico di tutte le società che vogliano prendere coscienza di loro stesse attraverso i sacrifici umani (SARA HEJAZI).
Oggi, in nome di Allah, si assiste a una radicalizzazione violenta di matrice islamica che non corrisponde più al concetto di «Jihad». La Jihad, infatti, deve essere considerata come lo «sforzo positivo»
che separi l’azione morale da quello immorale, mentre per i fondamentalisti rappresenta un’azione
violenta contro i nemici designati per liberare i mussulmani dall’imperialismo della globalizzazione che
allontanano gli uomini dall’obbedienza dei precetti religiosi (si pensi ai libri sacri delle altre due religioni monoteiste che hanno in comune con i mussulmani molti precetti religiosi).
La cosa che colpisce di più è la radicalizzazione della lotta che se da un lato coinvolge i fedeli che
vivono nelle periferie e rappresentano le fasce deboli e meno protette del popolo arabo, dall’altro si
assiste al reclutamento dei jihadisti anche nei paesi occidentali (i cd. «foreign fighters») grazie alla
crescente campagna mediatica.
È così che si può fare un primo identikit dei radicalizzati di matrice europea che con un viaggio di
«purificazione» verso la Siria alimenta il loro desiderio di vestire i panni di «martiri» e vendicarsi contro le prepotenze che hanno subito in occidente.
1.La rivelazione
Il termine arabo islam deriva dal verbo «aslama», ed indica l’atto di sottomissione; il
participio presente dello stesso verbo «muslin», (musulmano) indica, invece, colui che si
sottomette a Dio.
L’Islam rappresenta una «rivelazione», cioè una religione rivelata da Dio che si inserisce
nel quadro delle tradizioni abramiche dopo quello ebraico e quello cristiano.
Esso rappresenta una forma di un monoteismo espressione dello stesso e unico Dio dei
cristiani e degli ebrei. Non siamo di fronte, in riferimento al cristianesimo e all’ebraismo, a
tre diversi monoteismi abramici, ma piuttosto di un unico monoteismo abramico.
258
Parte V: L’Islam
Dalla Bibbia apprendiamo che Abramo ebbe due figli, il primogenito Ismaele, dalla schiava egiziana Agar, ed
il secondo, Isacco, dalla moglie Sara.
Gli Arabi sul piano storico, religioso, discendenti di Ismaele, si collocano, dunque, su un piano di perfetta continuità abramica con ebrei e cristiani.
2.La figura di Muhammad (Maometto)
Muhammad (letteralmente «il lodatissimo») nacque, secondo alcune fonti, il 20 aprile
dell’anno 570 a Mecca, nella regione peninsulare araba del Hijaz.
Mecca era una delle città più importanti della Penisola arabica, nodo nevralgico delle rotte carovaniere e punto
di sosta importantissimo all’incrocio di quelle che possiamo considerare le «autostrade» carovaniere per e dalla Siria, Mesopotamia e, attraverso la Penisola arabica centrale, Golfo Persico.
Questa felice allocazione geografica permise alla città di accrescere la sua importanza e la sua ricchezza.
Mecca, però, era riuscita ad assurgere ad un ruolo rilevante anche dal punto di vista religioso, in quanto rappresentò la sede dei culti dei gruppi sociali più importanti e trasformarsi, così, anche in un attivo centro di pellegrinaggio.
A Mecca Muhammad ebbe occasione di entrare in contatto sin dalla più tenera età con le
comunità ebraiche e con le scarse presenze cristiane aprendosi, così, alla conoscenza di
diverse religioni.
I numerosi viaggi intrapresi per via dell’attività mercantile familiare — dapprima con lo zio
e poi come agente della ricca e colta vedova Khadija bint Khuwaylid — dettero a Muhammad
occasione di ampliare in maniera significativa le sue conoscenze in campo religioso e sociale.
Sposato nel 595, infatti, Khadija, il profeta poté dedicarsi alle sue riflessioni spirituali in
modo pressoché esclusivo. Khadijia fu il primo essere umano a credere nella «rivelazione»
di cui Muhammad era portatore e lo sostenne con forte convinzione fino alla morte.
Nel 610 Muhammad, in base a una «rivelazione» ricevuta, cominciò a predicare una religione monoteista basata sul culto esclusivo di Allah.
Si narra, infatti, che una notte, intorno all’anno 610, durante il mese di Ramadan, all’età di circa quarant’anni,
gli apparve l’arcangelo Gabriele che lo esortò a diventare messaggero di Allah con le seguenti parole: «Leggi,
in nome del tuo Signore che ha creato l’uomo da un grumo di sangue. Leggi nel nome del tuo Signore il più
generoso, che ha insegnato per mezzo del calamo, che ha insegnato all’uomo quello che non sapeva».
Dopo un lungo e angosciante periodo di silenzio, Gabriele tornò di nuovo a parlargli per trasmettergli altri
versetti e questo legame proseguì incessantemente per 23 anni, fino alla morte nel 632 di Muhammad.
Quando Maometto cominciò a predicare la Rivelazione i convertiti furono pochissimi in relazione ai numerosi anni che egli ancora trascorse a Mecca. Fra essi il suo amico intimo e
coetaneo Abu Bakr (destinato a succedergli come califfo) e un gruppo ristretto di persone che
successivamente sarebbero stati i suoi più validi collaboratori: i cosiddetti «Dieci Benedetti».
L’ostilità dei suoi concittadini lo indusse a rifugiarsi con una settantina di correligionari a
Yathrib, a nord di Mecca, che mutò presto il proprio nome in al-Madinat al-Nabi, «la Città
del Profeta».
Il 622, l’anno dell’Egira (emigrazione), fu proclamato il primo anno del calendario islamico, adottato ancora oggi per la tenuta dei registri fiscali e dell’amministrazione in genere.
Muhammad predicò a Medina per otto anni ove formulò un Patto (Rescritto o Statuto o
Carta) che fu accettato da tutte le componenti della città-oasi e che vide la nascita della
Umma, la prima Comunità politica di credenti. Nello stesso tempo con i suoi seguaci iniziò
a lottare contro i suoi nemici e marciare sulla Mecca e conquistarla.
Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica
259
Tornò, poi, a vivere a Medina e da qui estese la sua azione a tutto il resto del territorio.
Due anni dopo Muhammad morì a Medina, senza indicare esplicitamente chi dovesse succedergli alla guida politica della Umma. Lasciava nove vedove e una sola figlia vivente,
Fatima, andata sposa a suo cugino.
3.I cinque pilastri
A fondamento dell’Islàm vi sono i cinque pilastri, regole fondamentali in rispetto delle
quali si distingue il musulmano dal non-musulmano.
A) Shahada
Shahada significa «testimonianza», perché attesta l’unicità di Dio e che Mohammed è il
Profeta da Lui inviato (1).
Tale dichiarazione, pronunciata alla presenza di due testimoni, con piena convinzione e fede, consente di entrare automaticamente nell’Islam, in cambio del perdono Divino di tutti i peccati commessi in precedenza, generando nel fedele una condizione di «rinascita».
Senza fare «shahada» e credendo fermamente nei principi che racchiude in sé, non è possibile convertirsi all’Islam.
Il versetto citato racchiude due principi fondamentali:
a) unità e unicità di Dio, la prima in contrapposizione al politeismo pagano, la seconda
contro il monoteismo ebraico-cristiano.
Il Dio musulmano è creatore dell’universo dal nulla, predestina gli uomini al bene e al
male, ed è irrapresentabile perché assolutamente misterioso. Ad esso gli si attribuiscono
99 nomi positivi (onnipotente, sapiente, fedele, etc.), ma il centesimo, il suo vero nome,
resta tuttora sconosciuto e viene appunto sostituito dall’appellativo Allah, che letteralmente significa «il Dio».
Allah è un Dio esclusivo e vendicativo, ma di fronte al pentimento perdona qualunque
peccato.
La sua qualità più grande non è l’amore (come quello cristiano) ma la potenza e la grandezza, per cui la religione islamica esige la sottomissione incondizionata alla sua volontà;
b) superiorità assoluta di Maometto su tutti i profeti (l’Islam crede anche in alcune figure storiche dell’ebraismo, considerate come profeti: ad es. Adamo, Noè, Abramo,
Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Davide, Salomone, Giobbe, Elia, Giovanni Battista, Gesù).
Ebrei e cristiani vengono considerati come la «gente del libro» (Bibbia e Thorah), cioè
credenti che non hanno saputo praticare i comandamenti di Dio, ecco perché Allah è
stato chiamato a un’ulteriore rivelazione, in lingua araba, a Maometto.
Altri punti salienti della professione di fede sono:
• l’anima è immortale e i morti risorgeranno e saranno giudicati nel giorno del Giudizio, per l’inferno o il paradiso eterni (quest’ultimo viene immaginato come un
luogo di piaceri fisici ed estetici: giardini deliziosi, profumi soavi, freschi ruscelli, cibi
prelibati, bevande gustose, sfarzosi abiti, bellissime vergini etc.).
(1) Questa frase «ashadu anna laa ilaha illa Allah, wa ashadu anna Mohammadun rasulu Allah» (attesto che non vi è Dio
oltre Allah, e che Mohammed è il suo Profeta), viene ripetuta più volte dai fedeli durante la giornata, infatti fa parte delle
parole da pronunciare durante le cinque preghiere quotidiane, e rappresenta il «cuore» del credo islamico.
260
Parte V: L’Islam
Coloro che pur avendo peccato avranno osservato la dottrina, rimarranno all’inferno sino
a quando non saranno liberati da Maometto. Viceversa, coloro che combattono e muoiono per l’islam vengono accolti subito in paradiso, prima del Giudizio universale;
• fede nelle sacre scritture: il Pentateuco di Mosè, i Salmi di Davide, il Vangelo di Gesù
e soprattutto il Corano di Maometto.
B) Salat
La salat è la preghiera che si effettua cinque volte al giorno in precisi momenti della
giornata.
Al musulmano è consentito di pregare in qualsiasi sito, purché il luogo del rito sia decente
e pulito anche se è preferibile stare nella moschea per ottenere maggiori ricompense da
parte di Allah.
La prima delle cinque preghiere obbligatorie è il «fajr» che si compie alle prime luci dell’alba, e
consiste in due unità (rak’a).
La seconda, il «dhor», deve essere svolta intorno al mezzogiorno, e consiste di quattro unità.
La terza, l’«asr», si compie durante il tardo pomeriggio, prima del tramonto, ed è composta da
quattro unità.
La quarta, il «maghreb», si deve svolgere durante il tramonto del sole, prima che sia completamente buio, ed ha tre unità.
La quinta, l’«isha», deve essere fatta dopo circa un’ora e mezza dall’orario del «maghreb», oppure
la si può rimandare fino a poco tempo prima del sorgere del sole: essa è costituita da quattro unità.
La preghiera, è fondamentale per un musulmano credente e praticante, in quanto rappresenta la dimostrazione concreta della fede verso Allah. Per svolgerla correttamente, bisogna
vestirsi secondo le regole che Dio ha dettato nel Sacro Corano (essere, cioè, coperti dall’ombelico alle ginocchia compresi per quanto riguarda l’uomo, ed integralmente, tranne il viso
e le mani, per ciò che concerne la donna), ed essere rivolti con il viso verso la Sacra Moschea
di Mecca, dove si trova la Sacra Ka’aba.
Il tempo della preghiera è annunciato ai musulmani dall’appello del mu’adhdhin, più familiarmente detto muezzin (dalla pronuncia alla turca) che è la chiamata a raccolta che parte
sempre dall’alto del minareto (manar).
Le parole pronunciate sono simili per tutte le preghiere, con una lieve variante per quella del mattino e cioè:
— 4 volte: Allah akbar (Dio è grande);
— 2 volte: io attesto che non v’è altro Dio che Allah;
— 2 volte: io attesto che Muhammad è l’inviato di Allah;
— 2 volte: Venite alla preghiera!;
— 2 volte: Venite alla salvezza!;
— 2 volte e solo per gli sciiti: Venite alla migliore delle azioni;
— 2 volte e solo per la preghiera del mattino: La preghiera è migliore del sonno;
— 2 volte: Allah Akbar;
— infine: Non v’è altro Dio che Allah.
Per il fedele compiere la «salat» costantemente e puntualmente contribuisce a tenere lontano
il peccato e a cancellare quelli che capita di commettere fra l’una e l’altra orazione, perché
Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica
261
oltre a rappresentare un atto di devozione, è anche momento di purificazione spirituale e fisica (difatti, prima di ognuna di esse, bisogna anche fare delle precise abluzioni per togliere la sporcizia fisica e prepararsi ad eseguirla con la dovuta intenzione e purezza interiore).
C) Sawm
Sawm significa digiuno. Nei pilastri dell’Islam, indica il precetto da compiere durante il
mese di Ramadan.
In questo periodo (che può essere di ventinove o trenta giorni, a seconda della durata del
mese lunare), bisogna astenersi dal cibo, dalle bevande, dai rapporti coniugali (nonché
dal fumare, per chi lo fa, pur essendo il fumo non consentito dall’Islam) ed evitare il cattivo comportamento in generale, a partire dall’alba fino al tramonto.
Ne sono comunque esentati gli ammalati, le donne incinte o che allattano, gli anziani, coloro che svolgono lavori pesanti, per i quali resta comunque obbligatorio spostare il digiuno
alla fine dello stato di impedimento.
Durante il Ramadan il ritmo della vita rallenta, poi al tramonto un colpo di cannone, in ogni
città, permette di nuovo che strade e piazze si rianimino e la vita riprende a scorrere.
Questo tempo è considerato «sacro» perché riservato alla riflessione individuale ed è il
periodo in cui più facilmente si esprime la solidarietà della comunità, la riconciliazione fra
parenti e amici e il perdono delle offese.
Il digiuno è una pratica che aiuta ad autodisciplinarsi e a purificare il proprio corpo e la
propria anima, infatti, consente il perdono dei peccati (tranne quelli gravi, come ad esempio
l’omicidio) commessi da un Ramadan all’altro.
Esiste anche in questo caso una «sunna» del digiuno, chiunque infatti, oltre a compiere
quello obbligatorio durante il Ramadan, può scegliere di digiunare alcuni giorni in più, se
e quando lo desideri (senza cadere in esagerazioni).
D)Hajj
L’hajj è il pellegrinaggio rituale alla città Santa di Mecca, che deve essere compiuto, per
chi ne ha la possibilità economica e fisica, almeno una volta nella vita.
Il fedele deve recarsi alla Mecca con l’intenzione di compiere un atto di devozione unicamente per compiacere Allah (come è giusto fare per ogni precetto), seguendo rituali ben
precisi:
• la circoambulazione intorno alla Sacra Ka’aba;
• la corsa fra i due colli di Safa e Marwa per ricordare Agar, moglie di Abramo e madre
di Ismaele, che corse fra questi due colli per cercare aiuto, essendo rimasta senza nutrimento per il neonato. Essa venne ricompensata da Allah, che fece miracolosamente
apparire una fonte ai piedi del piccolo Ismaele;
• la lapidazione di Satana (lancio di piccole pietre nei tre punti dove Satana apparì al
tempo del profeta Abramo, davanti a lui stesso);
• la sosta sulla piana di Arafat per invocare e pregare Dio, ed altri riti minori.
Chi va in pellegrinaggio deve concentrarsi sull’importanza del rito che sta per compiere, ed
indossare (questo precetto è valido soltanto per l’uomo, in quanto la donna, rimanendo
comunque coperta secondo le regole islamiche, può essere vestita con gli abiti che preferi-
262
Parte V: L’Islam
sce) una veste fatta di un unico pezzo di stoffa di colore bianco, che non presenti alcun tipo
di cucitura e possibilmente non nuovo. Tale abito deve essere avvolto intorno al corpo
formando una specie di tunica.
Il fedele non deve portare scarpe, sono consentite soltanto calzature tipo sandalo o ciabatta.
Chi partecipa all’hajj nel dovuto modo, con fede e corretto svolgimento delle pratiche rituali, ritornerà dopo il rito ad essere puro come quando nacque.
Non pochi tuttavia concludono il pellegrinaggio alla Mecca con la visita alla tomba di Maometto a Medina e con un pellegrinaggio a Gerusalemme. Non dobbiamo infatti dimenticare che per i musulmani le città sante sono tre: la Mecca, Medina (in Arabia Saudita) e
Gerusalemme.
E) Zakat
La zakat, è l’elemosina legale, e consiste nel donare ai bisognosi, a fine anno, una percentuale fissa dei propri averi, sia che essi siano denaro o altri tipi di beni, in ogni caso, però,
deve trattarsi di beni utilizzabili per scambi commerciali. È esentato dal versare la «zakat»
chi possiede un reddito basso.
Questa pratica, aiuta i credenti a superare (a partire dai familiari indigenti) la propensione
all’egoismo e all’avarizia ed ovviamente è utilissima per aiutare i bisognosi ai quali è destinata: anch’essa monda dal peccato i benefattori.
4.I Sunniti
I Sunniti, (coloro che seguono la Sunnah, ovvero la tradizione musulmana) ritengono di
essere i soli interpreti della volontà di Maometto e riconoscono legittimi i primi quattro
califfi elettivi. Nel corso dei secoli i sunniti sono andati elaborando una dottrina che si differenzia da quella delle altre sette.
Il sunnismo, ramo maggioritario dell’Islam, accetta l’interpretazione delle quattro grandi
scuole giuridiche (Madhabit) dell’VIII e del IX secolo: l’hanafismo, il malikismo, lo sciafismo e l’hanbalismo.
Il credo sunnita risiede nella professione di fede nell’unicità di Allah e l’obbligo di adorare solo Allah. In teoria basta rispettare i cinque pilastri, con la volontà di farlo, e già si
appartiene alla comunità musulmana.
5.Gli Sciiti
Gli sciiti con 200 milioni di fedeli rappresentano un quinto della totalità dei musulmani.
Il nome «sciismo» è peraltro piuttosto tardo e parte dal terzo secolo dopo la fondazione
dell’Islam anche se la sua origine risale alla morte del profeta e alla questione cruciale
della sua successione. Quanti ritengono che la successione spetti esclusivamente al suo
genero e cugino, Alì, e ai suoi discendenti da parte di Fatima, la figlia del profeta, costituiscono il primo nucleo dello sciismo.
Ciò che distingue lo sciismo dal sunnismo, è innanzi tutto la concezione dell’autorità religiosa che spetta all’imam, considerato come un iniziato ai segreti della rivelazione e non
come un semplice «commentatore» del corano e della shariah.
Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica
263
Per lo sciismo, la profezia legislatrice si arresta con la figura del profeta, ma la ricezione
della rivelazione prosegue grazie alla figura dell’imam che ha titolo per prolungare il contatto tra le creature e il creatore. Oltre alla concezione della figura dell’imam, una doppia
visione del mondo distingue gli sciiti dai sunniti: per gli sciiti, ogni realtà, da quella più
elevata (Dio) fino a quella più anonima della vita quotidiana, comporta due livelli: un livello apparente e un livello segreto, uno esoterico e uno essoterico.
La critica degli sciiti ai sunniti si incentra proprio sul mancato riconoscimento della centralità del senso esoterico del Corano, fermandosi questi ultimi al solo senso essoterico, letterale, legalistico.
L’importanza particolare che lo sciismo attribuisce alla dimensione esoterica dell’islam, è
visibile anche dalla dottrina del Imam nascosto, del dodicesimo imam che si è occultato.
Infatti sarà solo al ritorno di questo Imam che assistiamo alla Rivelazione e alla Manifestazione di tutti i sensi nascosti della Rivelazione divina. Per lo sciismo, dunque, non si attende una nuova Shari’a, una nuova Legge, cosa che, tra l’altro potrebbe portare solo un
nuovo profeta, dunque, ma la piena manifestazione del reale senso dell’islam.
Lo sciismo accorda una particolare importanza al culto dei martiri, in particolare ad Husayn,
il martire per eccellenza, ucciso vilmente a Garbala. Per Husayn si celebrano delle grandiosi manifestazioni di lutto e dolore collettivo per il giorno della sua morte.
6.Il Sufismo
Il Sufismo è un movimento religioso di carattere mistico e ascetico sorto nel mondo islamico a partire dall’XI secolo, in prevalenza fra i sunniti — benché comprenda anche confraternite e membri sciiti — che non assunse mai le caratteristiche settarie di altri gruppi,
come, ad esempio, quello degli ismailiti.
Tale lemma sembra derivare dal termine arabo «suf», che indica l’abito di lana grezza indossato dagli asceti musulmani.
Alla fine del X secolo questa corrente contava già numerose confraternite di seguaci da
Bassora e da Baghdad, in tutto il territorio dell’attuale Iraq e nel resto del mondo islamico,
dove rappresentava un tentativo di interpretazione mistico-esoterica della religione di Maometto.
Da principio oggetto dell’ostilità delle correnti islamiche più tradizionaliste, il movimento
ottenne dal XII secolo un riconoscimento formale nell’ambito dell’ortodossia, soprattutto
grazie all’operato e agli scritti di alcuni membri illustri provenienti dai ceti colti del sunnismo.
Il sufismo non prevede un sistema dottrinale omogeneo che lo caratterizzi rispetto alle altre
correnti dell’Islam per le prospettive teologiche tendenti al monismo, al teismo o al panteismo.
Motivo unificante tra le varie dottrine dei sufi è forse la convinzione di godere di una speciale relazione di elezione (walaya) con la divinità, grazie alla quale sarebbe possibile
stabilire una forma privilegiata di comunicazione con Dio al fine di ottenere la conoscenza
della verità divina (haqiqa).
Fonte di questa potenzialità è lo stato di grazia riservato da Dio stesso agli iniziati che ne
entrano in possesso mediante un lungo cammino di ascesi spirituale in varie tappe, da com-
264
Parte V: L’Islam
piersi sotto la guida di un maestro ritenuto capace di trasmettere al discepolo uno stato di
benedizione soprannaturale.
L’esistenza del mondo, secondo i sufi, sarebbe garantita, in ciascuna generazione, dalla
nascita di un maestro dotato della natura di «uomo perfetto» la cui identità può essere
svelata solo a quanti abbiano raggiunto lo stato del distacco da sé, della dipendenza da
Dio, e della conoscenza.
A differenza dell’imam degli sciiti, con il quale pure condivide alcuni aspetti essenziali,
come i poteri soprannaturali e il ruolo di garante dell’esistenza dell’universo, l’«uomo perfetto» del sufismo non dipende dalla discendenza familiare; rappresenta, al contrario, il
vertice di una gerarchia di maestri venerabili, dotati in qualche misura delle sue stesse facoltà. I sufi, infatti, venerano come santi, accanto agli uomini perfetti, innumerevoli maestri
del passato, fra i quali anche personaggi estranei alla loro dottrina e gli stessi imam sciiti.
Grande importanza è attribuita alla musica e alla poesia; all’amore profano e al vino, tendenzialmente demonizzati dalla tradizione islamica, vengono considerati esperienze simboliche dell’amore divino e dell’estasi mistica.
7.Brevi note sul pensiero islamico
A) Caratteristiche generali
L’Islàm non è solo una religione, ma è un modello di vita che permea ogni aspetto della
condotta del credente che abbraccia diverse scienze:
—scienze religiose;
—letture coraniche;
—tradizioni;
—esegesi;
—diritto;
—teologia speculativa;
—mistica.
Questa non è una classificazione tassativa, poiché le diverse parti delle scienze religiose
sono in stretto contatto e spesso le opere investono più campi delle discipline contemporaneamente.
Le fonti del pensiero islamico, del diritto, della teologia e della filosofia islamica, almeno
le due fondamentali, sono il Corano e la Sunna.
B) Il Corano
Il Corano (al Quran) che letteralmente significa «la lettura» o «la recitazione», rappresenta il testo sacro della religione dell’Islam. Il suo nome deriva dall’antico aramaico qeryana,
che significa leggere ad alta voce.
Consta di 114 capitoli (sure). Le sure sono disposte in ordine decrescente di lunghezza.
Fatta eccezione per la prima (al-Fatihah); l’attuale stesura risale all’anno 650, durante il
regno del terzo califfo Othman (644-655). Le sure sono, a loro volta, divise in 6236 versetti, il cui numero varia per la redazione sciita che vi aggiunge infatti alcuni versetti e un’intera sura.
Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica
265
Ogni sura, partendo da quella iniziale, incomincia con: « Nel nome di Dio il misericordioso,
il clemente»
Le sure sono divise in sure meccane e medinesi, a seconda del periodo in cui furono rivelate: le prime sono state rivelate prima dell’emigrazione (Egira) del profeta Maometto da
Mecca a Medina, le seconde sono successive all’emigrazione del popolo ebraico.
Questa divisione non identifica pertanto il luogo della rivelazione, ma il periodo storico.
In generale le sure meccane sono più brevi e di contenuto più forte e immediato (si racconta di conversioni improvvise al solo sentire la loro predicazione); le sure medinesi risalgono invece al periodo in cui il profeta Maometto è a capo della neonata comunità islamica e
le sure sono caratterizzate prevalentemente da norme religiose e istruzioni sulla vita della
comunità (da cui deriva in gran parte la Sunna).
Secondo i musulmani il testo della rivelazione coranica (nella versione originale in lingua
araba) deve considerarsi immutabile nel corso dei secoli; esso viene tramandato dai musulmani parola per parola, lettera per lettera. Oggi, come ieri, milioni e milioni di musulmani
e musulmane in tutto il mondo imparano a memoria le centinaia di pagine in arabo che
costituiscono il libro (processo noto come «Hifz», che significa «conservazione».
La memorizzare del testo del Corano garantisce la sua corretta preservazione nella sua
forma autentica nel corso dei secoli.
Sebbene il Corano sia stato tradotto in quasi tutte le lingue, la recitazione liturgica da
parte del fedele musulmano deve avvenire sempre e comunque in arabo (2).
Dalla «lettura» del Corano, intesa nel senso più ampio del termine, si sono sviluppate alcune vere e proprie scienze.
La scienza della lettura, il metodo usato nelle scuole per recitazione, vocalizzazione e
punteggiatura.
Attraverso questo metodo i musulmani apprendono a leggere e scrivere:
—la scienza della recitazione, il metodo di lettura salmodiata cioè la cantilena per gli usi
liturgici del Corano;
—la scienza dell’esegesi; (che si indica con il termine ta’wil, «interpretazione», «ermeneutica»), costituita dall’esegesi che ha dato vita ai commentari coranici. Questa scienza intende spiegare il Corano frase per frase, spesso parola per parola, basandosi sui
materiali accumulati nella Tradizione (sunna).
C) La Sunna
Il termine sunna, originariamente «uso», «regola abituale di condotta», venne successivamente ad indicare il complesso della tradizione condivisa dai musulmani.
La sunna si fonda sui hadith (narrazioni), che non sono altro che le narrazioni della vita e
dei detti di Muhammad, assurto a modello da imitare.
Intorno agli hadith è nata una vera e propria scienza, divisa in varie specializzazioni, ciascun
hadith è diviso in due parti: isnad (sostegno) e matu (testo vero e proprio).
(2) L’Islam professa infatti che è in questa lingua che la Rivelazione divina è stata trasmessa al profeta Maometto tramite
l’Arcangelo Gabriele. Non bisogna, quindi, fare indebiti parallelismi tra Corano e Bibbia – salvo per la Torah, rivelata in
prima persona da Dio agli Ebrei – e tra Maometto e Gesù. Per il Cristianesimo la parola di Dio è Gesù Stesso, per l’Islam la
Parola di Dio è il Corano stesso, mentre il profeta Muhammad rappresenta lo strumento attraverso cui la rivelazione del Corano all’umanità è avvenuta.
266
Parte V: L’Islam
In particolare l’isnad è l’elenco concatenato dei testimoni del detto che sono:
• coloro che vivevano a diretto contatto col Profeta o testimoni oculari;
• i successori, cioè gli appartenenti alla generazione successiva a Muhammad;
• i successori dei successori appartenenti alla generazione successiva e così via.
8.Il diritto islamico
A) Generalità
Il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina
coranica prende il nome di Sharia in cui convivono regole teologiche, morali, rituali e
quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali,
processuali e di diritto bellico.
Vincolato ad un testo sacro, il diritto islamico è sempre subordinato al rituale religioso;
quindi la scienza giuridica è vincolata dalla teologia.
Le categorie giuridiche dell’Islam sono più sfumate di quelle europee: mentre per il nostro
diritto vige la logica binaria del lecito e dell’illecito, mentre per quello islamico l’atto giuridico può assumere diverse dimensioni, infatti può essere obbligatorio, raccomandato,
permesso, riprovato e vietato (v. infra lett. D).
La disciplina accademica con cui gli studiosi descrivono ed esplorano la sharia è chiamata fikh.
Le fonti del diritto islamico coincidono con le fonti della teologia islamica. Anche la
figura del giurista inteso in senso occidentale non esiste per il diritto islamico, che nella
figura dell’alim (pl. Ulema) che è il teologo-giurista esperto di fikh.
B) Fonti teologico-giuridiche
Sono:
• il Corano;
• la tradizione sacra (sunna);
• l’opinione concorde (ijma);
• l’interpretazione analogica (qiyas).
A queste si aggiungono altre fonti di fatto.
Il Corano e la sunna assieme costituiscono il naql, cioè «quel che è tramandato».
Il Corano, come Rivelazione di Dio, ha precedenza assoluta; in realtà nel Corano si ritrovano precetti giuridici riguardanti svariati campi del diritto: per lo più il diritto di famiglia
e le successioni, ma non mancano addirittura indicazioni specifiche su cibi leciti o illeciti.
La sunna è la seconda fonte del diritto ed è formata dalla tradizione trasfusa negli hadith,
che fanno di Muhammad un modello di vita.
Talora la sunna ha scavalcato il Corano come fonte giuridica, come nell’esempio del diveso grado della punizione dell’adulterio tramite la lapidazione.
Una tradizione della sunna afferma che, se la comunità dei giuristi-teologi dà il suo consenso generale ad una teoria, questa per l’autorevolezza dei consensi non può essere
considerata errata. Questo consenso (ijma) non è facile da definire. Di fatto, questa forma
di consenso (l’ijma) rappresenta il consenso dei giurisperiti più autorevoli, purché il loro
numero sia ragionevolmente esteso e il loro parere chiaramente formulato.
Capitolo Unico: Profili generali della confessione religiosa islamica
267
L’ultima fonte è il qiyas («analogia» o meglio «ragionamento per analogia»), fatto dal
singolo esperto. Il parere del singolo non ha il carattere infallibile riconosciuto al parere che
trova il consenso dell’umma, tanto da definirsi anche zann (congettura).
C) Le singole scuole sunnite
Nel corso dell’assestamento del diritto islamico sotto la dinastia abbàside nell’VIII secolo,
le controversie teologiche impedirono che le estensioni analogiche del diritto sacro venissero incanalate in un’unica direzione: nacquero così quattro scuole ortodosse e numerose
scuole eretiche.
Ancor oggi il diritto islamico dei singoli stati si richiama a queste scuole o riti, spesso presenti nella medesima nazione. Il diritto islamico non è quindi unitario.
Le quattro principali scuole riconosciute dall’islam portano il nome del loro fondatore e
sono:
—la scuola hanafita (diffusa in Turchia, Egitto, India, Pakistan, e in alcuni paesi appartenenti all’ex URSS) è la più liberale, perché tende a sottolineare il carattere formale del
comportamento del fedele ma, una volta rispettata la forma, ammette che con le finzioni
si possano ammorbidire certe proibizioni del Corano;
—la scuola malikita (diffusa nel Maghreb - cioè la parte settentrionale dell’Africa fino
all’Egitto) è rigorosa;
—la scuola shafiita (diffusa in Indonesia, Siria e Africa orientale) occupa una posizione
intermedia tra le due precedenti;
—la scuola hanbalita (la più tradizionalista diffusa in Arabia Saudita) segue quella shafiita per quanto riguarda il ragionamento giuridico, ma esige un rispetto stretto della
sunna e strettissimo del Corano.
D)La classificazione delle azioni umane
Uno dei punti fondamentali di divergenza tra le varie scuole è il diverso valore delle azioni
umane nella griglia assiologica elaborato dai giuristi per classificarle.
I trattati di giurisprudenza classici dividono le azioni umane in:
1) obbligatorie e doverose. Se le si compie si merita una ricompensa e se non le si compie
si merita una punizione sia in questo mondo sia nell’aldilà. Queste azioni si dividono poi
in farz’ayn «obbligatorie per il singolo individuo», come la preghiera, l’elemosina e il
digiuno e «obbligatorie per la comunità» nel suo insieme, ma l’adempimento delle quali da parte di un certo numero di fedeli ne dispensa tutti gli altri, come lo jihad, la preghiera per i morti, etc.;
2) raccomandate, lodevoli. Se le si compie si merita una ricompensa ma non si merita
punizione se non le si compie (tra di esse vi è l’affrancamento degli schiavi, i digiuni e
altre opere pie);
3) permesse, ma moralmente indifferenti. Sono le azioni per le quali, le si compia o non
le si compia, non è prevista punizione né ricompensa;
4) riprovevoli o disapprovate. Ricadono tra queste le azioni per cui, se le si compie, non
è prevista punizione alcuna, ma per le quali è prevista ricompensa se non le si compie.
È la categoria più controversa;
268
Parte V: L’Islam
5) proibite o condannate. Tra queste azioni vi sono quelle che se le si compie si riceve una
punizione e se non le si compie si riceve (per la maggioranza degli studiosi) una ricompensa. Tra di esse vi sono le pene per cui è prevista esplicitamente nel Corano il tipo di
punizione, come il furto, il bere vino, i rapporti sessuali fuori del matrimonio. Ancora,
mentre la punizione è prevista già in questo mondo, l’eventuale ricompensa è prevista
nell’aldilà.
E) Il diritto penale islamico
Per diritto penale islamico non si distingue tra peccato e reato che coincidono, dato il
carattere religioso dell’intero sistema giuridico.
I reati si possono distinguere in tre grandi categorie:
—alla prima appartengono i reati espressamente puniti dal Corano e dalla sunna. Prendono il nome di reati hudud, sono i più gravi e il giudice gode nel giudicarli, di un
potere discrezionale molto limitato. Contro questi reati la religione viene difesa con
durezza: la flagellazione e la pena di morte colpiscono i reati contro Allah, quali l’apostasia, la bestemmia o l’adulterio. Pene corporali severe vengono applicate ad altri reati
gravi come il furto o il brigantaggio. Questa categoria di crimini viene sempre perseguita d’ufficio, perché rivolti contro Dio e lo stato rappresenta solo il vicario di Dio sulla
terra;
—alla seconda categoria appartengono i delitti di sangue (reati qisas). Anche per essi le
pene sono determinate dal Corano e dalla sunna e, quindi, la discrezionalità del giudice
è limitata. Sono puniti con la legge del taglione, la quale — a discrezione della vittima
o della sua famiglia — può essere sostituita dal prezzo del sangue (risarcimento) o del
perdono. Nel ricorso al taglione si può osservare come il giudice islamico (ma questo è
tipico dei diritti primitivi) più che tener conto della volontarietà dell’atto, si limita a
impedire la vendetta sorvegliando l’equa applicazione della pena del taglione o, se la
parte offesa accetta, del pagamento del prezzo del sangue;
—la terza categoria di reati — detti tazir — comprende infine quei comportamenti che,
di epoca in epoca, sono stati considerati nocivi alla buona convivenza sociale, ma per
i quali né il Corano, né la sunna prevedono pene specifiche. La loro punizione ricade
quindi nell’ambito della discrezionalità del giudice. Risulta, perciò, difficile fissarne
con precisione la fattispecie, perché variano di luogo in luogo e di epoca in epoca.
La parte tecnico-giuridica dell’originario diritto islamico è carente di molti istituti essenziali per un diritto penale occidentale: esso ignora infatti le nozioni di tentativo, di recidiva, di
cumulo delle pene e di circostanze attenuanti o aggravanti.
L’elemento che più differenzia il diritto penale islamico dagli altri è l’assenza dell’elemento soggettivo (dolo, colpa, preterintezione): ai fini dell’applicazione della pena è, infatti,
sufficiente il risultato materiale, sia esso voluto o meno.
Non sono considerati mai punibili il minore (che nel diritto islamico è l’impubere, e di
conseguenza la donna diviene punibile prima dell’uomo) e gli incapaci d’intendere e di
volere o per follia o per intossicazione.