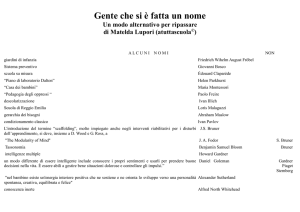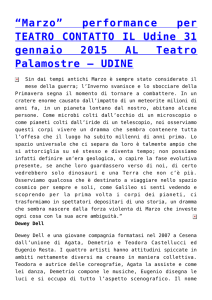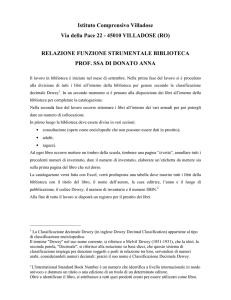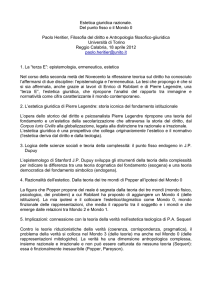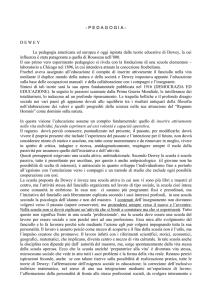Aesthetica Preprint
Supplementa
Esperienza estetica
A partire da John Dewey
a cura di Luigi Russo
Centro Internazionale Studi di Estetica
©
Aesthetica Preprint
Supplementa
è la collana editoriale pubblicata dal Centro Internazionale Studi di Estetica a integrazione del periodico Aesthetica Preprint©. Viene inviata agli studiosi im­pegnati nelle problematiche estetiche, ai repertori bibliografici, alle
maggiori biblioteche e istituzioni di cultura umanistica italiane e straniere.
Il Centro Internazionale Studi di Estetica
è un Istituto di Alta Cultura costituito nel novembre del 1980 da un gruppo
di studiosi di Estetica. Con d.p.r. del 7 gennaio 1990 è stato riconosciuto Ente
Morale. Attivo nei campi della ricerca scientifica e della promozione culturale,
organizza regolarmente Convegni, Seminari, Giornate di Studio, Incontri, Tavole
rotonde, Conferenze; cura la collana editoriale Aesthetica© e pubblica il periodico Aesthetica Preprint© con i suoi Supplementa. Ha sede presso l’Università
degli Studi di Palermo ed è presieduto fin dalla sua fondazione da Luigi Russo.
Aesthetica Preprint
Supplementa
21
Dicembre 2007
Centro Internazionale Studi di Estetica
John Dewey, 1859-1952
Esperienza estetica
A partire da John Dewey
a cura di Luigi Russo
Il presente volume raccoglie gli interventi presentati nell’omonimo Seminario promosso
dal Centro Internazionale Studi di Estetica in collaborazione con l’Università degli Studi
di Palermo e la Società Italiana d’Estetica (Palermo, 23-24 novembre 2007), in occasione
della pubblicazione dell’edizione italiana di Arte come esperienza di John Dewey.
Il presente volume viene pubblicato col contributo del Miur (prin 2005, responsabile scientifico prof. Luigi Russo) – Università degli Studi di Paler­mo,
Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi (Fieri), Sezione di Estetica.
Indice
L’antropologia dell’esperienza estetica in Dewey
di Giovanni Matteucci
7
Emozioni e soggetti nell’espressione artistica: il contributo di Dewey
di Roberta Dreon
19
Estetiche empiristiche
di Simona Chiodo
35
Art as Experience e l’arte contemporanea
di Marco Senaldi
49
È ancora possibile un’esperienza estetica?
di Stefano Velotti
61
Il modello antropologico dell’esperienza estetica
fra Dewey, Gehlen, Plessner
di Salvatore Tedesco
71
Fenomenologia ed esperienza estetica
di Elio Franzini
85
L’estetica come filosofia dell’esperienza. Rileggendo Dewey con Garroni
di Leonardo Amoroso
99
La critica dell’esperienza estetica nella filosofia analitica angloamericana
di Paolo D’Angelo
111
Come leggere Art as experience
nel quadro dell’orizzonte estetico attuale?
di Mario Perniola
123
Esperienza estetica e interattività
di Roberto Diodato
137
Patologie dell’esperienza estetica contemporanea
di Fabrizio Desideri
151
Esperienza estetica e anestesie dell’esperienza
di Pietro Montani
163
Arte ed esperienza. Dopo Dewey
di Fulvio Carmagnola
175
Appendice
a cura di Alfonso Ottobre
191
L’esperienza estetica come fase primaria e come sviluppo artistico
di John Dewey
195
L’antropologia dell’esperienza estetica in Dewey
di Giovanni Matteucci
1. Come ogni opera filosofica di rilievo, Art as Experience 1 di
Dewey presenta una trama concettuale fitta e densa. In tutti i casi del
genere i concetti che vengono utilizzati non hanno la medesima funzione né il medesimo statuto. Vi sono concetti che definiscono alcuni
elementi chiaramente enucleati nel corso della trattazione, ossia i concetti tematici. Vi sono però anche concetti che esprimono dinamiche
pervasive essenziali che tuttavia non trovano uno specifico luogo di
elaborazione e di definizione. Questi sono i concetti operativi. Eugen
Fink, a cui si deve la classificazione, in un mirabile saggio sulla fenomenologia di Husserl ha mostrato come la concettualità del secondo
tipo costituisca il nutrimento genuino della concettualità del primo
tipo 2. Negli atti di determinazione e di definizione ci si serve di, ovvero si opera con, l’energia speculativa di ciò che accompagna come
un’ombra le tematizzazioni.
Come si diceva, quanto alla dialettica tra tematicità e operatività
Art as Experience non fa eccezione. I suoi concetti tematici principali
coincidono con ciò che indicano i termini che compaiono nei titoli
dei diversi capitoli. “Esperienza”, “espressione”, “forma”, “sostanza”,
“contenuto”, persino “arte”, sono lemmi in linea di massima ben modellati, e costituiscono in senso proprio gli elementi della riflessione
estetica deweyana. Nello svolgimento dell’opera, però, tali elementi
vengono precisati facendo ricorso ad alcune dinamiche che non conoscono una precisa determinazione. È tutt’altro che un difetto. In una
prospettiva come quella di Dewey, che ammonisce costantemente a
evitare forme indebite di ipostatizzazione, l’esistenza di tracce robuste
di una viva operatività concettuale depone a favore della coerenza tra
metodo e dottrina. Ma allora per valutare l’orizzonte complessivo nel
quale si inscrive l’estetica deweyana ci si deve impegnare a vagliare la
natura dei concetti operativi mediante i quali si disegnano gli aspetti
dottrinali resi evidenti dai concetti tematici.
La definizione dei contenuti su cui insiste Art as Experience rinvia a
concetti come “resistenza”, “tensione”, “energia”, “forza”, “equilibrio”,
“armonia”, “ordine”, “incorporazione”, “assimilazione”, “perfezionamento”, la cui peculiarità è di esorbitare dalla logica della contrapposizione tra soggetto e oggetto. Infatti, essi non designano né contenuti
7
psichici né porzioni di enti obiettivi. Le dinamiche a cui alludono sono
quelle dell’interazione tra organismo e ambiente che dà adito al «comportamento biologico dell’adattamento» 3. Descrivono cioè un confronto che si rivela produttivo quando l’organismo che subisce un’iniziale
sperequazione rispetto all’ambiente come inibizione all’affermazione
di sé, assimila l’ostacolo che l’ambiente oppone alla sua prassi vitale
facendone una sollecitazione immanente alla sua condotta. In particolare, mediante i concetti di “resistenza” ed “energia” viene messo a
fuoco ciò che Dewey chiama «il prodigio di ciò che è organico, vitale:
l’adattamento per espansione, anziché per contrazione e sistemazione
passiva» (AE, 41). Si può addirittura affermare che l’adattamento per
espansione costituisce la cornice e determina l’architettura del progetto
realizzato attraverso Art as Experience. Infatti esso viene considerato
da Dewey fenomeno tipicamente umano nel momento in cui comporta
la produzione di nuovi oggetti ove si addensano e si estrinsecano le
alterazioni dell’organismo e dell’ambiente grazie a cui si stabilisce un
pur momentaneo equilibrio – nel momento in cui, cioè, l’interazione
assume la medesima espressività che connota le opere d’arte 4.
La mia tesi è che i concetti operativi che caratterizzano essenzialmente la riflessione consegnata ad Art as Experience, rinviando a dinamiche relazionali di tal sorta, sono resi omogenei da una comune
natura antropologica. Se questo è vero, si dovrà parlare del programma
estetico di Dewey come di una vera e propria antropologia dell’esperienza estetica che si muove entro un territorio rispetto a cui i domini
ontologici del mondo interno e del mondo esterno appaiono incongruenti nella loro tendenza a risolvere la relazione in sostanza, la modalità in assolutezza e la qualità in quantità. Qui di seguito mi soffermerò
sommariamente su alcune implicazioni di questo programma.
2. Nel primo capoverso di Art as Experience Dewey afferma che
l’opera d’arte risiede, piuttosto che nell’ente obiettivo che si presenta alla fruizione, in ciò che l’ente prodotto dall’attività artistica «fa
della e nella esperienza» (AE, 31). Ciò che fa dell’esperienza, poiché
esso va colto come termine di una relazione; è un centro di resistenza
che trasforma il corso esperienziale vigente in quanto gli conferisce
una specifica intenzionalità, di modo che l’esperienza sia proprio di
quell’oggetto. Ciò che fa nell’esperienza, poiché è un vettore che interviene a qualificare l’evento; è un punto di energia efficace all’interno
dell’arco esperienziale vigente nella misura in cui l’esperienza assume
l’andamento che si addice proprio a quell’oggetto. Anche la definizione
dell’opera d’arte passa, dunque, attraverso un’elaborazione concettuale
che ha come fulcro i concetti operativi di resistenza, energia e forza
che ancorano l’analisi dell’esperienza estetica alla dimensione della relazione, della qualità e della modalità.
“Resistenza” ha un preciso connotato operativo-relazionale. A di8
stinguere il comportamento biologico umano da quello di altre creature viventi è la consapevolezza che può affiorare solo se si avverte una
resistenza (cfr. AE, 61). La produzione artistica rappresenta il culmine
di questo processo, tanto che per Dewey l’artista deve coltivare la
resistenza e acuirla al massimo grado. Egli deve cioè mettere a frutto
tutte le potenzialità che vi sono riposte per portare «a viva coscienza
un’esperienza che è unificata e totale» (AE, 41), rendendo l’evento in
atto una esperienza, ossia compagine articolata e compiuta il cui perimetro e il cui profilo combaciano con la forma assunta dall’espressione
artistica. D’altro canto, il connotato operativo-relazionale di “forza”
ed “energia” è altrettanto marcato. In quanto campo di forze, l’opera
d’arte consiste infatti delle interazioni che si avvertono al suo interno.
Ecco perché una delle rarissime definizioni esplicite dell’opera d’arte che offre Dewey si risolve nella descrizione di relazioni operative:
«quando la struttura dell’oggetto è tale da far sì che la sua forza interagisca felicemente (ma non con semplicità) con le energie che si
sprigionano dall’esperienza stessa; quando le loro reciproche affinità
e i muti antagonismi operano insieme per determinare una sostanza
che si sviluppa progressivamente e costantemente (ma non in maniera
troppo rigida) verso la soddisfazione di impulsi e tensioni, solo allora
c’è un’opera d’arte» (AE, 169).
Analoghe sono le premesse che motivano la posizione alternativa
che assume Dewey rispetto a prospettive estetiche e, più in generale,
teoretiche centrate sulla soggettività. Sulla scia della destituzione della
sostanzialità della coscienza elaborata da William James 5, egli attribuisce alla dimensione soggettiva un valore eminentemente funzionale.
Così la mente viene interpretata in accezione verbale. Essa coincide
con le attività mentali. Mind, scrive Dewey, «denota tutti i modi in
cui ci occupiamo consapevolmente ed esplicitamente delle situazioni
in cui ci troviamo», e solo a causa di «una maniera influente di pensare» ci si è abituati a trasformare «i modi di agire in una sostanza
soggiacente che compie le attività in questione». Quando si tratta «la
mente come un’entità indipendente la quale fa attenzione, si prefigge,
si prende cura, osserva e ricorda», si annulla la relazionalità operativa
dell’attività mentale, sciogliendola «dalla necessaria connessione con gli
oggetti e gli eventi, passati, presenti e futuri, dell’ambiente con cui sono
intrinsecamente collegate le attività di reazione» (AE, 258). Quindi,
come l’“oggetto” viene considerato per quel che attiene all’energia che
esercita sulla configurazione di un campo esperienziale 6, così nell’analisi deweyana il “soggetto” appare uno dei centri di forza interni all’arco
esperienziale. Soggetto e oggetto sono energie correlate, anzi diventano
termini tendenziali, fuochi, di una correlazione che non mette capo ad
alcuna sostanzialità. Se l’ente è l’orizzonte interno verso cui converge
e si distende un’esperienza quasi ne fosse l’ancoraggio intenzionale, la
mente è questo stesso distendersi che si attua nella concretezza dei gesti
9
e delle pratiche di manipolazione ed elaborazione dei contenuti oggettuali. La soggettualità si identifica con le maniere in cui ci si misura con
l’ambiente, in cui cioè si pone mente ad esso. Equivale a modalità e a
qualità della relazione che si istituisce tra uomo e mondo.
Di conseguenza, come un’ontologia dell’oggetto artistico si dimostra sviante poiché assolutizza le componenti oggettuali dell’esperienza trasfigurate in obiettività, così un’ontologia del soggetto artistico
– che, nell’elevare l’uomo a collettore di stati mentali, interpone uno
iato tra organismo e ambiente – emargina e depotenzia l’organo della
relazione tra uomo e mondo, ossia il corpo, nello stesso momento in
cui fa della mente una sostanza autonoma immateriale che conosce
solo un rapporto contingente con l’alterità radicale della realtà fisica.
Occorre ovviare a questi impoverimenti, che comprimono l’intreccio
pregnante di qualità oggettuali direttamente esperite nella controparte
virtuale delle impressioni sensoriali, e il crogiolo di attività mentali e
moti corporei nell’evanescente spiritualità di un’anima disincarnata. Ed
è tal fine che Dewey combatte ogni estetica che cerchi, per intonazione soggettivistica, di desumere gli elementi dell’esperienza estetica da
presunti contenuti mentali stabilmente definiti entro il solo perimetro
della psiche individuale (cfr. AE, 258-59).
3. Posta la premessa della corrispondenza indistricabile tra attività
e passività rivelata dalla relazione tra uomo e mondo, la riflessione è
tenuta a riconsiderare l’integralità antropologica precedente alla dicotomia tra mente e corpo. Sul piano gnoseologico, ciò spinge Dewey a
condurre una strenua battaglia contro l’intellettualismo. In sede estetica, ciò indirizza invece la sua attenzione alla funzione mediatrice
dell’organismo vivente. Perciò il tragitto descritto da Art as Experience
è costellato dai risultati di un’insistita analisi della sensibilità. La teoria
della percezione sottesa al volume diventa addirittura banco di prova
decisivo per specificare la natura antropologica del programma teoretico perseguito da Dewey. È infatti nel percepire che prende dapprima
rilievo come l’interazione con l’ambiente si esplichi attraverso dinamiche che investono l’essere umano nella sua interezza, a conferma di
quanto sia assurda la partizione rigida tra diverse facoltà e sterile la
subordinazione della percezione alla conoscenza intellettuale.
L’aisthesis è di per sé evenienza pregnante di senso, una volta che si
veda in essa qualcosa di più di una serie di atti istantanei di riconoscimento di oggetti ovvero di fenomeni isolati di ricezione passiva. Anche
il percepire è invece insieme un fare e un subire. Articola in maniera
complessa un progetto d’ordine dettato dal modo e dalla qualità della
relazione che si istituisce mentre l’esperienza procede, e che coinvolge
sinesteticamente l’unità della persona nella sua continuità temporale
concreta e vissuta 7. Oltre che prima della forzosa dicotomia tra mente
e corpo, ciò avviene anche prima della differenziazione analitica de10
gli organi sensoriali e motori, e prima della contrapposizione astratta
tra gli orizzonti temporali. È impossibile percepire qualcosa, osserva
Dewey, «se non quando sensi diversi lavorano in relazione reciproca, se
non quando l’energia di un “centro” si comunica agli altri, stimolando
così nuove modalità di risposte motorie che a loro volta suscitano
nuove attività sensoriali». Questa unità sinestetica e cinestetica è anche,
però, continuità temporale, poiché ogni qualità sensoriale ricapitola un
passato essendo «condizionata da una storia» e allude al futuro poiché
«l’impulso degli elementi motori che sono coinvolti genera un’estensione nel futuro, predisponendosi a ciò che deve venire e in un certo
senso preannunciando ciò che deve accadere» (AE, 180).
La matrice antropologica della teoria della percezione sottesa ad
Art as Experience fa sì che Dewey attribuisca al percepire la funzione
primaria di cogliere direttamente nella tessitura qualitativa il senso
della realtà concreta, non concettualmente idealizzata. Questo possibile
accesso diretto allo strato qualitativo che dà consistenza alla realtà si
riflette sul piano della produzione dell’arte in una ricerca naturalistica
che costituisce il denominatore comune di tutte le opere pienamente
riuscite. “Naturalismo”, per Dewey, designa perciò ogni indagine artistica condotta sulla pienezza del reale che emerge nella prassi percettiva. Non indica l’ideologica proposizione dell’ideale artistico posto nella
natura naturata, bensì la volontà di manifestare la relazione antropologica presa in tutta se stessa. Anziché in quanto esito dell’intento di
restituire una scena con fedeltà rigidamente mimetica, l’opera d’arte
risulta naturalistica nella misura in cui si sforza di presentare un’interazione nella sua ricca dotazione di qualità. Il naturalismo diventa allora
«necessità di tutta la grande arte»; significa «che tutto quello che si
può esprimere è un qualche aspetto della relazione tra l’uomo e il suo
ambiente, e che questo contenuto raggiunge la sua più perfetta unione
con una forma quando ci si vincola e ci si affida completamente ai
ritmi di base che caratterizzano la loro interazione» (AE, 159-60).
Alla tendenza al naturalismo corrisponde senza contraddizione la
tendenza all’astrazione, egualmente condivisa dalle opere d’arte ben
riuscite. Ogni volta che la creazione artistica si prefigge di esprimere la
concreta realtà relazionale, essa compie una riduzione della congerie di
contenuti attuali. Il senso di tale operazione non va comunque equivocato. La creazione artistica prescinde dal dettaglio, fino all’estremo di
raffigurare la modalità azzerando elementi obiettivamente identificabili,
come spesso accade nelle ricerche artistiche del Novecento. Non lo fa,
però, attraverso un’astrazione intellettualistica che miri a presunti scheletri essenziali e formalisticamente determinati. Nell’astrazione artistica
a cadere è quanto si è soliti ipostatizzare assecondando l’abitudine a
servirsi di costrutti già confezionati che mistificano la qualità nella
quantità. Questa ineludibile astrazione è pienamente compatibile con
l’espressività naturale delle opere d’arte 8.
11
In questo quadro, la funzione dell’arte risiede nel potenziamento
qualitativo della percezione che condensa e intensifica la naturalità.
Ciò che esibisce la forma prodotta è al più un nuovo modo di vedere le stesse cose che si incontrano nell’esperienza quotidiana. Affiora
di conseguenza un duplice vincolo estetico. L’opera d’arte nasce nel
dominio percettivo, poiché è dagli ordini immanenti delle qualità sensoriali che essa trae le dinamiche che la innervano. Inoltre è protesa
verso il dominio percettivo, poiché anzitutto contribuisce a plasmare
e consolidare modi di accedere al mondo talvolta inconsueti. In tal
senso, si potrebbe dire che il suo compito è di rendere evidenti leggi
estetiche che governano complessivamente il percepire anziché particolari contenuti sentiti o pensati. L’arte rivela i principi in base ai quali
qualcosa diviene percepibile prima che percepito o concepito, ossia i
principi della percettualizzazione 9.
4. Così incardinata su una teoria dell’aisthesis e della naturalità
percepibile, quella di Dewey si profila come un’estetica in senso originario che ha per argomento la soglia relazionale tra organismo umano
e ambiente. Quest’ultimo è al tempo stesso fisico e sociale. Anzi, la
disomogeneità di un ambiente fortemente antropizzato, di una natura
più che fisica, spinge al centro di Art as Experience il problema della
ricostituzione dell’unità dell’uomo, ossia di come pervenire a equilibrio, armonia, ordine in situazioni che tendono in misura crescente alla
disgregazione 10. È un programma che richiede di evadere dagli schemi
dominanti del pensiero moderno e che anzi ambisce a rispondere allo
svuotamento antropologico che quegli schemi hanno determinato sulla
scorta di una fraintesa semplificazione della natura umana.
La peculiarità risiede nel fatto che Dewey parte dallo stesso principio
di tale svuotamento anziché volgergli sterilmente le spalle. La drastica
diminuzione di senso dell’uomo è dovuta non da ultimo alla pretesa di
giungere alla sua totale e obiettivistica naturalizzazione. La risposta che
suggerisce Dewey è opposta alla ricerca di compensazioni da ottenere
rievocando nostalgicamente la metafisica di un soggetto spiritualizzato.
La naturalizzazione ha i suoi buoni diritti, dà ottimi risultati sul piano
scientifico e addirittura, osserva Dewey, produce «un effetto favorevole,
non sfavorevole, per l’arte nel momento in cui se ne coglie il senso
intrinseco e non se ne interpreta più il significato in base al contrasto
con le credenze che ci derivano dal passato» (AE, 321).
Nel confrontarsi con questa realtà epistemica la filosofia deve semmai farsi carico di mostrare come la natura dell’uomo ecceda l’obiettività della sua fisiologia perché fa qualcosa in, con e di essa. Per saperne qualcosa si possono solamente analizzare le forme della condotta
umana 11. L’organismo antropologico si innesta nella natura vivente
con una capacità che, essendo pragmaticamente e operativamente
produttiva, è anomala rispetto a ogni meccanismo deterministico. È
12
il decentramento interno alla natura (di cui ci appropriamo in parte
quando la rendiamo “nostra”) che crea quegli scarti vissuti dall’uomo
come dinamiche di sensatezza. Occorre allora radicalizzare lo studio
della natura umana per enuclearne le dinamiche senza ipostatizzarle,
magari perché si parte da un netto concetto di uomo o perché si attribuisce indebitamente valore esplicativo a strutture concettuali che
invece ne possiedono solo uno descrittivo così da incorrere in perniciose fallacie metodologiche 12. Ecco perché la relazione e la funzione
dell’uomo come creatura vivente anomala, poietica, trovano espressione
nell’analisi dell’esperienza estetica sotto forma di una concettualità che
si sottrae alla tematizzazione. Il risultato è un’antropologia che ha la
propria forza nella mancanza di una definizione preventiva della natura
umana.
La realizzazione di questo progetto esige il difficoltoso studio di
forze che risultano tanto più efficaci quanto più permangono sullo
sfondo. Per affrontare questo compito, in Art as Experience Dewey
effettua ripetuti rilievi sull’emozione, intesa come lo scenario qualitativo sul quale si stagliano i vettori soggettuali e i vettori oggettuali che
si intersecano nell’esperienza estetica 13. Anzitutto l’emozione viene
sottratta al dominio della soggettività. Per Dewey essa non va confusa
con uno stato mentale che insorgerebbe in aggiunta a, o in occasione
di, un contenuto sensoriale dato. L’emozione è, invece, l’intonazione
che pervade e permea sia i cosiddetti stati mentali che i cosiddetti
elementi obiettivi che agiscono in un arco esperienziale. Le attività
mentali e i punti di resistenza, ossia tutti gli aspetti passibili al limite
di naturalizzazione, fanno la loro comparsa in un campo di per sé
refrattario alla quantificazione, e anzi connotato solo qualitativamente.
È la modalità della relazione che si avverte come emozione, di cui ci
si accorge per come agisce dando configurazione alla circostanza, ossia conferendo alla circostanza potenzialità espressiva e prospettiva di
senso. Per questo motivo l’emozione mai va disgiunta dalla concretezza
materiale dell’evento in corso di svolgimento a cui afferisce 14. Diventa
privo di senso parlare di emozioni come se si trattasse di entità recluse
nel perimetro dello psichismo. In termini fenomenologici, ogni emozione possiede una particolare intenzionalità poiché costituisce il modo
in cui l’attività mentale, e in generale la condotta dell’organismo, si
distende verso l’orizzonte attuale del mondo. Grazie alla sua pervasività, l’emozione colora la stessa attività mentale senza tuttavia ridursi
a un distinto contenuto psichico, a un definito stato mentale. Sottratta a ogni obiettivazione e a ogni soggettivizzazione, l’emozione viene
avvertita solo come forza. Essa rivela così di possedere uno statuto
qualitativo (qualifica l’esperienza), relazionale (sussiste esclusivamente
nell’interazione tra organismo e ambiente) e modale (è l’indice che
esprime la maniera in cui l’esperienza si compagina e si articola) 15.
In tal senso essa impregna anche gli strumenti espressivi che vengono
13
prescelti per dare una forma all’esperienza dotata di validità extraindividuale (cfr. AE, 67).
Se si dicesse semplicemente che lo strato qualitativo che innerva un
arco esperienziale è sfondo, si rischierebbe di darne un’immagine di
assoluta vaghezza e indeterminatezza. Essendo operativa, l’emozione è
invece informata da grammatiche potenziali. È, cioè, uno sfondo selettivo e filtrante che tende al perfezionamento nella scansione, quando
assume quella ritmicità che rende l’espressione capace di restituire, in
forma condensata, la misura e il passo dell’ambiente circostante. Più
corretto sarà dire allora che nell’emozione si rispecchia la struttura
della percepibilità e della percettualizzazione, ovvero l’inobiettivabile
compagine olistica che, come campo di forze, governa l’aggregazione e l’ordinamento del pattern percettivo, da cui si sviluppano anche
eventuali costruzioni concettuali 16. L’enucleazione di contenuti chiari e
distinti si ottiene con un esercizio analitico che diminuirebbe in senso
e incisività qualora dovesse recidere le proprie radici che si inoltrano
nello sfondo da cui trae alimento. Come ogni forma è il profilo che
assume un gioco fluido di forze che intramano una scena percettiva
(cfr. AE, 147), così ogni elaborazione intellettuale – a prescindere da
che sia finalizzata alla produzione artistica o alla conoscenza scientifica
– non fa che restituire di scorcio l’intonazione qualitativa, la tonalità,
che tinge i vettori di campo sospinti di volta in volta in primo piano,
e che «non solo viene per prima, ma persiste quale substrato dopo che
sono emerse distinzioni; esse infatti emergono come sue distinzioni»
(AE, 195).
5. Il riferimento alla tonalità non è rapsodico. Si deve prima di
tutto al luogo schilleriano menzionato da Dewey nella pagina appena
citata, che verte sulla Stimmung quale origine e condizione di possibilità di un’idea poetica 17. Ha però anche una giustificazione di ordine teoretico. Il registro metaforico che evoca svela che la dimensione
uditivo-sonora occupa una posizione di tutto rispetto nell’indagine
deweyana. Infatti, più che attraverso ogni altro senso, l’efficacia di
forze che insistono prevalentemente sulla soglia di relazione tra organismo e ambiente costituita dal corpo si avverte attraverso l’orecchio. A
differenza dell’occhio, l’orecchio è incompatibile con l’inclinazione all’ipostatizzazione. Per almeno tre motivi. L’orecchio non prescinde dal
contesto, non isola profili di enti determinati, non sopporta l’ipotesi di
soggettività disincarnate (cfr. AE, 233). La sua radicale contestualità è
testimoniata dal fatto che l’ascolto avviene sempre in rapporto a uno
scenario estetico (presente al limite come silenzio). Inoltre, l’ascolto
è radicalmente anti-obiettivista poiché è l’accorgersi di cambiamenti
come tali, ossia è proteso a fuochi oggettuali presenti nel campo uditivo solo come nuclei d’energia in interazione tra loro e con l’organismo.
Infine, il fatto che i suoni equivalgano alla presenza di corpi sonori, e
14
non siano assimilabili a rappresentazioni mentali, smarca l’ascolto dal
rischio di ipostatizzazioni soggettivistiche.
È nell’ordine uditivo che ci si confronta in grado estremo con l’integrità antropologica. Il suono proveniente dall’esterno è al tempo stesso riverbero interno di un’eccitazione fisica dell’organismo. In questa
struttura triadica primitiva (fonte – organismo – riverbero) il segmento
cruciale è il corpo. Con e in esso la fonte si tramuta in riverbero. In
quanto ambito d’azione, confine e concerto di fare e subire, il corpo
si mantiene all’interno di una dimensione funzionale che vieta di metter capo a entità sostanziali 18. Avendo esclusivamente il carattere del
mutamento, il fenomeno uditivo è intimamente congenere allo sfondo qualitativo-emotivo a cui vuole accedere l’antropologia deweyana.
Di conseguenza, almeno dal punto di vista antropologico la musica
diventa l’arte per eccellenza. Essa gestisce un mezzo espressivo che
ha presa diretta sulle modalità d’andamento del sistema di energie
efficaci nell’interazione esperienziale. Il tessuto musicale, infatti, non
rappresenta ma incarna l’emozione – anzi, in gran parte si “limita”
a ciò, sfruttando il fatto che «i suoni hanno la forza dell’espressione
emotiva diretta», dal momento che «un suono è di per sé, nella sua
stessa qualità, minaccioso, lamentoso, rasserenante, deprimente, feroce,
tenero, soporifero» (AE, 235).
In breve, nella dimensione uditivo-sonora la soglia relazionale, qualitativa e modale diviene come tale esperienza, con il suo carico di minaccia e promessa che assegna prospettiva futura al presente, e dunque imprime il sigillo antropologico del possibile sul comportamento biologico
attuale: «il suono è ciò che comunica quanto incombe, quanto sta per
accadere, poiché è un’indicazione di quel che è probabile che accada.
Rispetto alla visione è molto più carico del senso delle conseguenze;
attorno a ciò che incombe vi è sempre un’aura di indeterminatezza e
incertezza – tutte condizioni favorevoli a un’intensa eccitazione emotiva» (AE, 235).
6. Lo scandaglio obliquo delle dinamiche di sfondo effettuato da
Art as Experience sfocia in elementi ben definiti. A connettere i due
livelli, quello operativo e quello tematico, è un importante insieme di
ibridi che esprimono la scansione mediante la quale le dinamiche danno luogo ad elementi. Tali concetti non sono propriamente tematici,
nel senso che esprimono gli elementi solo in rapporto alle dinamiche
che li informano. Nemmeno sono propriamente operativi, poiché esprimono le dinamiche, a loro volta, solo in rapporto agli elementi che
vi danno corpo. Così, anche se non definiti in maniera diretta, sono
concetti che vengono esplicitati, svolti, nel corso della trattazione e che
percorrono trasversalmente vari capitoli di Art as Experience. Concetti
di tal genere sono “significato”, “medium” e “ritmo”.
La funzione contemporaneamente semi-operativa e semi-tematica di
15
alcuni di questi concetti può essere illustrata mettendo a fuoco il modo
in cui l’emozione (che in sé assorbe le dinamiche operative variamente
alluse) prende profilo in una forma espressiva (che è un concetto tematico). Ciò capita, scrive Dewey, solo quando un’emozione «trae forma
dai materiali afferrati e raccolti», poiché «un’emozione assume forma
e viene spinta in avanti quando la si sfrutta indirettamente nel cercare
materiale e nel dargli ordine, non quando la si consuma direttamente» (AE, 91). I concetti che mediano l’operatività dell’emozione nella
tematicità della forma espressiva sono, in particolare, due. Da un lato
quello di medium, che appunto designa il materiale in cui si realizza la
forma, in cui si incarna l’espressione. Dall’altro, quello di significato,
che indica la vettorialità impressa su contenuti, all’apparenza scalari,
per effetto della “spinta in avanti” assorbita nell’emozione. La sinergia
di medium e significato traduce un’emozione in costrutti che possiedono un rapporto più che strumentale con i mezzi di cui si servono per
apparire, e che nella loro presenza tendono a un prima e a un dopo e
pertanto, oltre a essere, significano19. Quando si concretizzano ricerca
del materiale appropriato e conferimento di un ordine, la dinamica
emotiva si pone in un rapporto produttivo con gli elementi fattuali
dell’espressione, e gli elementi espressivi che appaiono in primo piano
si pongono in un rapporto pregnante con la dinamica di sfondo.
Si dovrà quindi parlare di tre ordini di concettualità, il cui intreccio
viene illustrato dallo stesso Dewey quando tenta di dare una definizione
tematica dell’espressione sulla base del doppio cambiamento generato
da medium e significato: «cose nell’ambiente che altrimenti sarebbero solo alvei scorrevoli ovvero ciechi ostacoli diventano mezzi, media.
Al tempo stesso cose trattenute dall’esperienza passata che sarebbero avvizzite per la routine o divenute inerti per mancanza di utilizzo,
diventano coefficienti in nuove avventure e indossano la veste di un
nuovo significato. Qui ci sono tutti gli elementi necessari per definire
un’espressione» (AE, 83). L’espressione vive dell’interazione circolare
tra mezzi e fini, e incorpora il proprio significato in quanto incarna la
materialità vissuta degli ordini temporali. L’esperienza diviene allora un
accadimento per l’uomo. In tal senso, la pratica che perfeziona questa
funzione risulta essere l’arte come esperienza, e l’indagine volta a sondarla coincide con un’antropologia dell’esperienza estetica.
1
J. Dewey, Arte come esperienza, ed. a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo
2007 (da cui si cita d’ora in poi con la sigla AE).
2 E. Fink, Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie, “Zeitschrift für philosophische Forschung”, 1957, pp. 321-337.
3 J. Dewey, The Development of American Pragmatism, ora in Id., The Later Works,
vol. 2: 1925-1927, Southern Illinois University Press, Carbondale 1988, p. 17.
4 «Dalla prima manifestazione nel bambino dell’impulso a disegnare fino alle crea-
16
zioni di un Rembrandt, il sé si crea creando oggetti, fatto che richiede l’adattamento
attivo a materiali esterni, compresa una modificazione del sé al fine di utilizzare, e
pertanto superare, necessità esterne assimilandole in una visione ed espressione individuale» (AE, 273).
5 In particolare, cfr. W. James, Esiste la “coscienza”?, in Id., Saggi sull’empirismo
radicale, a cura di N. Dazzi, Laterza, Bari 1971.
6 Se ne veda il corrispettivo gnoseologico in J. Dewey, Logica, teoria dell’indagine,
a cura di A. Visalberghi, Einaudi, Torino 19652, p. 112.
7 Come Dewey scrive in Esperienza e natura (cfr. ed. it. a cura di P. Bairati, Mursia,
Milano (1973) 1990, p. 142), «percepire significa riconoscere possibilità finora non realizzate; significa porre in relazione il presente con delle conseguenze, con eventi finali
e risolutivi, e perciò comportarsi in riferimento alle connessioni degli eventi». Implica
dunque una “protensione” pragmatica dell’organismo, come viene spiegato in polemica
con Bergson in Perception and Organic Action (ora in J. Dewey, The Middle Works, vol.
7: Essays on Philosophy and Psychology, 1912-1914, Southern Illinois University Press,
Carbondale 1979, pp. 1-30).
8 Cfr. AE, 111. – Una significativa conferma della combinazione tra naturalismo e
astrazione Dewey la ricava esaminando le riflessioni di Wordsworth su alcune sue prove
giovanili, in cui si avvertirebbe già la ricerca di un naturalismo autentico in quanto
sarebbero comunque evitate forme di obiettivismo dogmatico (cfr. AE, 161-162).
9 Cfr. J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 280; e AE, 95. – Su queste basi appare
possibile il confronto con l’antropologia dell’esperienza estetica delineata da Ernst Cassirer, incentrata appunto sul concetto di percettualizzazione (cfr. soprattutto E. Cassirer,
Saggio sull’uomo, trad. it. di C. D’Altavilla, Armando, Roma 1968, p. 263; al riguardo mi
permetto di rinviare a G. Matteucci, Ipotesi di una estetica della “forma formans”, introd.
a E. Cassirer, Tre studi sulla “forma formans”, Clueb, Bologna 2004, pp. 18-23).
10 Si veda la cornice di critica della società che apre e chiude Art as Experience (AE,
31-38 e 323-30). Questo intento educativo dell’estetica di Dewey viene esplicitato anche
nella chiusura di un saggio sull’Affective Thought pubblicato nel 1926 sulla rivista della
Barnes Foundation: «i dipinti, quando sono estratti dalla loro nicchia specializzata, sono
la base di un’esperienza educativa, che si contrappone alle tendenze disgregatrici delle
specializzazioni inviolabili, delle divisioni a compartimenti e delle rigide separazioni che
confondono e vanificano a tal punto la nostra vita presente» (J. Dewey, Educazione e
arte, a cura di L. Bellatalla, la Nuova Italia, Firenze 1977, p. 37-38).
11 “Condotta” è appunto per Dewey «un’interazione fra gli elementi della natura
umana e l’ambiente naturale e sociale» (J. Dewey, Natura e condotta dell’uomo, a cura
di L. Borghi, La Nuova Italia, Firenze 1958, p. 16).
12 Esemplare al riguardo la critica della nozione di “istinto” in Natura e condotta
dell’uomo, cit., pp. 141-42 (passo ripreso e giudicato positivamente, non a caso, anche
da Cassirer nel Saggio sull’uomo, cit., pp. 142-43).
13 Radicalizzando le medesime premesse anti-sostanzialiste, nella Logic del 1939
Dewey preferirà evitare di parlare, oltre che di sentimento e sensazione, anche di emozione, a cui sostituirà di fatto la locuzione «situazione qualitativa totale» senza tuttavia
mutare la struttura della sua analisi (cfr. J. Dewey, Logica, cit., p. 113).
14 Cfr. anche J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 279.
15 Sulla originarietà relazionale delle situazioni qualitative cfr. anche J. Dewey, Qualitative Thought, ora in Id., The Later Works, vol. 5: 1929-1930, Southern Illinois University Press, Carbondale 1988, soprattutto pp. 244-249. Ma cfr. anche Logica, cit., pp.
112-16. – Su questi argomenti si è soffermata di recente Roberta Dreon ricostruendo con
chiarezza la nozione deweyana di esperienza, senza però rilevare l’operatività antropologica che caratterizza la posizione di Dewey, e dunque ammorbidendo il suo contrasto
rispetto ad approcci ermeneutici e fenomenologico-linguistici, da Heidegger a MerleauPonty (cfr. R. Dreon, Il sentire e la parola, Mimesis, Milano 2007, pp. 55-73).
16 Si legge nel saggio del 1930 Qualitative Thought (cit., p. 259), in riferimento al
riconoscimento di identità formali: «la sola maniera in cui forma o pattern possono
17
operare come collegamento immediato è sfruttando il modo di una qualità direttamente
esperita, qualcosa di presente e prioritario e indipendente rispetto a ogni analisi riflessiva, qualcosa che ha la stessa natura che controlla la costruzione artistica».
17
Il medesimo passo è citato e commentato, in maniera assai affine a quella di
Dewey, da Wilhelm Dilthey (cfr. Estetica e poetica, nuova ediz. ampliata, a cura di G.
Matteucci, Angeli, Milano 2005, pp. 163-64), proprio per sottolineare la funzione di
sfondo tonale che compete all’emozione.
18 «I suoni vengono dall’esterno del corpo, ma il suono stesso è vicino, intimo; è
un’eccitazione dell’organismo; sentiamo lo scontro delle vibrazioni attraverso tutto il
nostro corpo. Il suono sollecita direttamente un mutamento immediato perché dà conto
di un mutamento» (AE, 234).
19 Sul piano linguistico la vettorialità semantica viene camuffata dall’uso copulativo del verbo essere. Da qui una serie di equivoci che si ingenerano in particolare in
riferimento alla “predicazione” di attributi qualitativi secondari e terziari. Al riguardo
Dewey osserva: «è soltanto una peculiarità linguistica, non un fatto logico, che si dica
“questo è rosso” anziché “questo arrossisce”, sia nel senso di farsi, di diventare, rosso,
sia nel senso di rendere qualcos’altro rosso. Anche linguisticamente il nostro “è” è una
forma indebolita di un verbo attivo che significa “sta” o “si presenta”. Ma la natura
di qualsiasi atto (designato dalla forma verbale precisa) è colta meglio nel suo effetto
e nel suo esito; diciamo “è dolce” piuttosto che “addolcisce”, “è rosso” piuttosto che
“arrossisce”, perché definiamo il cambiamento attivo per il tramite del suo risultato
anticipato o conseguito» (J. Dewey, Qualitative Thought, cit., p. 252).
18
Emozioni e soggetti nell’espressione artistica:
il contributo di Dewey
di Roberta Dreon
L’idea che le arti siano espressive e che, anzi, la loro espressività
sia proprio tra le caratteristiche che le rendono più interessanti è forse una delle ovvietà più trasversali, comune alle concezioni estetiche
più raffinate come alle opinioni più ordinarie dell’uomo della strada.
La questione si fa tuttavia estremamente intricata quando si cerca di
comprendere che cosa il termine “espressione” significhi di volta in
volta e, ancor più, allorché si tenta di chiarire quale ruolo vi assumano
le emozioni individuali, la sensibilità o l’apporto dei singoli. Eppure
nel corso del Novecento fino agli anni più recenti una serie di critiche provenienti da vari fronti sembra avere mostrato l’inopportunità
di questo tipo di categorie per comprendere e articolare i fenomeni
artistici, ovvero la loro ascendenza dogmatica e dualistica.
Se l’ermeneutica ha dato un contributo decisivo contro le concezioni soggettivistiche dell’esperienza dell’arte, in particolare con la critica
delle nozioni di Erlebnis, di differenziazione e di coscienza estetica, sul
versante fenomenologico Merleau-Ponty ha proposto una interpretazione delle espressioni artistica e linguistica radicalmente innovatrici
anche rispetto alla sua stessa provenienza culturale. Se Goodman ha
operato un decisivo trasferimento del concetto di espressione sul piano delle relazioni di riferimento, gli argomenti di Wittgenstein contro il mito del linguaggio privato, contro le concezioni reificanti dei
significati e quelle pittografiche del linguaggio, nonché nei confronti
dell’opposizione tra interno ed esterno, sono stati variamente ripresi
per evidenziare i limiti delle interpretazioni delle arti come espressioni
soggettive.
Con questo tipo di strumenti concettuali e di argomenti filosofici è
stata così rilevata la debolezza di concezioni dell’arte quale linguaggio
delle emozioni indicibili di Susanne Langer, delle tesi di Collingwood
e di Croce sull’intuizione estetica come espressione di emozioni, della
assunzione di Santayana della qualità estetica quale oggettivazione o
proiezione di uno stato soggettivo… Tra gli studi critici più recenti in
questa direzione si possono ricordare quelli di Nigel Warburton, di
Garry Hagberg, e più indietro nel tempo quello di Bouwsma, significativamente intitolato The Expression Theory of Art 1.
Ci troviamo allora costretti ad abbandonare questo genere di cate19
gorie filosofiche per parlare di arte e a epurarne il lessico, in un modo
o nell’altro metafisicamente pregiudicato?
Come è stato notato, l’approccio di Dewey al linguaggio della tradizione filosofica è sempre stato caratterizzato nel senso opposto, con
tentativi costanti di reinterpretazione dei termini della tradizione, spesso attraverso il ricorso agli usi del linguaggio ordinario, e sempre senza
ignorare che anche le sue scelte lessicali non erano certo innocenti 2.
In particolare sul tema affrontato in questa sede, si è riconosciuto che
Dewey è riuscito ad articolare una concezione dell’espressione artistica
e dell’oggetto espressivo capace di prendere radicalmente le distanze
dal «principio dell’espressione come estrinsecazione di sentimenti» 3,
di evitare la caduta nel dualismo della rappresentazione all’esterno di
un contenuto a essa estrinseco e antecedente, non rinunciando tuttavia
ad articolare la centralità della componente emotiva e del contributo
individuale nei fenomeni espressivi. Questo è accaduto non solo attraverso una profonda rielaborazione della nozione di espressione, ma
anche per il tramite di una concezione dell’emozione, o meglio della
qualità emotiva dell’esperienza, maturata in una direzione che tende
nettamente a evitarne l’ipostatizzazione e l’attribuzione a un ambito
psichico contrapposto alla dimensione fisica, ma anche una caratterizzazione in termini privatistici e al limite estranei alla razionalità e al
linguaggio. La terza componente di questo ripensamento complessivo
riguarda la reinterpretazione del soggetto, della mente e del sé individuale nel corso esperienziale, in una concezione capace di sottrarsi
alla contrapposizione tra dualismi e riduzionismi, nell’alveo di quel
“naturalismo culturale” professato e praticato dal filosofo americano.
1. Emozioni e stati mentali
Uno degli aspetti che caratterizzano la concezione dell’espressione
elaborata da Dewey è senz’altro la centralità che è attribuita alla componente emotiva, che ha generato, tuttavia, numerosi fraintendimenti,
primo fra tutti la polemica con Croce e i tentativi di ricondurre le
proposte del filosofo americano in materia di espressione artistica a
forme di idealismo “organico” 4. Ma come è stato notato 5, questo
genere di lettura trascura almeno un punto sul quale le indicazioni di
Dewey sono sempre state molto nette: la tesi che l’emozione non costituirebbe il contenuto oggettuale espresso dalle opere d’arte, quanto
piuttosto funzionerebbe da principio di guida, controllo e selezione di
quei materiali sui quali l’atto espressivo esercita un’azione trasformatrice. A ben vedere già in questa versione sommaria delle connessioni tra
emozioni ed espressioni sono racchiusi almeno due aspetti di profonda
discontinuità con la nozione crociana di arte: da un lato, appunto, l’assunzione che l’espressione artistica equivalga all’intuizione di un sentimento, seppure purificato e reso universale, alla produzione di una
sua immagine, e dall’altro l’idea che questa immagine sia collocabile
20
in un ambito primariamente spirituale, mentale o psichico, indifferente
in linea di principio ai materiali e alle tecniche artigianali nelle quali
potrà successivamente ed eventualmente essere comunicato 6.
Ma si tornerà più tardi su questi elementi, per fermarsi ora a considerare le componenti della concezione dell’emozione elaborata da
Dewey.
Come era già stato sottolineato nel 1978 7, occorre assumere una
prospettiva continuistica e unitaria, seppure nel senso di una progressiva maturazione e articolazione dei temi, sia nella interpretazione di Art
as Experience rispetto al contesto più ampio dell’opera deweyana 8, sia
nel dettaglio sul tema dell’emozione, che non può essere confinata alle
decisive, ma non numerose indicazioni che si riscontrano nell’opera
del 1934. In particolare Whitehouse recuperava lo scritto giovanile
The Theory of Emotion 9, cui a mio parere vanno aggiunti un testo
appartenente ai primissimi anni di quella che viene considerata la piena maturità del filosofo americano, What are States of Mind? 10, oltre
ad alcune importanti indicazioni del capitolo di Experience and Nature
dedicato all’arte 11.
Nel primo articolo menzionato Dewey propone una caratterizzazione prevalentemente fisiologica dell’emozione 12, definendola come una
modalità di comportamento contraddistinta da una forma di tensione e
di esitazione momentanea circa la risposta da dare a una determinata
sollecitazione ambientale: a essere disturbata o momentaneamente sospesa sarebbe la connessione unitaria tra attività senso-motorie, quali
il vedere, il toccare, l’udire, e le attività motorio-vegetative del cuore,
dello stomaco e degli altri organi interni, regolati dal sistema simpatico,
che di solito risultano fuse in atti unitari, dai quali si originano risposte
abituali per lo più non coscienti e comunque non tematiche. In certe
circostanze questa unità verrebbe a rompersi in fasi apparentemente
giustapposte, che richiederebbero una scelta tra più possibilità disponibili per rispondere a quegli impulsi provenienti dall’ambiente che
determinano una forma di disagio o di disorientamento nelle risposte
abituali e consolidate.
Già a questo livello di elaborazione della questione il giovane filosofo americano ritiene pertanto che l’emozione sia da intendere non
tanto in termini sostantivi, quanto come modalità o qualità di un comportamento e più in generale di una certa esperienza dell’ambiente, e
che sia appunto caratterizzata da una direzione latamente intenzionale,
ovvero che riguardi innanzi tutto non già la presunta interiorità privata del soggetto, ma le sue relazioni strutturali con l’ambiente, e in
particolare le sue modalità di risposta non abituali e ordinarie, in cui
interviene la necessità di una scelta sul da farsi; il terzo elemento che
ritornerà nelle interpretazioni dell’emozione proposte successivamente è
l’assunzione per cui le esperienze caratterizzate da una forte preminenza emotiva comporterebbero una qualche forma di presa di coscienza
21
delle componenti attive e passive che sono in gioco, vale a dire un
approccio non diretto alla consumazione immediata dell’esperienza,
ma a una considerazione in qualche modo riflessa delle sue componenti soggettive e ambientali. In altri termini, già a questo stadio di
elaborazione della questione le indicazioni di Dewey appaiono molto
distanti sia dall’iscrizione del sentire emotivo in un ambito psichico o
soggettivo primariamente privato, sia dalla contrapposizione dualistica
tra l’affettivo o l’emozionale e l’intellettuale: come dirà in seguito il filosofo americano, l’emozione è un modo di coscienza perché comporta
una tensione o una rottura di un comportamento responsivo ormai
consolidato, che diventa pertanto consapevole o tematico, “riflessivo”
e non “immediato” 13.
Nel successivo What are States of Minds? Dewey avvia la sua interpretazione, come gli accade di sovente, dall’analisi dell’espressione “stato mentale” nel discorso ordinario, nel quale a suo parere si
possono trovare indicazioni migliori rispetto a quelle di tanti tomi di
epistemologia, che gli appaiono pregiudicati dai dualismi tra mente e
corpo, nonché tra mente, soggetto o coscienza, da un lato, e mondo o
realtà materiale, dall’altro. Nell’inglese colloquiale dire che qualcuno
si trova in un determinato “state of mind” significa ritenere che egli
assuma una certa disposizione comportamentale nei confronti delle
cose e degli individui che gli stanno intorno – in particolare il riferimento è di solito a una forma di irritazione o almeno di impazienza
nei confronti delle une e degli altri. Pertanto «Uno stato mentale è
essenzialmente un atteggiamento o una disposizione emotiva, tale per
cui questo atteggiamento o disposizione sono caratteristiche di certe
condizioni di un agente organico» 14.
Gli stati mentali non sono pertanto equiparati alle emozioni, ma
riguardano «sensazioni, idee, immagini, volizioni e i cosiddetti stati
di coscienza» 15 in quanto, prima di essere ipostatizzati in sostanze o
anche solo in eventi psichici autonomi, si riferiscono ai modi in cui un
organismo vivente è disposto nei confronti dell’ambiente circostante
– modalità che sono caratterizzate da una certa qualità emotiva. Il genitivo non va inteso in senso possessivo, come se un certo stato appartenesse a una certa dimensione speciale chiamata mente, ma nei termini
di una qualità che permea una determinata esperienza, una particolare
interazione tra un organismo e l’ambiente al quale esso appartiene,
per cui si tratta di una disposizione che è percepita come tale, diventa
cosciente come aspetto che caratterizza un sé individuale a causa della
tensione emotiva che viene a crearsi.
Il punto fondamentale per Dewey è interpretare questo genere di
fenomeni a partire dal dato primario di ogni esperienza, il quale non
è costituito da una mente o da una coscienza separata e indipendente
da un mondo e da una realtà bruta e indifferente che si limita a offrirsi
come tale alle nostre percezioni, ma è di volta in volta una «moving
22
complex situation» 16 in cui un organismo vivente si trova a lottare con
un mondo dal quale dipende, dando risposte sempre interessate – a
differenza delle entità inorganiche –, che contribuiscono a modificare
l’ambiente circostante, su cui le sue azioni e le sue passioni retroagiscono in una forma di adattamento reciproco e sempre dinamico. Se
si prende avvio da questa situazione mediale, per così dire, in cui gli
organismi viventi si trovano già sempre situati in relazioni di dipendenza circolare da un mondo del quale sono al contempo una parte
strutturale, si evitano secondo Dewey quei fraintendimenti fatali dei
fenomeni mentali ed emotivi che danno per originarie la separazione
tra un ambito psichico a se stante e un corpo meramente fisico, per cui
diventa problematico spiegare come l’uno possa esercitare una azione
causale sull’altro. Tra l’altro, il filosofo americano ritiene che in questo
modo sarebbe stata sostenibile con maggiore efficacia la teoria dell’emozione sviluppata da William James, per cui le risonanze o i riverberi
organici di una emozione non dovrebbero essere intesi quali conseguenze a livello di espressione corporea di stati mentali antecedenti, ma
come lo stesso «materiale mentale» 17 di cui sono costituite le nostre
disposizioni emotive verso il mondo circostante: la concezione tradizionale secondo la quale una emozione o un sentimento determinano
una certa espressione del volto o una certa postura come conseguenza
esteriore o puramente fisica di uno stato interiore appare inattaccabile
solo se si assume come dato primario il dualismo tra mente e corpo e
tra organismo e ambiente.
Questo, d’altra parte, non significa che la discriminazione tra un
organismo vivente, una mente individuale o un sé, e l’ambiente verso il
quale è disposto in un certo modo non si dia o sia fallace. Significa invece per Dewey che si tratta di una differenziazione derivata rispetto a
una interazione e a una interdipendenza circolari – e in particolare, nel
senso che il discriminare interviene come un tipo di esperienza riflessa
rispetto a quella immediata dell’interconnessione reciproca organicoambientale, rispondente all’esigenza di considerare analiticamente le
componenti della interazione che sta avvenendo, per poter controllare
più efficacemente i rapporti tra mezzi e conseguenze quando gli abiti
di risposta consolidati diventano problematici e si crea una tensione
emotiva sul da farsi, che porta ad assumere consapevolemente l’intrico del tessuto esperienziale. Tra l’altro, questo tipo di interpretazione
rende evidenti i limiti di una caratterizzazione dell’emozione in termini
irrazionali o ineffabili: come si sostiene in The Quest for Certainty, se
«L’aspetto emotivo di un comportamento responsivo è la sua qualità
immediata» 18, questo vuol dire che una situazione di tensione circa il
da farsi viene senz’altro esperita o vissuta come tale, ma non è separabile dalla esigenza di una considerazione riflessa per uscire dall’impasse che si è creato, ovvero non è nettamente districabile dall’analisi
che essa avvia delle componenti in gioco nell’esperienza immediata
23
della tensione, che proprio come tale ne produce una prima forma di
consapevolezza.
Lo scritto del 1912 si conclude attribuendo la genesi e il successo
dell’ipostatizzazione del mentale o dello psichico, da un lato, e del
corporeo e del meramente fisico dall’altro lato, insieme alla loro individuazione come dati primari, a motivazioni di matrice sociale e religiosa, oltre che a un certo autocompiacimento isolazionistico tipico delle
forme d’arte drammatica e letteraria, ma anche di tanta psicologia.
Il capitolo del volume del 1925, intitolato Experience, Nature and
Art, riprende il tema dell’emozione brevemente, ma con un intervento
decisivo, che mette in discussione l’interpretazione tradizionale dell’arte
come espressione delle emozioni, e in particolare l’implicazione che
essa porta con sé per la quale un’opera d’arte autentica comporterebbe
la riduzione dei materiali e dei mezzi in cui essa si realizza a meri strumenti esteriori di esternazione di una emozione già data in altra sede 19.
Di nuovo la critica di una simile concezione dell’arte si rifà al significato della parola emozione nella vita e nel linguaggio quotidiani:
L’emozione infatti nel suo senso ordinario è qualche cosa che viene chiamato in
causa da oggetti, fisici e personali; è una risposta a una situazione oggettiva. Non
è qualcosa che esista di per sé in un qualche stato e che poi adoperi del materiale
attraverso cui esprimersi. L’emozione è il segno indicatore dell’intima partecipazione,
in modo più o meno vivace, a qualche vicenda della natura e della vita; l’emozione è per così dire un atteggiamento o una disposizione che è funzione delle cose
oggettive 20.
L’assunzione per cui l’emozione costituirebbe innanzi tutto il dato
di una coscienza individuale a se stante, autonoma dal mondo nel quale
potrebbe in seguito rintracciare i materiali per essere resa pubblica,
contraddice la sua caratterizzazione nel discorso ordinario, in cui appare evidente che abbiamo paura di qualcosa, gioiamo per un certo
incontro, ci preoccupiamo per la nostra vita o avvertiamo una forma di
repulsione nei confronti di un certo atteggiamento… In altri termini,
piuttosto che uno stato mentale chiuso in una dimensione interiore,
l’emozione è assunta nella nostra vita quotidiana come qualità o come
modalità di risposta a una certa situazione nella quale viviamo e rivela,
al contrario, proprio la nostra esposizione strutturale all’ambiente.
Art as Experience ritorna su questo aspetto, sottolineando come
l’emozione riguardi un sé, ma gli appartenga solo in quanto «è coinvolto nel movimento degli eventi verso un esito che si desidera o che si
avversa» 21. Pertanto non c’è alcuna necessità che un soggetto proietti
le proprie emozioni sulla natura, poiché questa è esperita immediatamente come avversa, ostile, o favorevole, a seconda dell’accento su cui
cade il ritmo dell’interazione che costituisce di volta in volta l’organismo individuale. Questo diventa appunto un individuo, un sé anche
grazie alle qualità emotive delle esperienze che va compiendo, poiché
24
esse segnalano appunto delle rotture nel ritmo di integrazione con
l’ambiente, che diventano pertanto consapevoli 22.
Una precisazione ulteriore riguarda la distinzione tra mero conato
ed emozione: a differenza del primo che offre una risposta istintuale,
quasi automatica alle sollecitazioni ambientali, la seconda ha una qualità significativa che la caratterizza immediatamente proprio nella misura
in cui comporta un riferimento intenzionale o oggettuale in senso lato,
ovvero segnala il conforto o il pericolo che una determinata situazione
offre o impone a un sé.
Ma l’aspetto che viene articolato con maggiore ampiezza nel volume del 1934 riguarda il ruolo di guida, di selezione dei materiali, di
controllo e di tenuta unitaria dell’emozione nell’ambito dell’espressione, e di quella artistica in particolare. Prima di affrontare questo
tema, è però opportuno fornire alcune precisazioni sulla posizione del
sé che appare pur sempre coinvolto emotivamente nelle esperienze che
va compiendo e al quale Dewey riconosce una funzione comunque
decisiva nell’espressione artistica.
2. Soggetti, menti e coscienze
Ai temi del soggetto, del sé individuale, della mente, della coscienza
è dedicato il sesto capitolo di Experience and Nature, intitolato “Nature, Mind and the Subject”, cui si devono aggiungere alcune indicazioni
del successivo ottavo capitolo, “Existence, Ideas and Consciousness”.
Il testo esordisce con una presa di posizione netta rispetto alle
istanze del soggettivismo di matrice idealistica, ma anche nei confronti
delle forme coscienzialistiche di interpretazione dell’esperienza: «La
personalità, l’essere un sè, la soggettività sono funzioni di eventi che
emergono con il costituirsi di interazioni organiche e sociali in interazioni organiche e sociali organizzate in modo complesso» 23.
Fin dal primo approccio alle questioni Dewey vuole sottolineare
che le individualità soggettive non si situano all’inizio di un processo
di costituzione del mondo, ma nemmeno dell’esperienza, poiché si
configurano piuttosto quali fattori che si costituiscono all’interno dell’esperienza stessa, delle interazioni con un ambiente che è naturale e
naturalmente condiviso e pubblico. In particolare, inoltre, è necessario che le interazioni in corso abbiano raggiunto un grado di grande
complessità, tale da comportare quelle forme di consapevolezza delle
parti coinvolte nei processi di godimento o di sofferenza immediata,
che sono costituiti già dalla sensibilità emotiva e dall’analisi riflessiva
che ne consegue. È in questo senso che risulta sostenibile la differenza
decisiva dell’individualità umana pur nell’ambito dell’assunzione della
sua continuità profonda con i processi naturali da cui insorge e a cui
risponde 24.
Questo non significa – e la cosa ha una forte rilevanza nell’ambito
dell’espressione artistica – che i soggetti non siano riconosciuti come
25
fattori rilevanti e anzi decisivi per l’esperienza umana, ma ne implica
l’interpretazione quali «agent[i] di nuova ricostruzione di un ordine
pre-esistente» 25. I sé, in altre parole, si situano in una posizione mediale
nell’ambito di transazioni che stanno già accadendo e che generalmente
hanno già assunto una qualche forma di equilibrio mobile ma consolidato. Sono eventi che sopravvengo non già rispetto a una realtà in sé,
né rispetto all’esperienza tout court, quanto nei confronti dell’esperienza che procede per lo più senza intoppi, per cui «In primo luogo
e in prima istanza non è esatto né rilevante dire ‘io esperisco’ o ‘io
penso’. ‘Si’ (It) sperimenta o si è esperiti, ‘si’ pensa o si è pensati sono
espressioni più appropriate» 26. Nell’interazione esperienziale il singolo
individuo emerge come tale da forme di esperienza “prepersonali”, per
ricorrere al termine usato da Mereleau-Ponty 27, quando si sente chiamato in causa in prima persona da quello che sta facendo o vivendo,
perché si trova in una situazione di incertezza o di indeterminazione
tali da fargli riconsiderare riflessivamente ciò che sta esperendo e da
fargli dunque assumere consapevolmente la propria individualità. Dire
“io” vuol dire impegnarsi in una cura, addossarsi una responsabilità in
vista di certe conseguenze, non significa esserne l’autore, la sorgente, il
primo della costituzione: «Dire in modo significativo ‘Io penso, credo,
desidero’, invece di limitarsi a dire ‘si pensa, crede, desidera’ significa
accettare e dichiarare esplicitamente una responsabilità e avanzare una
pretesa. Non significa che io sia l’origine o il creatore del pensiero o
dell’affezione, né che l’io ne sia la sede esclusiva» 28.
L’io emerge dunque come un fenomeno naturale e sociale al contempo, intervenendo come evento che accade a un organismo coinvolto
nell’esperienza dell’ambiente da cui dipende e rispondendo alla istanza
sociale di rendere conto di certe azioni, di attribuire delle responsabilità rispetto agli esiti di certe attività. Da un lato, pertanto, la mente
non deve essere intesa come qualcosa di primariamente individuale, ma
si costituisce come tale socialmente: è «un sistema di credenze, riconoscimenti, omissioni, assunzioni e rifiuti, aspettative e apprezzamenti
di significati che sono stati istituiti sotto l’influsso del costume e della
tradizione» 29 – non è invece il polo da cui si diparte una percezione
o un’osservazione del mondo là fuori, già costituito come tale. D’altra
parte, la struttura partecipativa dell’esperienza umana, radicata nel linguaggio, consente di distinguere tra la mente e il sé, tra possibilità e
modalità di comportamento comuni e relazioni riflessive, che risultano
pertanto derivate nella misura in cui l’accento cade innanzi tutto sui
rapporti tra sé e il mondo, e in particolare con gli altri sé dai quali
ci si può o ci si deve distinguere – la riflessività non è in altri termini
una questione che si giochi nei recessi privati di una coscienza isolata
e autonoma, ma nasce come istanza di differenziazione, di riconoscimento e di assunzione di responsabilità nell’alveo di esperienze e di
attività partecipate 30.
26
Dire di una percezione, di un riconoscimento, di un certo comportamento che è soggettivo significa allora sostenere che mi appartiene,
che mi coinvolge in prima persona e che posso essere tenuto a risponderne, non che per questo non dica qualcosa del mondo di cui faccio
esperienza – come se si dicesse che, poiché l’attributo di quella casa è
di essere mia, allora la mia proprietà impedisce alla casa di essere come
essa è in sé. In altri termini, dal riferimento soggettivo di qualcosa non
si può inferire la negazione della sua struttura intenzionale.
Experience and Nature sostiene che le esagerazioni del soggettivismo – che dunque segnalano pur sempre un fenomeno autentico,
sebbene lo fraintendano – sorgerebbero storicamente nell’Umanesimo
in contrasto con il primato divino tipicamente medievale, ma in particolare dalla dottrina medievale per cui la salvezza (o la dannazione)
riguardano l’anima individuale. Ma il nodo centrale del travisamento
concerne l’assunto della separazione del soggetto dall’oggetto quale
dato primario, la concezione per cui ciò che è esperito è inteso come
indipendente dal modo in cui è esperito e i modi di esperienza del
mondo sono separati e determinati autonomamente rispetto al mondo
di cui fanno esperienza.
I contributi successivi su questo tema sono improntati soprattutto a intendere il fenomeno in termini non sostantivi, come la qualità
mentale che sarebbe tipica di relazioni organico-ambientali a elevato
grado di complessità e di libertà, e a sottolinearne l’apertura strutturale
al mondo, di contro al modello tradizionale in cui è interpretata prevalentemente come un ambito privato – o all’estremo opposto è intesa
in termini fisicistici, attraverso una riconduzione di tipo riduzionistico
ai fenomeni neurofisiologici, per dissolvere le difficoltà del solipsismo
soggettivistico e della sostantivizzazione delle rappresentazioni mentali 31. The Quest for Certainty propone allora di considerare la mente
come la qualità tipica di un insieme di risposte – emotive, deliberative,
intellettuali – all’incerto che caratterizza solo la vita umana, poiché gli
esseri inanimati non sono in grado di reagire alle cose come problematiche, ma si limitano a reazioni standard. Solo organismi dotati di una
struttura complessa e che si trovano a interagire con un ambiente altrettanto complesso avvertono la problematicità delle cose, l’incertezza
sul da farsi, con forme di consapevolezza che vanno dalle modalità più
emotive a quelle in cui la componente intellettiva diventa dominante.
L’intelligenza risulta pertanto una componente della mente: è la qualità
che un’esperienza assume quando si affronta esplicitamente un problema, quando si tratta di mettere in atto una strategia per migliorare
una interazione con l’ambiente, poiché quella attuale non funziona
ordinariamente e diventa perciò problematica e cosciente.
In Art as Experience la necessità di evitare la reificazione e l’isolamento della mente in un ambito psichico separato si appella agli usi
linguistici ordinari, dai quali risulta evidente, da una lato, la compo27
nente intenzionale o il legame strutturale con l’ambiente di ogni comportamento umano e, dall’altro, una tendenza a considerare il termine
“mind” come verbo o come parte di un’espressione verbale, piuttosto
che quale sostantivo. “Avere in mente”, “tenere a mente”, “richiamare
alla mente”, “porre mente”, significano memoria, proposito, attenzione,
osservazione interessata e più in generale cura o preoccupazione per
le cose e per gli individui tra i quali ci troviamo a vivere, per cui nel
linguaggio ordinario “mente” «Non denota mai qualcosa di sufficiente, di isolato dal mondo delle persone e delle cose, ma si usa sempre
facendo riferimento a situazioni, eventi, oggetti» 32.
I significati che risultano dalle nostre pratiche delle cose e da ciò
che facciamo con gli altri diventano parte di un sé in fieri, che lungi dall’avere una struttura indipendente dal mondo cui appartiene, è
appunto costituito dallo sfondo mobile, in continuo processo di assimilazione e ricostruzione delle cure, delle preoccupazioni, della partecipazione interessata a ciò che va facendo. La “coscienza”, in questa
prospettiva, viene interpretata come un fenomeno più ristretto della
mente, apparendo quale componente “intermittente” e di primo piano,
che di volta in volta mette a fuoco una interazione particolare a partire
da uno sfondo, da un “subconscio”, che funziona silenziosamente come
insieme dei comportamenti organici, delle abitudini comportamentali,
delle tendenze implicite alla selezione, al rifiuto, alla classificazione, che
guidano implicitamente i nostri comportamenti più consapevoli.
3. Atti e oggetti espressivi
Come è noto, Art as Experience dedica ben due capitoli al tema
dell’espressione, che possono essere letti come dissolvimento di una
serie di stereotipi interpretativi del carattere espressivo delle arti,
nonché quale rielaborazione in senso antidogmatico dei termini della
questione.
Innanzi tutto la concezione degli atti di espressione come forme di
interazione complessa tra organismi e ambiente, e in particolare quali
esperienze in cui hanno luogo profonde trasformazioni delle componenti in gioco, marginalizza da subito il luogo comune per cui esprimere, ivi inclusa l’espressione che avviene attraverso materiali e mezzi
artistici, consista nella mera estrinsecazione di un contenuto interiore,
immateriale, spirituale, o «etereo», per usare le parole di Dewey, che
sarebbe già determinato come tale prima dell’approntamento degli
strumenti fisici atti alla sua resa all’esterno, alla sua comunicazione in
termini pubblicamente riconoscibili 33.
L’atto espressivo è piuttosto interpretato come una esperienza complessa, vale a dire come una relazione organico-ambientale nella quale
i rapporti di determinazione appaiono reciproci, circolari e strutturati
dinamicamente, ma anche quale interazione caratterizzata da una forma emotiva di consapevolezza, determinata dall’interruzione momenta28
nea degli abiti di risposta consolidati in situazioni di vita abituali. Ciò
che caratterizza un atto come espressivo è che in esso non si verifica
la rappresentazione di qualcosa di preesistente – stato d’animo, impressione, idea, significato –, ma una vera e propria trasformazione o
rielaborazione in senso costruttivo di materiali ed esperienze precedenti, capace di produrre un’esperienza innovativa del mondo comune,
ovvero di dirla o di presentarla agli altri che ne fruiscono. Per spiegare
che cosa intenda sostenendo che l’espressione è una trasformazione il
filosofo americano sfrutta la vicinanza etimologica tra “esprimere” e
“spremere”, ricordando come anche la spremitura del succo degli acini
dell’uva non consiste nella mera espulsione del loro contenuto, nella
semplice restituzione all’esterno del chicco del materiale grezzo che
esso contiene, poiché persino un’operazione di tipo meccanico come
questa comporta l’interazione della materia prima con la pressione del
torchio, la separazione dalla buccia e dai vinaccioli, la filtrazione 34.
I materiali su cui agisce l’attività di trasformazione o di rielaborazione espressiva appaiono disparati nella interpretazione di Dewey,
ma mantengono in comune la caratteristica di non appartenere a una
interiorità privata, quanto piuttosto di essere prodotti di esperienze
individuali o collettive di un mondo condiviso e partecipato: non solo
suoni, colori, elementi tattili, ma anche disposizioni organiche motoriopercettive, abiti di comportamento dinamico e tecnico, oltre al bagaglio
di significati derivanti da esperienze riflessive precedenti, ormai sedimentati e incorporati anche nelle forme di esperienza meno mediate
di godimento o di sofferenza delle circostanze ambientali in cui gli
individui si trovano a vivere.
L’individualità dell’artista, ma anche del fruitore, assumono un ruolo decisivo, ma per così dire, mediano o intermedio nella pratica in cui
questi materiali sono modificati e rielaborati, in quanto la creazione
artistica non è concepita ex nihilo, alla stregua della creazione teologica, ma appunto come intervento che agisce su esperienze e significati
precedenti, appartenenti a un mondo comune, che sono sottoposti al
«filtro dell’esperienza individuale». D’altra parte entrambe le componenti, lo sfondo ambientale e organico condiviso e prepersonale, ma
anche le individualità coinvolte nella loro trasformazione, vengono a
trovarsi in un processo di determinazione reciproca e dinamica, per
cui l’esperienza espressiva alla quale prendono parte non si limita ad
agire su materiali e mezzi significativi, organici e ambientali, precedenti, ma retroagisce sulle stesse soggettività che ne sono chiamate in
causa, contribuendo a determinare i loro sé secondo un certo percorso
esperienziale.
Infine, per venire ai principi che guidano l’attività di rielaborazione
in cui l’espressione artistica consiste in questa interpretazione deweyana – oltre che ai materiali e ai fattori attivi e passivi delle trasformazioni in corso –, le emozioni, o meglio una forma di sensibilità e
29
di consapevolezza emotiva, vi assumono una funzione di linea guida,
di criterio di selezione e di riorganizzazione dei materiali, di bilanciamento delle componenti in un complesso unitario, che regolano sia
l’attività artistica sia la possibilità di fruizione delle opere d’arte. Da
questo punto di vista viene pertanto accantonata un’altra interpretazione tradizionale dell’espressione, per cui le arti consisterebbero
essenzialmente nell’esprimere emozioni o stati d’animo, ineffabili per
via verbale e al limite sottratte alla loro privatezza e rese universali
proprio dall’espressione artistica 35. Si tratta, in altri termini, della tesi
per cui le emozioni ne costituirebbero il contenuto oggettuale, vale a
dire ciò che le opere d’arte esprimerebbero. Su questo punto è d’aiuto
la distinzione che Dewey propone tra lo sfogo emotivo e l’espressione
artistica: il primo costituisce pur sempre una forma di esperienza immediata, in cui la rabbia o la gioia sono vissute per sé e chi le sfoga
lascia espandere liberamente le passioni da cui è assorbito, restando
completamente preso dall’impegno diretto in questa situazione. Le sue
urla irate o i suoi sorrisi saranno certamente eloquenti per coloro che
gli stanno intorno, e rinvieranno oltre se stessi in questa prospettiva,
ma questo accadrà solo per gli altri individui, non per chi è impegnato
totalmente nello sfogo. Un atto espressivo, invece, implica una qualità
emotiva che, come si diceva in precedenza, comporta l’interruzione
di un abito di risposta consolidato in precedenza, una resistenza a
lasciar procedere le cose come d’abitudine e la necessità di una scelta,
di una selezione o di una cernita tra più possibilità responsive all’impulso verso il quale l’organismo si è proteso 36. La sensibilità emotiva
è pertanto già portatrice di una forma di consapevolezza, determinata
da una esitazione o da una sospensione momentanea dell’esperienza
in corso, che conducono a considerare tematicamente i termini della
situazione attuale e avviano una riflessione o una considerazione analitica dell’interazione che sta avvenendo, rivelandone, così, la profonda
continuità con le pratiche conoscitive, deliberative e comunque più
mediate rispetto alla fruizione diretta degli eventi per il peso che essi
hanno direttamente su di noi. Di qui provengono le insistenze dell’anziano filosofo a ripensare le connessioni tra «un pensiero pregno di
emozione» e «sentimenti la cui sostanza consiste di significati o idee»,
per mettere in questione le separazioni nette che li hanno storicamente
contrapposti 37.
A questo si deve aggiungere che la stessa componente emotiva,
che agisce sui materiali e sulle esperienze precedenti, selezionandole,
rielaborandole, unificandole, non resta a sua volta indenne dall’azione
esercitata, poiché a sua volta subisce una trasformazione nel corso
dell’atto espressivo, passando da uno stadio più grezzo e indefinito a
uno più determinato e raffinato. Proprio per questo non si può sostenere che l’emozione operante a livello espressivo preceda tout court
l’atto della sua espressione e rimanga fondamentalmente estranea ai
30
mezzi tecnici e materiali in cui si esternerebbe, per restare all’ennesimo
stereotipo interpretativo su questo argomento. Piuttosto l’emozione si
determina come tale solo nel corso dell’espressione, si definisce soltanto attraverso la scelta del medium espressivo più congeniale alla
situazione specifica, di cui subisce la reazione o la modificazione, che
le conferisce quel particolare tratto estetico, caratterizzandola pur rispetto a una genesi comune alle emozioni ordinarie.
Ma cosa significa sostenere che un’opera d’arte è espressiva? Senza
esitazioni Dewey afferma che con questo si ritiene che l’opera d’arte
«ci dice qualcosa» 38. All’inizio del quinto capitolo di Art as Experience, Dewey articola questa formula nei tre aspetti che essa comporta. Innanzi tutto il “dire” è parafrasato con il verbo “rappresentare”, dove,
però, il filosofo americano ha cura di distinguere la rappresentazione
intesa come “riproduzione letterale” di una presunta realtà in sé – categoria che è stata tradizionalmente usata per interpretare l’arte cosiddetta figurativa, naturalistica o mimetica –, dal rappresentare inteso
come presentare, offrire, proporre qualcosa alla fruizione. Tuttavia, ciò
che viene presentato o proposto non è la resa trasparente o puramente
descrittiva di qualcosa di preesistente, e in particolare di un qualche
tipo di oggettualità, ma una esperienza del mondo comune che è nuova, perché pur partendo da materiali e da esperienze che sono parte
di una tradizione condivisa, le une e gli altri hanno subito una trasformazione espressiva che viene ulteriormente elaborata dall’“alambicco
individuale” di coloro che ne fruiscono. Anche per costoro, cui l’opera
d’arte inevitabilmente si rivolge nella misura in cui diventa parte della
loro esperienza del mondo condiviso, vale il processo di selezione, di
filtrazione e unificazione guidate da una sensibilità emotiva, che agisce
a partire da una certa propensione organica, percettivo-motoria – un
affinamento delle capacità di riconoscere suoni, colori, consistenze, una
dimestichezza con posture e movimenti degli arti… –, nonché dalla
ricchezza o meno dei significati di esperienze precedenti che si sono
sedimentati nell’esperienza attuale dell’osservatore o dell’uditore. Si
tratta pertanto fondamentalmente per Dewey non tanto di un nuovo
contenuto oggettuale, ma appunto di una nuova esperienza, ovvero
di una nuova opportunità di interazione con l’ambiente, che facendo
partecipare anche i fruitori a un fare comune che essi riprendono e
proseguono ulteriormente, è in grado di dire «qualcosa a coloro che
ne fruiscono circa la natura della propria esperienza del mondo» 39.
L’opera d’arte è dunque inevitabilmente comunicativa, nel senso
della parola “comunicazione” definito in Logic. The Theory of Inquiry,
come fare qualcosa in comune. Proprio per questo più problematica
risulta la contrapposizione tra espressione e asserzione e tra significato
immediatamente esperito nell’arte, e segnali e significati verbali, che
comporterebbero non tanto una nuova esperienza per chi ne fruisce,
quanto l’indicazione del percorso per giungervi. Tanto più che il ca31
pitolo successivo esordisce con una pagina sui “linguaggi” delle arti,
che rimette in questione queste separazioni, per altro generalmente
rifiutate da Dewey. Ma qui si aprirebbe un’ulteriore questione, per la
quale sono orami costretta a rinviare ad altrove... 40.
1 Cfr. N. Warburton, La questione dell’arte, Einaudi, Torino 2004, G. L. Hagberg,
Art as Language. Wittgenstein, Meaning, and Aesthetic Theory, Cornell University Press,
Ithaca and London 1995, O. K. Bouwsma, The Expression Theory of Art, in M. Philipson e P. J. Gudel (a cura di), Aesthetics Today, New American Library, New York
1980.
2 Sull’approccio di Dewey al linguaggio filosofico si veda la Introduction di T. M.
Alexander, John Dewey’s Theory of Art, Experience and Nature. The Horizons of Feeling, State University of New York Press, Albany 1987, pp. xi-xxi, ma anche V. M.
Colapietro, Embodied, Enculturated Agents, in C. Haskins e D. I. Seiple (a cura di),
Dewey reconfigured. Essays on Deweyan Pragmatism, State University of New York
Press, Albany 1999, p. 71.
3 G. Matteucci, Presentazione, in J. Dewey, Arte come esperienza, Aesthetica, Palermo 2007, p. 19.
4 Il primo ad avanzare questo tipo di lettura è stato S. C. Pepper, nel suo Some
Questions on Dewey’s Esthetics, in P. A. Schillp (a cura di), The Philosophy of John
Dewey, Northern University & Southern Illinois University Press, La Salle 1939 (1951),
pp. 371-89, seguito dallo stesso Benedetto Croce, Intorno all’estetica del Dewey, in
“La critica”, 38, 1940, pp. 348-53, e Intorno all’estetica e alla teoria del conoscere del
Dewey, in “Quaderni della critica”, 16, 1950, pp. 60-68. Ma molti altri hanno partecipato al dibattito, divisi tra coloro che sostenevano l’ispirazione idealistica dell’estetica di
Dewey e la sua conseguente estraneità all’impianto pragmatista della sua epistemologia
e coloro che invece hanno giustamente interpretato Art as Experience come prodotto
maturo della teoria dell’esperienza di Dewey. Quest’ultimo è stato del resto l’approdo
inevitabile cui ha condotto lo studio dell’opera completa di Dewey, ormai reso possibile dall’edizione integrale delle sue opere curata da Jo Ann Boydston per la Southern
Illinois University Press. Per una ricostruzione conclusiva degli aspetti della questione
si veda il primo capitolo, intitolato The Pepper-Croce Thesis, di T. M. Alexander, John
Dewey’s Theory of Art, Experience and Nature. The Horizons of Feeling, cit.
5
Cfr. L. Russo, La polemica tra Croce e Dewey e l’arte come esperienza, in “Rivista
di studi crociani”, 5, 1968, pp. 201-16.
6
Cfr. B. Croce, Breviario di estetica. Aesthetica in nuce, Adelphi, Milano 1992,
in particolare il primo capitolo del Breviario, dal titolo “Che cosa è l’arte?” e i saggi
“Intuizione ed espressione” e “Espressione e comunicazione” dell’Estetica.
7
Cfr. P. G. Whitehouse, The Meaning of “Emotion” in Dewey’s Art as Experience,
in J. E. Tiles, (a cura di), John Dewey: Critical Assessements, vol. iii: Value, Conduct and
Art, Routledge, London-New-York 1992, pp. 379-90.
8
J. Dewey, Art as Experience, vol. 10 di The Later Works, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville 1987, trad. it. a cura di G.Matteucci, Arte
come esperienza, cit. In Italia tra i sostenitori storici della tesi continuista si deve ricordare Aldo Visalberghi, che l’ha difesa fin dal primo lavoro sul filosofo americano, John
Dewey, Firenze, La Nuova Italia 1951; una ripresa e uno sviluppo efficaci di questa
interpretazione è ora proposta da G. Sputznar, Ricostruire la filosofia. Il rapporto individuo-ambiente nel pensiero di John Dewey, Aracne, Roma 2004.
9 J. Dewey, The Theory of Emotion, vol. 4 di The Early Works, cit., 1971, pp. 15288. Da ricordare che J. E. Tiles, nel suo The Fortunes of “Functionalism” (in C. Haskins
e D. I. Seiple, a cura di, Dewey Reconfigured. Essays on Deweyan Pragmatism, cit., pp.
32
39-61), sostiene la centralità di questo saggio, unitamente a quelli sull’arco riflesso e
sullo sforzo (The Reflex Arc Concept in Psychology e The Psychology of Effort, entrambi
in J. Dewey, vol. 5 di The Early Works, cit., 1972, rispettivamente pp. 96-109 e pp.
151-63) nel ripensamento critico delle proprie posizioni iniziali e nella elaborazione
del pensiero maturo di Dewey.
10 J. Dewey, What are States of Minds?, vol. 7 di The Middle Works, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville 1979, pp. 31-43.
11 Id., Experience and Nature, vol. 1 di The Later Works, cit., 1988, trad. it. a cura
di P. Bairati, Esperienza e natura, Mursia, Milano 1990.
12 Tra l’altro, questo tipo di caratterizzazione indebolisce le accuse di riduzionismo
dei fenomeni mentali ai comportamenti che da alcune parti sono state mosse a Dewey.
Su questo si veda A. S. Lothstein, The Pathology of Inwardness: John Dewey’s Critique
of the “Inner Life”, in J. E. Tiles (a cura di), Critical Assessements, cit., pp. 246-83.
Piuttosto al limite potrebbe venirne un’accusa di riduzionismo del mentale al fisiologico,
al fisico-meccanico, che avvicinerebbe Dewey ad alcuni esponenti del cognitivismo; ma,
come ricorda Tiles nell’articolo citato in precedenza, vi è una differenza enorme, che
impedisce di accusare Dewey di riduzionismo in questo secondo senso: «Le funzioni
che interessavano Dewey e gli altri della sua generazione erano funzioni dell’intero
organismo – preferibilmente (e senz’altro per Dewey) funzioni dell’intero organismo
che interagisce con il suo ambiente» (J. E. Tiles, The Fortunes of “Functionalism”, cit.,
p. 53), per cui è lontanissima l’ipotesi di poter ricondurre l’organismo di cui si trattava
a un meccanismo dal funzionamento autonomo, come una macchina di Turing.
13 Su questo avvicinamento delle emozioni a forme di coscienza intese in senso non
primariamente cognitivo sarebbe interessante verificare alcune continuità con posizioni
più recenti in ambito scientifico, come quella di A. R. Damasio, Emozione e coscienza,
Adelphi, Milano 2000.
14 J. Dewey, What are States of Mind?, cit., p. 33.
15 Ibidem.
16 Ivi, p. 37.
17 Ivi, p. 34 e p. 36. Sulla rilevanza della teoria delle emozioni di James per Dewey
cfr. sia J. E. Tiles, Dewey, Routledge, London and New York 1988, p. 35 e ss., sia T.
M. Alexander, cit., p. 137.
18 J. Dewey, The Quest for Certainty, vol. 4 di The Later Works, cit., 1988, p. 180,
trad. it. di E. Becchi e A. Rizzardi, La ricerca della certezza. Studio del rapporto tra conoscenza e azione, La Nuova Italia, Firenze 1966.
19 Non è escluso che Dewey si riferisse proprio alle teorie di Croce – il suo Breviario
di estetica era già stato elaborato sotto forma di lezioni a seguito di un invito ricevuto
dal Rice Institute di Houston in Texas. Come è noto, nella produzione estetica in lingua
inglese l’influenza di una concezione idealistica per molti versi analoga sarà sviluppata
da Collingwood nel suo Principles of Art del 1928. Sicuramente un altro termine polemico era la teoria dell’espressione di Santayana, come sottolinea Thomas Alexander (cit.,
p. 213 ss.). Che al termine del capitolo Dewey intendesse confrontarsi con il dibattito a
lui contemporaneo è manifesto, a mio parere, anche perché subito dopo avere discusso
questo genere di interpretazione dell’arte, si impegna nei confronti della teoria della
“forma significante”, su cui aveva insistito Clive Bell nel suo Art del 1914.
20 J. Dewey, Experience and Nature, cit., p. 292, trad. it. cit. (modificata), p. 279.
21 Id., Art as Experience, cit., pp. 48-49, trad. it. cit., p. 67.
22
Cfr. ivi, pp. 20-21, trad. it. cit., pp. 41-42. Su queste basi sarebbe interessante allargare il discorso a una revisione del tema dell’empatia come proiezione di sentimenti e di
emozioni soggettive sugli altri, che ultimamente è stata ripresa da alcuni esponenti della
cosiddetta “neuroestetica” a partire dal ruolo attribuito ai cosiddetti “neuroni specchio”
– su questo si veda D. Freedberg, Empatia, movimento ed emozione, in G. Lucignani e
A. Pinotti, Immagini della mente. Neuroscienze, arte, filosofia, Raffaello Cortina, Milano
2007, pp. 13-67.
23 J. Dewey, Experience and Nature, cit., p. 162, trad. it. cit. (modificata), p. 159.
33
24
Come sostiene Vincent M. Colapietro nel saggio citato in precedenza, la scelta
di Dewey di definire il soggetto come “organismo umano” non ha alcun intento riduzionistico, quanto piuttosto polemico nei confronti dei dualismi assunti indebitamente
dalle posizioni di tipo spiritualistico. «Il soggetto umano non è altro che l’organismo
umano; ma nel corso dell’esperienza, questo organismo è trasformato radicalmente nelle
e attraverso le sue interazioni con gli altri» (cit., p. 70).
25 J. Dewey, Experience and Nature, cit., p. 168, trad. it. cit. (modificata), p. 165.
Concordo pertanto con la tesi di Colapietro che difende Dewey dalle accuse di avere
vanificato il soggetto individuale, mosse in particolare da John E. Smith (John Dewey:
Philosopher of Experience, in Reason and God, Yale University Press, New Haven 1961,
pp. 92-114) e da Richard J. Bernstein (John Dewey, Washington Square Press, New
York 1966): nei testi del filosofo americano non si riscontra certo una dottrina sistematica della soggettività, ma una serie di indicazioni tali da ripensarla come evento non
riducibile dell’esperienza, che emerge appunto da essa ed è capace di retroagire sulle
condizioni naturali e culturali della sua insorgenza.
26 J. Dewey, Experience and Nature, cit., p. 179, trad. it. cit., p. 175.
27 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard 1945,
trad. it. a cura di A. Bonomi, Fenomenologia della percezione, Bompiani, Milano 2003.
28 J. Dewey, Experience and Nature, cit., pp. 179-80, trad. it. cit., p. 175.
29 Ivi, p. 170, trad. it. cit., p. 166.
30 Cfr. V. M. Colapietro, cit., p. 71, e T. M. Alexander, cit., pp. 160-61.
31 Mi limito qui a osservare che da questo punto di vista Dewey fornirebbe almeno
alcuni spunti per superare il dibattito tra dualismo e monismo nella comprensione delle
connessioni mente-corpo, nonchè per intessere un confronto non riduzionistico con
alcuni contributi delle neuroscienze.
32 J. Dewey, Art as Experience, cit., p. 268; trad. it. cit., p. 258.
33 Da questo punto di vista ricadono nella critica di Dewey anche quelle concezioni come quella di Croce e di Collingwood, secondo le quali l’intuizione estetica non
prescinderebbe dall’espressione, anzi si realizzerebbe propriamente solo in essa, ma
questa è compresa a sua volta come un fenomeno puramente spirituale o comunque
immateriale, del tutto indipendente rispetto al momento successivo ed esclusivamente
accessorio della sua comunicazione in mezzi e materiali. Sotto questo profilo sono notevoli le affinità con la critica che Merleau-Ponty formula alle concezioni tradizionali
del linguaggio come espressione all’esterno di significati logici già costituiti indipendentemente dagli strumenti lessicali nei quali sarebbero poi vicolati. Cfr., tra le altre, le
prime pagine di M. Merleau-Ponty, La prose du monde, Gallimard, Paris 1969, trad. it.
a cura di C. Sini, La prosa del mondo, Editori Riuniti, Roma 1984.
34 J. Dewey, Art as Experience, cit., p. 68; trad. it. cit., p. 86.
35 Si possono citare da un lato le tesi di S. Langer (si veda Feeling and Form, Routledge and Kegan Paul, London 1953) e dall’altro quelle di Croce o di Collingwood
(The Principles od Art, Oxford University Press, Oxford (1938) 1958).
36 Sul confronto tra vera e propria espressione e «mere act of discharge» si veda
T. M. Alexander, cit., p. 219 ssg. Per la distinzione tra impulso e stimolo, ovvero tra
“impulse” e “impulsion” si veda J. Dewey, Art as Experience, cit., p. 63, trad. it. cit., p.
81; questa differenziazione a mio parere ha le sue radici nella critica dell’arco riflesso
elaborata da Dewey nel saggio del 1896, citato in precedenza. Per una disamina della
questione cfr. R. Dreon, Il sentire e la parola. Linguaggio e sensibilità tra filosofie ed
estetiche del novecento, Mimesis, Milano 2007, p. 167 ss.
37
J. Dewey, Art as Experience, cit., p. 80, trad. it. cit., p. 93.
38
Ivi, p. 88, trad. it. cit., p. 101.
39 Ivi, p. 89, trad. it. cit., p. 102.
40 Sui significati di “linguaggio” in Dewey e sulle connessioni tra linguaggio ed
esperienza si cfr. R. Dreon, cit., il iv capitolo, Esperienza e linguaggio: le risposte del
“naturalismo culturale” di John Dewey, pp. 165-207.
34
Estetiche empiristiche
di Simona Chiodo
Arte come esperienza (1934) è un titolo che dà un’indicazione
importante: se vogliamo capire il significato della nozione di «arte»
dobbiamo capire il significato della nozione di «esperienza», perchè,
Dewey dice attraverso il titolo, l’«arte» è «come» l’«esperienza», cioè
è un’«esperienza».
Dobbiamo concentrarci, allora, su Esperienza e natura (la prima
edizione è del 1925 e la seconda edizione è del 1929) e soprattutto
sul suo primo capitolo “Il metodo della filosofia”, nel quale Dewey
articola la nozione di esperienza che fonda Arte come esperienza e
a partire dalla quale è possibile capire perché l’arte è un’esperienza
e, soprattutto, che cosa significa, qui, fare uso della nozione di esperienza e dei suoi corollari. Dewey unisce il significato della nozione
di esperienza alla scelta di procedere attraverso un metodo di lavoro
empirico: se usiamo «il vero metodo empirico», allora partiamo dall’«esperienza primaria» 1, perché «il metodo empirico richiede dalla
filosofia […] che i metodi e gli oggetti rifiniti vengano rinviati alle loro
origini nell’esperienza primaria […] [e] che i metodi e le conclusioni
secondarie vengano ricondotti alle cose dell’esperienza primaria» 2.
L’«esperienza primaria» è l’esperienza «rozza» 3 nella «sua generica
banalità» 4, è, cioè, l’esperienza di Darwin che osserva «piccioni, bovini e piante da allevamento e da giardino» 5. E il metodo di lavoro
empirico è, allora, lo strumento che considera l’«inclusiva integrità
dell’“esperienza”», perché «assume questa integra unità come punto
di partenza del pensiero filosofico» 6. Al contrario, «gli altri metodi
cominciano sempre con i risultati di una riflessione che ha già separato
nettamente il contenuto esperito, da un lato, e le operazioni e stati
dell’esperire, dall’altro» 7. I risultati di Dewey sono due: il metodo di
lavoro empirico dice che cosa è l’esperienza, perché considera anche il
suo grado «primari[o]», radicale, e, soprattutto, dice che l’esperienza,
se è anche il suo grado «primari[o]», radicale, non è «il contenuto
esperito» «separato» dalle «operazioni» e dagli «stati dell’esperire». La
filosofia empiristica di Dewey significa, al contrario, che, se un metodo
di lavoro empirico agisce, allora lo spazio dell’oggetto («il contenuto
esperito») non è diviso dallo spazio del soggetto (dalle «operazioni» e
dagli «stati dell’esperire»). Quando Dewey ragiona sul significato della
35
«parola “esperienza”» unisce il primo spazio al secondo spazio, perché
la «parola “esperienza”» significa sia «il lavoro del campo, la semina, il
raccolto e la mietitura, i cambiamenti del giorno e della notte, la primavera e l’autunno, l’umidità e l’arsura, il caldo e il freddo» sia «colui
che pianta e raccoglie, che lavora e gioisce, spera, teme, fa progetti,
ricorre alla magia o alla chimica per aiuto, che subisce disastri o passa
giorni fortunati» 8. La nozione di esperienza sulla quale Dewey ragiona
non sottintende, «nella sua primaria integrità», «alcuna divisione tra
atto e materiale, soggetto e oggetto» 9. E, se la nozione di esperienza,
che significa l’unione dell’«oggetto» con il «soggetto», è il risultato
della procedura empirica, allora nella procedura «non-empiric[a] […]
l’oggetto e il soggetto, lo spirito e la materia […] sono», viceversa,
«separati e indipendenti» 10. Dewey argomenta che l’unione tra oggetto e soggetto caratterizza il metodo della filosofia empiristica e che
la divisione tra oggetto e soggetto caratterizza il metodo della filosofia
non empiristica.
Ma il resoconto di Dewey su che cosa caratterizza la filosofia empiristica e che cosa caratterizza la filosofia non empiristica ha un’alternativa importante, che ha una direzione contraria, perché è possibile dire
che l’uso di un metodo di lavoro empirico sottintende la divisione, e
non l’unione, tra oggetto e soggetto. L’unione è un risultato, è il risultato ultimo di una procedura empirica. E la condizione di possibilità
dell’unione dell’oggetto con il soggetto è la divisione del primo dal
secondo: se credo che il sole che osservo sia diviso, cioè eterogeneo
ex parte aut in toto, dal mio sguardo, allora ho la possibilità di dare
una rappresentazione del sole fondata sulla credenza che il sole ecceda,
comunque, la mia rappresentazione. Ed è questa, non quella di Dewey,
la posizione che caratterizza la filosofia empiristica, considerata anche
attraverso il quid specifico che le sue articolazioni storiche, sia sincroniche sia diacroniche, conservano. Il filosofo che usa il metodo di lavoro
empirico crede che l’oggetto che osserva ecceda la rappresentazione
che dà dell’oggetto, perché l’oggetto è dato, anche se è formato dallo
sguardo dell’osservatore, perché lo sguardo dell’osservatore, anche se
ha il potere di vedere un oggetto ad hoc, non ha il potere di costruire
un oggetto ad hoc: da Hume agli empiristi logici di Vienna e di Berlino
il quid specifico che il filosofo che usa la procedura empirica conserva
è la credenza che, anche se non ho la possibilità di dimostrare che il
sole che osservo è diviso, cioè eterogeneo, autonomo ex parte aut in
toto, dal mio sguardo, perché lavoro attraverso il mio sguardo, «se
esamino il sistema tolemaico e quello copernicano, con le mie indagini
mi sforzerò solo di arrivare a conoscere la condizione reale dei pianeti;
cioè, in altre parole, cercherò di dare ad essi, nella mia rappresentazione, le medesime relazioni in cui si trovano l’uno con l’altro nei
cieli» 11. E credo addirittura che «la verità o la falsità non mutano con
il mutare delle percezioni degli uomini. Se anche tutta la specie umana
36
dovesse definitivamente concludere che il sole si muove e la terra sta
ferma, il sole non si sposterebbe certo di un pollice dal suo posto per
tutti questi ragionamenti, e queste conclusioni rimarrebbero eternamente false ed errate» 12. Da Hume, qui citato, agli empiristi logici di
Vienna e di Berlino il filosofo che usa il metodo di lavoro empirico
crede che «il sole non si sposterebbe di un pollice» «se anche tutta la
specie umana dovesse definitivamente concludere che il sole si muove»
– il filosofo che usa il metodo di lavoro empirico crede che l’oggetto
osservato, anche se è visto attraverso la sua rappresentazione, non sia
costruito dalla sua rappresentazione, perché, e ancora, eccede la sua
rappresentazione, dalla quale non è dato, ma alla quale è dato.
Dewey afferma che la filosofia empiristica è fondata sull’unione già
data tra oggetto e soggetto, e non sulla loro divisione, cioè sulla loro
unione non ancora data, perché è un pragmatista. La filosofia empiristica di Dewey è la filosofia empiristica di un pragmatista. Quando
Davidson domanda se la filosofia empiristica ha altri dogmi a parte i
due dogmi sottolineati da Quine, che fa riferimento soprattutto all’empirismo logico, risponde che la filosofia empiristica ha un terzo dogma,
cioè il «dualismo tra schema e contenuto, tra un sistema organizzante
e un qualcosa che attende d’esser organizzato», che è «forse l’ultimo,
perché se lo abbandoniamo non saprei dire se rimanga qualcosa di
specifico da poter chiamare empirismo» 13. Secondo Davidson il terzo
dogma dell’empirismo, che è anche il quid specifico dell’empirismo, è
la divisione tra lo spazio dell’oggetto («contenuto») e lo spazio del soggetto («schema»), che è la posizione che secondo Dewey caratterizza,
al contrario, la filosofia non empiristica. Il resoconto di Davidson dice
la verità: la tradizione filosofica dell’empirismo conserva, anche quando
varia nel corso della sua storia, la credenza che l’oggetto non sia già
unito al soggetto, cioè alla sua rappresentazione – perché l’oggetto, al
contrario, ha il potere di sorprendere il soggetto, cioè di fare variare
la sua rappresentazione, dalla quale è creduto eccedere. Ma Dewey
è soprattutto un pragmatista. E un pragmatista crede che il potere
essenziale da sottolineare non sia la capacità che l’oggetto ha di fare
variare la sua rappresentazione, ma, viceversa, la capacità che la sua
rappresentazione ha di fare variare l’oggetto – un pragmatista crede
che sia soprattutto il soggetto ad avere un potere straordinario, che è
il potere di fare l’oggetto attraverso la sua rappresentazione, al variare
della quale l’oggetto varia.
Ma un quid specifico, ed essenziale, che caratterizza la filosofia empiristica marca anche il pragmatismo di Dewey, che sigilla un risultato
notevolissimo, da conservare ancora, a quasi un secolo di distanza. Il
quid specifico risponde alla domanda che chiede perché serve scegliere
il metodo di lavoro empirico versus gli altri metodi di lavoro. E Dewey
dice: «il metodo empirico indica quando e come e dove sono state
conseguite le cose cui si riferisce una descrizione designata. Mette di
37
fronte agli altri una mappa della strada che è stata percorsa; se vogliono essi possono ripercorrere in modo analogo quella strada per
guardare il passaggio per conto loro. Così le scoperte di uno possono
essere corrette ed estese dalle scoperte degli altri, con quella certezza
umanamente possibile di conferma, estensione e correttezza. […] Il
ricercatore scientifico persuade gli altri non con la plausibilità delle
sue definizioni e la forza necessitante della sua dialettica, ma mettendo
di fronte ad essi il corso dettagliato dei tentativi, delle operazioni e
degli arrivi, in conseguenza dei quali sono state trovate certe cose» 14.
Dewey dà, qui, una lezione magistrale: lavorare a una nozione di esperienza a partire da un metodo di lavoro empirico significa considerare
l’esperienza tout court, sia dell’«arte» che è un’«esperienza» sia del
«ricercatore scientifico», il risultato di una relazione tra áisthesis ed
epistéme, il risultato, ancora, di una relazione tra spazio dell’oggetto
(dell’oggetto aisthetós, cioè “sensibile”, che è sentito dal soggetto) e
spazio del soggetto (del soggetto epistámenos, cioè “conoscitore”, che
conosce l’oggetto). Dewey sottolinea un dato essenziale, e radicale:
fare esperienza significa, comunque, sia nell’arte sia nella scienza, ma
anche nella nostra esistenza quotidiana, metterci in relazione con l’áisthesis – fare esperienza significa, comunque, fare esperienza “estetica”,
perché il metodo di lavoro empirico, che è il metodo di lavoro scelto,
fonda l’epistéme lato sensu, che comincia dalla conoscenza che dirige
la nostra esistenza quotidiana e arriva sia all’arte sia alla scienza, sulla
sensibilità, sullo spazio dell’oggetto sensibile considerato in relazione
allo spazio del soggetto conoscitore.
Ma, ancora, relazione non significa solo unione data già – relazione
significa anche unione da dare ancora, unione che conserva, comunque, la diversità dei due spazi in relazione, unione che non arriva alla
fusione e, insieme con la fusione, al potere che il soggetto ha di fare
l’oggetto attraverso la sua rappresentazione.
Dewey è diviso, qui, dalla tradizione dell’empirismo europeo, cioè
dall’empirismo che non è contaminato dal pragmatismo. La diatriba tra
Dewey e Reichenbach, unita alle osservazioni di Russell, è istruttiva. Sia
Reichenbach sia Russell partecipano allo studio The philosophy of John
Dewey curato da Schilpp, pubblicato nel 1951, cioè prima della morte
di Dewey. Reichenbach scrive Dewey’s theory of science e Russell scrive
Dewey’s new logic 15. Ed entrambi ragionano sul cardine della nozione
di esperienza, et ergo della nozione di esperienza estetica, di Dewey,
che è il suo empirismo pragmatistico. Reichenbach esemplifica attraverso un caso quasi classico: «Il pescatore che fa andare il suo remo
in acqua e vede il remo storto […] dice che questa è solo apparenza
e che in verità il suo remo non è storto» 16. Secondo Reichenbach
l’osservazione del pescatore è corretta: il remo in acqua è visto storto,
ma non è storto. Il remo, sia fuori dall’acqua sia in acqua, è, sic et
simpliciter, dritto. Reichenbach argomenta: «Lo “sbaglio” dell’occhio
38
nel caso del remo messo in acqua è causato dal fatto che non ha la capacità di correggere l’oggetto visto in riferimento alle condizioni fisiche
straordinarie nelle quali l’oggetto è presentato» 17. E sceglie un lessico
filosofico sintomatico: il remo dritto è «oggettivo» e il remo storto è
«soggettivo» 18. Secondo Dewey, al contrario, il remo dritto è «reale»
e il remo storto è, ancora, «reale» 19. E cioè: il remo storto non è «reale» secondo Reichenbach ed è «reale» secondo Dewey. Reichenbach
crede che la scelta lessicale, e filosofica, di Dewey sia generata dalla
paura che la scelta alternativa, che è quella dell’empirista logico, porti
a una nozione analoga a quella di «“cose in sé” elaborata da Kant» 20,
che, secondo il pragmatista, ha in sé il pericolo di dividere, ancora, lo
spazio dell’oggetto dallo spazio del soggetto, perché sottintende la divisione tra la cosa «oggettiva», cioè non sottoposta alla, e non data dalla,
rappresentazione del soggetto, e la cosa «soggettiva», cioè sottoposta
alla, e data dalla, rappresentazione del soggetto. Secondo Dewey, al
contrario, c’è uno spazio, non due, perché lo spazio che c’è è lo spazio
dell’unione, già data, tra «ciò che gli uomini fanno e soffrono, ciò che
ricercano, amano, credono e sopportano» (lo spazio dell’oggetto) e «il
modo in cui gli uomini agiscono e subiscono l’azione esterna, i modi
in cui essi operano e soffrono, desiderano e godono, vedono, credono,
immaginano, cioè i processi dell’esperire» 21 (lo spazio del soggetto).
Dewey ha paura che la divisione tra il remo «oggettivo» (dritto) e il
remo «soggettivo» (storto) significhi anche quella divisione tra l’oggetto
e il soggetto che introduce, anche, una metafisica sui generis, che separa gli individui dalle cose, perché toglie agli individui la possibilità di
arrivare alla verità delle cose, chiusa in uno spazio di «oggettiv[ità]»
diviso dagli individui, diviso, cioè, da uno spazio di «soggettività» che
chiude gli individui dentro le sue pareti e non lascia possibilità di uscita. Ma Reichenbach risponde che le «cose oggettive» degli empiristi
logici «non sono una specie di “noumeno”», perché secondo gli empiristi logici «le cose non osservabili» non sono «non conoscibili» 22, ma
sono, sic et simpliciter, non conosciute hic et nunc, cioè non conosciute
ancora, ma «conoscibili», perché è sbagliato non considerare possibile
la variazione futura dei limiti della condizione presente, e dei suoi
risultati. Secondo Reichenbach «il lessico del pragmatista, che chiama
reali le cose soggettive», non è corretto ed è, comunque, meno corretto
del lessico dell’empirista logico, che dice che «le cose soggettive non
sono reali» 23.
Il cardine della diatriba sta qui: Reichenbach divide il remo «oggettivo» dal remo «soggettivo» perché non crede che la divisione tolga
al soggetto la possibilità di unione con l’oggetto, e con la sua verità,
attraverso la rappresentazione. Se sono su una barca e vedo il remo
in acqua storto credo che la rappresentazione che dice che il remo
è storto sia falsa perché credo di avere a disposizione altri strumenti
attraverso i quali rappresentare la verità del remo, che è dritto fuori
39
dall’acqua ed è dritto in acqua, e attraverso i quali arrivare, in ultimo,
all’unione con l’oggetto, e con la sua verità. Viceversa, Dewey non
divide il remo «oggettivo» dal remo «soggettivo» perché crede che la
divisione tolga al soggetto la possibilità di unione con l’oggetto, e con
la sua verità, attraverso la rappresentazione. Se sono su una barca e
vedo il remo in acqua storto credo che la rappresentazione che dice
che il remo è storto sia vera perché credo di non avere a disposizione
altri strumenti attraverso i quali rappresentare la verità del remo, che
è dritto fuori dall’acqua ed è storto in acqua, e attraverso i quali arrivare, in ultimo, all’unione con l’oggetto, e con la sua verità. Il cardine
del pragmatismo di Dewey sta qui: non ho la possibilità di affermare
che, se ho due rappresentazioni diverse di un oggetto (il remo è dritto
e il remo è storto), la prima è vera comunque, cioè è vera anche al
variare delle condizioni pragmatiche di visione, e di uso, dell’oggetto.
Ho due uscite possibili da qui: la prima è dire che non ho condizioni
di affermazione della verità dell’oggetto «reale», perché, se il remo
è dritto fuori dall’acqua ed è storto in acqua, allora il remo «reale»,
che è un oggetto diverso al variare delle sue condizioni pragmatiche
di visione, e di uso, non c’è e, se c’è, se non posso sapere a quale
condizione pragmatica di visione, e di uso, corrisponde, allora non ho
la possibilità di dire che cosa è. La seconda è dire che ho condizioni
di affermazione della verità dell’oggetto «reale», perché, se il remo è
dritto fuori dall’acqua ed è storto in acqua, allora il remo «reale», che
è un oggetto diverso al variare delle sue condizioni pragmatiche di visione, e di uso, c’è, perché è il remo dritto se il remo è fuori dall’acqua
ed è il remo storto se il remo è in acqua e, se posso sapere a quale
condizione pragmatica di visione, e di uso, corrisponde, allora ho la
possibilità di dire che cosa è. Dewey sceglie la seconda uscita, perché
salva la possibilità di verità, cioè di unione tra lo spazio «oggettivo» e
lo spazio «soggettivo», attraverso il superamento della divisione tra che
cosa l’oggetto è (il remo è dritto), che è quello che non varia al variare
delle sue condizioni di visione e di uso, e che cosa l’oggetto non è (il
remo è storto), che è quello che varia al variare delle sue condizioni
di visione e di uso – Dewey salva la possibilità di unione tra lo spazio
«oggettivo» e lo spazio «soggettivo» attraverso l’unione data già, e non
da dare ancora, tra che cosa l’oggetto è e che cosa l’oggetto sembra
essere al variare delle sue condizioni di visione e di uso. Il remo di
Dewey è che cosa il remo sembra essere al variare delle sue condizioni
di visione e di uso.
Il pragmatismo di Dewey sceglie, qui, una soluzione alternativa
alla tradizione dell’empirismo classico, che divide le qualità secondarie
dalle qualità primarie. Reichenbach avverte: «lo scienziato mostra che i
colori in generale sono i prodotti degli organi umani di percezione [e
che] l’occhio di un uomo normale ha una possibilità di percezione assai limitata, che siamo ciechi di fronte ai colori, anche ciechi tout court,
40
in riferimento alle onde elettriche al di fuori da una sezione ridotta di
lunghezze d’onda. Anche il dibattito filosofico ha fatto riferimento a
questo dato: se i nostri occhi potessero percepire i raggi ultravioletti e
i raggi infrarossi il mondo avrebbe più colori e sembrerebbe diverso
da quello che sembra adesso. Se i nostri occhi potessero percepire i
raggi cosmici, il cielo di notte sarebbe luminoso e avrebbe una zona
di luminosità massima in prossimità della galassia, eccetera. Credo che
il fisico sia abbastanza ragionevole quando nega un lessico nel quale
queste variazioni sarebbero chiamate variazioni del mondo oggettivo o
reale» 24. Il colore, che l’empirismo britannico del Seicento e del Settecento, ma anche l’empirismo logico di Reichenbach, identifica con una
qualità secondaria, è secondo il pragmatismo di Dewey quasi una qualità primaria, cioè segue il funzionamento di una qualità primaria. Se A
vede X di colore azzurro e B vede X di colore blu, allora X azzurro è
«reale» e X blu è, ancora, «reale», perché la «real[tà]» è l’oggetto del
quale gli individui, che sono sia A sia B, fanno esperienza. X non ha
un colore diviso, cioè autonomo, dal colore che A e B vedono – ancora, l’oggetto non ha uno spazio di esistenza diviso, cioè autonomo,
dallo spazio di esistenza che i soggetti vedono. Il remo non ha uno
statuto ontologico diviso, cioè autonomo, dallo statuto ontologico che i
pescatori vedono. Il colore, che secondo l’empirismo classico è la qualità secondaria par excellence, è secondo il pragmatismo di Dewey la
«real[tà]» dell’oggetto, non la qualità secondaria, cioè «soggettiv[a]»,
che segna la riga di separazione tra che cosa un oggetto è (il remo è
dritto) e che cosa un oggetto sembra essere (il remo è storto, ma anche
X è azzurro e X è blu). La tradizione dell’empirismo che Dewey non
segue afferma: ci sono qualità «oggettiv[e]» (primarie), che possiamo
determinare, perché non variano al variare della «soggettiv[ità]», cioè
non variano se passiamo dal soggetto A al soggetto B, e ci sono qualità «soggettiv[e]» (secondarie), che non possiamo determinare, perché
variano al variare della «soggettiv[ità]», cioè variano se passiamo dal
soggetto A al soggetto B. Dewey sembra credere che la posizione empiristica classica significhi la perdita di una condizione importante, e
di un suo corollario altrettanto importante: le qualità «soggettiv[e]»
(secondarie) caratterizzano una porzione estesissima delle nostre esperienze et ergo se affermiamo che sono date da uno spazio «soggettivo»
separato da uno spazio «oggettivo» affermiamo anche che una porzione estesissima delle nostre esperienze sottintende la divisione, e non
l’unione, tra noi e gli oggetti, cioè affermiamo che quando facciamo
esperienza di un oggetto succede, in casi numerosissimi, che facciamo
esperienza della sua rappresentazione «soggettiv[a]» e che perdiamo,
allora, sia la possibilità di presa sugli oggetti sia la possibilità di presa
sulla loro verità.
La perdita importante della quale Dewey sembra avere paura è
visibile qui: se dico che il colore dell’oggetto che vedo non è «reale»,
41
perché è «soggettivo» e non «oggettivo», dico anche che una porzione
estesissima delle mie esperienze non è «reale», dico anche, cioè, che
una porzione estesissima delle mie esperienze non è una presa sugli
oggetti che vedo, e sulla loro verità – se dico che il colore dell’oggetto che vedo non è «reale» dico anche, soprattutto, che una porzione
estesissima delle mie esperienze estetiche non è «reale». Il cardine della
paura che Dewey sembra avere è l’esperienza estetica, perché i casi,
numerosissimi, di esperienze che l’empirista classico chiama secondarie sono i casi di quelle esperienze “estetiche”, cioè “sensibili”, che
registrano non i dati misurati attraverso criteri che non variano, ma i
dati misurati attraverso criteri che variano – e i dati misurati attraverso
criteri che variano sono numerosissimi. L’empirismo pragmatistico di
Dewey sembra corrispondere, allora, alla volontà di salvare la presa
diretta sugli oggetti, e sulla loro verità, esercitata attraverso l’esperienza
estetica tout court, esercitata, cioè, attraverso la totalità delle nostre
esperienze estetiche, sia misurate (e misurabili) sia non misurate (e
non misurabili).
Quando Dewey passa dall’analisi dell’esperienza estetica lato sensu,
che è quella che fonda la gnoseologia (Esperienza e natura), all’analisi dell’esperienza estetica stricto sensu, che è quella che fonda l’arte
(Arte come esperienza), quando, cioè, passa dal dominio delle qualità
primarie (anche “estetiche”, cioè “sensibili”) al dominio delle qualità
secondarie (soprattutto “estetiche”, cioè “sensibili”), argomenta ancora
la necessità di considerare già uniti lo spazio delle qualità, sia primarie
sia secondarie, degli oggetti e lo spazio delle loro rappresentazioni
«soggettiv[e]»: «L’esperienza è il risultato, il segno e la ricompensa di
quella interazione tra organismo e ambiente che, quando raggiunge
la pienezza, si trasforma in partecipazione e comunicazione. […] Le
opposizioni tra mente e corpo, anima e materia, spirito e carne, hanno tutte origine fondamentalmente nella paura di ciò che la vita può
produrre. Sono segni di contrazione e arretramento. Quindi il pieno
riconoscimento della continuità di organi, bisogni e istinti di base tra
la creatura umana e i suoi antenati animali non implica una necessaria
riduzione dell’uomo al livello delle bestie. Al contrario, permette di
descrivere il livello elementare dell’esperienza umana su cui si erge la
sovrastruttura dell’esperienza mirabile che contraddistingue l’uomo.
Ciò che è peculiare per l’uomo gli permette di scendere al di sotto
del livello delle bestie. Al tempo stesso gli permette di portare a nuovi e inediti vertici quella unità di senso e istinto, di cervello, occhio
e orecchio, che trova esempio nella vita animale, impregnandola dei
significati consapevoli che derivano dalla comunicazione e dall’espressione intenzionale» 25. Secondo Dewey l’esperienza è il «risultato» dell’«interazione» già data tra «organismo» (soggetto) e «ambiente» (oggetto), e non, viceversa, la sua condicio sine qua non. Fare esperienza
non significa, qui, mettere in atto, ma sottintendere, la relazione tra
42
«soggettiv[ità]» e «oggettiv[ità]» – fare esperienza significa, qui, che
le risposte date dalla mia esperienza sono, comunque, «reali», perché
sono il «risultato» di una relazione di verità che è già sottintesa, non
la condicio di una relazione di verità che è ancora da mettere in atto.
Scegliere di sperimentare la soluzione dell’empirismo classico, e
dell’empirismo logico, versus il pragmatismo di Dewey non costringe a
negare l’esistenza di una relazione radicale, quasi genetica, tra lo spazio
dell’«oggettiv[ità]» e lo spazio della «soggettiv[ità]». Ma costringe a
negare una conseguenza cruciale della radicalità quasi genetica della
relazione tra l’oggetto analizzato e il soggetto analizzante, cioè a negare
che il primo e il secondo sono tanto integrati da essere quasi fusi in
uno spazio unico, e omogeneo – scegliere di sperimentare la soluzione dell’empirismo non pragmatistico significa affermare che l’oggetto
analizzato e il soggetto analizzante, anche se registrano una relazione
radicale, non sono tanto integrati da determinare, in ultimo, una verità
dell’esperienza estetica quasi necessaria, quasi al di là dalla possibilità
di errore, il quale è essenziale da conservare se il progetto filosofico,
che sembra essere sia dell’empirismo classico, e dell’empirismo logico,
sia del pragmatismo di Dewey, è fondare una nozione di verità non
necessaria, ma che ha una possibilità di variazione.
Secondo Dewey esperienza estetica significa esperienza par excellence, regolata da un meccanismo specifico. Dewey esemplifica attraverso
l’immagine di una pietra: «si può immaginare una pietra che faccia
un’esperienza rotolando giù da una collina. […] La pietra parte da
qualche luogo e, a seconda di ciò che permettono le condizioni, si
muove verso un posto e uno stato in cui sarà in quiete – verso una
fine. A questi fatti esterni aggiungiamo con l’immaginazione l’ipotesi
che essa pensi al futuro desiderando l’esito finale; che si interessi delle
cose che incontra sul suo cammino – condizioni che accelerano e ritardano il suo movimento a seconda del loro nesso con la fine; che le
sue azioni e i suoi sentimenti nei loro confronti dipendano dalla loro
funzione di ostacolo o di aiuto che attribuisce a loro; e che alla fine
il giungere a riposo stia in relazione con tutto quello che è successo
prima come culmine di un movimento continuo. In tal caso la pietra
farebbe un’esperienza, anzi un’esperienza dotata di qualità estetica» 26.
La nozione di esperienza di Dewey indica una «stori[a]» 27, non una
serie di dati. Dewey contraddice la posizione di Locke e di Hume, che
anche Reichenbach, insieme con gli altri empiristi logici, conserva: «Il
pensiero avanza per successioni di idee, ma le idee formano una successione solo perché sono molto più di ciò che la psicologia analitica
chiama idee. Sono fasi, distinte emotivamente e praticamente, di una
qualità sottostante in sviluppo; ne sono le variazioni dinamiche, non
separate e indipendenti come le cosiddette idee e impressioni di Locke
e di Hume, essendo invece sfumature sottili di una tinta pervasiva
e in divenire» 28. Dewey specifica con una perspicuità ulteriore che
43
«facciamo una esperienza quando il materiale esperito porta a compimento il proprio percorso. Allora e soltanto allora esso è integrato e
delimitato da altre esperienze entro il flusso generale dell’esperienza.
Un lavoro è compiuto in modo soddisfacente; un problema trova la
sua soluzione; un gioco è portato a termine […]. Un’esperienza del
genere è un intero, e reca con sé la propria qualità individualizzante e la propria autosufficienza. È una esperienza. I filosofi, anche gli
empiristi, hanno parlato prevalentemente di esperienza in generale. Il
linguaggio parlato, invece, fa riferimento a esperienze che sono una ad
una singolari, dotate ciascuna di un proprio inizio e di una propria
fine. Infatti la vita non è un corso o un flusso uniforme ininterrotto.
È fatta di storie, ciascuna con la sua propria trama, il proprio inizio e
il proprio movimento verso una sua conclusione, ciascuna dotata del
suo peculiare movimento ritmico; ciascuna dotata di una sua propria e
unica qualità che la pervade per intero» 29. L’esperienza di Dewey è già
un «intero», è già una «stori[a]» con una sua «trama», che comincia
da un «inizio» e arriva a una «conclusione», a un «compimento». La
pietra che rotola «desiderando l’esito finale» fa esperienza – la pietra fa
esperienza estetica, Dewey sottolinea. Le caratteristiche essenziali della
nozione di esperienza progettata da Dewey sono due: l’esperienza è
già un «intero», perché è già una «storia», e, se è un «intero», allora
è estetica.
Dewey, versus Locke, Hume e gli empiristi logici, crede che fare
esperienza non significhi dire, in ultimo, “macchia blu adesso”, ma
“sto usando una matita blu adesso”. L’esperienza di Dewey non è un
dato, ma un dato già in relazione – l’esperienza di Dewey è, ancora,
una «stori[a]». E una «stori[a]» ha una virtù probabile e un vizio
possibile. La virtù probabile, e notevolissima, della nozione di esperienza di Dewey è sottolineare che se c’è esperienza c’è relazione, c’è
un soggetto capace sia di visione sia di uso di un oggetto. E l’oggetto,
che è l’oggetto sia visto sia usato dal soggetto, non sta a una distanza
eccessiva, perché “blu” è “la matita che sto usando adesso” prima
ancora che “la macchia”. Ma la relazione tra soggetto e oggetto che la
nozione di esperienza di Dewey sottolinea è, ancora, quasi estrema. E
il vizio possibile sta qui: se è esperienza una relazione tra un soggetto e
un oggetto tanto stretta da essere una «stori[a]», se è esperienza, cioè,
quella di una pietra che rotola interessata alle «cose che incontra sul
suo cammino», «pens[ando] al futuro» e «desiderando l’esito finale»,
allora la verità dei dati dell’esperienza è quasi già dentro l’esperienza,
è quasi già necessaria, perché è quasi la condicio di un’esperienza che
è già una «stori[a]». Se sono di fronte a una “macchia blu adesso”,
che sta in relazione con il mio esercizio di visione ma che conserva, comunque, una distanza sufficiente dal mio esercizio di visione, il
rapporto, che non è quasi già necessario, tra questo dato e altri dati
attorno ha una probabilità più alta di variare, cioè di essere corretto
44
dopo l’individuazione di un errore nei risultati della prima esperienza
della “macchia blu adesso”. Ma se “sto usando una matita blu adesso”,
che sta in relazione con il mio esercizio di visione e anche con il mio
esercizio di uso e che non conserva, allora, una distanza sufficiente
dai miei esercizi di visione e di uso, il rapporto, che è quasi già necessario, tra questi dati ha una probabilità più bassa di variare, cioè
di essere corretto dopo l’individuazione di un errore nei risultati della
prima esperienza dell’“uso di una matita blu adesso”. L’esperienza di
un oggetto che è già un «intero» ha una verità che è quasi già dentro
la «storia», che non ha quasi, allora, possibilità di un errore autentico.
Il remo oggetto dell’esperienza di Dewey è, ancora, «reale» sia se è
visto e usato dritto sia se è visto e usato storto. Se l’esperienza è una
«stori[a]» già data, allora ha una verità già articolata tra i suoi dati
– se l’esperienza è un «intero» già dato, allora è un «intero» già vero,
perché è un «intero» costruito già, non da costruire ancora.
E l’esperienza estetica, che secondo Dewey è l’esperienza al suo
grado più alto, è quasi il simbolo di questa «inter[ezza]», che già c’è
perché è radicale, quasi genetica: «l’estetico […] è lo sviluppo chiarificato e intensificato di tratti che appartengono a ogni esperienza normalmente compiuta» 30. «La ricerca filosofica o scientifica più elaborata
e l’iniziativa industriale o politica più ambiziosa, nel momento in cui i
loro ingredienti differenti costituiscono un’esperienza completa, hanno
qualità estetica. Infatti in tal caso le loro parti diverse sono collegate
tra loro e non si susseguono meramente l’una all’altra. E le parti, grazie al loro legame di cui si fa esperienza, si muovono verso un perfezionamento e una conclusione, e non solamente verso una cessazione
temporale» 31. In particolare: «L’esistenza dell’arte è la prova concreta
di ciò che si è […] affermato in maniera astratta. […] L’arte è la prova
vivente e concreta che l’uomo è capace di restaurare consapevolmente,
e dunque a livello intenzionale, l’unione di senso, bisogno, istinto e
azione che è caratteristica della creatura vivente» 32. L’esperienza estetica, se è arte, è quasi il simbolo, potentissimo, di quella «unione» tra lo
spazio dell’oggetto e lo spazio del soggetto che significa, soprattutto, la
possibilità del soggetto di conoscere l’oggetto. L’arte, che è esperienza,
è, allora, conoscenza, perché l’esperienza significa nel suo grado più
alto, che è il suo grado artistico, quella «unione» tra oggetto e soggetto
che è quasi già vera, perché è quasi già data.
La nozione di esperienza estetica di Dewey, allora, che arriva al
vertice dello statuto artistico, salva uno spazio essenziale, che è quello
della funzione gnoseologica lato sensu che l’arte ha il potere di esercitare. Ma toglie anche, qui, quella divisione tra oggetto e soggetto che
ci dà una probabilità più alta che quando conosciamo, cioè quando
proviamo a dire la verità, non diciamo una verità assoluta, vera comunque (il remo è dritto e il remo è, anche, storto), perché fare uso
di un metodo di lavoro empirico non significa che siamo uniti agli
45
oggetti attraverso un’esperienza già vera, cioè vera comunque – fare
uso di un metodo di lavoro empirico significa che siamo uniti agli
oggetti attraverso un’esperienza che non è ancora vera, cioè non vera
comunque (il remo è dritto et ergo non è, anche, storto).
L’empirismo pragmatistico di Dewey salva due cose essenziali, da
continuare a conservare: la messa in relazione di áisthesis ed epistéme,
che fonda, anche, un metodo di lavoro empirico chiaro, quasi etico,
cioè attento a «mette[re] di fronte» ad altri «il corso dettagliato dei
[suoi] tentativi, delle [sue] operazioni e de[i suoi] arrivi, in conseguenza
dei quali sono state trovate certe cose» e il potere veritativo lato sensu
dell’arte. Ma la strategia attraverso la quale Dewey arriva sia alla relazione tra áisthesis ed epistéme sia al potere veritativo lato sensu dell’arte
sceglie una via, non necessaria, che ha un pericolo in sé, perché quasi
incastra già la verità nell’esperienza, che al suo grado più alto è arte,
quasi incastra già, cioè, lo spazio del soggetto nello spazio dell’oggetto.
E ha una possibilità più alta, allora, di arrivare a una nozione di esperienza estetica quasi assoluta, cioè quasi vera comunque.
J. Dewey, Esperienza e natura, a cura di P. Bairati, Mursia, Milano 1973, p. 33.
Ivi, p. 45.
3 Ivi, p. 24.
4 Ivi, p. 45.
5 Ivi, p. 24.
6 Ivi, p. 27.
7 Ibidem.
8 Ivi, pp. 26-27.
9
Ivi, p. 27.
10
Ibidem.
11
D. Hume, Lo scettico, in Id., Opere, a cura di E. Lecaldano ed E. Mistretta, tr.
it. di G. Preti, Laterza, Bari, 1971, pp. 567-89, qui p. 572.
12
Ibidem.
13
D. Davidson, Sull’idea stessa di schema concettuale, in Id., Verità e interpretazione,
a cura di E. Picardi, tr. it. di R. Brigati, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 263-82, qui p.
271.
14
J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 41.
15
B. Russell, Dewey’s new logic, in P.A. Schilpp, ed. by, The philosophy of John
Dewey, Tudor Publishing Company, New York 1951, pp. 135-56. La critica di Russell
è severa: «La posizione pragmatistica […] è un prodotto di un scetticismo limitato
integrato da un dogmatismo sorprendente» (ivi, p. 154).
16
H. Reichenbach, Dewey’s theory of science, in P.A. Schilpp, ed. by, cit., pp. 15792, qui p. 169.
17
Ivi, p. 171.
18
Ivi, p. 169.
19
Ibidem.
20 Ibidem.
21 J. Dewey, Esperienza e natura, cit., p. 26.
22 H. Reichenbach, cit., p. 173.
23 Ivi, p. 172.
1
2
46
Ivi, p. 178.
J. Dewey, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo
2007, p. 49.
26
Ivi, pp. 64-65.
27
Ivi, p. 61.
28
Ivi, p. 63.
29
Ivi, p. 61.
30
Ivi, p. 70.
31
Ivi, p. 78.
32
Ivi, p. 51.
24
25
47
Art as Experience e l’arte contemporanea
di Marco Senaldi
A lungo trascurato, Art as Experience va senz’altro ricollocato nella
giusta prospettiva insieme storica e teorica. Qui proveremo a ricostruire
una vicenda – quella della ricezione e delle appropriazioni dell’estetica
di Dewey da parte di alcune correnti artistiche americane (e conseguentemente di grande importanza per i destini dell’arte contemporanea in
genere) – e al contempo tenteremo di verificare l’ipotesi se questo testo
abbia ancora qualcosa da offrire alle attuali teorie estetiche.
1. Bauhaus, Albers, Dewey
Per cominciare, facciamo un passo indietro al Bauhaus (la celebre
scuola d’arte fondata nel 1919 da Gropius a Weimar; trasferita poi a
Dessau dal ’26, infine a Berlino dal ’32 al ’33, anno della chiusura) 1.
Il grande artista Josef Albers (1888-1976), che aveva studiato al
Bauhaus di Weimar fin dal 1920, era entrato a far parte stabilmente
del corpo accademico (insieme alla moglie Anni) nel 1925, e vi aveva
applicato innovative teorie pedagogiche 2. Albers era convinto che si
imparasse come risultato di una diretta interazione con la vita, e richiedeva che i suoi studenti avessero familiarità con la natura fisica del
mondo materiale. Ciò era dovuto in parte all’influenza di Dewey, che
aveva difeso un’educazione basata sull’attività di laboratorio e aveva
coniato lo slogan «learning by doing». Per Dewey, «le condizioni della
vita quotidiana» determinavano la “natura dell’esperienza” e così, l’arte
(l’esperienza estetica) significava essere attivamente impegnati. Come per
Dewey, la pedagogia di Albers poggiava su esercizi concreti e pratici:
secondo le sue stesse parole significava «learning through conscious
practice» 3.
Ma ciò che spinge a considerare più da vicino la figura di Albers è
il fatto che un anno dopo la pubblicazione di Art as Experience (1934),
egli redige il suo primo articolo in lingua inglese sulla rivista Progressive
education che porta esattamente lo stesso titolo: “Art as Experience”.
Il motivo che spinge Albers a scrivere l’articolo è la sua partecipazione
al famoso Black Mountain College, ad Asheville, nel North Carolina,
dove si era trasferito nel 1933.
Nel suo articolo Albers combina la fraseologia di Dewey con l’ideologia Bauhaus, cercando di dimostrare come l’arte non può essere più
49
rimossa dalla vita quotidiana. «L’arte non è un fenomeno che può essere considerato con distacco storico. È un fatto che non può, nei suoi
fini e nella sua esecuzione, essere rimosso dalla vita» (Buettner 1981,
p. 129). Idea che ricorda l’attacco di Dewey contro la segregazione
dell’arte nei musei: «I nostri musei e le nostre gallerie d’arte d’oggi,
in cui sono relegate e depositate opere d’arte bella, rendono evidenti
alcune cause che hanno fatto sì che l’arte venisse segregata» (Dewey
1934, p. 35).
Inoltre, sulla scorta della pedagogia deweyana, Albers sottolinea
come esperienza estetica e insegnamento (come esperienza pratica)
sono due lati inscindibili della crescita individuale (cfr. Kelly, 2000):
«Le regole sono il risultato dell’esperienza e vengono dopo, e scoprire
le regole è più vitale che non applicarle» (Albers, 1935, p. 391). In una
intervista più tarda Albers affermerà: «l’esempio, l’influenza indiretta
e implicita, sono il più forte strumento di educazione» (Albers 1969,
cit. in Adler 2004).
Stewart Buettner, che ha analizzato dettagliatamente l’influsso delle
idee estetiche di Dewey sull’arte americana del secondo dopoguerra
tramite le figure degli artisti europei emigrati negli USA, sottolinea
come il legame educazione-arte fosse per Albers il modo per connettere esperienza estetica e vita vissuta. «In quanto disciplina educativa,
l’istruzione artistica deve smettere di essere considerata una attività
di aula, dedicata a scopi che sarebbero per natura meramente decorativi. In istituti d’arte come il Bauhaus e il Black Mountain College
l’arte doveva rappresentare un ruolo di primo piano nelle vite degli
studenti. “Real art – scrive Albers – “is essential to life”» (Buettner
1981, p. 129).
Albers era stato invitato al Black Mountain College da Philip Johnson, all’epoca alle dipendenze del Moma di New York, e già suo allievo
al Bauhaus. Albers allena gli studenti a tradurre in immagini le relazioni
formali e cromatiche astratte. Li orienta anche verso materiali eterodossi
come foglie, legno, scarti, indicandone combinazioni incongrue. Inoltre
la didattica prevede laboratori di fotografia, lavorazione del legno, metallo, stampa scultura, disegni di abiti e tessitura – laboratorio questo
diretto dalla mogli, Anni – laboratori finalizzati alle necessità del college
(costruzione di mobilio, suppellettili e anche di edifici) (Zevi 2000, p.
89 ss.).
La vicinanza del suo metodo a Dewey è stringente: «il materiale
con cui viene composta un’opera d’arte appartiene al mondo comune
[...] e tuttavia il sé assimila quel materiale in modo peculiare così da
farlo riemergere [...] in una forma che costituisce un nuovo oggetto»
(Dewey 1934, p. 122); «una delle funzioni dell’arte è proprio di indebolire la soggezione moralistica che spinge la mente a rifuggire da certi
materiali [...] fino a comprendere (potenzialmente) ogni e qualsiasi
cosa» (ivi, pp. 193-94).
50
Tuttavia quella di Albers è “una” interpretazione di Dewey. Albers
cioè, a differenza di Dewey, che parla sovente di «indivisibilità dell’atto
artistico» (p. 215), di polisensorialità e di sinestesia corporea (p. 133),
si “ferma” sul “vedere”, tende a non tradurre l’esperienza visiva in
esperienza totale: «Quando ai laureati a Yale si chiedeva in che cosa
avessero ottenuto beneficio dai loro studi con Josef Albers, invariabilmente rispondevano “Albers mi ha insegnato a vedere” (“taught me to
see”)» (Kelly 2000, p. 133).
Inoltre, Albers resta convinto che il “caso” non possa entrare a far
parte dell’esperienza estetica (e le testimonianze degli anni di Yale sono
chiare in tal senso, cfr Kelly 2000). «L’enfasi di Albers sull’articolazione, il controllo, la disciplina mentale, e la precisione di esecuzione,
lo conducevano ad avere una scarsa tolleranza verso gli elementi del
caso e dell’automatismo che erano cruciali per pittori come Pollock»
(Buettner 1981, p. 131). Non che Dewey teorizzi un’apologia del caso
come tale, ma rimarca spesso come la “forma” dell’opera necessiti dello
“scompiglio” del nuovo, e di come la bellezza nasca dalla cooperazione
tra «il cambiamento che eccita e il compimento che calma» (Dewey
1934, pp. 166-67).
2. Il Black Mountain College, laboratorio deweyano
Fondato nel 1933 da transfughi del Rollins College della Florida (a
causa di divergenze sul genere di educazione da impartire ai giovani
studenti), il Black Mountain College si era qualificato da subito come
un progetto educativo all’avanguardia, dove vengono arruolati come
insegnanti numerosi artisti europei.
Il College nasce nell’epoca entusiasta del New Deal come scuola
modello di ispirazione Bauhaus; tuttavia la sua originalità irripetibile
consiste nel fatto che è un tentativo generoso di dar vita e realtà al
modello educativo delineato da Dewey in Democracy and Education
(1916). Per esempio, la gestione e l’amministrazione erano a carico del
corpo docente; ogni questione era discussa nelle assemblee studentesche; vigeva la parità tra insegnanti e studenti, ecc.
Nelle parole di John Rice, rettore del College dal ‘33 al ‘40 e fervente ammiratore di Dewey, l’educazione ivi impartita era di questo
tenore: «Al Black Mountain College l’educazione era totalizzante. Tre
pasti collettivi, il tempo trascorso negli spazi comuni, gli incontri nelle
classi e ovunque, l’istruzione impartita per strada. Era il soddisfacimento di una vecchia idea, l’educazione dell’uomo nella sua complessità»
(cit. in Zevi 2000, p. 89)
L’educazione dell’uomo nella sua complessità, l’idea che l’educazione non sia un training che conduce a uno scopo predeterminato, ma
un continuum aperto e armonioso, nel quale «processo e fine dell’educazione sono una sola e medesima cosa» (Dewey 1916) – sono temi
che tornano puntualmente nei programmi del College: «Noi stiamo
51
tentando, con crescente (ancorché, più o meno, altalenante) successo
di insegnare un metodo più che un contenuto. Il nostro sforzo è sul
processo più che sul risultato (“Our emphasis is on process as against
results”)» (Rice, 1938, cit. in Adler 2004). Nel 1940, inoltre, vengono
introdotti campi di lavoro estivi, articolati in programmi accademici
informali, condotti da ospiti di rilievo, tra cui, accanto a Gropius e
Einstein, spicca, nel 1949, lo stesso Dewey (cfr. Harris 1987).
Le estati dal 1945 al ’49 sono ricche di novità; soprattutto vi soggiornano artisti destinati a diventare famosissimi come Motherwell,
Noland e Rauschenberg e si nota l’emergere dei giovani americani. In
particolare nell’estate del ’48 soggiorna il duo John Cage – Merce Cunningham, che suscita entusiasmo con le sue azioni teatrali. Ma anche i
poeti W. Carlos Williams e Wallace Stevens teorizzano e praticano l’idea
di una poesia aperta, e della composizione come “campo” (invece che
come “opera”).
Accanto alle arti visive (insegnate, secondo lo spirito Bauhaus, insieme a quelle “applicate”) emerge l’importanza del teatro. Xanti Schwainsky, tra il ’33 e il ’39, insegna al College una forma di teatro totale (che
trae ispirazione dal suo maestro Schlemmer, pietra miliare dello spirito
Bauhaus; si tratta di “azioni” secondo taluni ante litteram, che relegano
in secondo piano la trama a vantaggio di spazio, forma, luce, tempo,
e aprono la strada all’happening di John Cage. Proprio Cage, con la
collaborazione di Merce Cunningham, mette in scena nel ’48 The rise
of Medusa, che va considerato il primo tentativo di creare un “evento”,
anche se la piéce, tratta da un poema lirico di Satie, è ancora di impianto teatrale. Cage dirà che in esso vi era «something which engages both
the eye and the ear» (cit. in Buettner 1981, p. 114), un’affermazione
che va letta in senso deweyano e in contrasto con il predominio affidato al seeing predicato da Albers; e anche che in esso vi era l’idea di
rappresentare la «vita quotidiana stessa come un teatro» (Cage 1965, in
Buettner, ivi), altra affermazione capitale che tende verso l’avvicinamento
dell’esperienza quotidiana all’esperienza artistica.
3. Espressionismo Astratto e Dewey
Vi è inoltre una seconda importante direzione di influenza del pensiero estetico di Dewey che conduce alla nascita del cosiddetto Espressionismo Astratto (Jackson Pollock, Marc Rotko, Clifford Still, Roberth
Motherwell, Arshile Gorky). In questo senso, la figura chiave è quella
di Thomas H. Benton, l’unico maestro riconosciuto di Pollock negli
anni tra il 1931 e il 1937. Pittore figurativo, affascinato dal muralismo
messicano di Rivera e Siqueros, al punto di realizzare egli stesso dei
murales, T. H. Benton era un convinto deweyano perché interessato
all’etnico (le forme di rappresentazione non occidentali), allo spazio (il
murale come forma di pittura espansa), e all’idea di comunità locale
(con riferimento alla “comunità organica” di Dewey). Anche lui, in un
52
articolo per Modern Monthly, si esprime nei termini di Art as Experi�������
ence quando afferma che «Una definizione di arte significativa deve
essere compresa in base alla definizione del genere di esperienza che
può generarla» (Benton, 1934; cit. in Buettner 1981, p. 62).
Pollock lo segue: abbandona prima le misure ristrette del quadro
per opere di grandi dimensioni (come Mural, del ’43), poi il pennello
e infine il contatto diretto (volontario) tra mano e tela, e nel 1947
“inventa” la celeberrima tecnica del dripping.
Più tardi, nel 1950, Hans Namuth fotografa e riprende Pollock al
lavoro – foto che lo consacrano quale «primo maestro americano», ma
che soprattutto evidenziano l’importanza del “processo” antecedente il
quadro come tale, e di cui quest’ultimo non è che «la morta spoglia» 4.
Pollock non è solo il “primo” artista interamente (cioè culturalmente)
americano, è anche il primo artista in cui opera d’arte come prodotto è
inscindibile dal processo e dall’esperienza da cui l’opera stessa è sorta.
Secondo la definizione di Dewey, una esperienza (in quanto opposta
alla normale esperienza) era vista come un incontro totale con i fenomeni esterni che seguiva un corso completo dall’inizio alla fine ed era
completamente integrata nella coscienza come un’entità distinta da altre
esperienze. Dato che un’esperienza era continua e potente, non ammetteva «buchi, giunzioni meccaniche e centri morti» (Dewey 1934, p. 62).
Allo stesso modo, Pollock parla della sua esperienza estetica: «Quando
sono nel mio quadro, non sono consapevole di cosa sto facendo. […]
Non ho timore di fare cambiamenti, di distruggere l’immagine, ecc.,
perché il quadro ha una sua vita propria. Tento di lasciarla venir fuori.
È solo quando perdo contatto col quadro che il risultato è un disastro»
(cit. in Buettner 1981, p. 59). Questa definizione del momento creativo come una coinvolgente esperienza di unità, con un inizio e una
fine discreti, si avvicina alla descrizione di Dewey, esprimendo gli stessi
concetti in forma non-immediata.
4. Verso il 1952
Nei primi anni ’50 le varie influenze del pensiero di Dewey tendono
a sovrapporsi. Da un lato, in un articolo per Art News del 1952, H.
Rosenberg definisce la nuova arte Action Painting – definizione che
sposta l’accento dal formalismo di Greenberg (inventore della definizione di Espressionismo Astratto), verso un’idea molto più dinamica e
processuale dell’“evento” artistico 5. In questo periodo molti artisti più
o meno legati all’Action Painting, da Rothko a Motherwell, a Paalen,
prendono come riferimento le teorie estetiche di Dewey (cfr. Berube
1988).
Dall’altro lato abbiamo la realizzazione dell’evento puro, senza più
nemmeno la “mediazione” del quadro come opera-risultato – cioè il
primo “happening”, il famoso Untitled event di Cage, Cunningham,
Rauschenberg e altri, proprio del 1952.
53
John Cage (1912-1992), già invitato come docente al Black Mountain
College nel 1948, nel 1952 organizza un evento considerato il precedente
degli happening e dei concerti Fluxus e di tutta l’arte contemporanea
performativa e ambientale/installativa: Untitled Event (chiamato anche
Theatre Piece n. 1) che includeva una performance simultanea di pianoforte, di danza improvvisata, declamazioni poetiche e una conferenza.
L’evento non accadeva su un palco ma in una stanza, in mezzo agli
spettatori, mentre Tim La Farge e Nick Cernovich proiettavano sulle
pareti film e diapositive. L’Untitled Event fu interpretato non come
una performance musicale, ma come esempio di “nuovo teatro”. Nella
stanza erano inoltre appesi i Quadri bianchi di Robert Rauschenberg.
M. Kirby in Happening (1968) ne rintraccia la matrice dadaista (con
riferimento al Teatro Merz di Schwitters; ma rispetto a Cage l’influenza
più diretta era piuttosto Marcel Duchamp) descrivendolo così: «I sedili per il pubblico, tutti volti verso il centro, erano stati sistemati nel
mezzo del refettorio del collegio in modo da lasciare un passaggio tra
la “platea” e le pareti. Calcolate al secondo come in una composizione
musicale, le varie azioni si svolgevano tra e intorno agli spettatori. Cage,
con abito e cravatta neri, lesse una conferenza su Meister Eckhart da
un leggio collocato in un lato della camera [...] Mary Caroline Richard
(che aveva tradotto per l’America Il teatro e il suo doppio di Antonin
Artaud) declamò solennemente dei versi da una scala a pioli. Charles
Olson e altri attori “nascosti” tra il pubblico si alzarono a turno in piedi
e recitarono poche battute. David Tudor suonò il piano. Sul soffitto
vennero proiettate immagini cinematografiche: all’inizio si vide il cuoco
della scuola, poi il sole che tramontò quando l’immagine si mosse dal
soffitto al muro. Mentre Robert Rauschenberg metteva vecchi dischi
su un fonografo portatile, Merce Cunningham improvvisò una danza
intorno al pubblico. Un cane prese a seguirlo e fu accettato nella rappresentazione (cit. in Balzola-Monteverdi 2004, pp. 457-58).
La componente teatrale era molto forte, ma le differenze rispetto a
una tradizionale rappresentazione teatrale erano evidenti: non esisteva
una differenza netta tra palco e platea, il pubblico poteva prendere
parte all’azione, non era prevista una regia degli eventi e le varie azioni
artistiche, oltre ad avere luogo simultaneamente, mescolavano, come si
è visto, arti diverse, dalla pittura, alla musica, alla danza.
L’importanza di questo primo happening per una nuova concezione
delle arti risiede quindi in diversi fattori. Innanzitutto, di nuovo esso
sembra tentare l’antica utopia wagneriana della Gesamtkunstwerk, cioè
di un’opera d’arte in grado di unire in un tutto sinestetico musica,
parola, rappresentazione e immagini. D’altra parte, però, invece di
condurre ad uno spettacolo unitario, delimitato da una forma chiusa
e del quale si può essere solo spettatori passivi, il primo happening
include elementi accidentali (vedi l’esempio del cane) e tende a coinvolgere gli spettatori nell’azione. In questo modo i limiti formali sono
54
resi estremamente labili, sia perché l’unica regola dell’azione erano i
segnali di inizio e di fine, e inoltre perché ogni volta che, anche in
seguito, un happening verrà realizzato, esso costituirà un evento unico
e irripetibile, diversamente da quanto accade nella rappresentazione
teatrale classica (che comunque resta legata a limiti formali definiti a
priori, quali un testo, una regia, una messa in scena, ecc.).
L’influenza di questa inedita forma espressiva sulla musica, le arti e
il teatro è stata enorme perché ha cambiato la forma dell’opera, il ruolo dell’artista e quello dello spettatore. L’essenza dell’opera non è più
legata necessariamente ad artefatti materiali, ma può essere costituita
anche da gesti, eventi, azioni; non è più solo un prodotto, ma è anche
un processo. La volontà artistica dell’autore è messa radicalmente in
crisi, sia dal fatto che gli autori sono più di uno, sia dal fatto che elementi casuali e accidentali devono essere considerati non come errori
da eliminare, ma come parti integranti del “lavoro”. Infine, il pubblico
stesso diventa co-autore – quindi, secondo l’intuizione che fu già di
Duchamp, l’opera d’arte stessa non potrebbe nemmeno esistere senza
la presenza e la partecipazione attiva del pubblico. Da ultimo, ogni
volta che un happening, cioè un evento-accadimento, viene “riprodotto”
esso ha luogo nella concreta attualità del momento in cui accade.
Il più famoso prosecutore degli happening, cioè Allan Kaprow,
riconoscerà, alla fine degli anni ’50, proprio in Pollock e Cage i suoi
due maestri. Lo stesso artista in una intervista racconta di essere stato
colpito particolarmente dal pragmatismo contestualista di John Dewey
– che sottolineava la fluidità del significato, rapportandolo al contesto
in cui una azione viene compiuta – e dal suo Arte come esperienza, che
legava strettamente l’arte alle altre esperienze umane, e in definitiva
alla vita quotidiana.
5. Dewey e l’arte contemporanea
Ora, secondo Dewey non esistono oggetti d’arte, in quanto tali, staccati dall’esperienza che ne fa l’uomo; se noi li vediamo così è a causa
delle istituzioni museali, che a loro volta riflettono condizioni sociali
ed economiche di antagonismo e separazione. Ne segue così che oggi
le opere d’arte siano esperite come un alcunché di separato dalla vita
comune, oggetti di collezionismo o direttamente prodotti nati per il
mercato – oggetti «feticizzati» (Shusterman 1997, p. 33). Occorre riscoprire la continuità fra l’esperienza estetica e il normale processo di
vita; occorre ritornare a focalizzarsi sul processo più che sul prodotto
e sul godimento (enjoyment) della sua percezione. Occorre insomma
che l’arte ritorni alla sua radice estetica in senso proprio che è quella esperienziale: ossia che l’arte ritorni ad essere esperienza nel senso
pieno del termine, in quanto azione determinata dalle condizioni di
vita che il soggetto sperimenta interagendo coll’ambiente. È sintomatico
che Dewey citi fra le esperienze del vivente fatti come il respirare, il
55
deambulare, il prendere interesse alla cura del giardino: esperienze che
senz’altro qualifica come estetiche, ponendo in tal modo per la prima
volta il problema della «continuità dell’esperienza estetica con i processi
normali di vita» (Dewey 1934, p. 37). L’arte è considerata separata dalla
vita solo perché la vita è separata da se stessa, divisa in compartimenti
dove l’arte dovrebbe trovare il suo posto. Ma così anche l’esperienza
viene abbassata al rango di mera sensazione, perde il suo significato
profondo, che invece è quello di essere vera interazione del vivente con
l’ambiente. «Non ci sono buchi, giunzioni meccaniche o centri morti»
quando abbiamo un’esperienza; quest’ultima è una unità, dotata di una
singola qualità che la pervade tutta, a dispetto delle variazioni delle sue
parti; è un evento integrale.
Da un punto di vista teoretico, l’happening costituirebbe esattamente quella forma d’arte in grado di restituire la continuità tra arte
e esperienza quotidiana – cosa che però implica un profondo rovesciamento dialettico nella nozione stessa di “arte”. «Nell’ottica dell’arte
come esperienza di Dewey, molti esempi di forme d’arte istituzionali
non andrebbero qualificate come estetiche, qualora le loro condizioni
di esperienza non fossero soddisfatte [fulfillment]. Allo stesso modo,
molte esperienze in precedenza considerate in- o an-estetiche diventano il materiale di base per il sorgere di esperienze artistiche. Mentre
Dewey rifiutava di fare distinzioni fra l’esperienza e ciò che costituisce
l’oggetto d’arte, il prodotto dell’espressione artistica diventa una forma
di esperienza [...] L’oggetto d’arte stesso era un’esperienza, sia per
l’artista (nel crearlo) che per lo spettatore (nel percepirlo)» (Buettner,
1981, p. 59).
Questo rovesciamento tuttavia, coincide lagamente con i destini di
auto-negazione che pervadono il divenire dell’arte almeno a partire
da Hegel. La ricusazione da parte della filosofia analitica (Beardsley,
Dickie, Goodman, in parte Danto) dell’estetica deweyana, in quanto
«filosoficamente inutile» per definire la nozione di «arte» (Shusterman
1997, p. 34 ss.) è perciò essa stessa filosoficamente poco significativa,
in quanto fondata su un’idea di determinatio della categoria “arte”
che viene facilmente smentita dalla capacità di (auto)negazione propria dell’arte (contemporanea) stessa. Viceversa, la vitalità delle tesi di
Dewey è suffragata dal fatto di costituire una sorta di regesto di tutte
quelle tendenze artistiche che, dal dopoguerra in avanti, hanno fatto
dell’equazione arte=vita il loro credo fondamentale. Quando Dewey
insiste sulla necessità di esperire non solo l’oggetto ma il processo di
produzione, quando dice che anche se si tratta di un’opera visiva, la
vista non è il solo senso impiegato per produrla o per fruirla (p. 123),
non possiamo non pensare alle forme d’arte contemporanea extra-pittorica. Similmente, quando dice che «l’artista incarna in se stesso l’atteggiamento del percipiente» (p. 72), non può non ricordare Duchamp.
Quando invita a soffermarsi sulla struttura dinamica della creazione
56
che deve comprendere dei vuoti e dei silenzi («una pausa in musica
non è un vuoto, ma è un silenzio ritmico», “a pause in music is not a
blank, but is a rythmic silence”, p. 178), non può non far pensare a
4’33”, il pezzo di Cage sempre del 1952, in cui la sola indicazione per
l’orchestra è «tacet» 6. E ancora, quando parla dello spazio come di una
“scena” e del tempo non come una dimensione uniforme, ma come un
flusso di impulsi ritmici – per esempio come quando un lampo illumina
la campagna e abbiamo una momentanea riconoscimento delle cose (p.
50), o quando parla di environment, o di embodiment – le sue parole
sembrano anticipare l’uso di spazio e tempo proprio dell’happening (e
forse non è un caso che negli happening di Kaprow della fine degli anni
’50 venissero usati flash e luci intermittenti), ma anche della natura nella
land art o del corpo nella body art (cfr. Jay 2002). Si potrebbe anche
parafrasare la famosa frase di Migliorini – che sosteneva la “teoreticità”
dell’arte contemporanea dicendo che «Hegel lo diceva, Duchamp lo
faceva» – ripetendo che “Dewey lo diceva, Cage lo faceva” (intendendo
lo slogan più in difesa di Dewey che di Cage) 7.
6. Conclusioni problematiche
Fino a qui sembrerebbe dunque di essere di fronte ad un autorevole anticipazione filosofica di temi ripresi dall’arte contemporanea più
avanzata (ed elitaria), se non che questo stesso fatto getta un luce assai
particolare proprio sull’assunto filosofico in questione, cioè sull’identità
fra arte e esperienza.
Per Dewey infatti, il rinnovamento dell’esperienza naturale preculturale non è fine a se stesso, ma è il mezzo per recuperare l’esperienza
culturale della «vita significativa di una comunità organica» (quella in
cui, ad esempio, aveva luogo la fruizione del Partenone da parte dei
Greci antichi, o lo svolgimento delle cerimonie rituali da parte dei
popoli primitivi): «le opere d’arte che non sono separate dalla vita
comune, che sono ampiamente fruite da una comunità, sono segni di
una vita collettiva unitaria» (p. 81 ed. or.).
Tuttavia, il ritorno all’indietro, verso le sorgenti dell’esperienza
vivente, produce un’arte che crea un clamoroso distacco dalla “vita
della comunità organica”. Il fatto che tutte le opere d’arte che abbiamo citato abbiano incontrato una forte resistenza del pubblico lascia
capire chiaramente che il ritorno all’esperienza che esse promuovevano
era percepito come traumatico – un po’ come era già accaduto oltre
mezzo secolo prima con l’impressionismo, quando i vetturini di Parigi digrignavano i denti e stringevano i pugni a causa dell’odio verso
quella pittura (Kahnweiler 1961, p. 34) – senza dubbio perché quelle
opere esprimevano un’“esperienza” che risultava estranea se non proprio minacciosa.
Il lascito dell’estetica deweyana si rivela pertanto più ambiguo di
quanto non possa apparire di primo acchito. In tempi recenti il dibatti57
to è stato riacceso dai sostenitori del “ritorno” a un’estetica pragmatista,
ben consapevoli che la rottura del legame fra esperienza comunitaria e
produzione artistica contemporanea rappresenta una minaccia verso una
compiuta crescita sociale in senso democratico. Questa tesi, sostenuta in
particolare da Shusterman in diversi saggi, è stata a sua volta criticata
da Martin Jay che, in un importante articolo (Jay 2002), ha notato che
Art as Experience può essere considerato il fondamento teorico persino
della body art più shockante, e che pure questo shock/stoss ha esso
stesso un valore di salutare scossa nei confronti del rischio di un conformismo estetico di ritorno.
Tuttavia, entrambe queste posizioni – quella per cui l’arte attuale
«brancola a tentoni e senza scopo, tagliata fuori dalle correnti del
gusto popolare di una cultura democratica» e quindi occorre tornare
all’esperienza estetica nel senso di Dewey (Shusterman), e quella per
cui l’(esperienza dell’) arte contemporanea va invece salvata, a rischio
però della disintegrazione sociale (Jay) – sembrano non tenere conto
della contraddittorietà già avvertibile in Dewey stesso quando, identificando l’esperienza autentica con l’esperienza estetica, non può evitare
di sostenere che il solo momento residuo di autentica esperienza è
l’esperienza stessa dell’arte. Infatti, per una ironica inversione dialettica, proprio l’unica esperienza possibile, quella dell’arte, è, oggi, anche
il sinonimo della separazione dall’esperienza autentica della comunità
significante (simbolica).
Dewey per primo riconosce che l’antica comunità simbolica è perduta; ed anche a lui è del tutto evidente che il neo-gotico ottocentesco ha
poco a che spartire col simbolismo medievale, o che «Thorwaldsen non
è un Fidia» (Dewey 1934, p. 152). Ma il rimedio proposto è peggiore
del male, anzi, coincide con esso: da un lato non è più possibile imitare i simboli della “vita culturale” ormai perduta, dall’altro l’equazione
arte=vita distrugge ogni possibile restaurazione della “vita naturale”, dal
momento che l’esperienza della natura è esattamente ciò che è andato
perduto nell’esperienza dell’uomo moderno, dell’uomo “innaturale”.
Così, i concetti separati di arte ed esperienza, riavvicinati l’uno all’altro,
non possono fare a meno di manifestare tutta la contraddittorietà che
ciascuno possiede non in relazione al suo opposto, ma dentro sé medesimo – fatto per cui l’“arte”, per essere se stessa, deve essere anche
il contrario di se stessa (esperienza, vita, ecc.), mentre l’esperienza, per
essere esperienza, deve anche negare la propria immediatezza (deve
essere “estetica”, ecc.) (Senaldi 2003, parte ii, cap. 1).
Il lascito di Dewey non si chiude dunque nell’ovvio richiamo ad
una “naturalizzazione” del fatto artistico, ma in un ambiguo dilemma: tramite la quotidianizzazione dell’estetica, pare aprire la porta ad
un’estetizzazione della vita quotidiana di carattere però infinitamente
(in senso hegeliano) diverso dalla (immaginaria) “vita della comunità
organica”.
58
1
Sul Bauhaus cfr. il classico Il Bauhaus, di H. M. Wingler, 1962; ed. it. Feltrinelli
1972.
2
Cfr. Adler, 2004. Albers a Dessau dirigeva l’importante corso preliminare, pedagogicamente fondativo.
3 J. Albers, “Art as Experience”, 1935. Rainer K. Wick nel suo Teaching at the
Bauhaus, 2000, ha notato che The School and Society e Democracy and Education di
Dewey furono pubblicati in traduzione tedesca nei primi due decenni del xx secolo e
che le idee di Dewey erano ben note al Bauhaus.
4 Sul rapporto Namuh-Pollock, cfr. Krauss 1990, cap. 5.
5 Più tardi lo stesso Rosenberg, 1959, dirà che con l’Action Painting il quadro
diventa «un’arena di eventi» dove la distinzione fra arte e vita tende a scomparire (cfr.
Krauss 1990, p. 88).
6 L’esempio di 4’33” è stato ampiamente discusso sia contra Dewey che in suo favore; cfr. per un utile riassunto la voce “Dewey’s Aesthetics” della Stanford Enciclopedia
of Philosophy disponibile on line.
7 Inoltre, è legittimo considerare la processualità dell’happening e dell’Action Panting come radice delle forme d’arte successive, come la process art e la performance,
e persino la body art contemporanea, come dimostrano le analisi di Krauss (2004) e
Jay (2002).
Referenze bibliografiche
Aa. Vv., 2006, “Dewey’s Aesthetics”; Stanford Enciclopedia of Philosophy, http://
plato.stanford.edu/entries/dewey-aesthetics.
Adler, Esther Dora, 2004, “A NEW UNITY!” The Art and Pedagogy of Josef Albers, Master of Arts, Thesis, Univ. of Maryland, https://drum.umd.edu/dspace/bitstream/1903/1788/1/umi-umd-1767.
Balzola, A., Monteverdi, A. M., 2004, Le arti multimediali digitali. Storia, tecniche,
linguaggi, etiche ed estetiche delle arti del nuovo millennio, Milano, Garzanti.
Berube, M., 1988, “John Dewey and the Abstract Expressionists”, Educational
Theory, 48, pp. 211-27.
Bonomo G., Furghieri G., a cura di, 1997, John Cage, RIGA, 15, num. monografico, Milano, Marcos Y Marcos
Buettner, S., 1981, American Art Theory, 1945-1970, Ann Arbor, UMI Research Press.
Cage, J., 1961, Silence, Middletown Wesleyan U. P.; tr. it. 1971, Silenzio, Milano,
Feltrinelli.
Dewey, J., 1916, Democracy and education, Macmillan, NY; trad. it. 1974, Democrazia ed educazione, La Nuova Italia, Firenze.
Id., 1934, Art as experience, Perigee Books, New York; tr. it. 2007, Arte come esperienza, Aesthetica, Palermo.
Foster, H., Krauss, R., Bois, Y.-A., Buchloh, B., 2004, Art since 1900, New York,
Thames & Hudson; trad. it 2006, a c. di E. Grazioli, Arte dal 1900, Bologna, Zanichelli.
Harris, E., 1987, The arts at Black Mountain College, MIT, Cambridge-London.
Jay, M., 2002, “Somaesthetics and Democracy: Dewey and Contemporary Body Art”,
Journal of Aesthetic Education, vol. 36, n. 4, Winter.
Kahnweiler, D.-H.., 1961, Mes galeries et mes peintres, Paris, Gallimard; trad. it.
1991, Le mie gallerie e i miei artisti, Milano, Politi.
Kaprow, A., 1971, The Education of the Un-Artist, Part I, ArtNews, feb.
Id., 1998, Allan Kaprow, Atti del Corso Superiore di Arte Visiva, Fondazione Ratti,
Como; Milano, Skira.
Kelly, Rob Roy, 2000, “Recollections of Josef Albers,” Design Issues, 16, 2, summer,
pp. 3-24.
Krauss, R., 1990, Le Photographique, Paris, Macula; trad. it. 1996, Teoria e storia
della fotografia, Milano, Bruno Mondadori.
59
Id., 2004, Re-inventare il medium, Milano, Bruno Mondadori.
Migliorini, E., 1992, La rosa di Kant, Palermo, Aesthetica.
Pontiggia, E., 1991, a c. di, Jackson Pollock. Lettere, riflessioni, testimonianze, Milano, SE.
Rosenberg, H., 1959, The Tradition of the New, New York, Horizon Press; trad. it.
1964, La tradizione del nuovo, Milano, Feltrinelli.
Shusterman, R., 1997, “The End of Aesthetic Experience”, The Journal of Aesthetics
and Art Criticism, 55, 1, pp. 29-41.
Senaldi, M., 2003, Enjoy! Il godimento estetico, Roma, Meltemi.
Sonora, 1992, num. monogr. su John Cage, S. Giovanni Valdarno, Materiali Sonori.
Wick, R. K., 2000, Teaching at the Bauhaus, Ostfildern, Hatje Cantz.
Wingler, H. M., 1962, Das Bauhaus, Verlag Gebr. Rash & Co., Bramsche; ed. it.
1972, Milano, Feltrinelli.
Zevi, A., 2000, Arte USA del Novecento, Roma, Carocci.
Id., 2005, Peripezie dell’arte nel dopoguerra italiano, Torino, Einaudi.
60
È ancora possibile un’esperienza estetica?
di Stefano Velotti
«È all’esperienza estetica [...] che deve rifarsi il filosofo per comprendere che cos’è l’esperienza» 1. L’importanza di questa affermazione
di Dewey può essere misurata se si tiene presente che “esperienza” è
probabilmente la parola chiave della sua intera riflessione filosofica,
pedagogica e politica. In Il mio credo pedagogico (1897), che anticipa molte tesi poi sviluppate nell’importante Democrazia ed educazione
(1916), si dice per esempio che uno dei punti qualificanti del programma di «educazione attiva» è che «l’educazione deve essere concepita
come una ricostruzione continua dell’esperienza; che il processo e il fine
dell’educazione sono una sola e identica cosa» 2. L’idea stessa di trasmissione della conoscenza – con cui si intende solitamente il compito
dell’istruzione e il processo cumulativo del sapere – è un’idea confusa
e forse persino contraddittoria, a meno che non venga intesa, appunto,
come un processo che passa attraverso una ricostruzione dell’esperienza:
«non è possibile trasmettere un pensiero, un’idea, come idea, da una
persona all’altra. Quando viene detta, per la persona alla quale viene
detta non è un’idea ma un altro fatto preciso»: si impara dunque solo
facendo esperienza, attraverso la sperimentazione diretta di «forme di
vita che vale la pena vivere per loro stesse» e non come «preparazione
a un vivere futuro» 3. Un’esperienza, infatti, per essere tale, non può
essere usata solo come un mezzo per un’eventuale esperienza futura, ma
deve essere un’esperienza essa stessa dotata di valore, secondo quella
inseparabilità di mezzi e fini che è un altro tratto caratteristico del pensiero di Dewey. Ancora: «tutto il pensiero è ricerca, ed ogni ricerca è
nativa, originaria, per colui che la effettua, anche se il resto del mondo
è già sicuro di quello che egli sta ancora cercando» 4. Non solo, dunque,
l’esperienza non si trasmette se non mediante un’altra esperienza, ma
persino la conoscenza in senso stretto non si trasmette se non mediante
una ricostruzione “nativa” di esperienze.
Il danno prodotto dall’illusione che la conoscenza si possa trasmettere senza esperienza non è solo individuale: in uno scritto del 1937
sulla democrazia nell’amministrazione scolastica, Dewey si interroga
anche sulle cause dell’insorgere dei totalitarismi europei: «Sono complesse le cause della distruzione della democrazia politica nei paesi nei
quali essa era stata istituita nominalmente. Ma credo che di una cosa si
61
possa essere sicuri. Dovunque è caduta, essa aveva un carattere troppo
esclusivamente politico. Non era diventata ossa e sangue del popolo
nella sua vita quotidiana» 5, non era diventata, cioè, esperienza. È facile
capire, dunque, quanta importanza assuma per Dewey la comprensione
dell’esperienza estetica, se questa fornisce il modello di ogni esperienza
possibile e, dunque, di ogni acquisizione e trasmissione di conoscenza,
di abiti, di coscienza e responsabilità etiche e politiche.
Eppure, l’idea di “esperienza estetica” è diventata sempre più sospetta e incerta: non tanto perché vale ancora, nel senso comune, la
vecchia riduzione dell’esperienza estetica a esperienze di tipo estetistico, museale, o elitario, quanto perché essa, rimandando a processi
di integrazione, di armonia, di equilibrio, sembra per ciò stesso di rimandare a qualcosa di lontano dalla condizione che da circa un secolo
a oggi riconosciamo, per lo più, come nostra.
A partire dalla prima industrializzazione, attraverso le diverse fasi
o “rivoluzioni industriali” e tecnologiche che conducono fino a noi, le
nostre forme di vita sono state descritte plausibilmente in termini di
scissione tra cultura oggettiva (quella incorporata nei prodotti dell’uomo) e cultura soggettiva (quella di ciascun individuo), dove quest’ultima non riesce più ad adeguarsi alla prima e a trasformarla in esperienza (G. Simmel); di distruzione o atrofia dell’esperienza (W. Benjamin);
di discrepanza tra la nostra capacità di produrre e la nostra capacità
di immaginare, sentire e comprendere ciò che abbiamo prodotto (G.
Anders); di divaricazione tra uno spazio dell’esperienza, sempre più
contratto, e un orizzonte d’attesa, sempre più dilatato (R. Koselleck).
A livello artistico poi – ed è nell’arte, si presume, che l’esperienza
estetica dovrebbe trovare la sua occasione esemplare – sembra che
tutto il Novecento, e ancor di più il nuovo secolo, contraddica l’idea di
un’esperienza unitaria e conclusa, quando non si oppone, addirittura,
all’idea stessa di una qualità estetica della produzione artistica; per
non dire poi delle filosofie che hanno visto nell’arte del nostro secolo
la rivelazione dell’insignificanza dell’esperienza estetica per una comprensione delle opere d’arte in generale (A. Danto e, per altri versi, G.
Dickie, e i loro rispettivi seguaci). Eppure, secondo Dewey, è proprio
nell’esperienza estetica che verrebbero «resi manifesti per loro stessi» i
«fattori che fan sì che qualcosa possa essere chiamata una esperienza»,
essendo, tali fattori, soltanto in essa «innalzati molto al di sopra della
soglia percettiva» (AE, 79).
Quali sono, dunque, i fattori che Dewey ritiene necessari affinché
si dia un’esperienza estetica? L’esperienza, infatti, per un certo verso
«accade continuamente, poiché l’interazione tra la creatura vivente e
le condizioni ambientali è implicata nello stesso processo del vivere»
(AE, 61). Ma questa sorta di esperienza, non ulteriormente qualificata,
non è necessariamente una esperienza. L’interazione tra l’essere vivente
e l’ambiente – anche quando è caratterizzata da un’intenzione consape62
vole – può restare «appena abbozzata», dispersa e frammentata, priva
di un accordo tra pensiero e osservazione, desiderio e oggetto. La sua
fine è una semplice cessazione, non il compimento o perfezionamento
di un percorso. Questi abbozzi di esperienze sono dunque diversi da
un’esperienza che è «un intero» e «che reca con sé la propria qualità
individualizzante e la propria autosufficienza» (AE, 61).
Ciò vale per ogni tipo di esperienza, che sia un’esperienza del pensiero o dell’azione: qualsiasi esperienza, per avere una sua unità, dovrà
possedere una qualità estetica. L’estetico, dunque, non è contrapposto
né alla sfera pratica né a quella intellettuale, ma semplicemente all’anestetico: «Cediamo alla pressione esterna, oppure ci sottraiamo ad
essa e cerchiamo compromessi [...] Una cosa sostituisce l’altra senza
però assorbirla o portarla avanti. C’è esperienza, ma talmente fiacca e
divagante da non essere una esperienza. Inutile dire che tali esperienze sono anestetiche». (AE, 65) Le “esperienze anestetiche” sembrano
caratterizzate da un far fronte più o meno adattivamente a stimoli
diversi, senza che essi vengano elaborati in alcuna maniera e integrati
tra loro.
Questo primo insieme di tratti caratterizzanti si sintetizza nel fattore che sembra davvero necessario al darsi di un’esperienza («Ci sono condizioni che vanno soddisfatte senza le quali non può istituirsi
un’esperienza»): l’interazione tra attività e passività, tra agire e subire,
tra produrre e fruire. Affinché si dia una esperienza, non sono i tratti
materiali dell’oggetto, dell’opera, del prodotto che si esperisce a dover
mostrare, secondo certi canoni, un equilibrio o un’armonia, ma è proprio questa stessa interazione a dover trovare una misura armoniosa.
Se, infatti, uno dei due aspetti prevale sull’altro, se si dà un eccesso sul
versante dell’agire o su quello del patire, l’esperienza risulterà «parziale
o distorta» (AE, 69). Un’esperienza, naturalmente, è sempre, in una
certa misura, parziale: non si dà mai un’esperienza di cui si riesca a
cogliere la totalità delle relazioni tra agire e patire che la costituiscono:
«Nessuno giunge a una maturità tale da percepire tutte le connessioni
che sono implicate». La profondità e l’ampiezza dell’esperienza dipendono dunque dal livello di maturità (e dunque di esperienza) raggiunto
dalla persona che esperisce. L’esperienza non è esauribile, non è un
oggetto, e dunque non può essere interamente dominata e controllata:
il suo «contenuto significativo» (AE, 69) dipende invece dalla capacità
del soggetto che esperisce di cogliere, per quanto è possibile, le relazioni tra azione e passione che la costituiscono. Ogni interferenza nella
percezione di queste relazioni limita l’esperienza, al punto che, come
si è accennato, l’eccesso di uno solo dei due poli – l’attivo o il passivo
– la snatura e la rende infine impossibile.
Vediamo brevemente queste opposte patologie: l’eccesso sul versante dell’azione («lo zelo nel fare, la brama nell’agire») impedisce il com63
piersi di un’esperienza. Soprattutto «nell’ambiente umano frettoloso e
impaziente in cui viviamo» tale eccesso si traduce in una successione
di abbozzi di esperienza eterogenei, dove lo scopo, spesso neppure
avvertito, è quello della massimizzazione dell’efficienza, di «poter fare
il maggior numero di cose nel tempo più breve». Decisivo, in questo
sbilanciamento, è il contrarsi del tempo, un’«impazienza» che implica,
letteralmente, una prevaricazione di ogni «resistenza»: quella del medium in cui qualcosa si realizza (ridotto a mezzo da sfruttare in vista
di un fine ad esso estraneo), quello di qualsiasi realtà o alterità, che
non viene ascoltata, esplorata, curata, amata, colta come «un invito a
riflettere», ma trattata come «un’ostruzione da abbattere».
Uno degli autori più citati da Dewey in Arte come esperienza è il
poeta John Keats, di cui viene ricordata a più riprese la famosa lettera
in cui introduce la nozione di «Capacità negativa» 6, una nozione che,
nel 1916, già aveva attirato, per motivi analoghi, l’attenzione di Freud,
e che poi costituirà un costante punto di riferimento per W. R. Bion
(autore, non a caso, di un importante volume intitolato Apprendere
dall’esperienza) 7. Poche pagine prima di tematizzare la relazione necessaria tra patire e agire, Dewey ricorda come, per Keats, Shakespeare
costituisse il modello di un uomo dotato eminentemente di tale capacità: il modello di un uomo, cioè, «capace di essere nell’incertezza, nel
mistero, nel dubbio senza l’impazienza di correre dietro ai fatti e alla
ragione». Ed è proprio questa «impazienza» che, poco dopo, Dewey
identifica come ciò che «confonde e distorce invece di condurci alla
luce» (AE, 57-59).
Se sul versante dell’eccesso di attività predomina una percezione
del reale troppo ristretta e parziale, che lo riduce alla misura dei propri
scopi determinati e non permette di cogliere le opportunità impreviste
che esso potrebbe racchiudere in sé, «l’eccesso di ricettività» produce
un analogo e complementare disconoscimento del reale: non per un
eccesso di focalizzazione, di appropriazione cieca e violenta, ma per
una sorta di bulimia di sensazioni e impressioni, nell’illusione che ciò
che rende vivi, che ciò che costituisce «la “vita”», sia «l’affollarsi del
maggior numero possibile di impressioni, malgrado nessuna di esse sia
più di un’impressione fuggevole e rapsodica» (AE, 69). Anche in questo modo la realtà sfugge, dissolvendosi in una stimolazione continua
e occludente, che non lascia spazio ad alcuna riflessione, ad alcuna
distanza, e ci schiaccia sull’ambiente rendendolo così avvolgente da
essere invisibile: «Qualche azione risoluta è necessaria a stabilire un
contatto con la realtà del mondo e per far sì che le impressioni possano essere messe in relazione con fatti in modo che ne venga saggiato
e definito il valore» (AE, 69). In definitiva, «l’eccesso di ricettività»
impedisce il pensiero, la riflessione, il giudizio. Come gli era chiaro da
tempo, Dewey sa che «nella percezione è implicato l’uso del giudizio;
altrimenti la percezione resta semplice eccitazione sensoriale o un ri64
conoscimento del risultato di un giudizio precedente, come nel caso
di oggetti già noti» 8.
“Riconoscimento” è qui la parola chiave. Dewey sembra infatti usare, come equivalenti, termini quali il patire, l’essere pazienti, il subire,
la ricettività, ma li caratterizza tutti, precisando la contrapposizione
iniziale, come dotati di un elemento attivo: «la ricettività non è passività», «questa ricezione comporta attività che sono comparabili a quelle
del creatore» (AE, 75). È possibile allora cogliere, come vedremo, il
nesso tra la pazienza come attività, la «capacità negativa» di Keats, il
tempo e la percezione, in quanto distinta, appunto, dal mero «riconoscimento»: questo, infatti, «è una percezione che si è arrestata prima
di avere l’opportunità di svilupparsi liberamente. Nel riconoscimento
c’è l’inizio di un atto di percezione [...] [la quale] si arresta al punto
in cui servirà a qualche altro scopo, come quando riconosciamo un
uomo per strada per salutarlo o per evitarlo e non per vederlo al solo
fine di vedere che cosa c’è» (AE, 75-76). Nel riconoscimento, anche
l’uomo incontrato per strada è solo un segnale tra segnali, solo uno
stimolo sufficiente a causare una reazione (salutarlo o evitarlo), non
qualcosa che si offre come la realtà complessa che è e che richiede di
«vedere che cosa c’è». Per «vedere che cosa c’è» è richiesto del tempo:
il processo della percezione non è comprimibile nel tempo istantaneo
del riconoscimento (quel tempo che, come sappiamo, «nell’ambiente
umano frettoloso e impaziente in cui viviamo» non è, per lo più, a
nostra disposizione), richiede una pazienza attiva, una «capacità negativa», una tolleranza per la complessità, un permanere e un indugiare
sul reale senza risolverlo in «fatti e ragioni».
I due fattori necessari al darsi di un’esperienza (patire e agire, recepire e fare) non sono dunque due ingredienti che si sommano o si
combinano, ma devono presentarsi in una relazione indissolubile, quale
che sia. L’«equilibrio», l’«armonia», l’«accordo» tra i due fattori non
è infatti comprensibile altrimenti che come una perdurante relazione.
Lo squilibrio, la disarmonia, il disaccordo non possono essere altro che
il dissolversi di quella relazione, lo sganciarsi di uno dei due fattori
dall’altro, la scissione che elimina ogni «resistenza» dall’attività e ogni
«regola» dalla ricettività e che porta a una perdita di contatto con il
reale: la perdita di contatto tra i due fattori necessari all’esperienza è
infatti insieme perdita di contatto con la realtà (quale che sia), e senza
un contatto con la realtà non può esserci esperienza, nel senso pieno
del termine. Ora, se è vero che «l’estetico non si intrufola nell’esperienza dall’esterno, a causa di un lusso ozioso o in virtù di un’idealità
trascendente, ma che è lo sviluppo chiarificato e intensificato di tratti
che appartengono a ogni esperienza normalmente compiuta», per comprendere «ogni esperienza normalmente compiuta» bisognerà guardare
a un’esperienza esemplarmente estetica quale è quella artistica.
Nel discutere l’esperienza artistica, Dewey assimila «l’artistico» al
65
lato attivo, fattivo, creativo dell’esperienza e «l’estetico», in senso stretto, al suo lato recettivo, fruitivo, valutativo, lamentando una mancanza
di un terzo termine che designi i due processi presi insieme. L’artistico, infatti, non può in alcun modo stare senza l’estetico, in quanto si
ridurrebbe al prodotto di un processo essenzialmente meccanico, alla
produzione di uno stimolo per un riconoscimento, non per una percezione intessuta di tempo e di relazioni. È per questo che «l’abilità
dell’artefice, per essere indubitabilmente artistica, deve essere “amorosa”: deve prendersi cura a fondo del contenuto su cui si esercita la sua
tecnica» (AE, 71). Una cura “amorosa” non è però soltanto una cura
meticolosa, attenta, partecipe, che richiede tempo e dedizione, ascolto e rispetto dell’altro nella sua autonomia: perché si sia “amorosi”
deve accadere qualcosa di spontaneo, qualcosa che non è interamente
riconducibile alle mire intenzionali e consapevoli del soggetto (non si
prova amore grazie a una scelta deliberata, intenzionale e consapevole), qualcosa che induca a vedere il «contenuto» su cui si «esercita la
propria tecnica» come dotato di una propria fisionomia individuale e
non come «un’ostruzione da abbattere».
Se – continuando nella nostra ricostruzione del pensiero di Dewey
– guardiamo ora alla nozione di «spontaneità», possiamo mettere in
questione l’assimilazione esclusiva della sua nozione di esperienza alla
Erlebnis vitalistica, come è invece accaduto anche in chi, come R. �����
Shusterman, si è dedicato a riscattare il pensiero di Dewey dall’oblio in cui
è stato consegnato per molto tempo dall’estetica analitica 9. Se, per
un verso, attribuendo all’esperienza di Dewey il carattere di Erlebnis,
di “esperienza vissuta”, si intende preservarne a ragione il carattere
“fenomenologico”, “sentito”, “vivo”, d’altra parte ci si lascia sfuggire
del tutto il suo spessore, il suo radicamento nella storia dell’individuo
e della collettività a cui appartiene, il cambiamento duraturo che essa
provoca, il suo aspetto costituente dell’essere stesso di una persona e
di una civiltà – quella che, insomma, in contrapposizione a Erlebnis, si
è chiamata Erfahrung.
Come si sa, il volume Arte come esperienza ha la sua origine nella
serie di lezioni istituite dalla Harvard University in memoria di William
James. Ora, l’omaggio reso da Dewey a James nelle sue lezioni non è
affatto rituale, ma interviene anzi in un punto cruciale della sua argomentazione, in cui ritroviamo l’intreccio tra patire e agire che, come
abbiamo visto, costituisce il vero nodo della sua teoria dell’esperienza
(estetica). Dewey si sta interrogando su ciò che rende un atto espressivo: un «atto è espressivo solo quando in esso c’è unisono tra qualcosa
che si è accumulato da un’esperienza passata, e dunque qualcosa che
si è generalizzato, e condizioni presenti» (AE, 92). Nei bambini questo accordo è facile, e facilmente spontaneo, in quanto il passato – lo
spazio dell’esperienza – è in loro molto ridotto («ci sono pochi ostacoli
da superare, poche ferite da sanare, pochi conflitti da risolvere»), e
66
si adatta facilmente al presente: lo spessore, la densità dell’espressione sarà però proporzionale alla facilità dell’accordo o, meglio, alla
limitatezza dell’esperienza messa in gioco nel presente. Nelle persone
adulte il rapporto è rovesciato: lo spazio dell’esperienza accumulata,
il passato, è ingombrante, e richiede una lunga elaborazione per trovare un’espressione felice, cioè riuscita e spontanea, nel presente. La
spontaneità, negli adulti, «viene [...] solo a coloro che si sono immersi
in esperienze di situazioni oggettive; a coloro che sono stati a lungo
assorti a osservare materiali correlati e la cui immaginazione è stata a
lungo occupata a ricostruire ciò che si vede e si ode [...] La “spontaneità” è il risultato di lunghi periodi di attività, altrimenti è tanto
vuota da non essere un atto di espressione» (AE, 92). E qui interviene
il decisivo riferimento al James autore di Le varie forme dell’esperienza
religiosa 10, il cui sottotilo – Uno studio sulla natura umana – è certamente molto impegnativo, ma anche giustificato. James infatti coglie
qualcosa che ha a che fare non tanto con ciò che gli esseri umani si
rappresentano, vogliono, intenzionano, quanto con ciò che riguarda
la loro “natura” al di qua di ciò che è dominabile e controllabile da
intenzioni e volizioni consapevoli. Vale la pena di riportare per esteso
il passo che Dewey cita dall’opera di James: «L’intelligenza cosciente
e la volontà dell’individuo, quando si affaticano verso l’ideale, mirano
a qualcosa di immaginato solo in modo confuso e indefinito. Tuttavia
le forze organiche di maturazione progrediscono in tutto quel periodo
verso il loro fine prestabilito, e gli sforzi consapevoli liberano alleati
subconsci dietro le quinte i quali a modo loro, operano in direzione
dell’assetto; e il riassetto verso cui tendono tutte queste forze più profonde è definito con sufficiente sicurezza, e nettamente differente da
quello che l’individuo concepisce e determina coscientemente. Esso
può, quindi, essere effettivamente disturbato – come fosse inceppato
[...] – dagli sforzi volontari dell’individuo, che lo fanno desistere dalla
giusta direzione. [...] quando il nuovo centro dell’energia personale è
stato tenuto in incubazione subconscia abbastanza a lungo per essere
pronto a fiorire, “giù le mani” è l’unica regola per noi, perché deve
sbocciare senza soccorsi» (AE, 93).
Nel leggere questo passo, non bisogna pensare ai luoghi comuni di
origine romantica riguardo al genio inconscio o a alle forze irrazionali
che lo guiderebbero, quanto invece a un altro aspetto – quello della
maturazione, dell’elaborazione – questo sì essenziale per comprendere
la natura dell’esperienza, e in particolar modo della creazione e della
ricezione artistica che ne costituisce il modello: «lo sforzo diretto di
“intelligenza e volontà” – commenta Dewey – di per sé non ha mai dato
origine a qualcosa che non fosse meccanico; la loro funzione è necessaria, però deve lasciare agire alleati che esistono al di là dei loro scopi».
Lavorare volontaristicamente in vista di uno scopo sarà ciò per mezzo
di cui è possibile formare e dare espressione a un’esperienza, ma non
67
anche ciò grazie a cui tale esperienza, e la sua espressione “spontanea”,
possono prendere forma. Più che lavorare, si tratterà quindi di elaborare:
cioè di valorizzare il proprio vissuto, nel dialogo con altri soggetti, con
una cultura («È per mezzo dei rapporti sociali che un individuo acquista
una mente», scrive Dewey 11), e dentro di sé; di “digerire”, in un tempo
non comprimibile, mediante i succhi della riflessione, le proprie relazioni
con l’ambiente, gli altri, la realtà, gli eventi reali, psichici, emotivi. Si
tratterà, insomma, di esercitare quella pazienza attiva, quella «capacità
negativa» di cui Dewey, a ben guardare, non rinuncia mai a mettere in
rilievo il ruolo fondamentale nella costituzione dell’esperienza, e innanzitutto dell’esperienza artistica o “creativa”: «Quando la pazienza ha
svolto tutto il suo lavoro, l’uomo cade preda della musa appropriata, e
parla e canta nel modo dettato da qualche divinità» (AE, 93).
Certo, Dewey sa benissimo che l’eterogeneità delle cose che ci accadono quotidianamente richiede puntualità e determinatezza nelle reazioni e negli scopi che mettiamo in gioco per affrontarle: «compiamo atti
differenti, ciascuno dei quali con il suo risultato particolare» (AE, 93).
Questa frammentazione è inevitabile, tanto più nell’ambiente metropolitano e industriale in cui maturano tutte le riflessioni sull’esperienza
che hanno preso corpo nel Novecento. La cosiddetta “parcellizzazione dell’esperienza” ha poi raggiunto oggi livelli neppure immaginabili
negli anni in cui Dewey andava scrivendo le sue riflessioni. Dagli anni
trenta – dal decennio, cioè, in cui Dewey, e Benjamin, andavano riflettendo sulla costituzione e il destino dell’esperienza – abbiamo assistito
a una incredibile escalation dei fenomeni di disgregazione e scissione
degli ambiti vitali: non solo la vita frenetica e spaesante delle grandi
metropoli, la divisione del lavoro e la sua crescente automazione, ma
il trauma della seconda guerra mondiale, con i campi di sterminio e la
distruzione – su una scala letteralmente inimmaginabile – resa possibile
e attuata dagli armamenti atomici; i televisori in tutte le case, internet e
la realtà virtuale; la globalizzazione, i grandi flussi migratori, le nuove
ricchezze e le nuove povertà, le nuove guerre e le nuove minacce. È
vero, dunque, che l’individuo deve far fronte con strategie diverse e
puntuali a questa complessa e gigantesca massa di stimoli, ma, come
scrive Dewey, è anche vero che tutta questa eterogeneità fa riferimento
a «un’unica creatura vivente», i cui atti «sono in qualche modo legati
insieme al di sotto del livello dell’intenzione». (AE, 93).
Si potrebbe obiettare, naturalmente, che qui si esprime solo una
ingiustificata fiducia da parte di Dewey, e si potrebbe contrapporre
così un ottimismo pragmatico tutto americano – disposto a dare credito all’onnipotenza dell’educazione e alla possibilità astorica di fare
un’esperienza unitaria e integrata – a una coscienza critica e tormentata
tutta europea, volta a diagnosticare la progressiva atrofia dell’esperienza; si potrebbe obiettare, ancora, che il problema della disgregazione
dell’esperienza viene in tal modo aggirato e che ciò che si tratta di
68
dimostrare, la possibilità di un’esperienza unitaria, viene circolarmente
presupposto con il richiamo alla debole unità di «un’unica creatura
vivente»; o, per riprendere un’espressione di Anders, che il bisogno
molto concreto e reale che si esprime nella fame non costituisce una
dimostrazione dell’esistenza del pane.
Tuttavia, è innegabile che chi denuncia una disgregazione o un’atrofia dell’esperienza deve sapere qualcosa – anzi, deve aver esperito, in
qualche forma – quell’esperienza di cui va diagnosticando la perdita.
Chi avesse sempre vissuto soltanto in uno dei due “eccessi”, del fare
e del patire irrelati, non saprebbe nulla di un’esperienza integrata che
sarebbe in via di disgregazione o di atrofizzazione. Di questa esperienza, infatti, non si potrebbe sapere nulla mediante un’informazione o
una conoscenza mediata: se di esperienza si tratta, bisogna serbarne
una traccia esperita. Ciò non toglie, naturalmente, che questa sorta di
presupposto anamnestico non garantisce affatto l’eventualità di fare e
avere esperienza. Dewey non si fa alcuna illusione sul proprio tempo:
«la diffusa disgregazione» (AE, 320), le condizioni di iniquità sociale,
il controllo oligarchico sul lavoro, (AE, 324-26), non sono condizioni
che si possano superare con le buone intenzioni, né certo il singolo
artista volenteroso può incidere in alcun modo. Dewey, indagando le
condizioni di un’esperienza sensata, non pensa affatto a fornire ricette
empiriche, né si fa tentare da nostalgie per una condizione che apparterrebbe al passato: «una cosa è certa; l’unità non si può raggiungere
predicando il bisogno di ritornare al passato», anche perché è dubbio
«che ci sia mai stato in qualsiasi tempo un certo numero di persone
che “abbia visto la vita con fermezza e per intero”» (AE, 322-23).
Tuttavia, da Dewey viene un’indicazione importante, anche riguardo
all’arte dei nostri tempi: tutti i tentativi, o le tentazioni, di assimilare
le opere d’arte a dispositivi semantici anestetici, di “normalizzare” la
“produzione artistica” per ricomprenderla nel grande e vago calderone
della “cultura”, tradiscono la stessa ragion d’essere del fare arte, quella
cioè di far «sentire possibilità che sono irrealizzate e che potrebbero
realizzarsi» (AE, 327). Ma, come si è visto, la realizzazione e la fruizione di opere in grado di far sentire queste possibilità presuppongono
degli esercizi costanti di attenzione, di “cura amorosa”. Il circolo è
evidente, ma è lo stesso circolo dell’esperienza, che funziona finché
fare e patire mantengono una relazione e non si scindono. Dewey, di
questa relazione, ha offerto un quadro plausibile, che non può e non
deve garantire alcuna prassi effettiva, né dettare condotte che determinino in un modo o in un altro la realizzazione di queste o quelle
relazioni empiriche. Ma la teoria garantisce almeno la possibilità di
tali relazioni: una possibilità, però, che non è una “mera possibilità”, un’opzione tra tante possibili, ma che ha rivelato di possedere un
carattere normativo, essendo inscritta, come compito, nella struttura
stessa dell’esperienza.
69
1
J. Dewey, Art as Experience (1934), a cura di H. F. Simon, Center for Dewey’s
Studies, Southern Illinois University Press, Carbondale, Ill., 1987; trad. it. a cura di G.
Matteucci, Arte come esperienza, Aesthetica, Palermo, 2007, p. 267. D’ora in poi AE.
2
Id., Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull’educazione, a cura di L. Borghi,
La Nuova Italia, Firenze 1954 (19719), p. 18.
3 Ivi, p. 10.
4 Ivi., p. 5.
5 Id., Democrazia e amministrazione scolastica, da un discorso tenuto da Dewey il
22 febbraio del 1937, in Il mio credo pedagogico, cit., p. 265.
6 J. Keats, Lettere sulla poesia, tr. it. e cura di N. Fusini, Feltrinelli, Milano 1984,
p. 75.
7 Per un’analisi più approfondita di questo intreccio di temi intorno alla “capacità
negativa” mi permetto di rimandare a S. Velotti, Storia filosofica dell’ignoranza, Laterza,
Roma-Bari 2003.
8 Questo tema è svolto ampiamente nel capitolo 11 di Democracy and Education,
intitolato “Experience and Thinking”.
9 Vedi per es. R. Shusterman, The End of Aesthetic Experience, in «Journal of ����
Aesthetic�������������������������������������������������������������������������������������
and Art Criticism», 55, 1 (Winter, 1997), pp. 29-41, in cui si legge: «In these ����
philosophies [le filosofie della vita di fine ottocento e inizio novecento] experience replaced
atomistic sensation as the basic epistemological concept, and its link to vividly felt life is
clear not only from the German term “Erlebnis”, but also from the vitalistic experiential
theories of Bergson, James, and Dewey», p. 30.
10 W. James, Rhe Variety of Religious Experience. A Study in Human Nature (1902),
trad. it. di P. Paletti, Le varie forme dell’esperienza religiosa. Uno studio sulla natura
umana, Morcelliana, Brescia, 1998.
11 Questa tesi viene sostenuta in modo particolare nel capitolo xxiv di Democracy
and Education, cit.
70
Il modello antropologico dell’esperienza estetica
fra Dewey, Gehlen, Plessner
di Salvatore Tedesco
Fra i numerosi meriti della nuova edizione italiana di Arte come
esperienza di John Dewey curata da Giovanni Matteucci 1, c’è sicuramente quello di aver illuminato le profonde innervazioni che da Dewey
si dipartono su alcuni momenti essenziali del dibattito novecentesco,
promuovendo una lettura in chiave antropologica del concetto di esperienza in Dewey.
Detto in tutta brevità e con la necessaria approssimazione, se l’esperire in generale non è altro per Dewey che la relazione ambientale in
cui il vivente è costantemente immerso, il perfezionamento, la consummation dell’esperienza risiede poi nella «qualità individualizzante»,
nella «auto-sufficienza» che il materiale dell’esperienza acquisisce nel
momento in cui «porta a compimento il proprio percorso» 2. Ovvero, per citare un altro straordinario passaggio dell’argomentazione di
Dewey, «l’esperienza è emotiva, ma in essa non ci sono cose separate
chiamate emozioni» 3.
Esperienza ed espressione stanno così, nel paradigma antropologico di Dewey, in una relazione che ritengo si possa utilmente porre a
confronto con le riflessioni più o meno coeve dell’antropologia filosofica tedesca. Il vero filo conduttore che ci guiderà nella nostra breve
analisi sarà il concetto di movimento espressivo, la cui enucleazione
costituisce il vero obiettivo di quanto segue. Se, come scrive Dewey,
la funzione cognitiva dell’esperienza sta in ultima analisi nel «controllo
prospettico delle condizioni dell’ambiente» 4, il concetto gnoseologico
di esperienza verrà superato, come ben argomenta Matteucci, e per
così dire ripensato all’interno di una più ampia lettura antropologica.
È giusto da questa prospettiva che parte, riferendosi del resto esplicitamente ai risultati di Dewey, la ricerca di Arnold Gehlen. Nel 1936,
muovendo tanto da suggestioni nietzscheane quanto nello specifico da
William James e dal Dewey di Natura e condotta dell’uomo 5, Gehlen
pubblica un saggio Sull’essenza dell’esperienza 6, che costituisce un passaggio decisivo per l’elaborazione della sua prospettiva antropologica.
Risultato dell’analisi dell’esperienza lì condotta sarà infatti la determinazione del concetto di esonero (Entlastung), ed il ripensamento
dei rapporti fra azione e teoria della conoscenza, dunque gli aspetti
centrali del pensiero di Gehlen.
71
Gehlen vede empirismo e metafisica accomunati da un approccio
parziale ai problemi dell’esperienza, un approccio che riconducendo
in ogni caso l’esperienza alla coscienza, e dunque intendendola come
«un genere del sapere» 7, mancherebbe di coglierne l’aspetto decisivo per cui essa consiste anzitutto nell’interazione fra uomo e mondo,
in un’elaborazione della realtà che immediatamente si traduce (come
invece era stato compreso da Aristotele, «primo grande pensatore dell’organismo» 8 e con ciò di una filosofia dell’aisthesis al tempo stesso
in cui è il filosofo dell’agire e della tecnica) in un “saper deliberare”
e in un “fare esperto”, quello della techne, in quanto tale «neutrale
rispetto alla distinzione fra “fisico” e “psichico”» 9.
Anche Plessner, ci si permetta una breve parentesi, osserverà per
parte sua nella premessa alla seconda edizione delle Stufen che il concetto di azione di Gehlen e di Dewey evita «la fatale spaccatura dell’essere umano in una regione corporea e in una non-corporea» 10.
Un uomo esperto, prosegue Gehlen, «non è in prima linea uno
che ha a disposizione giudizi giusti, ma è invece uno che in qualsiasi
campo – si tratti pure in definitiva di mera destrezza corporea – costruisce qualcosa, lo ha a disposizione, e semplicemente può qualcosa» 11. Ambito dell’esperienza è dunque l’interazione costruttiva con
le cose, con le situazioni, con gli altri e con se stessi, e l’esperienza
ha innanzitutto un carattere di prestazione, ovvero è un modificare
se stessi e le condizioni del proprio rapporto col mondo. Decisivo a
questo punto, ma ci torneremo, il rapporto fra il “fare esperto” della
tecnica e l’aistheticità del vivente.
Esemplare, per Gehlen, il caso del bambino che impara a camminare: «di tutte le innumerevoli varianti della locomozione […], alcune
vengono fissate, e proprio queste vengono rese possibili e costruite da
tutto ciò che si svolge in precedenza e viene lasciato cadere» 12. La
nostra esperienza della realtà si orienta sempre sulle maniere in cui le
cose “ci concernono”; ben lungi dal permetterci di pervenire ad un
immutabile esser-così della realtà, aggiunge Gehlen in polemica con
l’antropologia spiritualista di Max Scheler, l’esperienza che noi facciamo è sempre un tentativo di «fissare univocamente per la disponibilità
futura il genere e la maniera di questo concernere» 13; l’oggettività non
è che una momentanea “posizione di riposo” nell’interazione uomo/
mondo. E qui, al ricordo della polemica di Dewey contro il disinteresse si aggiungono probabilmente gli esiti del dibattito tedesco di
quegli anni, e in primo luogo le riflessioni di Uexküll e di Rothacker
sulla valenza antropologica dell’istituzione di un “piano di significato”,
di un «orizzonte di ciò che è per noi vitalmente ed emozionalmente
significativo» 14.
Già in questa iniziale descrizione dell’esperienza si prospettano alcuni dei grandi temi che Gehlen affronterà negli scritti successivi, a
partire da Der Mensch, e si prospetta soprattutto il carattere simbolico
72
e dunque esonerante dell’esperire umano: costruiamo «forme della
percezione e in generale del sapere vitale più elevate, simboliche, cioè
semplicemente abbreviate e quindi esoneranti, che esonerano intere
concatenazioni esperienziali ampie e conquistate con difficoltà» 15.
Riflettere sull’esperienza significa dunque per Gehlen riflettere sui
modi in cui si realizza l’apprendimento umano e considerare l’uomo
come colui che, non limitandosi a vivere ma conducendo la propria
vita 16, profondamente rielabora, dissoda e ridefinisce i terreni di confine fra i comportamenti istintivi e le prestazioni coscienti.
Abbiamo dunque innanzi un primo piano di lavoro indubbiamente
assai articolato: alle relazioni fra esperienza e tecnica corrisponde la
messa in discussione della dicotomia fisico/psichico e il ripensamento
della relazione fra soggetto e oggetto in funzione della relazione simbolica fra l’uomo e il mondo.
Gehlen ritorna sul senso della lezione di Dewey in un breve saggio
del 1951, Der gegenwärtige Stand der anthropologischen Forschung 17,
affermando che la caratteristica essenziale del comportamento umano,
in specie di quello sociale, è quella di affiancare alla relazione con
l’oggetto la tematizzazione del proprio sé e l’autopercezione. L’uomo è
cioè capace di assumere su di sé il ruolo dell’altro e di vivere se stesso
oggettivandosi nella relazione con l’altro. L’esempio è ancora una volta quello del bambino, che nel suo modo di agire e parlare è capace
di prefigurare la risposta dell’altro, il comportamento dell’altro, e di
regolare di conseguenza il proprio. Non si tratterà tanto di imitazione, quanto della creazione di strategie di autopotenziamento, o ancor
meglio di vere e proprie strutture del comportamento che a giudizio
di Gehlen iniziano a costruirsi nel corso di quella che Portmann 18
definiva la “primavera extrauterina” durante la quale il neonato, vero
e proprio parto prematuro normalizzato, lentamente dà vita a una serie
di processi di maturazione e di crescita sotto l’influsso degli stimoli
provenienti dal mondo esterno.
E infatti, spiega Gehlen, «persino il parlare e il movimento umano
si sviluppano in quel tempo sotto l’influsso dello stimolo immediato
dell’ambiente simbiotico, come una “motorica acquisita” tanto auto
quanto eterodiretta» 19. A giudizio di Gehlen si dà così la possibilità
di seguire la vita spirituale dell’uomo sin nelle sue radici, nella sua
materia costitutiva, procedendo dunque dal livello superficiale della
coscienza a quello più profondo delle interazioni motorie e percettive
con il mondo esterno, sino a ricostruirne, con Louis Bolk 20, i nessi
con il complesso degli equilibri del sistema ormonale.
Gehlen si muove qui davvero sulla zona di confine fra l’ambito degli
istinti e quello della progettualità umana, meglio ancora del «prendere
posizione circa se stesso» 21 da parte dell’essere umano; se nel caso del
comportamento animale le interazioni fra le strutture della percezione
e quelle del movimento conducevano alla definizione dei modi della
73
relazione fra ambiente e animale (in breve, l’ambiente – Umwelt – è
composto per Jakob von Uexküll 22 appunto dal prodotto della relazione fra mondo percettivo – Merkwelt – e mondo agito – Wirkwelt),
l’unità complessa fra percezione e movimento andrà compresa nel caso
dell’uomo in un sistema di relazioni profondamente differente.
Da qui anche, occorre sottolineare, le ragioni delle parziali riserve
di Gehlen nei confronti di Dewey 23: il terreno dell’esistenza umana,
dice infatti Gehlen, non è senz’altro la “vita quotidiana” come afferma
Dewey, ma è piuttosto costituito dal nostro cronico proiettarci dalla
vita quotidiana verso il futuro: dalla chiusura ambientale propria dell’animale, in direzione dell’apertura al mondo del circolo funzionale
delle nostre relazioni percettive e motorie con la realtà.
Il discorso si apre qui in due direzioni differenti, entrambe del più
grande interesse per il nostro ripensamento delle condizioni dell’esperienza estetica: per un verso la relazione fra l’uomo e la tecnica, per
l’altro verso quella fra istinti e azione.
Più in breve quanto al primo punto: va anzitutto ricordato che già
nel saggio del 1936 l’analisi dell’esperienza si legava alle condizioni
storiche della tarda modernità, e dunque alla crisi dell’esperienza, in
maniera in qualche modo analoga alla diagnosi benjaminiana della povertà dell’esperienza, se si vuole, benché come è noto con implicazioni
politiche del tutto differenti: l’attenzione per le strategie esoneranti
legate al comportamento simbolico dell’essere umano era anche una
difesa delle strategie culturali dell’uomo occidentale contro l’oggettiva
perdita di pregnanza dell’esperienza nell’era contemporanea 24. Negli
anni Cinquanta il discorso di Gehlen si approfondisce con la considerazione della mediazione tecnica dell’esperienza; occorre anzitutto
ricordare che Gehlen definisce circolo dell’azione la forma generale
dell’interazione fra percezione e movimento nell’uomo, e la descrive
in base al principio di retroazione per cui il comportamento viene sperimentato nei suoi risultati, e tali risultati retroagiscono influenzando
i comportamenti futuri 25.
Ebbene, sottolinea Gehlen, sono proprio le proprietà costitutive
del circolo dell’azione e del principio dell’esonero a fungere da determinanti dell’intero sviluppo della tecnica 26, sino al suo esito estremo,
cioè non solo la sostituzione dell’organo con lo strumento inorganico,
ma l’automatismo della macchina, vero punto di arrivo delle strategie
esoneranti e insieme del processo di autoapprendimento instradato
dal circolo dell’azione. Tenendo conto di ciò, probabilmente non sarà
sufficiente nel caso di Gehlen parlare di integrazione dell’inorganico
nell’ambito dell’organico, ma piuttosto si dovranno fare i conti con
la chiara percezione da parte del nostro autore di una svolta assai
più radicale, che certo è anche il compimento, alla lettera, di un processo antico quanto l’ominazione stessa, e cioè del tentativo, operato
tanto con gli strumenti della magia quanto con quelli della tecnica,
74
di pervenire a quella che significativamente Gehlen definisce stabilità
ambientale: «l’interesse umano elementare per l’uniformità del corso
della natura è assai rilevante e corrisponde a un bisogno di stabilità
ambientale quasi istintivo» 27. Quasi un ritorno alle condizioni di sicurezza della vita animale.
La Instinktähnlichkeit, la prossimità all’istinto di questo bisogno
apre però per noi al secondo aspetto del problema, e cioè quello della
«zona di confine fra esecuzioni istintive ed esecuzioni intellettuali negli
esseri umani» 28, cui Gehlen dedica nel 1961 un saggio che costituisce
probabilmente il suo principale contributo al dibattito sull’esperienza
estetica.
Proviamo dunque a seguire per qualche tratto la densa argomentazione di Gehlen, che muove giusto dall’assunzione che esista una
proporzionalità inversa fra istinto e coscienza, per cui l’uomo si caratterizzerebbe per un processo di riduzione degli istinti da porre molto
indietro nella storia evolutiva della nostra specie, che presenta di fatto
a giudizio di Gehlen solo dei «residui istintuali» 29. Alla riduzione degli
istinti si accompagna, d’accordo con le teorie di Bolk sull’ominazione,
un insieme di inibizioni ormonali che determinano il mantenimento
sino all’età adulta di un sistema di caratteristiche evolutivamente primitive (prolungamento dell’infanzia e tarda maturità sessuale, assenza
di peli, elevata aspettativa di vita, instabilità della vita pulsionale). Sulla
base di queste premesse Gehlen si domanda se sia ancora possibile
nel caso dell’essere umano rintracciare reazioni istintive come quelle
studiate dall’etologia di Konrad Lorenz, e consistenti in un processo di
scatenamento per cui in determinate specie determinate figure di movimento «vengono disinibite da parte di uno stimolo che sopraggiunge
dall’esterno» 30, secondo una relazione definita “chiave/serratura”.
Caratteristica comune di questi meccanismi scatenanti è la loro improbabilità e semplicità, ovvero, spiega Gehlen, «i segnali scatenanti
sono soliti staccarsi nell’ambiente delle diverse specie animali dallo
sfondo solito, appaiono insoliti, vistosi, insistenti» 31, e insomma, come
già osservava Lorenz, si distaccano da un ambiente per lo più fatto di
configurazioni irregolari e indistinte per quella regolarità e simmetria,
che solitamente rende belli agli occhi degli uomini i fattori scatenanti
ottici degli istinti animali (i colori puri e le forme regolari).
Occorrerà allora chiedersi se esiste la possibilità di rintracciare
«qualcosa come un substrato biologico delle esperienze propriamente
artistiche» 32, che permetterebbe di addentrarsi nel territorio secondo
Gehlen «mai esplorato» 33 di una fisiologia dell’arte. Per chi si occupa
di storia delle idee è in effetti piuttosto singolare dover osservare come
anche qui Gehlen, benché evidentemente a sua insaputa, stia seguendo
le orme di Herder e di ampia parte del dibattito dell’Illuminismo tedesco in direzione di una fisica dell’anima e di un’estetica fisiologica.
Come che sia, la risposta di Gehlen passa ancora una volta attra75
verso quel grande discrimine costituito dalla riduzione degli istinti,
che implica anzitutto l’affrancarsi nell’uomo degli organi di senso «dai
circuiti funzionali animali» 34, dove andrà notato che l’espressione “circuito funzionale” (Funktionskreis) fa riferimento una volta di più alla
teoria ambientale di Uexküll, e vale a indicare l’interazione e gli effetti
di feedback fra animale e ambiente tanto nell’ambito della percezione
quanto in quello del movimento.
Ecco perché il passo successivo di Gehlen sta nella distinzione fra
la motorica innata, ereditaria, dell’animale, e la motorica acquisita,
«istintualmente esonerata» 35, dell’uomo. Infatti per un verso la massima parte di ciò con cui l’uomo interagisce è artificiale, prodotto dall’uomo stesso, come tavoli, sedie, penne, case, strade, e dunque non
si danno circuiti funzionali innati nell’uso di tali elementi artificiali.
Ma soprattutto, poi, il movimento e la sua relazione con la percezione
sono volti nell’uomo all’attiva modificazione di circostanze in linea di
principio imprevedibili, alle quali appunto è funzionale il carattere
autoavvertito delle prestazioni sensomotorie umane. L’esuberante ricchezza delle pulsioni umane ha caratteristiche tali (cronicità, convertibilità) da sfuggire del tutto alla traduzione in precise figure motorie.
Si ha così, nel caso di una «situazione biologicamente significativa»
(riguardante la sessualità, la nutrizione, il pericolo di vita ecc.), una
«scossa sensoriale» 36 che però non necessariamente si traduce in un
determinato comportamento, e talvolta anzi non si traduce affatto in
azione, ma semmai in un differimento dell’azione.
È però importante osservare come lo stesso Gehlen registri quasi a
margine l’esistenza di una via alternativa di sfogo della scossa sensoriale,
costituita dalla motilità periferica, involontaria, legata ai canali vegetativi, con fenomeni dell’espressività quali il riso, il pianto, l’arrossire, che
dovrebbero a giudizio di Gehlen «venir compresi come vie di sfogo
non pratiche (che non modificano nulla nel mondo esterno) di scosse
sensoriali, che per parte loro sarebbero reazioni istintive, trattenute all’interno, a stimoli o situazioni scatenanti» 37. Vedremo come già nella
ricerca di Plessner e Buytendijk dei primi anni Venti proprio l’analisi di
tali fenomeni abbia portato a risultati del più grande interesse.
La plasticità e convertibilità della nostra vita pulsionale ha poi a
giudizio di Gehlen un’altra conseguenza di grande portata, ovvero ha
per effetto l’unità temporale della nostra vita interiore, che non è disseminata in un pulviscolo di presenti irrelati relativi alle varie sfere
pulsionali, né però è unificata solo a livello della coscienza intellettuale,
ma alla lettera getta le sue radici sin nell’oscurità della vita vegetativa:
«si costruisce in un costante processo di autotrasformazione, di cui
solo la minima parte diviene consapevole, qualcosa come una “base di
reazione storica”, che però viene anch’essa costantemente ridefinita» 38.
Una volta di più un risultato riportabile a un dibattito oggi troppo
ingiustamente dimenticato (i nomi sarebbero qui soprattutto quelli di
76
Erich Rothacker e di Philipp Lersch 39), nonché una prestazione aisthetica dell’essere umano.
Cosa ne è però dello stimolo scatenante, nel momento in cui esso,
nell’essere umano, non genera più una figura motoria, e dunque almeno tendenzialmente non genera più gli esiti cui sarebbe biologicamente
preposto? «Tutte queste cose», cioè tutte le configurazioni scatenanti
“improbabili”, risponde Gehlen, «risulterebbero vistose in primo luogo dal punto di vista ottico, in modo pienamente indipendente da
qualsiasi valenza biologica anche residuale, e a loro volta sarebbero
coordinate con un’attenzione e una coordinazione sensoriale con gli
istinti del tutto astratta, soltanto rudimentale, e quindi dotata di una
sua propria qualità» 40. È qui che si radica antropologicamente il primato del ben formato indagato dalla psicologia della Gestalt, ed è qui
che si fonda la possibilità di un’estetica fisiologica.
Gehlen non esita ad esprimere la sua insoddisfazione nei confronti
dei metodi più accreditati della scienza filologica dell’arte – un’insoddisfazione di cui si ricorderà ancora Hans Belting nella sua recente BildAnthropologie 41 – avvertendo l’esigenza di una comprensione dell’arte
che sollevi il velo su quella «animazione [Belebung] ed entusiasmo che
fanno battere il cuore e mozzano il fiato» 42, e che restano totalmente
inspiegabili «senza alcuna partecipazione di istanze fisiche» 43.
Occorrerà allora rintracciare nelle esperienze estetiche la partecipazione di «qualcosa come una motorica particolare, che va vista in
relazione ad altre particolarità del movimento umano» 44, ovvero, come
spiega il rinvio alla seconda sezione di Der Mensch 45, va posta in relazione col carattere acquisito e autoavvertito del movimento, in grado
di nutrire la fantasia motoria, in primo luogo nella sua qualità ottica.
«In modo corrispondente – prosegue Gehlen – deve essere possibile
mettere in relazione con la qualità della struttura delle pulsioni umane
certe proprietà delle esperienze estetiche vissute, o addirittura il loro
intero ambito» 46. La sobria precisazione ulteriore di Gehlen è che
ovviamente in tal modo ambito della fisiologia dell’arte sarebbero solo
«gli strati prossimi all’istinto nel campo dei fenomeni estetici» 47.
È allora giunto il momento di raccogliere tutti gli elementi sinora
dispiegati analiticamente da Gehlen: in cosa consiste la qualità della
struttura delle pulsioni coinvolte nell’ambito estetico, e che genere
di Sondermotorik (motorica particolare) è quello cui esse danno vita
rendendosi indipendenti da ogni valenza biologica e traducendosi nella
qualità del “ben formato”?
Gehlen risponde dicendo che «ciò che è rimasto dell’effetto scatenante evolutivamente primordiale è un residuo divenuto privo di funzione, depotenziato, che però proprio per questo motivo può irradiarsi
all’intera ampiezza del campo della percezione in interminabile multiformità» 48. Se la percezione e la motorica animale sono per Gehlen
meramente elementi del circolo funzionale ambientale, la zona di confi77
ne prossima all’istinto nel comportamento estetico umano può viceversa essere investita di un godimento che è commisurato alla raggiunta
libertà dall’azione: «sentiamo di fronte a questi valori estetici qualcosa come un impulso di genere particolare, libero dal comportamento
[…]. Abbiamo l’impressione di un venir attirati sensibilmente forte,
molto immediato e vivificante, ma d’altro lato decisamente puntuale e
per così dire senza risultato» 49.
Insomma risulterebbe soppressa o ridotta la concatenazione fra stimolo scatenante e risposta motoria istintiva, e proprio nel raggiungimento della libertà dall’azione, dunque direi in una sorta di prefigurazione del compimento del processo esonerante del circolo dell’azione,
consisterebbe il piacere estetico 50.
La valenza antropologica dell’esperienza estetica si traduce dunque
per Gehlen già dai primordi dell’umanità nel tentativo di fissare in determinate configurazioni un sentimento di piacere in cui si custodisce
un residuo istintuale «che non è più accentuato per singoli gruppi di
oggetti determinati, ma proprio perciò risponde a oggetti tout court,
se solo essi esibiscono quelle qualità scatenanti, benché biologicamente depotenziate» 51. Dunque – va da sé – in nessun caso una qualche
forma di determinismo biologico, ma al contrario una straordinaria
apertura alle infinite potenzialità plastiche dell’azione umana.
In questo senso, anche quelle che Gehlen descrive come fonti ulteriori del piacere estetico si lasciano piuttosto riportare allo stesso processo, a partire proprio dal piacere che più direttamente Gehlen riconduce
all’esonero, e cioè quello che si lega a quelle forme che ci fanno avvertire
la nostra esperienza come «libera da obbligazioni» 52 e dunque liberatoria, o ancora il piacere intellettuale per la razionalità che avvertiamo
appunto nelle forme geometriche, nel ritmo, nella regolarità.
Un ultimo punto dell’argomentazione di Gehlen è per noi del più
grande interesse, e non da ultimo perché ci riporta ancora a quel grande controaltare dell’antropologia gehleniana costituito dalla riflessione
settecentesca, con la quale ancora dovremo confrontarci. Gehlen osserva infatti che il godimento estetico realizza una peculiare inversione
nella direzione delle pulsioni, che non tendono più a modificare la
realtà esterna, ma piuttosto il nostro stato interno: «l’essere umano
pone come scopo del suo comportamento non un’utile modificazione del mondo esterno, ma una modificazione biologicamente priva di
senso del proprio stato soggettivo […]. Un comportamento in qualche
modo tecnicamente determinato termina in una “configurazione” (ornamento, corona di piume, ecc.) la cui funzione e senso consiste nella
qualità di stimolo della costellazione scatenante, nell’esperienza vissuta
del “bello”» 53; ben lungi dal costituire una manifestazione marginale
dell’umano, quello che in tal modo l’uomo esperisce esteticamente è
«il tratto più profondo della sua essenza, lo sganciamento dall’incatenamento agli istinti, l’esonero dall’esterno» 54.
78
Era stato Moses Mendelssohn, in via definitiva nelle Morgenstunden
del 1785 55, a distinguere dall’atteggiamento conoscitivo – per mezzo
del quale io modifico i miei concetti per adeguarli alla realtà dell’oggetto – la facoltà di apprezzamento estetico, che mi conduce viceversa
ad agire in vista del mio stato d’animo, e dunque a plasmare in ragione
del mio sentire estetico la configurazione dell’oggetto; e Mendelssohn,
come si ricorderà, individuava con chiarezza nell’illusione estetica lo
strumento perché ciò avvenga.
Gehlen ne riprende in certo modo il gesto teorico quanto al primo
aspetto; quanto al secondo, prevale adesso decisamente l’attenzione
per la configurazione, ovvero per la traduzione del circolo dell’azione
in cui si realizza l’esperienza umana in un comportamento «in qualche
modo tecnicamente determinato» 56. Anche per questa via, dunque,
l’ambito della tecnica costituisce l’orizzonte in cui si iscrive per Gehlen
il problema dell’esperienza estetica.
Possiamo chiederci a questo punto se tutto il percorso sin qui seguito da Gehlen non possa essere ulteriormente illuminato mettendo
in relazione la “motorica particolare” coinvolta nel nostro apprezzamento estetico, la “motorica soppressa” se mi si passa l’espressione,
con quella motilità periferica che lo stesso Gehlen aveva ritenuto esser
così caratteristica dell’espressione delle emozioni, e nella quale aveva
trovato in certo modo un residuo di un movimento istintivo, lo sfogo
non pratico di una scossa sensoriale. È questa la via che, in uno straordinario saggio del 1925, era stata effettivamente seguita da Helmuth
Plessner e Frederik Buytendijk 57.
Mi limito in questo caso a qualche indicazione più rapida, solo
per circoscrivere un insieme di problemi teorici che richiederebbero
ben altro approfondimento: si diceva intanto dei referenti settecenteschi della teoria del movimento espressivo, referenti che restano per
la verità impliciti nel saggio del 1925, per esser esplicitati solo in alcuni lavori assai più tardi di Buytendijk 58, nonché nelle ricerche di
Klages 59. Faccio riferimento in particolare alle riflessioni di Schiller
sulla relazione fra movimenti volontari e movimenti simpatetici, sviluppate nel celebre saggio su Grazia e dignità 60. E vediamo brevemente:
i movimenti volontari sono quelli che il soggetto prescrive al corpo
per mezzo della volontà; quelli involontari avvengono invece senza
concorso della volontà 61. Questi ultimi cioè avvengono secondo una
legge necessaria, ma tuttavia per impulso e sull’occasione di un affetto. I movimenti involontari, o appunto simpatetici, accompagnano un
sentimento, da cui si occasionano: «la volontà quale causa di quelli si
determina secondo sentimenti morali, dai quali nascono questi» 62. E
tuttavia è decisivo che mentre i movimenti volontari seguono a una decisione, sono cioè effetto di una determinata finalità dell’azione, non di
una persona e del suo stato d’animo, il movimento simpatetico invece
79
accompagna lo stato d’animo. Il legame dei movimenti volontari con
lo stato d’animo è dunque accidentale, quello dei movimenti simpatetici è necessario. Il movimento simpatetico esprime dunque la natura
dell’anima assai più di quanto non faccia il movimento volontario, che
l’anima, diremmo, meramente dirige: «non si può nemmeno dire che
lo spirito si manifesti in un movimento volontario, poiché esso esprime
solo la materia della volontà (lo scopo), ma non la forma della volontà
(lo stato dell’animo)» 63.
Analoga a quella schilleriana fra movimenti volontari e simpatetici
la distinzione proposta da Plessner e Buytendijk fra azione (Handlung)
e movimento espressivo (Ausdrucksbewegung): se cioè la prima temporalmente scorre mirando ad un determinato fine esterno alla configurazione assunta dal movimento in quanto tale, il secondo invece
dura nella configurazione stessa del movimento, «ha il suo fine in sé, si
compie in sé stesso, secondo la propria essenza non è finalisticamente
orientato verso alcunché» 64.
Come intendere dunque la natura del movimento espressivo, e con
ciò alla lettera la possibilità della comprensione dell’altro, o meglio, in
senso più peculiare, della configurazione espressiva del vivente? Il ritmo, la configurazione dinamica del movimento espressivo – osservano
Plessner e Buytendijk – si aprono a una comprensione solo se considerati a partire dalla relazione dell’organismo vivente con l’ambiente 65; si
tratterà dunque di considerare la sfera del comportamento (Verhalten,
Benehmen) in cui si costituisce il senso della relazione ambientale fra
organismo e realtà, indifferente alla contrapposizione fra corpo e spirito come a quella fra soggetto e oggetto 66, e di considerare le forme del
movimento come forme del comportamento del corpo vivente (Leib).
Essenziale alla comprensione del vivente è appunto l’attivo relazionarsi
ad un ambiente; di più, all’unità della configurazione strutturale del
corpo vivente appartiene proprio il suo indirizzarsi verso un ambiente esso stesso strutturato, configurato (eine gestaltete Umgebung, dice
Plessner 67). C’è dunque una reciprocità fra organismo e ambiente
nel processo di costituzione del senso, ovvero, come affermano i nostri autori, «questa intenzionalità ambientale del corpo vivente (Leib)
[…] garantisce tramite la sua indifferenza soggettivo-oggettiva l’unità
dell’esperienza con gli oggetti dell’esperienza» 68, ed è proprio questa reciprocità e questa indifferenza nei confronti della scissione fra
soggetto e oggetto a costituire la sfera per eccellenza aisthetica dell’esperienza 69. La riflessione di Plessner degli anni Trenta e Quaranta
– da Sensibilité et raison sino al celebre saggio su Il riso e il pianto 70
– si occuperà di declinare in senso storico la categoria dell’esperienza
aisthetica del corpo vivente. Il corpo, dirà Plessner in Sensibilité et
raison, è una categoria storica, e storicamente si struttura l’esperienza
della configurazione espressiva del vivente 71.
80
J. Dewey, Arte come esperienza, Palermo 2007.
Questa e le cit. precedenti ivi, p. 61.
3
Ivi, p. 67.
4
Id., The Development of American Pragmatism, cit. nell’introduzione di G. Matteucci alla cit. ed. it. di Arte come esperienza, p. 9.
5 Id., Human Nature and Conduct, New York 1930, ed. it. Firenze 1958.
6 A. Gehlen, Vom Wesen der Erfahrung, in “Blätter für deutsche Philosophie”, 10,
1936, pp. 207-24. Il saggio è stato ripubblicato in Id., Anthropologische Forschung,
Hamburg 1961, pp. 26-43, nuova ed. it. Prospettive antropologiche, Bologna 2005, pp.
45-67; si veda anche Id., Gesamtausgabe, Bd. 4, Philosophische Anthropologie und �����
Handlungslehre, Frankfurt am Main 1983, pp. 3-24.
7 A. Gehlen, Prospettive antropologiche, cit., p. 46.
8 A. Baeumler, Ästhetik, München 1934; ed. it. Estetica, Padova 1999, p. 74, e cfr.
p. 71. Gehlen contrappone al modello kantiano e post-kantiano di esperienza quello
aristotelico, cfr. A. Gehlen, Prospettive antropologiche, cit., pp. 47-48.
9 A. Gehlen, Prospettive antropologiche, cit., p. 48.
10 H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch (1928), in Id., Gesammelte Schriften, vol. IV, nuova ed. Frankfurt am Main 2003, ed. it. Torino 2006, p. 16.
Plessner si riferisce al cit. Human Nature and Conduct.
11 A. Gehlen, Prospettive antropologiche, cit., p. 48.
12 Ibid.
13 Ivi, p. 55.
14 E. Rothacker, Die Schichten der Persönlichkeit (1938), Bonn 1966, p. 51. Per
quanto riguarda Uexküll si veda riassuntivamente J. von Uexküll, Bedeutungslehre
(1940), in J. von Uexküll e G. Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und
Menschen – Bedeutungslehre, Hamburg 1956. Su questi problemi mi si permetta di
rinviare al mio Forma e tempo nell’antropologia storica a cavallo della metà del Novecento, in “FIERI. Annali del Dipartimento di Filosofia, Storia e critica dei Saperi”, n.
4, Palermo 2006, pp. 419-37.
15 A. Gehlen, Prospettive antropologiche, cit., p. 57.
16 Ivi, p. 60.
17 Id., Der gegenwärtige Stand der anthropologischen Forschung, in “Merkur”, V, 4,
1951, pp. 379-389; ora in Id., Gesamtausgabe, Bd. 4, Philosophische Anthropologie und
Handlungslehre, cit., pp. 113-26, qui pp. 120-21.
18 Cfr. ad es. A. Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen, Hamburg
1956, pp. 68-80.
19 A. Gehlen, Der gegenwärtige Stand der anthropologischen Forschung, cit., p.
120.
20 L. Bolk, Das Problem der Menschenwerdung, Jena 1926, ed. it. Roma 2006.
21 A. Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940), nuova
ed. Wiesbaden 1986, ed. it. Milano 1983, p. 35.
22 Si veda ad es. il cit. J. von Uexküll e G. Kriszat, Streifzüge durch die Umwelten
von Tieren und Menschen.
23 Cfr. A. Gehlen, Der Mensch, cit., pp. 143-44, ed. it. cit., pp. 176-77.
24 Mi riferisco in senso specifico ai §§ 6 e 7 del cit. Vom Wesen der Erfahrung.
25 Cfr. Id., Die Seele im technischen Zeitalter, Hamburg 1957, pp. 17-18.
26 Ivi, p. 19.
27
Ivi, p. 15.
28
Id., Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen (1961), pubblicato per
la prima volta nel cit. Anthropologische Forschung, pp. 104-26, ed. it. cit., pp. 149-79,
qui a p. 149.
29 Ivi, p. 150.
30 Ibid. Trad. modificata.
31 Ivi, p. 155. Trad. modificata.
32 Ivi, p. 156.
1
2
81
Ivi, p. 170.
Id., Der Mensch, cit., p. 30, ed. it. p. 56.
35
Id., Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen, cit., ed. it. p. 157. Qui
Gehlen si basa sulla ricerca di Otto Storch, Die Sonderstellung des Menschen in Lebensabspiel und Vererbung, Wien 1948; cfr. specialmente la discussione del concetto di
Umwelt (ambiente) alle pp. 36-46.
36 Idem, Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen, cit., ed. it. p. 159.
37 Ibid.
38 Ivi, p. 166.
39 Si veda del primo almeno il già cit. Die Schichten der Persönlichkeit, e del secondo Aufbau der Person, München 19525, originariamente apparso nel 1938 col titolo
Der Aufbau des Charakters. Ci interessano i concetti di Tiefenperson e di Endothymer
Grund.
40 A. Gehlen, Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen, cit., ed. it. p. 169.
Trad. modificata, e cfr. l’ed. tedesca, p. 119.
41 H. Belting, Bild-Anthropologie, München 20063, p. 241.
42 A. Gehlen, Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen, cit., ed. it. p. 170.
Trad. modificata.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Gehlen per la verità si limita a un rinvio generico alla seconda sezione, ma direi
in modo più circoscritto che è il § 18, Bewegungssymbolik, in A. Gehlen, Der Mensch,
cit., pp. 188-93, ed. it. cit. pp. 223-29, ad esser pertinente ai nostri problemi.
46 Id., Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen, cit., ed. it. cit., pp. 17071.
47 Ivi, p. 171, si è profondamente modificata la trad. it., che stravolge il senso dell’originale; cfr.l’ed. tedesca, p. 121.
48 Ivi, p. 172. Ancora una volta la trad. it. è da modificare.
49 Ivi, p. 173, trad. modificata.
50 A questo punto Gehlen può anche sperimentare una variazione del detto kantiano affermando che «bello è ciò che piace senza conseguenze» (ivi).
51 Ivi, p. 173, trad. modificata, e cfr. l’ed. tedesca, p. 123.
52 Ivi, p. 174.
53 Ivi, pp. 175-76, trad. modificata, e cfr. l’ed. tedesca, pp. 124-25.
54 Ivi, p. 175, trad. modificata.
55 M. Mendelssohn, Morgenstunden, Stuttgart 1979.
56 A. Gehlen, Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen, cit., ed. it. cit.,
p. 176.
57 F. J. J. Buytendijk e H. Plessner, Die Deutung des mimischen Ausdrucks. Ein
Beitrag zur Lehre vom Bewusstsein des anderen Ichs (1925), in H. Plessner, Ausdruck
und menschliche Natur, in Gesammelte Schriften, vol. vii, nuova ed. Frankfurt am Main
2003, pp. 67-129.
58 Cfr. F. J. J. Buytendijk, Allgemeine Teorie der menschlichen Haltung und Bewegung, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1956; parzialmente ripreso in Id., Die Anmut, in F.
J. J. Buytendijk, P. Christian, H. Plugge, Über die menschliche Bewegung als Einheit von
Natur und Geist, Schorndorf bei Stuttgart 1963, pp. 9-18.
59 Si vedano i lavori oggi raccolti in L. Klages, Werke, vol. 6, Ausdruckskunde,
Bonn 2000, e specie Prinzipielles bei Lavater (1901), pp. 3-12; e il capitolo su Schiller
in Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck (1936), pp. 528-31.
60
Fr. Schiller, Über Anmut und Würde, in Id., Theoretische Schriften, cit., pp. 33094; ed. it. in Id., Saggi estetici, a cura di C. Baseggio, Torino 1959, pp. 137-202. Mi
permetto di rinviare in proposito al mio Antropologia e retorica della dignità in Schiller,
in “Ágalma. Rivista di studi culturali e di estetica”, n. 11, 2006, pp. 69-79.
61 Cfr. ivi., ed. it., p. 154.
62 Ivi, p. 155.
33
34
82
63
64
90.
Ivi, pp. 156-57.
F. J. J. Buytendijk e H. Plessner, Die Deutung des mimischen Ausdrucks, cit., p.
Ivi, pp. 77-79.
Cfr. ivi, pp. 87-89.
67
Ivi, p. 80.
68
Ivi, p. 122.
69
Cfr. in tal senso specialmente le conclusioni del saggio, ivi pp. 128-29.
70
Cfr. Id., Sensibilité et raison. Contribution à la philosophie de la musique (1936),
in Id., Gesammelte Schriften, vol. vii, cit., pp. 131-83; Id., Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen Verhaltens (1941), ivi, pp. 201-387, ed. it. Milano
2000. Parte dell’originaria redazione tedesca di Sensibilité et raison è adesso edita in Id.,
Politik Anthropologie Philosophie. Aufsätze und Vorträge, München 2001, pp. 119-43.
71
Cfr. Id., Sensibilité et raison, cit., p. 136 e pp. 161-62.
65
66
83
Fenomenologia ed esperienza estetica
di Elio Franzini
Il termine “esperienza” è, notoriamente, uno dei più ambigui presenti all’interno del vocabolario filosofico, al punto che è quasi sempre
necessario un aggettivo che lo qualifichi, delineandone l’orizzonte tematico. Il problema si aggrava nel momento in cui si usa l’esperienza per
tradurla in movimento filosofico, costruendo l’empirismo. Empirismo
che è soltanto un modo – di straordinaria importanza storica – per
delineare il concetto di esperienza, ma che certo non ne esaurisce la
densità sia teorica sia storica.
Questo legame con l’empirismo sembra perseguitare la fenomenologia, come se Husserl non fosse stato, a questo proposito, di straordinaria chiarezza. Locke – ed è difficile non concordare con lui – è
empirista solo per i manuali, dal momento che opera come uno psicologo della conoscenza, mentre Hume è apprezzato proprio nella parte
“non empirista” del suo pensiero, quello in virtù del quale si presenta
come il primo tentativo sistematico di una scienza delle pure datità
di coscienza, la cui fenomenologia ha come difetto proprio quelli di
essere “empirica e sensistica”.
L’esperienza per la fenomenologia non può dunque essere quella
dell’empirismo di Hume, notoriamente definito da Husserl, sin dagli anni Venti, come la «bancarotta della conoscenza oggettiva» o, in
modo più radicale, la bancarotta di «ogni filosofia che intenda dare
chiarimenti scientifici sul mondo mediante la scienza della natura o
la metafisica» 1, che finisce così per essere la bancarotta di qualsiasi
conoscenza.
È noto come Husserl risolva la questione, ovvero spostandola sul
piano di un’esperienza trascendentale, che non è ricerca dei modi per
costituire un’esperienza possibile, bensì il tentativo di coglierne le condizioni di possibilità. Non si può ignorare che in questa esigenza vi sia
l’eco dell’avvio della Critica della ragion pura, in virtù della quale se è
vero che ogni nostra conoscenza incomincia con l’esperienza, tuttavia
da ciò non segue che essa derivi interamente dall’esperienza. D’altra
parte, è chiaro che anche questa affermazione kantiana – che avvia la
problematica della sintesi a priori – non può soddisfare, proprio per
il rovesciamento di tale sintesi che la fenomenologia propone.
Non mi soffermerò, considerata la loro notoria complessità, sui mo85
tivi di tale assenza di soddisfazione, limitandomi a osservare che nella
nozione sia humeana sia kantiana di “esperienza”, manca un concetto
qui centrale, ovvero quello di percezione, che qualifica l’esperienza per
il fenomenologo. Una percezione che non è “conoscenza del mondo
esterno” (espressione che di per sé non significa proprio nulla, e che
implica una strana dicotomia tra un occhio e un mondo, come se fossero realtà del tutto distinte), ma tentativo di cogliere le operazioni
connesse all’esperienza del percepire, vederne l’essenza, che non è un
dato immutabile da descrivere, bensì le strutture costanti che si rivelano nei suoi atti.
Esperienza è dunque, in prima istanza, e al di là dei molteplici
giochi linguistici che intorno a essa possono instaurarsi, la percezione
in quanto capacità «che ci pone alla presenza di oggetti, e proprio nei
modi e nelle forme in cui essa si differenzia» 2. Ma, in un accezione
più ampia, è esperienza, sono esperienza, tutti quei “modi” che, “a
loro modo” ci mettono alla presenza di oggetti. Per cui, appunto, in
un’accezione più ampia, anche il ricordare è un’esperienza «di cui è
possibile determinare i modi di operare» 3, come peraltro sono esperienza l’immaginare, il desiderare, gli stati emotivi e via dicendo.
Si sarà allora compreso che non si nega affatto la vastità e la genericità della nozione di esperienza – peraltro dimostrata dalla storia
stessa del pensiero, del linguaggio comune, delle idee, ecc. – ma che
la questione non è quella di fissarne, magari solo linguisticamente, una
o plurime definizioni, bensì di indicare suo tramite «uno spazio aperto
di problemi» 4.
Ciò significa che l’esperienza che diciamo estetica (fermo restando
che, nell’accezione sopra riportata, a rigore tutte le esperienze sono
estetiche) è una modalità di questo spazio descrittivo che si apre, di
cui si devono dispiegare le “funzioni intellettuali”, nell’ovvia consapevolezza che l’intelletto «non è un complesso di dispositivi predisposti
da proiettare sull’esperienza, ma ha le sue radici nell’esperienza stessa
in quanto essa si auto-organizza nelle forme di correlazione necessaria
tra i dati della sensibilità e la soggettività concreta che li riceve» 5. Per
cui alla via trascendentale-kantiana che procede dal giudizio all’esperienza contrapponiamo una via che procede dall’esperienza al giudizio
– senza con ciò ricadere in forme di riduzionismo empirista.
In questa direzione non si ha una definizione astratta o empirica
delle rappresentazioni estetiche, ma esse si determinano in una “correlazione necessaria” che va indagata nelle sue specifiche modalità intenzionali. L’esperienza dell’arte è dunque un modo particolare di esperienza
estetica, che determina una correlata esperienza giudicativa. In sintesi,
sul piano dell’analisi descrittiva va in prima istanza precisato che cosa
si possa intendere con “esperienza estetica”, in seguito stabilendo come
tale esperienza possa diventare “artistica”.
È chiaro che, su questa strada, anche Dewey può fornire utili in86
dicazioni fenomenologiche, proprio perché si muove dall’esperienza
verso il giudizio. In un saggio dei tardi anni Cinquanta, infatti, Formaggio osserva che egli è un autore che «non ama le nebbie delle
estreme astrazioni metafisiche» e piuttosto «s’immerge nel concreto
delle esperienze divenienti, ascolta ed opera in esse» 6. La teoria dell’esperienza deweiana ha dunque un suo significato fenomenologico in
quanto, come osserva Formaggio, denuncia le fratture che attraversano
il pensiero e la prassi del nostro tempo, proclamando al tempo stesso
«la necessità di ristabilire la continuità». Ciò accade proprio attraverso
l’idea di percezione, o coscienza, o idea che sono «l’esperienza stessa,
il flusso stesso degli eventi, nel momento di crisi in cui ciascuna cosa
sboccia in significato» 7. Dewey permette così di delineare un concetto
di esperienza che porta con sé principi di connessione e organizzazione, rendendo inutile, come egli stesso osserva, una sintesi sovrannaturale o sovraempirica, e ponendo invece l’intelligenza come un fattore
di organizzazione all’interno dell’esperienza.
Questo aspetto, peraltro, che segna, come giustamente scrive Matteucci 8, la sua posizione eccentrica rispetto alla tradizione cartesianokantiana, è anche il segnale di una comune eccentricità, che proprio in
un’idea di autorganizzazione dell’esperienza e del suo senso intrinseco,
vede operante, negli stessi decenni, la tradizione dell’estetica fenomenologica (che forse potrebbe essere studiata anche attraverso il lavoro
di William James).
È tuttavia indubbio che, se si esce da un’ispirazione generale – che
peraltro non può essere sottovalutata – le analogie svaniscono nel momento in cui, approfondendo Dewey, si coglie la sua idea di esperienza
connessa all’interazione tra organismo e ambiente, che se da un lato
è utile per spazzare artificiose dicotomie, e per sottolineare il valore
sociale dell’estetico e dell’artistico, dall’altro enfatizza una visione priva di quei connotati “conoscitivi” che sono invece un caposaldo del
descrittivismo fenomenologico, e che, come già si è osservato, vedono l’esperienza solo come “modo operativo”, rifuggendo da una sua
“naturalizzazione”, che è solo l’aspetto uguale e contrario di un’altrettanto equivoca sua psicologizzazione. La distinzione tra contenuto apprensionale e apprensione, che è un caposaldo essenziale per la
fenomenologia, non può incontrarsi con la sostanziale identificazione
tra l’esperienza e i suoi modi di apprensione che si ricava da Dewey.
Tuttavia – ed è un punto dal quale si può ripartire – è significativo
che sia per la fenomenologia sia per Dewey il campo estetico-artistico
sia un orizzonte esperienziale in cui si verifica il senso stesso dell’esperienza, della sua operatività e dei modi in cui essa si articola, permettendo così di sfuggire a quegli orizzonti critici che vorrebbero cogliere
l’apprensione, lo studio e l’analisi del fenomeno artistico in una sua
astratta autonomia, separata dalla concreta prassi esperienziale, da una
sua funzione espressiva e comunicativa. Si ha invece consapevolezza,
87
come ancora scrive Formaggio, che compito dell’estetica non è quella
di discutere sull’arte, sulle sue opere, sulla loro “attualità”, sui molteplici risvolti delle sue più o meno ideologiche poetiche, bensì quello di
«reintegrare l’esperienza artistica ed estetica nell’esperienza ordinaria»,
qui descrivendo «i rapporti di distinzione-relazione che all’interno di
questa si possono rintracciare» 9. La posizione di Dewey è qui chiara,
e coincide con quella di certa tradizione fenomenologica, Dufrenne
in prima istanza: scoprire, attraverso l’esperienza estetico-artistica, la
qualità estetica dell’esperienza stessa. Cogliere, come avrebbe detto
Dufrenne, come dall’esperienza ordinaria si possa afferrare il senso
dell’esperienza estetica e, da qui partendo, cercare il potere espressivo
e ontologico dell’esperienza stessa, il suo valore simbolico, in modo
che l’arte diventi testimonianza di una possibilità antropologica, quella
di «trascrivere ed organizzare in ritmo ed equilibrio le energie viventi
del mondo» 10.
Allo stesso modo, e proprio perché non ha senso “definire” l’esperienza, va osservato che se è termine che non tutta la tradizione fenomenologica ama e apprezza (centrale in Husserl, ben presente in
Dufrenne, è invece termine quasi del tutto assente nella prima estetica
fenomenologica tedesca e, elemento che può destare maggior stupore,
anche in Merleau-Ponty), viene comunque sempre considerato come
un modo per afferrare le relazioni estetiche tra il soggetto corporeo e il
suo mondo circostante, al fine di formare un “intero”, di cui le qualità
si determinano attraverso una rete di atteggiamenti, intenzionalizzazioni, determinazioni qualitative. Descrizione, analisi trascendentale e
ricerca del significato metafisico – che sono poi i tre obiettivi che Dufrenne pone per la sua fenomenologia dell’esperienza estetica – sono
su un piano comune, che è quello attraverso il quale, al di là di ogni
psicologismo, si è consapevoli che «la coscienza che si volge all’oggetto
è costitutiva, ma a condizione che l’oggetto si presti alla costituzione»,
dal momento che «la sussunzione è possibile soltanto se si presuppone
un’autocostituzione dell’oggetto che comprende in qualche modo il
soggetto, soggetto e oggetto essendo un momento assoluto di cui la
finalità è testimone» 11.
Siamo così all’interno di una prospettiva che, in modo esplicito,
prende avvio da un’antropologia per concludersi in un’ontologia, dove
l’unità carnale e organica di soggetto e oggetto costituisce un insieme che definisce la vita stessa dell’esperienza estetica, all’interno della
quale l’opera d’arte si pone come campo privilegiato, quello che potrà
con maggiore sicurezza «condurci all’oggetto estetico e all’esperienza
estetica» 12. La conclusione della fenomenologia dell’esperienza estetica
è così, per Dufrenne, un’ontologia che, sulla scia di Merleau-Ponty,
vede nell’incontro ontologico dei due piani la destinazione finalistica
dell’esperienza estetica, che assume, in rinnovata analogia con Dewey
(pur mai citato da Dufrenne), aspetti espressivi, dove l’espressione è
88
caratterizzata da quella stessa interattività che si ritrova in Arte come
esperienza. In tutti questi casi, pur separati da impostazioni, tradizioni
e finalità teoriche, si ritrova sempre una specie di quello stesso elogio
naturalistico dell’organico di cui sono grandi esempi Diderot o ����
Goethe, che è più rifiuto ideologico di forme precostituite di determinismo,
meccanicismo e, all’opposto, di psicologismo ed empirismo ingenuo
che precisa opzione teorica. Opzione che invece costituisce l’ossatura
dell’argomentazione di Dufrenne: perché, se esperienza estetica è la
correlazione intenzionale di soggetto e oggetto, e se quest’ultima realizza il suo senso eidetico come sintesi passiva, si tratta di descrivere
lo svolgersi modale di questo incontro, cioè gli atti che illuminano i
punti di vista che meglio dispiegano le qualità intrinseche all’oggetto
estetico.
Pur viziata da qualche retaggio humeano, e da alcune utilizzazioni non rigorose di Husserl, la descrizione dufrenniana dell’esperienza
estetica ha comunque fatto scuola. Anche senza indulgere in particolari
analitici, è importante sottolineare che qui, come in Dewey, vi è una
centralità di un piano percettivo, visto non come isolamento atomistico, ma in quanto dinamicità attiva. Esperienza è così, in prima istanza,
rifiutando Sartre e il suo elogio idealistico e nullificante dell’immaginazione e della sua eterea libertà, lo svolgersi della percezione, che è in
prima istanza presenza estetica e capacità di costruire rappresentazioni
che si sottopongono a un’attenzione riflessiva. Se questo è dunque il
piano generale dell’esperienza, vi sono oggetti che “richiedono” un
diverso atteggiamento ricettivo, cioè un diverso modo esperienziale,
in quanto esprimono (e questo termine va ovviamente sottolineato) un
universo di senso che il piano presenziale e quello rappresentazionale
non esauriscono. Alle qualità intrinseche a questi oggetti – che Dufrenne chiama, sulla scia della terza Ricerca logica di Husserl, gli apriori
materiali dell’affettività, che è la loro intrinseca espressività – corrisponde un’espressività del soggetto che viene chiamata “sentimento”,
che è un modo per cogliere la “profondità” dell’oggetto stesso.
Vi è, a questo punto, un’implicita divaricazione, che Dufrenne stesso sottolinea. Se si segue infatti l’aspetto organicistico ed empatico
della relazione espressiva e sentimentale con l’oggetto estetico, sorge
la domanda su che cosa esso si fondi, introducendo quell’ipotesi organicistica cui si accennava, che ha esiti ontologici. Se si lascia cadere
questo aspetto, ci si concentra invece sulla relazione sentimentale ed
espressiva, chiedendosi che significato abbia la “profondità” espressiva e sentimentale che rende possibile quella particolare tipologia di
esperienza che è chiamata “estetica”, esperienza dove la percezione
e la rappresentazione tendono “al di fuori” di sé, verso territori descrittivi che, a partire dal visibile, hanno come orizzonte l’invisibile o
il sovrasensibile.
Scegliendo questo percorso, al centro dell’esperienza estetica si
89
pone quel particolare oggetto che eccede la percezione “ordinaria”,
che con le sue sintesi estetiche stimola l’attenzione sinergica di un
corpo vivo organico e operante: oggetto che, appunto, si è chiamato “opera d’arte”. L’esperienza estetica non è esperienza dell’arte, ma
l’arte è l’orizzonte estetico che permette di far venire in luce il senso
espressivo dell’esperienza stessa, la forza sentimentale e organica di un
corpo proprio, che è, come tutti gli autori citati potrebbero dimostrare
da vari angoli di visuale, il vero protagonista dell’esperienza estetica,
sulla scia di quel che Husserl scrive nel secondo volume di Idee e nelle
Meditazioni cartesiane. Senza il Leib, e le cinestesie che ne costituiscono
la prassi descrittiva e operativa, non sarebbe possibile porsi nell’orizzonte dell’esperienza estetica, che è capacità di cogliere nella variazione
immaginativa l’essenza delle cose stesse, che non è nulla di immutabilmente platonico – come spesso ancora non si comprende – bensì una
struttura corporea, una struttura d’esperienza. È una corporeità che,
come scrive Formaggio, è «una emergenza polifonica da molti contesti» e che dunque «chiede di essere considerata in tutta la sua ampia
complessità fenomenologica» 13 perché è solo da questa che il corpo
può apparire come «qualcosa di geneticamente dinamico, qualcosa che
non è mai un se stesso, poiché è sempre il sé e l’altro» 14. Un corpo,
quindi che, come afferma Husserl, ma come si può desumere anche
da Dufrenne, nel suo essere Leib, corpo vivo e vivente, muta, proprio
in virtù della sua costitutiva dinamicità, i suoi atteggiamenti descrittivi,
cercando nelle anse percettive non solo rappresentazioni, prospezioni
immaginative, nessi memorativi, cause finali ed efficienti, bensì, ove
l’oggetto lo richieda, interrogando in questa direzione la percezione,
orizzonti motivazionali, qualità espressive, contenuti spirituali.
Un corpo in movimento è il motore mobile di un’esperienza dinamica, che su di esso disegna i suoi percorsi: ed è questa la mobilità
di un’esperienza estetica che cerca sempre di nuovo, attraverso l’arte
e i suoi complessi piani motivazionali, di uscire dalle strettoie della
ripetitività, della “museificazione”: sia Dewey sia Dufrenne, attraverso
la mobilità organica dell’esperienza espressiva del corpo, vedono un
modo per “liberare” l’esperienza, liberando con essa l’arte. L’opera,
scrive Dufrenne, «deve offrirsi alla percezione: deve essere eseguita
per passare in qualche modo da un’esistenza in potenza a un’esistenza
in atto» 15. L’arte autentica, aggiunge, «è una parola originale che al
tempo stesso desta un sentimento e scongiura una presenza, più che
recarci un senso concettuale» 16.
Lo schema dell’esperienza estetica ha dunque una sua lineare
chiarezza concettuale: possiede una struttura percettiva, una concettualizzazione rappresentazionale, una organica mobilità corporea, che
diviene espressività e sentimento quando un oggetto estetico denso di
“profondità” – che la tradizione chiama “opera d’arte” – sollecita una
percezione a sua volta più “profonda”, una tipologia di esperienza che
90
è antropologica, organica, fors’anche ontologica, una percezione che
non può rimanere rinchiusa in una “istituzionalizzazione” dell’artistico
proprio perché, per dirla con Dewey, «l’opera d’arte ha una qualità
peculiare, che è, però, quella di chiarire e concentrare significati che
sono contenuti in modo disperso e debole nel materiale di altre esperienze» 17.
Ci si può chiedere, a questo punto, che cosa tutto ciò significhi,
e soprattutto a che cosa conduca. Il significato generale è, si ritiene,
evidente, e ha anche recentemente trovato vari avversari in alcune manifestazioni della filosofia analitica. Infatti, se l’esperienza estetica definisce il suo più alto livello di consapevolezza avendo di fronte l’oggetto
artistico, anche quest’ultimo non può che sprigionare il suo senso se
non inserendosi nei processi di questa stessa esperienza, nelle dinamiche
motivazionali, storiche e intersoggettive che stratificano la dottrina e la
prassi dell’esperienza – che è sempre esperienza corporea, intercorporea
connessa agli atti della percezione e delle sue modificazioni immaginative e memorative. Un’arte senza estetica – posta, come avrebbero
detto Banfi e Formaggio, in un’astratta autonomia – può forse essere
oggetto di ricerche critiche, iconologiche, linguistiche, storiche, non di
una dinamica filosofica di carattere conoscitivo. È questo un caposaldo
che, se unisce Dewey e la fenomenologia, è anche perché fa da spartiacque tra ricerche, segnando differenze che troppo spesso si preferisce
ammorbidire o annegare in raffinatissime storie delle idee. Se le opere
d’arte sono forme di vita, ebbene, la vita non è quella del linguaggio,
ma della prassi esperienziale e corporea, pur coniugata secondo differenti e articolate modalità.
L’analisi di singole esperienze, di singole forme di vita artistiche,
non dice nulla sul significato generale del processo: è soltanto una
forma di empirismo, non sempre raffinato, che riporta ogni cosa a un
orizzonte fattuale che si può definire solo come pre-critico (in senso
kantiano) o addirittura, per dirla ancora con Banfi, «pregalileiano».
Si eserciti pure lo sguardo, più o meno definitorio, sull’arte o sulle
sue singole esperienze, purché non si dimentichi il monito aristotelico,
da cui la filosofia ha preso avvio, cioè che del particolare non si dà
scienza. La singola esperienza, l’esempio, deve cercare di far risalire
alla condizione di possibilità, ovvero al valore generale conoscitivo
dell’esperienza estetica dell’arte. È significativo che molte esperienze
della cosiddetta arte concettuale – che sembrerebbe un mero elogio
del linguaggio accompagnato da una anestetizzazione dell’esperienza
estetico-artistica – possa in realtà condurre in tutt’altre direzioni. Infatti, come ben osserva Migliorini 18, a partire da Duchamp e dalla sua
volontà di “annullare” la definizione dell’arte, si vede nell’arte non un
luogo sacrale e museale, da sottoporre alle raffinate indagini dei critici
e dei sociologi, bensì «il luogo dove si svolgono gli esercizi e i riti della
sensibilità».
91
È tuttavia indubitabile, come ancora osserva Migliorini 19, che siano
stati certi eccessi – peraltro proprio in stile con esperienze filosofiche
come quelle di Dewey o di alcune espressioni della fenomenologia – ad
avere originato «una ricerca nel senso opposto», che alla hyle preferisse,
con procedimento astrattivo, la morphè intenzionale (sviluppando, a rigore, un’altra direzione implicita nella fenomenologia stessa). È questo,
appunto, il primo risultato cui un’enfatizzazione del valore corporeo
dell’esperienza estetica può condurre, cioè alla restaurazione di una
nuova dicotomia, tutta giocata sulle raffinatezze analitiche, in cui cade
nell’oblio anche la più banale delle ovvietà, cioè che noi si esperisce
sempre con il nostro corpo, e che tale esperienza ha una sua struttura
che si definisce in processi e funzioni, e non in formule linguistiche
(cui pure è stato trasportato anche il pragmatismo, senza che in tale
trasformazione alcuna responsabilità si possa attribuire alle pagine di
Dewey).
Per evitare dunque che l’esperienza estetica, di cui già si è guardato
con sospetto la deriva sociologista e critica, convinta che vi sia “pensiero nuovo” ovunque si verifichi qualche “prassi nuova”, si ossifichi in
una contrapposizione tra “materia” e “forma”, rigettando la lezione di
Goethe, si tratta di avere ben presente, in conclusione che i due punti
di vista coesistono. Una coesistenza già ben compresa da Kant, al di
qua di dialettiche scissioni e riconciliazioni, nella consapevolezza che
ove si colgono i limiti speculari dell’empiria e del razionalismo, si deve
trovare lo spazio – e l’esperienza estetica è tale spazio – per una “comunicabilità”, dove comunicare significa in prima istanza un “mettere
in comune” una «prassi consentanea, compossibile e cosensibile, del
mondo» 20. Anche quando l’arte sembra diventare “linguaggio” o “parola”, come per esempio accade nelle esperienze dell’arte concettuale,
si deve quindi evitare l’equivoco che ciò accada per rigetto di regole
esperienziali, assumendo invece un paradigma linguistico o semiologico. Siamo invece di fronte a un trapasso da un universo segnico a un
altro di campo diverso non in virtù di una nullificazione dell’esecuzione
materiale, fisica, corporea, gestuale, bensì in un tentativo di cogliere i
sensi problematici della progettualità intrinseca all’esperienza estetica.
Di conseguenza, «proprio l’arte concettuale, anziché verificare una ineliminabile condizione linguistica dell’arte (come pur è stato detto), verifica, proprio all’opposto, una intransività dall’arte alla lingua o meglio
alla condizione linguistica, se non mettendo in scacco metaprogettuale
sia l’una sia l’altra» 21. Seguendo dunque le fila di un esempio, quello
dell’arte concettuale, Art after Philosophy di Kosuth, mettendo tra parentesi le sue notevoli ingenuità filosofiche, può indicare una direzione,
aporetica quanto il concetto di esperienza estetica. Sembra infatti che
Kosuth, basandosi sull’ovvia citazione da Wittgenstein, dica che «The
meaning is the use», mirando a determinare un concetto all’interno di
un “uso”, cioè sul piano di un gioco linguistico che non vuole né deve
92
verificare i suoi riferimenti. A ciò, peraltro, si accompagna un’esplicita
volontà di separare l’estetica dall’arte, intendendo con il primo termine
proprio ciò che connette percezione e bellezza, avendo a che fare, a suo
parere spesso in modo estetistico, con le “forme” decorative. Quando,
invece, si tratta di condurre l’arte al di fuori dell’esperienza estetica per
riportarla, come è nella logica dei ready-mades, nella quotidianità della
pratica percettiva. Come ben riassume Migliorini: «La forma dell’oggetto, la sua organizzazione, il suo presentarsi come tale alla sensibilità,
solo equivocamente possono essere riconosciuti come arte: l’artisticità
dell’oggetto, la sua appartenenza ai piani dell’arte è puramente occasionale, è dovuta all’intervento nei suoi confronti di qualcos’altro che
non sia la semplice oggettività, all’intervento cioè dell’idea, del concetto,
che attribuiscono un valore d’arte a ciò che ne è fondamentalmente privo. Ma l’arte, allora, l’artisticità, una volta sottratto l’oggetto nella sua
occasionalità, resta in sé pura e incontaminata, si presenta per essere
colta in quanto tale» 22.
La famosa espressione kosuthiana che «tutta l’arte (dopo Duchamp)
è concettuale (nella sua natura) perché l’arte esiste solo concettualmente» sembra dunque essere l’esplicito rifiuto di un edonismo morfologico e formalistico, che abbandonando l’esteticità ritiene che l’esperienza
dell’arte non sia propriamente estetica, bensì si riferisce alla sola contemplazione del concetto stesso di arte: in senso proprio, è artista solo
colui che non costruisce opere particolari attraverso specifiche forme o
generi dell’arte, bensì indaga e riflette sulla natura dell’arte. Concetto
che per Kosuth è a priori e che dunque, malgrado l’indagine, dovrà
essere considerato, come la matematica e la logica, in quanto struttura
formale priva di contenuti empirici e che, attraverso Linguaggio, verità
e logica di Ayer, finisce per essere riducibile a proposizioni analitiche
che ne esprimano le conseguenze formali. Da ciò è facile dedurre che
il piano di presentazione dell’arte è il linguaggio e quindi ogni sua
risoluzione esperienziale potrà essere solo linguistica e preposizionale.
L’unico modo per operare nel campo dell’arte è così quello «di derivare proposizioni analitiche nei confronti dell’arte (dell’artisticità come
autovalore)» 23.
Questa posizione ha un solo esito: se fare arte significa soltanto
«contemplare e definire la struttura formale dell’autovalore arte, le relazioni, forse, dell’autovalore con altri autovalori, in una ricerca infinita» 24, allora il risultato è soltanto il silenzio – e proprio un silenzio
dell’esperienza. A meno che, ed è ciò che accade a Kosuth pochi anni
dopo, in un saggio dedicato all’idea di “contesto”, si introduca in questa dinamica una visione contestuale dell’arte, dove però, come osserva,
il contesto finale ed essenziale è sconosciuto e non può esistere in alcun
modo riferibile a una Gestalt o a qualsiasi entità iconica implicita. Si
esce così da una definizione tautologica – e linguistica – dell’arte dal
momento che l’arte stessa rifiuta di essere definita. E tale rifiuto non
93
può che essere un ritorno all’esperienza, come se, alla fine, si fosse appresa la lezione di Goethe, comprendendo che gli “esperimenti” hanno
senso solo se inseriti nel quadro generale che ne pone le condizioni di
possibilità empiriche, e che si chiama, appunto, “esperienza”: la parola
è puro suono se non è sostenuta da un concetto, ma il legame tra il
concetto e il suono è comunque un evento estetico, che ha in sé un
elementi misterico
L’antica affermazione di Lewitt, per la quale «gli artisti concettualisti sono dei mistici piuttosto che dei razionalisti», torna dunque
di attualità: essi balzano a conclusione cui la logica – o, si può aggiungere, la parola come puro evento – non può giungere. La parola,
l’irriducibile alla forma, dell’arte concettuale si perde infatti qui in un
plotiniano anéideon, che è il segno dell’impossibilità dell’arte a essere
ricondotta a una forma, ma che è anche, al tempo stesso, «disperata
tensione verso un valore perduto o nascosto», tentativo «di indurlo ad
una impossibile rivelazione (quasi a una incarnazione del logos)» 25. La
parola è un nulla che esplode, un visibile che chiede di andare fuori
da sé, in un invisibile che nell’atto si incarna, sempre di nuovo.
Si sarà intuita la conclusione cui si voleva giungere: non soltanto
quella che bisogna arrivare ai limiti estremi della parola-concetto per
rovesciarne il nulla in valore comunicativo, ma anche che i processi
dell’esperienza estetica hanno nelle loro stesse condizioni di possibilità
quelle di non limitarsi al “dato” e alla sua “presenza” – sia esso una
forma empirica, un concetto, una parola, un atto – nel momento in cui
questo stesso “dato” richiede domande che mentre ne rivelano l’aspetto sensibile muovono, sempre e comunque, oltre la sua esteticità.
Se questo principio decade, perdendo nel frammento la propria
teleologia, confondendo l’intero e la parte, essa va “recuperata” nel
suo senso originario, cercandone l’attività di base, quella che si vede
in funzione nei processi della sensibilità e dove, con l’arte, ma non soltanto con l’arte, bensì in tutte quelle configurazioni il cui senso non si
limita al primo sguardo, essa si realizza attraverso strumenti simbolici,
in cui il giudizio esce dai limiti del linguaggio e coinvolge modalità
giudicative e fondative del nostro corpo vivo. Il senso del percorso
dell’esperienza estetica – che senso estetico e razionale insieme – va
cercato là dove appare originariamente, in quelle immagini sensibili
che fanno pensare, il cui senso è intrinseco ai dati che appaiono, alla
loro forza presentativa e rappresentativa. Le opere non si esauriscono
nella loro presenza, e apparenza, in quanto tali substrati conducono
alla questione della fondazione di un senso che rinvia a un processo di
formazione del senso stesso. È in tal modo che, al di là delle mistiche
dell’autonomia dell’arte, della parola, del linguaggio, della forma di
vita, del logos o dell’aisthesis, della forma o dell’immagine, una fenomenologia degli strati dell’esperienza estetica è sempre – da Giotto ai
concettualisti – il tentativo di chiarificare e ricomporre la frattura tra
94
visibile e invisibile, tra un significato legato alla presenza e uno che la
trascende, nella consapevolezza che la nostra esperienza del mondo,
che è l’esperienza stessa della ragione, non può limitarsi alla mera
visibilità e deve piuttosto, attraverso il visibile, senza il quale nulla
potrebbe essere conosciuto, avviare il recupero di una dimensione invisibile, cioè di una genesi profonda in cui si incrociano, senza mai
unificarsi in una tranquillizzante ontologia, i piani dell’immanenza e
della trascendenza.
Le rappresentazioni “simboliche”, le forme che hanno profonde
stratificazioni di senso, gli atti concettuali e le parole che le costituiscono, nelle intenzionalizzazioni di uno sguardo che indaga, appaiono
comunque come esperienze che generano al tempo stesso emozione e
ragionamento: non sono entità astratte, né esempi di svolte epocali cui
l’arte ci avrebbe condotto, bensì correlati di un’esperienza che è una
rinnovata interrogazione della complessa stratificazione degli atti del
rappresentare. Un’esperienza di tal genere non è però soltanto l’attestazione empirica di alcune attualità particolarmente “significative”, bensì,
loro tramite, mira a porre le condizioni di possibilità per un’interrogazione generale sul senso delle cose mondane: un senso che si fonda
certo sul loro apparire sensibile, ma ad esso non limita il loro valore
cognitivo, afferrandone invece le regole sulla base delle quali se ne
evidenziano le qualità intrinseche, le specificità espressive e significanti.
L’esperienza simbolica, il pensiero che da essa scaturisce, si radica nel
darsi stesso del sensibile, e nella forza immaginaria che in esso si pone,
nel divenire delle sue forme, nel celarsi in esse di mondi possibili,
nella convinzione che è da qui che si può avviare un “recupero” del
senso non contingente della conoscenza. Un senso che ha in queste
sintesi estetiche, quelle che Husserl chiama “sintesi passive”, che sono
il senso stesso dei dati empirici, una condizione di possibilità che non
è forma astratta, bensì conoscenza estetica del mondo, che sul piano
metodologico procede interrogandone e descrivendone le differenze,
gli strati di significato, le modalità dell’intuizione sensibile, le regole di
costituzione degli interi, gli intrecci di dimensioni temporali, tutti quei
modi d’essere il cui senso non si limita al “primo sguardo”.
Numerosi fondamentali testi di estetica o teoria dell’arte tra gli
anni Sessanta e Settanta, anche se di impostazione diversa, si trovavano
quasi costretti a confrontarsi con le variatissime posizioni sociologiche,
linguistiche, semiotiche, spesso tra loro commiste e occasionalmente
attraversate dalla psicanalisi. Le stesse opzioni di teoria critica o sociologica, tramontate nella loro autonomia ideologica, si sono, spesso
inconsapevolmente, riversate sul piano linguistico, disegnando una sorta
di autonomia dell’artisticità nel senso kosuthiano dell’arte come “autovalore”, spesso attraversato dalla banalizzazione irrispettosa dei giochi
linguistici di Wittgenstein sino alla deriva – a quella che per me è una
deriva – di un discorso analitico che riduce l’arte a linguaggio, dimen95
ticando l’aisthesis, il desiderio, il corpo, le sue operazioni di senso.
Forse è stato l’eccesso di “carne” a condurre a questa reazione uguale
e contraria, all’ambigua anestetizzazione linguistica dell’estetico o, al
contrario, alla sua autonomia linguistica che ne cancella la valenza di
pensiero simbolico cui abbiamo assistito negli ultimi trent’anni, l’orgia
di estetizzazione cui la quotidianità spesso conduce, facendo divenire
“estetica” anche le poetiche dei grandi scrittori del secolo scorso, confondendo dunque gli ambiti in una notte in cui tutte le vacche sono
nere, e tutti gli artisti filosofi.
Un testo come quello di Dewey, allora, oggi può avere il valore che
nel Seicento ebbero gli Essais di Montaigne: un richiamo, a fronte di
tutti i riduzionismi, alla salute dell’esperienza. Una salute che dall’arte o, meglio, dall’artisticità, dal legame tra l’artistico e l’estetico deve
riprendere avvio. Le utopie sociali sono superate, e sono la parte transuente della riflessione deweyana, ma non lo sono affatto le istanze
antropologiche, quelle che devono farci uscire dall’orgia incontrollata
dell’esperienza come esperienza linguistica – che non è affatto esperienza – per riportarci alla convinzione che è il pensiero, non la parola, che
noi coltiviamo. E il pensiero – mai si dimentichi l’incipit della Critica
della ragion pura – è cieco e vuoto senza l’esperienza (esperienza di
un’opera, di un cancello di ferro battuto, di un atelier ben fatto, come
quelli in cui passeggiava Diderot) perché la sua specificità antropologica
è proprio quella di comprendere, come scrive Dewey, che «la fame che
ha l’organismo di trovare appagamento attraverso l’occhio è a mala pena
inferiore al suo pressante bisogno di cibo».
1 E. Husserl, Storia critica delle idee, a cura di G. Piana, Guerini, Milano 1989,
p. 193.
2 G. Piana, Elementi di una dottrina dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1979,
p. 19.
3 Ivi, p. 20.
4 Ibidem.
5 Ivi, p. 217.
6 D. Formaggio, L’estetica di John Dewey, in D. Formaggio, Studi di estetica, Renon,
Milano 1962, p. 104.
7 Ivi, p. 109.
8 G. Matteucci, Presentazione a J. Dewey, Arte come esperienza, Aesthetica edizioni,
Palermo 2007, p. 9.
9 D. Formaggio, cit., p. 115.
10
Ivi, p. 119.
11
M. Dufrenne, Fenomenologia dell’esperienza estetica, Lerici, Milano 1969, p. 19.
Quest’opera di Dufrenne è del 1953. Di essa è stato tradotto in italiano solo il primo
volume.
12 Ivi, p. 31.
13 D. Formaggio, Arte, Mondadori, Milano 1981, p. 228.
14 Ibidem.
15 M. Dufrenne, cit., p. 67.
96
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Ivi, p. 206.
J. Dewey, cit., p. 103.
E. Migliorini, Lo scolabottiglie di Duchamp, Il Fiorino, Firenze 1970, p. 201.
Id., Conceptual Art, Il Fiorino, Firenze 1972, p. 12.
D. Formaggio, Arte, cit., p. 173.
Ivi, p. 178.
E. Migliorini, Conceptual Art, cit., p. 153.
Ivi, p. 158.
Ivi, p. 160.
Ivi, p. 164.
97
L’estetica come filosofia dell’esperienza
Rileggendo Dewey con Garroni
di Leonardo Amoroso
Il progetto di una rifondazione dell’estetica nel senso di una filosofia dell’esperienza è stato autorevolmente proposto e approfonditamente sviluppato da un autore che è un riferimento imprescindibile nella
storia recente dell’estetica italiana: Emilio Garroni. La sua proposta è
ben presente a tutti noi. Sarà dunque sufficiente che la richiami dapprima in maniera telegrafica, per passare subito dopo a valorizzare i
riferimenti e le critiche di Garroni a Dewey. Seguendo la via indicata
da Garroni, e sviluppandola come posso, cercherò di inquadrare l’opera di Dewey in un orizzonte più ampio: quello della definizione teorica
dell’estetica e, insieme, della riconsiderazione della sua storia.
L’estetica di Garroni è una «filosofia non speciale», come suona il
sottotitolo dell’opera in cui essa è stata per la prima volta proposta:
Senso e paradosso 1. Non è una parte, magari marginale, della filosofia,
dedicata a un’esperienza, quella dell’arte bella, tutto sommato secondaria rispetto ad altre forme di esperienza (quella conoscitiva, quella
morale, etc.), ma una filosofia dell’esperienza in genere. Ma ciò non
significa che essa sia, d’altro canto, una «filosofia generale» al modo
di una metafisica che pretenda di descrivere dall’esterno l’esperienza e
le sue forme. Né filosofia speciale né filosofia generale, l’estetica intesa
al modo di Garroni si configura invece, secondo quanto suggerisce il
titolo stesso del libro, come un risalimento, all’interno dell’esperienza,
verso il suo senso.
I pensatori ai quali Garroni si richiama nel proporre quest’estetica
sono soprattutto Kant e poi Wittgenstein e Heidegger. Ma è significativo anche il riferimento a Dewey. Quanto e perché lo sia risulta immediatamente chiaro da poche frasi di un’intervista concessa da Garroni,
un anno prima della morte, a uno studente, Fiorenzo Ferrari, che gli
stava dedicando la tesi di laurea 2. Alla domanda relativa, Garroni
rispose: «L’estetica di Dewey è un’estetica precisamente nel mio senso
più che non nel senso di molti altri. Non un’estetica dell’opera d’arte.
Ha come oggetto non solo l’opera d’arte, ma certe esperienze, che
rimandano ad un certo principio che è lo stesso di quello del giudizio
estetico in senso stretto. Veramente, Dewey non parla esplicitamente
di principi, ma fa esempi che non hanno niente a che fare con l’arte, assimilandoli tuttavia a questa sotto un comune denominatore: il
99
pranzo in un ristorante fran­cese, oppure la tempesta (se ricordo bene)
durante una crociera, e così via».
Gli esempi qui ricordati da Garroni (e da lui più ampiamente discussi – come vedremo – in Senso e paradosso) sono addotti da Dewey
nel terzo capitolo di Art as Experience 3, quello che ne conclude la parte introduttiva, dedicata alla nozione di esperienza e al suo rapporto
con la nozione di arte. Data l’importanza fondamentale di questi tre
capitoli per il progetto di un’estetica come «filosofia dell’esperienza»,
ne richiamo, sia pur brevissimamente, i temi più significativi per quel
progetto. Tuttavia, preciso subito che Dewey non si discosta dalla nozione tradizionale (o, più precisamente, ottocentesca) di estetica come
«filosofia delle belle arti» 4. Quello che critica è la concezione dell’arte
e delle opere d’arte come un regno separato dell’esperienza: una concezione che, lungi dal valorizzarle, ne impedisce la comprensione. Per
questo – argomenta – occorre invece acquisire consapevolezza della
continuità fra l’esperienza estetica e l’esperienza ordinaria, riscoprendo
quell’elemento estetico che è presente già in quest’ultima e che l’esperienza specificamente estetico-artistica sviluppa e accentua.
Dewey fa valere anche una continuità fra l’esperienza la natura,
come risulta chiaro, del resto, fin dal titolo dell’opera che costituisce la
premessa immediata di Art as Experience, cioè Experience and Nature 5.
In questo modo, l’esperienza è ricondotta alla nozione, più generale,
di «vita» e descritta, più precisamente, nel senso di un’interazione fra
organismo e ambiente. L’esperienza è un «adattamento per espansione» 6, una «vitalità intensificata» 7 che si produce quando una perdita
dell’integrazione viene superata e si realizza una nuova integrazione:
«L’esperienza è il risultato, il segno e la ricompensa di quella interazione tra organismo e ambiente che, quando raggiunge la pienezza, si
trasforma in partecipazione e comunicazione» 8.
Già questa concezione dell’esperienza ha tratti che possiamo definire “estetici”. Ma la qualità estetica dell’esperienza viene ricondotta
da Dewey soprattutto a quella che si potrebbe chiamare la vocazione
dell’esperienza all’unità. Più che di «esperienza in generale», come fanno
i filosofi (compresi «gli empiristi»), è infatti opportuno parlare, dice
Dewey richiamandosi al linguaggio comune, di «esperienze che sono
ad una ad una singolari, dotate ciascuna di un proprio inizio e di una
propria fine» 9. L’unità numerica (il fatto che l’esperienza sia sempre
questa o quella esperienza determinata) trova per così dire il suo suggello – come già si evince dalla fine del passo appena citato – nell’unità
qualitativa, quella che il linguaggio comune definisce accentando l’articolo: «Facciamo una esperienza quando il materiale esperito porta a
compimento il proprio percorso. Allora e soltanto allora esso è integrato
e delimitato da altre esperienze entro il flusso generale dell’esperienza.
[…] Un’esperienza del genere è un intero, e reca con sé la propria qualità individualizzante e la propria auto-sufficienza. È una esperienza» 10.
100
È in riferimento a quest’unità qualitativa, quella per cui un’esperienza può essere un «evento integrale» 11 (o, anzi, deve esserlo per
valere come «una esperienza»), che Dewey ricorre agli esempi del pranzo e della tempesta ricordati da Garroni. Solo alla fine di questo terzo
capitolo Dewey parlerà dell’esperienza specificamente estetica (quella
in cui – anticipo – «vengono resi manifesti per loro stessi» i «fattori» 12
estetici di ogni vera esperienza). Subito prima porterà gli esempi di
un’esperienza intellettuale e di un’esperienza pratica, dotate anch’esse
di una qualità estetica. Ma prima ancora degli esempi relativi a queste
tre forme elevate di esperienza (la conoscenza, l’azione e l’arte), che
sono quelle per lo più tematizzate dai filosofi, Dewey porta volutamente esempi tratti dalla vita ordinaria.
Tuttavia, siccome quest’ultima è per lo più, purtroppo, non-estetica,
quegli esempi hanno comunque qualcosa di straordinario. Per questo
– osserva Dewey – si è soliti ricordarli qualificandoli come «vere esperienze» o commentando: «quella è stata un’esperienza». E non si tratta
nemmeno necessariamente di esperienze «di grande importanza», che
abbiano segnato la vita di una persona. Può trattarsi per l’appunto
di «qualcosa di relativo scarso rilievo» (come quella tempesta e quel
pranzo), ma che «proprio per il suo scarso rilievo mostra al meglio
cosa può essere un’esperienza» 13.
Su quest’ultima osservazione fa leva Garroni – al quale possiamo
adesso ritornare – per poter rintracciare in Dewey un’estetica «non
speciale». In Senso e paradosso, in un denso riferimento a Dewey 14,
Garroni sottolinea infatti che quegli esempi sono «non tipici», come
sarebbero invece quadri e opere d’arte, e che rispetto a questi ultimi
hanno addirittura una funzione euristica maggiore. L’hanno – argomenta – perché, proprio in quanto non sono «tipici», «non possono
passare come rappresentanti» di una «classe» di oggetti di «tipo presuntivamente estetico», cioè di un’ideale «collezione di oggetti artistici»
«di tutti i tempi e di tutti i luoghi».
Seguiamo ancora Garroni nella sua interpretazione. Quel pranzo
e quella tempesta nominati da Dewey sono stati real experiences 15 e
possono dunque ben esemplificare ciò che merita di essere appunto
chiamato «un’esperienza», cioè – commenta Garroni – «l’esperienza
genuina, non parcellizata nel tempo». E ad esplicazione aggiunge immediatamente, dopo due punti: «l’esperienza come tale». Poche righe
sotto, Garroni arriva a parlare di «esperienza in genere», traendo infine
questa conclusione: «Quadri, pranzi, tempeste non sono che esempi di
qualcosa che li rende possibili come esempi. Così che, in Dewey, una
vera e propria riflessione sull’esperienza reale non può non essere che
risalimento, all’interno dell’esperienza concreta, verso la sua condizione
di possibilità, verso quell’“esperienza in genere“, anticipata a priori, che
ci consente e di avere e di parlare di questa o quella esperienza».
In questo passo ritornano, accanto ai pranzi e alle tempeste, anche
101
i quadri, cioè opere d’arte. Ne discuterò più avanti. Adesso vorrei
invece soffermarmi su un ritorno ben più sconcertante: il riferimento
all’«esperienza in genere», che Dewey sembrava avere tolto di mezzo. Tuttavia, Garroni non vuol certo ricadere in posizioni filosofiche
«astratte», proprie della filosofia moderna, dalle quali Dewey intendeva
risolutamente uscire (come si è visto col suo riferimento all’empirismo.
Ma il razionalismo non è certo meno «astratto»). Anche Garroni intende uscirne, ma in un modo diciamo meno sbrigativo di quanto gli pare
che faccia Dewey, il quale, a suo avviso, non sfruttò «fino in fondo»
«le possibilità di comprensione delle sue proprie tesi».
Garroni, dunque, rilancia il riferimento all’«esperienza in genere» e
lo fa addirittura nella sua interpretazione di Dewey. Si potrebbe forse
dir così: proprio l’«esperienza in genere», per essere pensata davvero,
va pensata tenendo conto anche di quel tratto singolare, individuale,
che caratterizza volta a volta l’esperienza appunto in quanto esperienza, nel suo essere cioè esperienza concreta. Altrimenti ci si trova a che
fare con un’astrazione che, nel caso dell’esperienza più che in altri, ci
fa perdere l’essenziale. Questo riferimento all’individuale animò del
resto a suo tempo il fondatore dell’estetica, Baumgarten, e già, anzi,
la sua fonte: Leibniz. Si trattava, per esempio, di pensare il rapporto
fra individualità e universalità (o fra singolarità e totalità) in un modo
diverso da quello di una mera subordinazione logica di particolare e
generale.
E quest’istanza ha poi animato, in vario modo, molti autori della successiva storia dell’estetica, per esempio (e non è certo un mero
esempio fra gli altri) già il Kant della terza Critica 16, dove si parla per
l’appunto, fra l’altro, di un’universalità, diversa da quella «logica», rivendicata – paradossalmente – da giudizi singoli e da singoli giudicanti.
In generale, in quest’opera Kant compie un tentativo poderoso di pensare l’esperienza, pur restando a livello trascendentale, in modo meno
astratto e «tautologico» (e, dunque, più specificato e determinato) di
quanto non accada quando la si concepisce semplicemente dal punto
di vista delle categorie dell’intelletto 17. Ma la possibilità di pensarla in
tal modo, ha mostrato Garroni con ottimi argomenti, è offerta da Kant
dalla scoperta di un principio e da una facoltà in senso lato «estetici»18
che permettono un «risalimento» dell’esperienza, dal suo interno, verso
il suo «senso».
Abbiamo ritrovato questa formulazione (già citata in apertura, riassumendo telegraficamente Senso e paradosso) alla fine del brano di Garroni su Dewey, del quale vorrei ora citare alcuni punti (finora volutamente omessi) che avvicinano Dewey proprio a Kant in riferimento a
un’«estetica non speciale», ovvero in riferimento a una filosofia dell’esperienza che riconosca come fondamentale in quest’ultima un «principio»
(Kant) o una «qualità» (Dewey) estetici (in senso lato). L’excursus su
Dewey è infatti introdotto, nel libro di Garroni, appunto a partire da
102
Kant, sia pure nel senso di voler mostrare come non ci sia «per niente
bisogno di essere seguaci fedeli di una tradizione trascendentalista» 19
(quindi come non ci sia bisogno di riconoscersi kantiani) per far valere
una concezione «estetica» dell’esperienza.
Poche righe più avanti, dove suggerisce (come abbiamo ricordato)
che Dewey non avrebbe sviluppato compiutamente le «possibilità di
comprensione delle sue proprie tesi», Garroni imputa questo fatto a
«un qualche eccesso […] di vitalismo», che «impedì» a Dewey anche
«di vedere le profonde consonanze tra il suo pensiero del Kant della
Critica del Giudizio, che anzi egli fraintese affatto» 20. Garroni torna
poi brevemente su questo fraintendimento (o, quanto meno, su un suo
aspetto) in un altro luogo del suo libro, quando, prima d’introdurre
la sua interpretazione della terza Critica (quella secondo cui essa è il
primo, fondamentale tentativo di un’estetica come filosofia dell’esperienza), sgombra il campo da ogni interpretazione riduttiva di quell’opera kantiana come quella, per esempio, che non vede in essa altro
che un’«‘aggiunta’ al sistema critico già delineato – come ingenuamente
e curiosamente pensava Dewey, e non solo lui – per completare la
“trinità classica” del Vero, del Bene e del Bello» 21.
Vediamo più da vicino, e discutiamo (proseguendo lungo la via indicata da Garroni), l’argomentazione di Dewey. Con tutto l’amore per
Kant, non si può dire che Dewey non abbia qualche ragione quando afferma che «Kant era un provato maestro nel tracciare prima distinzioni
e nell’innalzarle poi a divisioni per compartimenti» 22. Ma la critica non
coglie affatto nel segno nel caso del significato della terza Critica, che
è senz’altro irriducibile (come Garroni ben argomenta e come anche
il processo stesso della genesi di quest’opera conferma) a quello che
vorrebbe Dewey. Quest’ultimo scrive, in riferimento alle tre critiche
kantiane: «Dopo aver risolto il problema della Verità e del Bene c’era
ancora da trovare una nicchia per la Bellezza, il termine che rimaneva
della triade classica» 23. La parola «nicchia» (niche) era comparsa già
nelle prime pagine di Art as Experience 24, cioè in quell’incipit polemico
nel quale Dewey aveva criticato, nel contesto di una polemica più vasta
(perché anche sociale e politica), ogni teoria che consideri l’arte come
un regno separato, per esempio la concezione dell’esperienza estetica
come mera contemplazione 25.
Ed è appunto nel contesto di una critica alla concezione dell’esperienza estetica come contemplazione (è opportuno sottolinearlo) che
Dewey critica Kant. Con la sua estetica – afferma Dewey – «venne
[…] aperta la strada […] che conduce alla torre d’avorio della “Bellezza” lontana da ogni desiderio, azione e turbamento dell’emozione» 26.
Dewey ha ragione a dire che l’estetica kantiana è stata recepita anche
(e forse soprattutto) in questo senso. È illuminante, al riguardo, il fatto
che, più avanti, discutendo dell’inadeguatezza di varie teorie dell’esperienza estetica 27 e, nella fattispecie, di quelle che la intendono come
103
una fuga dal mondo verso un altro mondo, al di là dell’esperienza,
Dewey indichi in Schopenhauer il continuatore della teoria della contemplazione di Kant 28, considerandolo quasi l’interprete accreditato
dell’estetica kantiana.
Ma quello di Schopenhauer non è l’unico (e non il più fedele) sviluppo del tema kantiano della «contemplazione» e del «disinteresse» 29.
Basti pensare, in alternativa, a Schiller 30, che – proseguendo in tutt’altro modo sulla strada indicata da Kant – vede nell’esperienza estetica
non un vuoto, ma un pieno, nel senso che è proprio in essa che l’uomo
può fare esperienza della propria integralità e della totalità delle sue
possibilità 31: è da questo punto di vista che Schiller parla di educazione
estetica e collega arte e politica. Non cito Schiller solo come obiezione
all’interpretazione che Dewey dà di Kant. Lo cito anche perché ritengo
che Dewey, trattando di arte, di educazione e di politica, riprenda a suo
modo non pochi temi schilleriani. Una qualche conferma può venire
da un’importante nota di Art as Experience che dice che la filosofia di
Schiller è «un coraggioso tentativo da parte di un artista di sottrarsi
al rigido dualismo della filosofia kantiana pur restando all’interno del
quadro da essa delineato» 32.
La nota suggerisce – ed è certo un’osservazione convincente – che,
una volta posto un dualismo, è poi difficile sottrarcisi o superarlo. E
si può anche convenire sul fatto che, se possibile, è meglio tagliare a
monte il dualismo, come appunto Dewey tenta di fare con la sua filosofia dell’interazione di organismo e ambiente. Ma in ogni caso, almeno
il tentativo di superare il dualismo è già presente, con tutta evidenza,
nella terza Critica di Kant. Ed è sorprendente che Dewey non lo colga,
così come non coglie il significato positivo, e non «anemico» 33, della
teoria del «disinteresse».
In Kant, infatti, il «disinteresse» dell’esperienza estetica fa tutt’uno
(come poi in Schiller) con la sua libertà da costrizioni (sia dei sensi sia
della ragione). E questo libero gioco, questa libertà estetica, è tale, come
poi Kant argomenta, da vivificare l’animo 34 di chi fa tale esperienza e
addirittura da congiungersi con gli interessi più alti dell’uomo 35. In
questo senso l’esperienza estetica, con la sua peculiare finalità formale 36, s’inserisce, quale elemento centrale, in una teleologia cha vede
nella cultura la continuazione della natura 37, come risulta ben chiaro
nella seconda parte della terza Critica, dove sono centrali i temi della
vita e degli organismi (anche «artificiali», cioè culturali e politici) 38.
Insisto su questi temi ben noti (ma, pare, non a Dewey) non solo
per portare altre prove della tesi di Garroni di una consonanza tra la
filosofia di Dewey e quella di Kant, ma anche per tentare un’interpretazione dell’affermazione di Garroni secondo cui il mancato riconoscimento, da parte di Dewey, della consonanza fra la propria filosofia e
quella (da lui fraintesa) di Kant dipende da un «eccesso di vitalismo».
Forse – vorrei commentare – è stato tale eccesso a impedire a Dewey
104
di cogliere il «vitalismo moderato», per chiamarlo così, presente, come
appena ricordato, nell’estetica e nella filosofia di Kant.
All’«eccesso di vitalismo» di Dewey Garroni imputa anche – come
si è detto – il fatto che egli non seppe realizzare appieno le possibilità
di comprensione della sua stessa filosofia. Anche a proposito di questa
tesi vorrei suggerire una glossa: forse in Dewey la nozione stessa di
«esperienza» rischia talvolta di essere di fatto impoverita per un eccesso di vitalismo. Per chiarire questo paradosso, farò un rapidissimo
rimando a un altro pensatore importante per il progetto di Garroni
di un’estetica come filosofia dell’esperienza. Heidegger ha distinto due
modi opposti d’intendere l’esperienza: quello, inautentico, dell’Erlebnis
(mera «esperienza vissuta», puntuale e superficiale) e quello, autentico,
dell’Erfahrung (un incontro che trasforma) 39. È senz’altro possibile che
così dicendo Heidegger sia un po’ manicheo. Ma è anche possibile che
Dewey, nonostante che egli sostenga senz’altro una concezione dell’esperienza come Erfahrung, l’appiattisca talvolta sul mero Erlebnis.
Ora però, a prescindere dal problema di questo eventuale scivolamento di Dewey verso la mera esperienza vissuta e anche da quello,
più generale, di ripensare la dicotomia Erlebnis-Erfahrung in relazione
all’esperienza estetica, vorrei piuttosto concludere questo mio intervento guardando al nesso di arte ed esperienza, nominato fin dal titolo del
libro di Dewey e al problema del rapporto fra un’estetica intesa come
filosofia dell’arte e un’estetica intesa come filosofia dell’esperienza. Notavo prima che nel brano di Garroni che riporta gli esempi del pranzo
e della tempesta compaiono di nuovo anche i quadri. La cosa pone
qualche problema: più precisamente, il problema di una possibile differenza del carattere «esemplare» di questi due tipi di esempi. Forse si
potrebbe distinguere dicendo che i primi sono – come osserva Dewey
e come sottolinea Garroni – particolarmente significativi perché, proprio in quanto non convenzionalmente «artistici», svolgono la funzione
euristica di farci riscoprire l’estetico già nell’esperienza comune, e di
porre dunque le basi per una teoria dell’arte fondata nell’esperienza.
Ma sono i secondi (i quadri e, in generale, le opere d’arte) ad essere
effettivamente «esemplari», nel senso forte di Garroni, in quanto manifestano esemplarmente le condizioni estetiche dell’esistenza. Dewey la
pensa in modo simile: «Un oggetto è peculiarmente e prevalentemente
estetico, e dunque consente il godimento caratteristico di una percezione estetica, quando i fattori che fan sì che qualcosa possa essere
chiamata una esperienza sono innalzati molto al di sopra della soglia
percettiva e vengono resi manifesti per loro stessi» 40.
In questo passo Dewey parla di «oggetti», ma più avanti distingue
chiaramente fra i meri oggetti, cioè i «prodotti artistici», e le «opere
d’arte», che si realizzano solo nell’esperienza che ne viene fatta 41. Questa distinzione (che chiarisce fra l’altro uno dei significati del titolo Art
as Experience) ha qualche analogia, mi pare, con quella di Garroni fra
105
le opere d’arte intese come meri rappresentanti di una presunta classe
oppure come occasioni esemplari per un’esperienza del senso. Il significato dell’aggettivo «esemplare» come lo usa Garroni ha poi qualche
analogia con quello dell’aggettivo «ideale» col quale Dewey indica questa capacità propria dell’arte: «Attraverso selezione e organizzazione,
quei tratti che fan sì che ogni esperienza diventi un’esperienza degna di
essere fatta sono predisposti dall’arte a una percezione adeguata» 42.
Così dicendo, non intendo sovrapporre le due prospettive che restano comunque diverse: un naturalismo, con qualche «eccesso di vitalismo», in un caso, e invece un trascendentalismo, radicalizzato in
modo «paradossale», nell’altro. Per quanto riguarda in particolare la
concezione dell’estetica, Dewey continua a tener ferma (come ricordato
in apertura) la concezione dell’estetica come «filosofia dell’arte bella»,
mentre Garroni propone una nuova concezione dell’estetica come filosofia dell’esperienza. Tuttavia, le considerazioni appena svolte mostrano
che la distanza è meno grande di quanto non sembri. Infatti (e accenno a un altro significato del titolo Art as Experience), Dewey intende
non solo l’arte come esperienza, ma anche, reciprocamente, l’esperienza come arte, quanto meno «in germe» 43, e Garroni, dal canto suo,
indica proprio nelle opere d’arte le occasioni esemplari per cogliere il
senso dell’esperienza.
Il problema che vorrei toccare in conclusione è appunto quello del
rapporto di un’estetica ripensata in modo nuovo, cioè come filosofia
dell’esperienza, con il suo vecchio oggetto, l’arte. È un problema con
il quale noi cultori di estetica facciamo i conti da decenni. Ricordo per
esempio una bella discussione di alcuni anni fa in un altro seminario
organizzato, come questo, dal Centro Internazionale di Estetica, al
quale partecipò anche Garroni 44. All’ordine del giorno era appunto
il problema se l’estetica debba essere ancora una filosofia dell’arte. Se
“debba” esserlo, ma anche, in realtà, se “possa” esserlo, visto che è
stato anche lo stesso declino, nel Novecento, dell’“arte bella” a privare
l’estetica del suo oggetto istituzionale. Ma quell’oggetto istituzionale
è in realtà tale solo dall’Ottocento. Nella sua fondazione settecentesca (per esempio con Baumgarten, dal quale prendeva le mosse quel
seminario) l’estetica riguardava un ambito ben più vasto. E c’è poi la
difficoltà di applicare la concezione dell’estetica come “filosofia dell’arte bella” a periodi storici più antichi (o a mondi geografici diversi
dall’Occidente). Con tale difficoltà ha variamente fatto i conti la storia
dell’estetica, un ambito di studi al quale attribuisco pertanto un’importanza fondamentale anche da un punto di vista teorico.
Ma l’alternativa, se l’estetica debba o no essere (ancora) una “filosofia dell’arte”, dà spesso per scontata – dicevo in quel seminario e
vorrei ripetere ora, richiamandomi questa volta a Dewey – un’identità
discutibile fra “arte” e “arte bella”, prendendo per buona la posizione
(per l’appunto ottocentesca) secondo cui quell’aggettivazione sarebbe
106
pleonastica e ridondante. Ora, uno dei meriti di Dewey è quello di
rilanciare la nozione antica di “arte” come techne. Mettendo in primissimo piano il rapporto di «esperienza» e «natura», Dewey riscopre
infatti il nesso greco di techne e physis: con i Greci – dice – «la concezione dell’uomo in quanto essere che usa l’arte divenne al tempo
stesso la base per distinguere l’uomo dal resto della natura e la base
per legare l’uomo alla natura» 45. Alla fine del brano da cui è tratta
questa citazione Dewey rimanda al capitolo sull’arte di Experience and
Nature 46. Esso si apre affermando che, secondo il suo concetto greco,
«l’esperienza è l’equivalente dell’arte» 47 e continua poi argomentando
che il venir meno, nella scienza e nella filosofia moderne, dell’essenzialismo antico dovrebbe condurre a riconoscere il primato dell’arte «in
quanto culmine supremo della natura» 48.
Questo primato non è quello dell’“arte bella” in quanto separata
dalle arti utili: sia in Experience and Nature sia in Art as Experience è
costante la polemica contro questa separazione 49, strettamente connessa alla separazione fra mezzi e fini (e solidale a determinati assetti
storico-sociali). Non m’interessa adesso entrare nel merito delle ricostruzioni storiche di Dewey, che proprio per quanto riguarda la storia
dell’estetica sono spesso discutibili (come si è visto nel caso di Kant).
M’interessa piuttosto sottolineare l’istanza teorica di fondo (che potrebbe essere peraltro sviluppata anche in studi storici). Essa, infatti, può
forse aiutarci ad uscire da quella falsa alternativa pro o contro l’estetica
come filosofia dell’arte, ricomprendendo anche l’arte, ma pensata in un
modo sufficientemente ampio, in un’estetica concepita come filosofia
dell’esperienza.
1
Cfr. E. Garroni, Senso e paradosso. L’estetica, una filosofia non speciale, Laterza,
Roma-Bari, 1986.
2
L’intervista è ora disponibile on line fra i testi del sito della “Cattedra Internazionale Emilio Garroni”: http://w3.uniroma1.it/emiliogarroni.
3
J. Dewey, Art as Experience, 1934, ora in Id., The Later Works, a cura di J. A.
Boydstone, vol. 10, a cura di H. F. Simon, Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville 1987, tr. di G. Matteucci: Arte come esperienza, Palermo,
Aesthetica 2007, p. 62.
4
Ivi, p. 31.
5
Dewey, Experience and Nature, 1925-29, ora in Idem, The Later Works, a cura di
J. A. Boydstone, vol. 1, a cura di P. Baysinger e B. Levine, Southern Illinois University
Press, Carbondale and Edwardsville 1981, tr. di P. Bairati: Esperienza e natura, Mursia,
Milano 1973.
6
Id., Arte come esperienza, cit., p. 41.
7 Ivi, p. 45.
8 Ivi, p. 49.
9 Ivi, p. 61. Il passo continua così: «Infatti la vita non è un corso o un flusso uniforme ininterrotto. È fatta di storie, […] ciascuna dotata del suo peculiare andamento
ritmico».
107
Ibidem.
Ivi, p. 64.
12
Ivi, p. 79.
13
Ivi, p. 62.
14 Garroni, cit., pp. 184-85.
15 Garroni cita dall’unica versione allora esistente, quella curata da C. Maltese: L’arte
come esperienza, La Nuova Italia, Firenze 1951, che (a p. 46) rende real experiences con
«esperienze reali». Matteucci traduce – molto meglio – con «vere esperienze».
16 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, 1790, tr. di L. Amoroso: Critica della capacità di
giudizio, BUR, Milano 1995, tr. di E. Garroni e H. Hohenegger: Critica della facoltà di
giudizio, Einaudi, Torino 1999.
17 Cfr. L. Scaravelli, Osservazioni sulla «Critica del Giudizio» (1955), poi in Id.,
Scritti kantiani, La Nuova Italia, Firenze, 1969, al quale Garroni (cit., sp. pp. 212-14)
si richiama.
18 Ne ho discusso recentemente in Emilio Garroni interprete di Kant e maestro di
estetica, in “Studi kantiani”, XIX/2006, pp. 107-12.
19 Garroni, cit., p. 183.
20 Ivi, p. 184.
21 Ivi, p. 212.
22 Dewey, Arte come esperienza, cit., p. 249. Nella nota 196 (cit., p. 341) Dewey
osserva, contro l’essenzialismo germanico (di Kant, dunque, ma non solo): «L’effetto sul
pensiero tedesco dell’uso delle maiuscole non ha ricevuto adeguata attenzione».
23 Ibidem.
24 Ivi, pp. 34 e 38 (la seconda occorrenza del termine “nicchia”, in questa pagina,
traduce un sinonimo inglese: pigeon-hole).
25 Ivi, p. 37. Le istanze filosofiche (e anche politiche) di Dewey sono a mio avviso
senz’altro valide, ma in queste pagine egli accomuna un po’ sbrigativamente (come càpita
quando si polemizza) concezioni e fenomeni sì in parte interconnessi, ma non identici,
per esempio spiritualismo, art pour l’art e teoria della contemplazione.
26 Ivi, p. 249.
27 È l’argomento del cap. 12, intitolato La sfida alla filosofia. Per la filosofia (o, più
precisamente, per una filosofia che voglia essere filosofia dell’esperienza) è vitale vincere la sfida, ossia riuscire a comprendere l’esperienza estetica. Infatti, se quest’ultima
manifesta per così dire allo stato puro le condizioni dell’esperienza, non comprendere
quell’esperienza significa non comprendere l’esperienza in generale.
28 Ivi, p. 284: «Kant aveva già identificato esperienza estetica e contemplazione.
Schopenhauer dichiarò che la contemplazione è l’unica maniera di trovare scampo e
che, quando contempliamo opere d’arte, noi contempliamo le oggettivazioni della volontà e di conseguenza ci liberiamo dalla presa che la volontà ha su di noi in tutti gli
altri modi dell’esperienza».
29 Cfr. Kant, cit., sp. §§ 1-5.
30 Sull’opposizione fra la ripresa schilleriana e quella schopenhaueriana del «disinteresse» kantiano cfr. M. Heidegger, Nietzsche, 1961, tr. di F. Volpi: Nietzsche, Adelphi,
Milano, 1994. vol I, p. 114 ss.
31 Fr. Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, 1795, tr. di G. Pinna: L’educazione estetica, Aesthetica, Palermo 2005 (sp. lettera
XV e lettera XXII).
32
Cfr. Dewey, cit., p. 342, n. 219. Più in generale, l’importanza, per Dewey, dell’estetica classica (kantiana e post-kantiana, tedesca e inglese) mi pare implicitamente
riconosciuta dal passo di Experience and Nature (cit., p. 258) in cui egli afferma che è
giusta l’affermazione (anche se fatta «senza alcuna base o alcun valore empirico») dei
«sistemi filosofici» che hanno concepito l’arte come «l’unione di necessità e libertà,
l’armonia dei molti e dell’uno, la riconciliazione del sensibile e dell’ideale».
33 Quest’aggettivo si trova nel brano contro la teoria della mera contemplazione, la
quale conduce – osserva Dewey – «a una concezione dell’arte completamente anemica»
10
11
108
(Art as Experience, cit., p. 250). Dewey, anzi, afferma che Kant addirittura «trascura,
ritenendoli irrilevanti, il fare e il creare implicati nella produzione di un’opera d’arte (e
i corrispondenti elementi attivi interni alla risposta fruitiva)». Pare quasi che della terza
Critica Dewey abbia letto solo (e male) il primo momento dell’Analitica del bello.
34 Cfr. Kant, cit., per es. § 9.
35 Ivi, § 43.
36 Ivi, §§ 10-17.
37 Ivi, sp. § 83.
38 Ivi, § 65 n.
39 Ne ho discusso in Arte, poesia e linguaggio, cioè nel cap. V di Heidegger, a cura
di F. Volpi, Laterza, Roma-Bari 1997. Per quanto riguarda la nozione di esperienza,
Heidegger e Dewey hanno senz’altro una fonte comune: Hegel, che a quella nozione
dedicò l’introduzione della Phänomenologie des Geistes, 1807, tr. di V. Cicero: Fenomenologia dello spirito, Rusconi, Milano 1995, pp. 146-67.
40 Cfr. Dewey, cit., p. 79. Ma le citazioni si potrebbero facilmente moltiplicare.
41 Cfr. ivi, p. 169, e anche già p. 123: «Un’opera d’arte […] è effettivamente, non
già potenzialmente, un’opera d’arte solo quando vive in qualche esperienza individuale.
[…] Essa viene ricreata ogni volta che se ne fa esperienza estetica».
42 Cfr. ivi, p. 189.
43 Cfr. ivi, p. 45. Ma anche qui le citazioni si potrebbero facilmente moltiplicare.
44 Mi riferisco al seminario Baumgarten e gli orizzonti dell’estetica (9-10 ottobre
1998). Da esso ha tratto spunto una pubblicazione con lo stesso titolo (“Aesthetica
Preprint”, 54, 1998).
45 Cfr. Dewey, cit., p. 52.
46 Si tratta del cap. ix, intitolato Experience, Nature and Art.
47 Id., Esperienza e natura, cit., p. 255.
48 Dewey, cit., p. 257. Già la Prefazione (p. 18) aveva anticipato: «Nell’arte si ritrova la più alta, perché più compiuta, incorporazione delle forze e dei processi naturali
nell’esperienza. […] L’arte rappresenta […] l’evento culminante della natura e nello
stesso tempo il grado più elevato dell’esperienza». Cfr. anche Id., Experience, Nature
and Art, in Id., Art and Education, 1954, tr. di L. Bellatalla: Educazione e arte, La Nuova
Italia, Firenze 1977.
49 Cfr. per es. Arte come esperienza, p. 52, cioè il seguito del brano sopra citato,
e p. 323 ss., cioè le pagine conclusive del libro, nelle quali il tema è collegato, come
anche in altri luoghi, alla critica delle condizioni socio-economiche del sistema basato
sul profitto privato.
109
La critica dell’esperienza estetica
nella filosofia analitica angloamericana
di Paolo D’Angelo
1. In questo mio intervento intendo soffermarmi brevemente sulle
critiche alla nozione di “esperienza estetica” che sono state elaborate
in ambito analitico a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Queste
critiche rappresentano indubbiamente un allontanamento, e quasi un
rifiuto, dell’ordine di problemi affrontati da John Dewey nella sua estetica, e questo è sufficiente a giustificare il fatto che ce ne occupiamo
in questa sede. Ma ci sono altri elementi di interesse ai quali vorrei
rapidamente accennare.
In primo luogo, anche se è certamente possibile trovare nell’ambito
della filosofia cosiddetta continentale altre critiche molto serrate alla
nozione di esperienza estetica (si pensi all’attacco portato da Heidegger alla nozione di Erlebnis in riferimento all’arte, o alle critiche di
Gadamer alla “soggettivizzazione dell’estetica” che avrebbe luogo con
Kant, o ancora alle teorie sviluppate da Pierre Bourdieu nel volume
sulla Distinzione), l’attacco radicale alla nozione di esperienza estetica
resta un fatto tipico dell’estetica analitica. E dato che l’estetica analitica comincia appena a essere discussa in Italia, credo non sia male
soffermarsi su di un aspetto che, anche se non ha riguardato tutta
l’estetica analitica, certamente ne ha segnato in profondità una gran
parte. Proprio perché in una vasta area dell’estetica continentale degli
ultimi decenni si è non solo continuato a parlare di esperienza estetica,
ma le si è anzi assegnato un ruolo spesso centrale (penso all’opera di
Mikel Dufrenne Phénoménologie de l’expérience esthétique in Francia,
alla Kleine Apologie der aesthetischen Erfahrung di Jauss, ma anche
alle posizioni argomentate di recente da Martin Seel in Aesthetik des
Erscheinens) può essere interessante verificare come invece in un’altra
tradizione filosofica si sia cercato di farne a meno.
In secondo luogo, l’attacco all’esperienza estetica portato dall’estetica analitica è stato insolitamente radicale e distruttivo. Non si è trattato, per alcuni autori almeno, di affiancare all’esperienza estetica altri
principî esplicativi, di mostrare dei limiti o delle difficoltà, ma proprio
di eliminare dall’orizzonte problematico dell’estetica la nozione stessa
di esperienza. L’esperienza estetica è stata considerata un mito, una
chimera, un’illusione della quale sbarazzarsi il più rapidamente possibile. Ciò ha avuto naturalmente conseguenze molto nette sul modo in
111
cui si è creduto di poter dar conto – per esempio – dell’arte. Ma tutto
questo ha per noi il vantaggio di metterci sotto gli occhi posizioni ben
delineate e implicazioni molto chiare, il che è sempre istruttivo.
In terzo luogo, credo che il momento sia propizio per una riconsiderazione del problema. Dopo decenni in cui il tema dell’esperienza
estetica era stato guardato con sospetto e diffidenza, gli ultimi anni
hanno portato ad una sua riproposizione, anche in ambito analitico. Le
tesi liquidatorie non mi pare godano più di molta fortuna. L’esperienza
estetica riconquista centralità, si torna a discutere di come si possa caratterizzare, descrivere e utilizzare questa nozione, mentre si fa strada
la consapevolezza che la sua eliminazione crea molti più problemi di
quanti ne risolva. Per dirla in una battuta, oggi molti filosofi analitici
pensano che parlare di esperienza estetica può sì implicare che ci si
muova in un circolo, magari vizioso, ma non parlarne, presumere di
poterne non parlare, ci chiude in qualcosa di peggio, un vicolo cieco.
Il pendolo torna a oscillare dal lato dell’esperienza estetica.
Non ho usato a caso la metafora del movimento pendolare. Infatti
è possibile dire che alla filosofia angloamericana della prima metà del
Novecento la nozione di esperienza estetica era tutt’altro che estranea, e che quindi la situazione che si sta delineando negli anni a noi
più vicini rappresenta in qualche misura un ritorno, se non su vecchie posizioni, almeno a temi tradizionali. Non credo sia necessario
insistere a lungo su questo punto, dato che qualche semplice rinvio
basterà a chiarirlo. È noto per esempio che all’inizio del secolo scorso
un autore inglese, fortemente influenzato però dall’estetica tedesca,
come Edward Bullough, aveva teorizzato la “distanza psichica” come
caratteristica essenziale dell’esperienza estetica. Nello scritto del 1912
Psychical Distance as a Factor in Art and an Aesthetic Principle, Bullough interpretava appunto in termini di “distanza psichica” il tradizionale concetto di “disinteresse estetico”, e se ne serviva per marcare
l’opposizione tra fatti di mero piacevole ed esperienze estetiche vere e
proprie, fino a vedere nella distanza psichica il principio fondamentale
di quella che chiamava “coscienza estetica”: «È la distanza estetica a
rendere l’oggetto ‘un fine in se stesso’. Ed è ciò che innalza l’arte al di
sopra della sfera dell’interesse individuale […]. È proprio la distanza a
fornirci uno dei criteri per discernere i valori estetici da quelli pratici
(utilitaristici), scientifici o sociali (etici) […] pertanto la distanza estetica incarna uno dei tratti distintivi della ‘coscienza estetica’, di quella
particolare mentalità o sguardo sull’esperienza e sulla vita che […]
nella sua forma più significativa e sviluppata condurrà all’arte» 1.
Né si può dimenticare che proprio l’estetica di Dewey, poco più di
vent’anni dopo, aveva fortemente contribuito a orientare la riflessione
su alcuni caratteri dell’esperienza, ponendo quest’ultima in primo piano. Certo, è ben noto, ed è ben ribadito nella Presentazione scritta da
Giovanni Matteucci per questa nuova, importante edizione dell’opera
112
deweyana che per Dewey non esiste un’esperienza estetica come campo separato e speciale («l’arte è una tendenza interna all’esperienza e
non un’entità in se stessa» 2), e che l’estetico è piuttosto «lo sviluppo
chiarificato e intensificato di tratti che appartengono a ogni esperienza» 3, ma proprio perciò i caratteri che costituiscono l’esteticità (la
compiutezza, l’unità, il perfezionamento) si colgono nell’esperienza e
attraverso l’esperienza. Piuttosto che appellarsi, nel caso di Dewey,
al dato di fatto che il ciclo di lezioni dal quale ha preso origine Art
as Experience si intitolava Art and Aesthetic Experience, insomma, è
utile fissare la nostra attenzione sulla circostanza che per Dewey è
dai caratteri dell’esperienza che si va all’arte, cioè l’arte non è che la
specificazione e l’intensificazione di caratteri che sono propri dell’esperienza, di qualsiasi esperienza, ragione per cui il campo dell’esperienza
estetica è assai più ampio di quello che indichiamo tradizionalmente
come arte.
In terzo luogo, ricorderò che all’inizio degli anni Sessanta Jerome
Stolnitz aveva ribadito, in chiave storiografica, l’importanza della nozione di “disinteresse” nella nascita dell’estetica moderna, cioè in particolare nel costituirsi della teoria estetica del Settecento 4, mentre negli stessi
anni la nozione di esperienza estetica era il nucleo attorno al quale si
andava costruendo la teoria estetica di Monroe C. Beardsley. Nella sistemazione complessiva che Beardsley offrirà con l’edizione del 1981 di
Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, l’esperienza estetica
viene definita come quella esperienza che implica cinque caratteristiche
salienti: (1) è rivolta verso un oggetto, (2) è libera da interessi esterni,
(3) l’oggetto di tale esperienza deve essere emotivamente distanziato,
(4) si deve avere un senso di scoperta, (5) si deve dare un senso di
integrazione tra il soggetto e l’esperienza che egli viene compiendo.
Si sarà notato che in questo sintetico quadro storico ho messo assieme teorie dell’esperienza estetica propriamente dette, indagini sulla
“aestehtic Attitude”, sull’atteggiamento estetico, e teorie del “disinteresse estetico”. In effetti, anche se si tratta di aspetti diversi, sono
tutti strettamente interrelati e in qualche modo coinvolti pressoché
costantemente nel discorso sull’esperienza estetica 5. Proprio il loro
ripetuto affiorare in autori e momenti diversi dimostra che la nozione
di esperienza estetica, nelle sue varie declinazioni, era ben presente
nella filosofia angloamericana del Novecento.
2. È contro questo complesso di teorie, ma soprattutto contro le
loro elaborazioni più prossime nel tempo (vale a dire contro Beardsley
e Stolnitz) che si appuntano le critiche all’esperienza estetica formulate
dall’estetica analitica negli anni Sessanta. Le più note, perché espresse
con la rudezza e la mancanza di sfumature tipica di questo autore,
sono quelle esposte da George Dickie nei due saggi The Myth of the
Aesthetic Attitude del 1964 e Beardsley’s Phantom Aesthetic Experience
113
dell’anno seguente 6. Nel primo di questi due saggi Dickie attacca la
teoria della “distanza psichica” di Bullough e la teoria del disinteresse
avanzata da Stolnitz allo scopo di sbarazzarsi della nozione di “atteggiamento estetico”, che viene definita «an encrusted article of faith» e
considerata un mito del quale sbarazzarsi al più presto, perché inutile
e fuorviante. La cosiddetta distanza estetica, infatti, è solo una forma di
attenzione rivolta all’opera, e chi non la sa attingere non ha una diversa
forma di attenzione ma è semplicemente disattento. Perché allora moltiplicare gli enti e parlare di un nuovo stato di coscienza, che all’analisi
si rivela soltanto illusorio? Anche nel caso del disinteresse estetico,
definito da Stolnitz come «assenza di coinvolgimento per scopi ulteriori», si può dimostrare, secondo Dickie, che i comportamenti opposti a
quello “disinteressato” non sono altre forme di attenzione ma forme di
disattenzione. Lo scopo per il quale facciamo qualcosa, sostiene Dickie,
è altra cosa dal modo in cui la facciamo, e si può prestare attenzione,
la stessa attenzione, a un’opera, per scopi molto diversi.
L’argomento di Dickie è, al fondo, il medesimo sia quando si tratta
di criticare la distanza estetica che quando è in gioco il disinteresse:
perché si possa parlare della prima o della seconda sarebbe necessario
che si potesse parlare sensatamente del comportamento opposto, ossia
di un comportamento “non distanziato” e “interessato”. Ma, a parere
di Dickie, tutti i comportamenti di questo secondo tipo proposti dai
sostenitori dell’esistenza di un “atteggiamento estetico” sono in realtà
esempi di non-attenzione all’opera d’arte. E la disattenzione, conclude Dickie, non è un tipo speciale di attenzione. D’altronde, se seguo
un’opera letteraria o teatrale con un’attenzione finalizzata (per esempio
se voglio riscrivere il dramma o se sono un regista che sta pensando
a una sua messa in scena) la mia attenzione non differisce affatto da
quella di chi lo segue “disinteressatamente”. Anche in questo caso,
il disinteresse non è un tipo particolare di attenzione, ma attenzione
tout-court. Porsi in un atteggiamento estetico per Dickie significa soltanto “guardare attentamente” un’opera d’arte o un oggetto naturale.
La teoria della aesthetic Attitude incammina l’estetica su di una strada
sbagliata, inducendola ad assunzioni errate su ciò che è esteticamente
rilevante, facendole supporre che l’atteggiamento del critico d’arte sia
diverso da quello del comune fruitore, e infine mettendo l’una contro
l’altra etica ed estetica.
Nell’anno seguente, il 1965, è la teoria dell’esperienza estetica
di Beardsley ad attrarre gli strali di Dickie. Nella prima edizione di
Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, apparsa nel 1958,
Beardsley aveva sostenuto che la nostra relazione con gli oggetti artistici
è caratterizzata da alcuni tratti specifici che permettono di parlare di
un’esperienza estetica. Essa è distinta dal fatto di essere complessa, intensa e unificata. Dickie critica queste determinazioni sostenendo che Beardsley sta semplicemente facendo slittare i caratteri dell’oggetto estetico
114
su quelli dell’esperienza estetica. Un’opera d’arte può essere completa,
complessa e coerente, ma da ciò non segue che sia tale l’esperienza che
ne facciamo. L’esperienza di certe proprietà non è un’esperienza con
quelle proprietà. La replica di Beardsley arriva qualche anno dopo con
l’articolo Aesthetic Experience Regained, nel quale viene offerta una definizione dell’esperienza estetica che, pur mantenendo le caratteristiche
prima individuate, insiste ora maggiormente sul fatto che qusto tipo di
esperienza implica piacere: «A person is having an aesthetic experience
during a particolar stretch of time if and only if the greater part of
his mental activity during that time is united and made pleasurable
by being tied to the form and qualities of a sensuously presented or
imaginatively intended object on which his primary attention is concentrated» 7. Dickie replicherà a sua volta nel capitolo finale di Art and
the Aesthetic del 1974, nel quale ribadisce che, a suo parere, non ci
sono tratti caratteristici che differenzino l’esperienza estetica da altre
esperienze, e che quindi quest’ultima può essere identificata solo se si
è prima e indipendentemente definito che cos’è un oggetto estetico.
La strada non va dall’esperienza estetica all’arte, ma caso mai in senso
inverso, dall’opera d’arte all’esperienza estetica 8.
Quest’ultima conclusione non è solo di Dickie, così come Dickie è
tutt’altro che solo, in questi anni, a pensare di potere fare interamente
a meno dell’esperienza estetica. Si prenda il caso, indubbiamente più
rilevante per la statura dell’autore e per la complessità della cultura che
lo ispira, di Arthur Danto. Danto non accetta la teoria istituzionale dell’arte proposta da Dickie, ma approva le critiche di Dickie alla nozione
di “atteggiamento estetico” e al disinteresse estetico. Quasi all’inizio di
The Transfiguration of the Commonplace troviamo il rifiuto di Danto
per queste nozioni, così come per quella di “distanza psichica”. Il fatto
che sia possibile assumere un atteggiamento “distanziato” o “disinteressato” nei confronti di qualsiasi oggetto o avvenimento dimostra che il
riferimento all’atteggiamento estetico non ci è di nessun aiuto quando
si tratta di identificare le opere d’arte. Inoltre il discorso sul disinteresse non fa che elevare a norma generale un atteggiamento che è proprio
soltanto di periodi limitati della storia dell’arte: a lungo l’arte ha avuto
una serie molto ampia di concreti scopi pratici 9. Perché Danto può essere per una volta d’accordo con Dickie? Perché anche per Danto una
definizione estetica dell’opera d’arte (cioè una definizione che si basa su
di un tipo particolare di esperienza che compiremmo dinanzi all’opera
d’arte) è minacciata dalla circolarità. Ora è vero invece che per apprezzare esteticamente le qualità sensibili di un’opera d’arte secondo Danto
noi dobbiamo già sapere che quell’oggetto è un’opera d’arte, e questo
non lo sappiamo dall’esperienza che compiamo con quell’oggetto, ma
dalla teoria e dalla storia dell’arte 10. Il che è confermato, a parere di
Danto, dal fatto che ci sono opere d’arte che non presentano affatto
requisiti estetici, cioè che sono del tutto prive di qualità esteticamente
115
valutabili o pregevoli. Ci possono dunque essere, tra un oggetto che è
un’opera d’arte e un oggetto che non lo è, differenze che non sono in
alcun modo differenze percettive. Non tutte le differenze artisticamente
rilevanti sono di natura percettiva. Quindi non è l’esperienza estetica
quella che ci permette di decidere che cosa è un’opera d’arte e cosa
non lo è, ma piuttosto un atto interpretativo nel quale ci basiamo su
teorie e tradizioni storiche. Per Danto, l’interpretazione deve andare a
occupare il posto che nelle teorie tradizionali era occupato dall’esperienza estetica.
Si potrebbero facilmente moltiplicare gli esempi di autori che condividono il rifiuto di Dickie o Danto nei confronti dell’esperienza estetica.
Per venire ad anni ancora più vicini, ricordo che entrambi gli aspetti,
ossia tanto la critica al disinteresse quanto quella più generale all’esperienza estetica, sono espliciti nel volume del filosofo israelo-americano
Eddy Zemach, Real Beauty (1997). Zemach sostiene che il cosiddetto
“disinteresse” è solo un tipo particolare di interesse, e che l’esperienza
che noi facciamo dell’opera d’arte non sono altro che i suoi effetti su di
noi. Ora, molte opere hanno effetti del tutto diversi, e non c’è nessun
effetto che sia comune a tutte le opere d’arte. Inoltre Zemach sottolinea
come teorici dell’esperienza estetica da Dewey a Beardsley abbiano sempre fatto riferimento ai caratteri positivi dell’esperienza estetica, mentre
noi possiamo fare esperienza anche di proprietà negative (squilibrio, aridità, bruttezza), il che dovrebbe implicare che l’analisi dovrebbe andare
dalle proprietà all’esperienza, e non the other way around 11.
Visto che ho citato le proprietà estetiche, accenno infine a un altro
ordine di attacchi che sono stati rivolti all’esperienza estetica. Mi riferisco alla critica, elaborata da Ted Cohen, alla possibilità di distinguere
fra termini “estetici” (come grazioso, elegante) e termini non-estetici
(come cilindrico o curvo), così come essa era stata argomentata da
Frank Sibley. Cohen sostiene che non sia possibile dividere i termini
sulla base del fatto che si applichi loro, o non si applichi, il gusto. Ci
sono esempi di distinzioni sensoriali che implicano particolari abilità
(si pensi al riconoscimento delle grafie), senza che con ciò sia implicato
il gusto. Insomma, non è possibile arrivare a una definizione di cosa
intendiamo con “estetico”, e, quel che più conta, è possibile parlare di
arte senza fare riferimento alla distinzione tra estetico e non estetico,
che anzi si rivela non solo superflua ma dannosa 12.
3. Non intendo discutere in dettaglio queste critiche alla nozione
di esperienza estetica. Non solo perché in questa sede ci verrebbe a
mancare il tempo per farlo, ma anche perché sulle singole contestazioni si è sviluppato un dibattito assai ampio. Del resto molte delle
obiezioni che sono state mosse da parte analitica al concetto di disinteresse possono trovare risposta anche nella tradizione continentale
che si è misurata con l’estetica kantiana, e che spesso si è trovata a
116
fronteggiare critiche analoghe. Ma soprattutto vorrei concentrare la
mia attenzione su alcune conseguenze che si sono prodotte quando si
è pensato di poter fare a meno della nozione di esperienza estetica.
Mi pare, come accennavo in apertura, che oggi sia divenuto chiaro che
le strade percorse in alternativa alla nozione di esperienza estetica si
sono rivelate irte di difficoltà, e assai meno produttive di quanto era
parso in un primo momento.
Per esempio, il rifiuto dell’esperienza estetica ha indotto una parte
dell’estetica analitica a puntare tutto su una definizione dell’arte che
rendesse superflua tale nozione. Così sono fiorite le definizioni di tipo
istituzionale e procedurale, pensate appunto come definizioni che prescindono totalmente dalle qualità estetiche dell’oggetto, e si appoggiano invece al puro dato di fatto del riconoscimento di un oggetto come
opera d’arte. Queste teorie presumono di poter descrivere tale riconoscimento senza alcun riferimento ai motivi per cui viene compiuto,
ossia appoggiandosi alle mere procedure che portano all’identificazione
dell’opera d’arte. Il legame tra esclusione dell’esperienza estetica e ricorso alla definizione procedurale è del tutto evidente in Dickie, nel
quale il rifiuto di nozioni quale distanza estetica, disinteresse, atteggiamento estetico ecc. serve appunto come pars destruens che dovrebbe
dimostrare come l’unica alternativa percorribile sia rappresentata dal
nudo fatto del conferimento dello status di artisticità da parte dei componenti di un mondo dell’arte. Ma le cose non sono poi troppo diverse
anche nel caso della cosiddetta teoria storico-intenzionale di Levinson,
nella quale il ruolo svolto dal mondo dell’arte è soltanto sostituito dal
riferimento alla storia precedente. Ora, non solo i limiti di questo tipo
di definizioni si sono fatti sempre più chiari (scarsa o nulla informatività, circolarità, difficoltà a dar conto degli stati iniziali dell’arte o
dell’arte elaborata al di fuori dei circuiti deputati, illusione di poter
trattare il concetto di arte come concetto puramente classificatorio e
avalutativo, ecc. 13) ma, quel che più conta ai fini del nostro discorso
presente, non è affatto detto che questo tipo di definizioni riescano veramente a fare a meno di ogni riferimento all’esperienza estetica.
Si prenda in esame la teoria istituzionale di Dickie. Nella sua forma
più semplice, essa definisce l’opera d’arte come un artefatto che possiede degli aspetti i quali lo hanno “candidato all’apprezzamento” da
parte di uno o più agenti che operano a vantaggio di un modo dell’arte.
Ora, la natura di questo apprezzamento non viene mai ulteriormente
chiarita. Eppure, se si tratta di un apprezzamento qualsiasi, cioè poggiato su qualunque motivo, l’oggetto artistico non potrebbe distinguersi
da qualunque altro oggetto sia apprezzato per qualche ragione (economica, utilitaria, religiosa ecc.); se invece l’apprezzamento deve essere
un apprezzamento specifico dell’opera d’arte, come si vede l’esperienza
o l’atteggiamento estetico che erano stati cacciati dalla porta rientrano
dalla finestra. Ma qualcosa di molto simile vale anche per la teoria di
117
Levinson. Se dico che un oggetto è un’opera d’arte se è stato prodotto
per esser considerato in uno qualunque dei modi in cui sono state
considerate le opere d’arte in un tempo precedente, siamo alle solite:
o questa considerazione è una considerazione specifica per l’arte (e
allora siamo di nuovo all’esperienza estetica), oppure qualsiasi tipo di
considerazione è buona, ma allora, dato che in passato non c’è dubbio
che certe opere d’arte siano state considerate, per esempio, anche come
delle forme di investimento, dovrebbe logicamente seguirne che quel
che oggi consideriamo tale, per esempio un buon fondo obbligazionario, è un’opera d’arte.
Le cose non vanno molto meglio nel caso dell’altro presupposto largamente condiviso dai critici dell’esperienza estetica, ossia il fatto che
ci sono – ci sarebbero – molte opere d’arte del tutto prive di qualità
estetiche. Si potrebbe anzi avanzare l’ipotesi che il rifiuto della nozione di esperienza estetica sia nato proprio dalla volontà di giustificare
l’esistenza di questo tipo di opere. Nella teoria di Dickie, ma anche in
quella di Danto, il caso dei ready-made o delle opere d’arte concettuale appaiono come i fenomeni centrali di cui occorre dar conto da
parte di una teoria dell’arte. La “svolta anestetica” delle teorie dell’arte
analitiche è una diretta conseguenza della medesima svolta anestetica
compiuta da molta arte figurativa a partire dagli anni Sessanta. Le cose,
però, sono più complesse di come appare. Intanto, le opere d’arte
concettuali non sono opere d’arte prive di aspetti estetici: in Self-���
Described and Self-Defined di Kosuth vediamo una scritta gialla al neon
su di un fondo nero, e il contrasto tra sfondo e scritta non è estraneo
all’effetto dell’opera. Il caso del ready-made apparentemente è insuperabile, perché qui l’oggetto è veramente scelto (almeno nel caso dei
primi ready-made duchampiani) senza alcun riguardo alle sue proprietà
“retiniche”. E tuttavia è sufficiente pensare al carattere intimamente
parassitico del ready-made (che è arte perché nega il suo legame con
l’arte precedente, ma così facendo paradossalmente lo conferma) per
rendersi conto che qui l’errore consiste nel prendere come fenomeno centrale dell’artisticità una sua manifestazione estrema e derivata
(possiamo immaginare un mondo in cui le uniche opere d’arte sono
tele dipinte a olio, o disegni a sanguigna, ma non un mondo in cui le
uniche opere d’arte siano ready-made: il ready-made, per funzionare,
ha bisogno che ci sia altra arte).
Un’altra conseguenza indesiderata, o almeno ai nostri occhi indesiderabile, dell’esclusione dell’esperienza estetica è rappresentata dal
fatto che in questo modo diventa del tutto impossibile parlare di esteticità al di fuori dell’arte, per esempio nel caso della bellezza naturale.
Non per nulla tanto Dickie che Danto hanno voluto fare una filosofia
dell’arte, e non hanno mai prestato attenzione ai comportamenti estetici che non hanno luogo dinanzi ad artefatti umani. Questo disagio
di fronte all’esperienza estetica nella natura si riscontra anche in quei
118
teorici analitici che pure hanno cercato di fare i conti con il fenomeno.
Sintomaticamente Allen Carlson, che ha dedicato tanti studi all’environmental Aesthetics, non riesce neppure a costituire il rapporto estetico
con la natura, perché riduce l’esperienza esteticamente corretta della
natura alla conoscenza di essa sulla base delle appropriate categorie
scientifiche: ma quello che otteniamo attraverso lo scientific cognitivism
di Carlson non è un rapporto estetico con la natura, è un approccio
scientifico, con tutte le difficoltà che pensare questo approccio per il
comune fruitore della natura comporta 14.
Infine, un problema simile è rappresentato, per gli avversari dell’esperienza estetica, da quella che ormai si chiama “estetica diffusa”,
cioè da quei fenomeni di estetizzazione che si manifestano al di fuori del campo proprio dell’arte in senso stretto, nella vita quotidiana,
negli spazi pubblici, nella moda, nel design. Persino l’arte di massa e
quella popolare, tuttavia, creano difficoltà all’atteggiamento “purista”
degli avversari dell’esperienza estetica (si pensi al disprezzo di Danto
per tutto quel che nell’arte produce piacere in luogo di conoscenza).
Proprio l’ultimo libro di Danto, The Abuse of Beauty, appena tradotto
in italiano, mi pare una spia significativa di questo disagio. Esso reca il
sottotitolo Aesthetics and the Concept of Art, un titolo che solo pochi
anni fa sarebbe parso a Danto impossibile, o possibile al più come segnalazione di un errore, e rappresenta lo sforzo cui Danto si sottopone
per rendere pensabile alla sua teoria un qualche uso sensato del termine “bellezza” e di altri predicati “estetici”. Mentre la teoria di Danto
era nata da una netta separazione tra filosofia dell’arte ed estetica, e
dal rifiuto di quest’ultima, ora si torna a parlare di estetica, anche se
non a proposito della “grande arte” dell’irriducibile avanguardia ma a
proposito della vita quotidiana e dell’arte di intrattenimento 15.
4. Credo che tutti questi motivi abbiano concorso a riaccendere
l’interesse per la nozione di esperienza estetica nell’estetica analitica
degli ultimi anni. Intendiamoci: l’esperienza estetica non è mai veramente uscita di scena, nel senso che ci sono sempre stati autori di
ambito analitico che hanno ritenuto utile e anzi indispensabile parlare
di esperienza estetica. Al caso già visto di Beardsley se ne possono
aggiungere parecchi altri: già negli anni Settanta Roger Scruton aveva
offerto una teoria nella quale l’esperienza estetica e i suoi rapporti con
l’immaginazione giocavano un ruolo centrale 16. E nell’ultimo decennio
del Novecento molti sono tornati a parlare di esperienza estetica, da
Jerrold Levinson (che non considera più un tabù parlare di piacere a
proposito della nostra risposta alle opere d’arte 17) a Kendall Walton
(che incontra l’esperienza estetica nel cammino che porta verso una
teoria del valore estetico 18) a Malcom Budd (anche lui in un volume
che si intitola non per caso Values of Art 19).
In conclusione, tuttavia, vorrei soffermarmi su due casi, quello di
119
Noël Carroll e quello di Richard Shusterman. Non li scelgo perché
siano i più accesi o i più convinti sostenitori dell’esperienza estetica. Da
questo punto di vista, anzi, qualcuno degli autori che ho appena citato
si presterebbe forse meglio a fare da portabandiera del ritorno dell’esperienza estetica in ambito analitico. E tuttavia i casi di Shusterman e
Carroll mi sembrano particolarmente significativi, e buone testimonianze
del cambiamento in atto, proprio in quanto, pur condividendo in buona
parte le critiche all’esperienza estetica che siamo venuti esponendo,
nondimeno entrambi questi autori sono tornati a parlarne, ritenendo
che le difficoltà che incontriamo nel definire o caratterizzare l’esperienza
estetica non ci esimono dalla necessità di fare i conti con essa. Il caso di
Carroll è il più marcato in questo senso. Carroll è d’accordo con molte
delle obiezioni che sono state mosse all’esperienza estetica e soprattutto
non accetta affatto il concetto di disinteresse di derivazione kantiana
proprio di molte teorie formaliste. Ma nella sua introduzione all’estetica
Philosophy of Art il capitolo sull’esperienza estetica c’è, e la tesi che vi
si sostiene è che, anche se l’esperienza estetica non è l’unica risposta
corretta all’opera d’arte, essa è tuttavia una risposta fondamentale, che
può essere adeguatamente caratterizzata in termini di contenuti, facendo
riferimento alle proprietà estetiche. Il saggio di Carroll Four Concepts of
Aesthetic Experience illustra bene questa posizione, che l’autore stesso
definisce una “delfazione” ovvero un ridimensionamento del concetto 20.
Carroll vi distingue tre concezioni tradizionali dell’esperienza estetica,
quella formalista basata sul disinteresse, quella pragmatica di Dewey,
quella che denomina “allegorica” di Adorno e Marcuse (nel senso che
in loro la mancanza di finalità dell’arte diventa il simbolo del valore
utopico di essa e della sua funzione di protesta politica contro i sistemi
in cui tutto è asservito all’utilità). Nessuna di esse resiste alle critiche
che le sono state mosse. Ma è possibile parlare di esperienza estetica in
termini più modesti, evitando di rintracciare un’essenza comune dietro
i comportamenti estetici e limitandosi a descrivere l’esperienza estetica
in termini di attenzione agli aspetti formali e compositivi dell’opera e
alle sue qualità estetiche ed espressive. Quel che importa, conclude
Carroll, è porre fine alla moratoria che ha colpito l’esperienza estetica
impedendo per parecchio tempo che se ne parlasse e si riflettesse su
di essa.
Apparentemente, il saggio di Richard Shusterman The End of ����
Aesthetic Experience è ancora più disincantato, o almeno il titolo stesso
lo fa pensare. Buoni quattro quinti del saggio di Shustermann sono
occupati da un bilancio degli attacchi portati alla nozione di esperienza
estetica in ambito sia continentale sia analitico, un bilancio culminante
nella risoluta negazione di Danto. Ma proprio da questa negazione riparte, in coda al saggio, un’appassionata difesa dell’esperienza estetica.
Dividere e opporre, come fa Danto, piacere e significato, sentimento e
conoscenza, godimento e comprensione significa perdere di vista che
120
quel che l’arte fa è proprio tenere assieme queste coppie di presunti
opposti. Le critiche all’esperienza estetica hanno dimostrato che essa
non fornisce né una condizione sufficiente né una condizione necessaria per l’applicazione del nostro concetto di arte, ma questo non significa che essa non costituisca «a more general background condition for
art». L’anestetizzazione dell’estetica propiziata da Dickie e Danto non
ha portato niente di buono, perché, riflettendosi sulle arti stesse, le ha
chiuse sempre di più in un circuito autoreferenziale e intellettualistico
lontano dal gusto popolare. Vale la pena, dunque, di richiamare in vita
la nozione di esperienza estetica, «not for a formal definition but for
art’s reorientation toward values and populations that could restore its
vitality and sense of purpose» 21.
Ma con Shusterman il sentiero che abbiamo cercato di percorrere
si rivela un cammino circolare, e ora il cerchio si chiude. Shusterman
è infatti l’estensore del capitolo su Dewey nel recente Routledge Companion to Aesthetics 22, un’appassionata difesa dell’estetica di Dewey e
del contributo che la tradizione pragmatista può apportare all’estetica.
Come già aveva sostenuto in Pragmatist Aesthetics del 1992 23, Shusterman è convinto che l’orientamento esclusivo verso gli oggetti artistici piuttosto che verso l’esperienza estetica manifestato dall’estetica
analitica sia una strada poco fruttuosa, che proprio l’innesto della tradizione pragmatista sull’estetica analitica può aiutare a evitare. E l’apporto più fruttuoso che questa tradizione può dare è proprio il concetto di esperienza elaborato da Dewey, un concetto “trasformazionale”, ben diverso da quello meramente demarcativo-definitorio proprio
della filosofia analitica, e quindi attento alla considerazione fenomenologica dell’esperienza estetica e alla sua relazione con l’esperienza in
genere. Dietro il ritorno dell’esperienza estetica nella filosofia angloamericana contemporanea si delinea insomma, ben chiaramente distinguibile, l’ombra per nulla minacciosa, anzi bonaria e amichevole, del
vecchio Dewey.
�
1
E. Bullough, La distanza psichica come fattore artistico e principio estetico, tr. it. di
G. Compagno, “Aesthtetica Preprint”, 50 (agosto 1997), pp. 58-59.
2
J. Dewey, Arte come esperienza, tr. it. a c. di G. Matteucci, Palermo, Aesthetica,
2007, pp. 314-15.
3
Ivi, p. 70.
4
J. Stolnitz, On the Significance of Lord Shaftesbury in Modern Aesthetic Theory,
in “Philosophical Quarterly”, 1961; On the Origins of Aesthetic Desinterestedness, in
“Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 1961.
5
Lo nota correttamete A. Goldman in The Aesthetic, in B. Gaut e D. Lopes, The
Routledge Companion to Aesthetics, London – New York, Routledge, 2002, p. 255 ss.
6 G. Dickie, The Myth of the Aesthetic Attitude, in “American Philosophical Quarterly”, 1964, 1, pp. 55-66;
7 M. C. Beardsley, Aesthetic Experience Regained (1969), in Id., The Aesthetic Point
of View, Ithaca, Cornell University Press, 1982, pp. 77-92.
121
8
G. Dickie, Art and the Aesthetic. An Institutional Analysis, Ithaca, Cornell University Press, 1974
9
A. Danto, The Transfiguration of the Commonplace, Cambridge, Harvard University Press, 1981, pp. 21-24.
10 Ivi, p. 90 ss.
11 E. Zemach, Real Beauty, Pennsylvania State University Press, 1997.
12 T. Cohen, Aesthetic-Non aesthetic and the Concept of Taste: a Critique of Sibley’s
Position, in “Theoria. A Swedish Journal of Philosophy”, 1973, pp. 113-52.
13 Per una più ampia critica alle teorie procedurali di definizione dell’arte mi permetto di rinviare al mio La definizione dell’arte, in P. D’Angelo (a c. di), Introduzione
all’estetica analitica, Roma-Bari, Laterza, 2008.
14 Per una critica più articolata a queste posizioni mi permetto di rinviare al mio
saggio Su cosiddetto cognitivismo scientifico nell’estetica ambientale contemporanea, in R.
Calcaterra (a cura di), Le ragioni del conoscere e dell’agire. Scritti in onore di R. Egidi,
Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 243-57.
15 A. C. Danto, The Abuse of Beauty. Aesthetics and the Concept of Art, Chicago,
Open Court, 2003. Si veda in part. p. xix.
16 R. Scruton, Art and Imagination. A Study in the Philosophy of Mind, London,
Methuen, 1974.
17 J. Levinson, The Pleasures of Aesthetics, Ithaca, Cornell University Press, 1996.
18 K. Walton, How Marvelous! Toward a Theory of Aesthetic Value, in “Journal of
Aesthetics and Art Criticism”, 1993.
19 M. Budd, Values of Art, London, Penguin, 1995.
20 N. Carroll, Four Concepts of Aesthetic Experience, in Id., Beyond Aesthetics, Cam����
bridge, Cambridge U. P., 2001.
21 R. Shusterman, The End of Aesthetic Experience, in “The Journal of Aesthetic
and Art Criticism”, 1997, 1, pp. 29-41; di recente Shusterman ha accentuato la sua
“riabilitazione” dell’esperienza estetica in Aesthetic Experience: from Analysis to Eros,
in “The Journal of Aesthetic and Art Criticism”, 2006, 2, pp. 217-29.
22 R. Shusterman, Pragmatism. Dewey, in B. Gaut e D. Lopes, The Routledge Companion to Aesthetics, cit., pp. 121-32. Un altro saggio recente nel quale le tesi di Dewey
vengono considerate un punto di orientamento ancora valido per la discussione odierna
sull’esperienza estetica è J. Petts, Aesthetic Experience and the Revelation of Value, in
“The Journal of Aesthetic and Art Criticism”, 2000, 1, pp. 61-70.
23 R. Shusterman, Pragmatist Aesthetics. Living Beauty, Rethinking Art, Oxford,
Blackwell, 1992. Per il ritorno delle dottrine pragmatiste in altri campi della filosofia
analitica, si veda R. M. Calcaterra (a cura di), Pragmatismo e filosofia analitica, Macerata,
Quodlibet, 2006.
122
Come leggere Art as experience
nel quadro dell’orizzonte estetico attuale?
di Mario Perniola
1. L’orizzonte estetico – Quale posto occupa la grande opera estetica
di John Dewey nel quadro dell’estetica attuale? A quali pericoli di
fraintendimento è esposta? Per rispondere a questa domanda bisogna
innanzitutto descrivere sommariamente la tendenza prevalente nella
ricerca estetica di oggi, che è caratterizzata da un duplice processo.
Da un lato si assiste ad un ampliamento dell’orizzonte estetico che
tende a includere sempre nuovi territori e oggetti di studio. Dall’altro
l’unità dell’orizzonte estetico si spezza in una molteplicità di ricerche e
di indirizzi e che sembrano avere poco che fare gli uni con gli altri. La
situazione mi pare caratterizzata da due tendenze opposte: l’una verso
l’espansione, che si potrebbe definire come la svolta culturale dell’estetica, attraverso la quale l’estetica finisce a identificarsi con lo studio
della cultura; l’altra verso la frammentazione, che si potrebbe definire
come la decostruzione dell’estetica, attraverso la quale perfino le nozioni
fondamentali dell’estetica perdono il loro carattere unitario.
Come tutti sappiamo, l’orizzonte estetico si è costituito fin dal Settecento dall’incontro di quattro problematiche differenti che facevano
capo a quattro oggetti distinti: il bello, l’arte, la conoscenza sensibile
e l’educazione. Tuttavia questo accordo è durato molto poco. Già per
Kant il giudizio non appartiene più all’ambito della conoscenza sensibile. Dopo poco Schelling ed Hegel spezzano l’accordo tra la bella
natura e l’arte e ritengono che il titolo Filosofia dell’arte sia preferibile
a quello di Estetica. Lo stile di vita estetico, che Schiller aveva identificato con la formazione dell’umanità, diventa oggetto della critica
di Kierkegaard. L’orizzonte estetico non è più un luogo di pace e di
armonia, ma un campo di battaglia in cui quattro contendenti (il bello,
l’arte, la conoscenza e gli stili di vita) si confrontano e si affrontano
dando luogo alle più varie situazioni strategiche. L’orizzonte estetico
è caratterizzato da un dinamismo permanente che di tanto in tanto si
manifesta in aperti conflitti, ma che è sempre attraversato da tensioni
e attriti.
I contendenti che agiscono all’interno di tale orizzonte non sono
individuabili in modo essenzialistico indipendentemente dalle relazioni che via via stabiliscono gli uni con gli altri. Chi si interroga sulla
loro identità, cioè si chiede che cos’è l’arte, che cos’è il bello, che
123
cos’è l’estetico (inteso al neutro come l’oggetto per eccellenza della
disciplina estetica), che cos’è la condotta esemplare, corre il rischio
di arrivare a risultati nulli. Questo approccio metodologico, anche se
preceduto da un’ampia rassegna storica dei vari modi in cui sono stati
pensati il bello, l’arte, l’estetico e lo stile di vita esemplare, arriva alla
conclusione sconfortante che tutto può essere considerato come bello
(anche il brutto nelle sue varie declinazioni), come arte (anche l’antiarte), come estetico (anche l’anestetico), come stile di vita esemplare
(anche l’abiezione).
2. Espansione dell’orizzonte estetico – Nel mio libro L’estetica del
Novecento 1 ho cercato di fornire le linee generali dell’orizzonte estetico
di quel secolo delineando cinque concetti fondamentali all’interno delle
quali possono compresi i più significativi contributi a questa disciplina.
Questi concetti filosofici sono la vita e la forma (riportabili a Kant), la
conoscenza e l’azione (riportabili a Hegel), e infine il sentire (riportabili
a Nietzsche). Ancora oggi una gran parte dei contributi estetici contemporanei si muovono all’interno di queste cinque nozioni.
Tuttavia un numero crescente di ricerche e di studi sta ampliando
ulteriormente l’orizzonte estetico allargando in modo considerevole i
confini della disciplina e mutando le sue caratteristiche essenziali. Il
senso generale di questa tendenza è quella di considerare l’estetica
come un campo di studi più vasto della filosofia. Questo fenomeno è
stato descritto come la svolta culturale dell’estetica. Due recenti opere
monumentali condividono questo progetto: la prima è l’Encyclopedia of
Aesthetics, diretta da Michael Kelly, recentemente pubblicata in quattro
grossi volumi 2, alla cui stesura hanno contribuito più di cinquecento
studiosi di varie specialità; la seconda è l’Aesthetische Grundbegriffe,
diretta da Karlheinz Barck, in sette grossi volumi 3. Si tratta di opere
differenti tra loro e di diverso rigore metodologico; tuttavia presentano
alcuni aspetti comuni.
L’enciclopedia anglo-americana è molto esplicitamente ispirata da
una metodologia che considera l’estetica come un meeting place, un
luogo d’incontro di numerose discipline e di varie tradizioni culturali.
Essa cerca così di colmare lo iato esistente tra il sapere estetico e la
società contemporanea. Infatti ciò che caratterizza quest’ultima è l’incontro e la mescolanza di codici appartenenti ad ambiti diversi: essa si
sviluppa attraverso una continua interazione di segni e un incessante
slittamento di significati. A essere inadeguato rispetto alle sollecitazioni della società contemporanea non sarebbe tanto il sapere estetico
tradizionale quanto la sua pretesa teoretico-speculativa. Sembra che
l’estetica possa essere fruttuosa solo se riesce ad aprire un orizzonte
epistemologico caratterizzato dalla flessibilità. In fondo, alla base della
metodologia dei Cultural Studies sta il principio barocco dell’ingegno
che consiste nell’avvicinare cose a prima vista lontane e nell’allontanare
124
cose a prima vista prossime. Tale principio è ancora più importante
se applicato alla ricerca, la quale è generalmente tanto più originale
e innovativa, quanto più esplora le zone marginali e i confini delle
conoscenze canoniche. Trovano un’ampia trattazione voci su fenomeni
alternativi e considerati come marginali dalla tradizione estetica come
“lesbian aethetics”, “gay aethetics”, “feminism”, “Aids, aesthetics and
activism”, “obscenity” “sexuality”, “situationist aethetics”, “iconoclasm and iconophobia”. Questa scelta non conformistica è confermata
dall’introduzione nel canone estetico di fenomeni che non appartengono all’“alta cultura”, come “comics” “popular culture” “fashion”,
“rock music”, “jazz”, oppure fanno parte dell’avanguardia artistica più
trasgressiva come “anti-art”, “performance art”, “installation art”. Le
origini dell’attuale svolta culturale si trovano già nel Settecento per
esempio in Inghilterra dove la parola usata per designare l’estetica è
criticism. Fin dall’inizio dunque l’approccio estetico anglosassone alla
società e alle arti si caratterizza in senso non conformistico ed è con
un’idea della cultura intesa come formazione di una sfera pubblica
discorsiva a cui tutti possono partecipare. Con la parola criticism si
intende infatti il diritto di ciascuno ad esprimere una valutazione ed
un apprezzamento indipendenti dai canoni ufficiali e dalle gerarchie
convenzionali.
Anche l’opera tedesca, le cui voci sono veri e propri saggi, ha un
approccio non conformistico alla problematica estetica contemporanea, in particolare in alcune voci come “Alltäglish, Alltag”, “Design”,
“Ekel”, “Erotisch, Erotik, Erotismus”, “Film, filmisch”, “Kommunication”, “Medien, medial”, “Négritude, Black Aesthetics, créolité”,
“Performance”, “Schrecken, Schock”, “Subkultur”, “Warenaesthetik,
Kulturindustrie”. C’è però dietro l’opera tedesca una conoscenza molto
maggiore della storia dell’estetica e delle origini di questa svolta culturale, la quale non è poi così nuova come pretendono i sostenitori dei
Cultural Studies. Il padre fondatore dell’estetica culturale in Germania
può essere considerato Jakob Burckhardt il quale ha considerato la
cultura come una potenza critica nei confronti dello stato e della religione, definendola come la somma complessiva delle manifestazioni
dello spirito che avvengono spontaneamente e non rivendicano nessuna
validità universale e coercitiva. Essa nasce da una eccedenza, da un
surplus inutilizzato che inizialmente può essere anche molto esiguo,
ma si sviluppa se trova le condizioni favorevoli, cioè l’assenza di repressione, la possibilità di avere relazioni sociali non funzionali, la
sicurezza delle condizioni materiali di vita. Ogni azione se eseguita con
zelo e non per puro servilismo contiene in se stessa questa eccedenza
che trova nell’arte la più alta manifestazione. Con Burckhardt l’intera
storia universale diventa l’oggetto di una visione estetica, cioè distanziata e disinteressata, che prende in considerazione anche l’individuo,
relativizzando le nozioni di successo e di fallimento.
125
La svolta culturale dell’estetica implicita nell’opera storica di Burckhardt
consente di inserire nella storia dell’estetica del Novecento e quindi nel
canone estetico tutta una serie di autori e pensatori che comunemente
sono rubricati nella storiografia o nelle scienze umane come lo storico
Georg Mosse, i sociologi Plessner e Gehlen, il semiotico Umberto Eco,
il pensatore giapponese Watsuji e molti altri. In epoca più recente importantissimo per questo ampliamento culturale dell’estetica mi sembra
il sociologo francese Pierre Bourdieu e dei suoi allievi.
La riflessione di Pierre Bourdieu sulla nozione di “disinteresse interessato” è della più grande importanza, perché espande le frontiere
dell’estetica e getta le premesse di una nuova sintesi più vasta in grado
di rispondere alla sfida proveniente dalla globalizzazione dei saperi e
delle conoscenze. Non si tratta infatti di proporre una generica interdisciplinarietà che il più delle volte apre la strada al confusionismo
comunicativo. La strategia teorica della nuova sintesi estetica consiste
nel prendere sotto l’egida di un’economia dei beni simbolici tutte le
attitudini, i comportamenti, le azioni, in una parola tutti gli habitus
guidati da quel “disinteresse interessato”, che nel corso dei secoli ha
costituito l’aspetto essenziale dell’esperienza estetica.
Sotto l’estetica vengono così a trovarsi non solo le arti, ma anche
tutte quelle attività scientifiche, professionali e burocratiche che implicano per definizione libertà e autonomia rispetto all’economia del
profitto immediato e della negoziazione e che sono dirette verso la
formazione di un capitale culturale e simbolico non riducibile al capitale economico. L’estetica finisce così col fornire i criteri deontologici
dai quali è retto l’esercizio di ogni attività intellettuale e sui quale si
fonda il suo prestigio.
A maggior ragione rientrano nell’estetica i rapporti familiari, educativi, di amicizia, e di amore che da sempre sono stati considerati come
indipendenti da contrattazioni esplicite e controllate, ma anche come
fonti di obbligazioni molto più impegnative e prolungate nel tempo.
L’essenziale è cominciare a sottrarsi nelle piccole come nelle grandi
cose a quel “pensiero unico” che pretende di appiattire sotto il suo
rullo compressore dell’economia ristretta e quantitativa tutti gli aspetti
dell’esistenza. La nuova sintesi estetica può fornire così le coordinate
teoriche e gli strumenti concettuali che consentono di trasformare la
crescente insofferenza nei confronti della comunicazione massmediatica, in una strategia globale di resistenza e di lotta. Attraverso questo
ampliamento è del resto possibile comprendere ed apprezzare le logiche che regolano i rapporti sociali nelle cosiddette “società tradizionali” le quali non a torto si oppongono ad una colonizzazione che ha
assunto l’aspetto di una dissennata autodistruzione della stessa cultura
occidentale.
3. Frammentazione dell’orizzonte estetico – A questa espansione del126
l’orizzonte estetico corrisponde tuttavia una linea di tendenza opposta,
che decostruisce i concetti fondamentali dell’estetica occidentale, mostrando come essi siano inseparabili dalle lingue in cui sono espressi. Il
Vocabulaire Européen des Philosophies. Dictionnaire des Intraduisibles,
realizzato sotto la direzione di Barbara Cassin 4, costituisce un risultato
rilevantissimo di questo tipo di approccio metodologico ai problemi
della filosofia, che ha nel Vocabolario delle istituzioni indoeuropee di
Émile Benveniste, il suo modello ispiratore. Il punto di partenza di
quest’opera che in milllecinquecentotrentadue pagine prende in esame
quattrocento parole chiave delle principali lingue europee è la constatazione che molti termini del linguaggio filosofico sono così strettamente
legati alla lingua nella quale sono elaborati concettualmente da risultare
intraducibili, oppure traducibili solo attraverso uno slittamento di significato che deve in ogni caso evidenziato. Ne risulta che da un lato non
c’è concetto senza parola: poiché quest’ultima appartiene ovviamente ad
una lingua specifica, la condizione di un approccio metodologico non
ingenuo alla filosofia passa attraverso lo studio del singolo termine e
dalla comparazione del modo in cui è tradotto nelle altre lingue. La parola non è affatto il segno di un concetto, ma è radicata nelle lingue.
Come spiega Barbara Cassin nell’introduzione, tale metodologia
implica il rifiuto dell’universalismo logico che sostiene l’esistenza di
un universale logico, identico in tutti i luoghi e in tutti i tempi: poco
importa la lingua in cui viene detto. Il modello a cui esso si ispira è
la logica matematica: nell’impossibilità di una formalizzazione radicale
del linguaggio filosofico, l’uso di un inglese internazionalizzato (cioè
privato delle sue caratteristiche letterarie) costituisce un compromesso
accettabile per i tempi moderni, svolgendo così una funzione analoga
a quella svolta dal latino per quasi due millenni. È questa la scelta della corrente analitica della filosofia contemporanea, la quale – secondo
Barbara Cassin – unisce «l’angelismo del razionale col militantismo del
linguaggio ordinario».
Nello stesso tempo tuttavia la metodologia seguita da quest’opera
rifiuta la posizione opposta all’universalismo logico, il nazionalismo
ontologico, che enfatizza il rapporto tra la filosofia e la lingua al punto
di ritenere la meditazione filosofica inseparabile dalla lingua in cui si
manifesta. I concetti sarebbero così radicati nell’esperienza collettiva
di un popolo al punto che ogni traduzione o decontestualizzazione
darebbe luogo al fraintendimento e al malinteso. L’atteggiamento di
sufficienza e di altezzosità con cui vengono percepiti dalle grandi culture nazionali i contributi che le riguardano provenienti da stranieri,
è appunto un sintomo quanto mai significativo di tale atteggiamento,
quasi che ognuno sia legittimato a parlare solo degli autori che appartengono alla sua lingua madre. Secondo i sostenitori del nazionalismo
ontologico, le lingue filosofiche per eccellenza sarebbero il greco per
l’antichità e il tedesco per la modernità.
127
L’approccio metodologico che ispira questo vocabolario si configura come una terza posizione alternativa rispetto alle prime due. Esso
studia i principali sintomi di differenza tra le lingue e va alla ricerca
dei termini che nelle singole lingue europee presentano caratteri così
particolari da risultare intraducibili. Nello stesso tempo si interroga
sulla specificità del linguaggio filosofico delle singole culture nazionali,
per cui il francese, l’inglese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo, il russo,
il portoghese e il greco costituiscono altrettanti lemmi autonomi, mentre il greco antico, il latino, l’ebraico e l’arabo sono trattati nella voce
“Lingue e tradizioni”. I presupposti teorici su cui è costruito questo
vocabolario sono due. In primo luogo in ogni termine filosofico di
qualsiasi lingua esiste una tensione tra la pretesa di universalità del
concetto e la sua espressione linguistica: proprio su tale tensione si
basa la specificità del linguaggio filosofico rispetto a qualsiasi altro. In
secondo luogo, ogni lingua apre su un modo particolare di vedere il
mondo e contiene un intero un sistema di concetti che si rimandano
l’un l’altro.
Ne deriva che anche i concetti fondamentali dell’estetica non sfuggono a questa decostruzione. Prendiamo la parola da cui prende origine l’estetica e la sua traduzione in molte lingue occidentali. La parola
senso è una delle più ambigue del vocabolario filosofico. Essa infatti
ha quattro differenti significati che si intrecciano e si contaminano in
modo molto complesso. Ve le elenco brevemente: (1) “sensazione”,
“percezione sensibile” (aisthêsis); (2) “comprensione”, “percezione
intellettuale” (nous); (3) “significato” (sêma); (4) a queste bisogna aggiungere anche “direzione” (come quando nella segnaletica stradale si
parla di un senso vietato). Tale polisemia non esiste in greco, il quale
dispone di termini differenti per indicare queste quattro accezioni.
Faccio un esempio che riguarda direttamente l’idea intorno a cui
ruotano alcuni miei libri recenti: il sentire impersonale 5. Se traduciamo la parola senso in inglese: troviamo feeling (di etimologia anglosassone). È stato infatti osservato che il verbo to feel è sovente usato
al passivo, senza indicazione di colui che sente, come nell’espressione
spesso ricorrente nell’opera di Hume: “Something felt”, che si riesce
a tradurre molto male con “qualcosa di sentito”. A questa desoggettivazione corrisponde una deoggettivazione, perché il feeling non ha
un oggetto prestabilito come ha la sensazione, tanto è vero che si può
dire “I feel a sensation”o “I feel my mind”, mentre l’espressione “sento
una sensazione” costituisce un pleonasmo.
Feeeling rimanda quindi ad un sentire impersonale. La difficoltà di
tradurre la parola feeling non deriva soltanto dalla sua etimologia che
è completamente differente da senso. Più radicalmente è l’operatore
–ing a essere intraducibile. Tradurre feeling con il sentire significa sostanzializzarlo troppo. Certo il sentire è più impersonale del senso, ma
si configura o come una facoltà soggettiva sostanzializzata o al contrario
128
come un non sentire affatto, nel caso che non si riesca ad immaginare
un sentire senza soggetto. Per esprimere più correttamente il tipo di
esperienza neutra ed impersonale che costituisce il cardine intorno a cui
ruota la mia riflessione sull’affettività, si dovrebbe inventare una parola
che la grammatica italiana non consente, il sentendo, cioè la sostantivazione di un gerundio. Nella sostantivazione di un infinito, il sentire, va
perduta la dimensione progressiva implicita nell’operatore –ing In altre
parole, in italiano, in francese e in tedesco, trasformare un verbo in un
sostantivo, implica nello stesso tempo sostanzializzarlo metafisicamente, correndo il rischio di regredire da una metafisica del soggetto (di
derivazione cartesiana) a una metafisica della sostanza. L’inglese invece
ci fornisce la possibilità di sostantivare senza sostanzializzare, di creare
concetti che eludono lo schema soggetto-oggetto all’interno del quale
rimaniamo prigionieri in lingue che hanno una impronta metafisica.
4. Arte come esperienza o esperienza come arte? – Se considero il
grande libro di Dewey, Art as experience, alla luce dell’attuale situazione dell’estetica, osservo che esso corre il rischio di costituire una
legittimazione di un approccio pseudo-culturalistico che propone considerare di qualsiasi esperienza quotidiana, sic et simpliciter, come dotata
di un significato e di un valore estetico. Se così fosse il libro di Dewey
avrebbe dovuto intitolarsi Experience as art. Ora invece non c’è dubbio
che l’accento è posto sull’arte, intesa come il punto di arrivo di una
“vera” esperienza.
In un passo particolarmente significativo, Dewey paragona l’esperienza estetica al sentire una pietra che rotola giù da una collina per
avere un’esperienza (A generalized illustration may be had if we immagine a stone, which is rolling down ill, to have an experience”) 6. Dewey
suppone che questa pietra sia dotata di immaginazione, si interessi alle
cose che incontra nel suo cammino, attribuisca loro l’effetto di accelerare o di ritardare il suo movimento, provi sentimenti nei confronti
del loro aiuto o del loro ostacolo e alla fine si fermi al termine della
sua corsa. Tutto ciò le è accaduto è pensato da lei come il culmine di
un processo continuo.
Per Dewey questa pietra senziente avrebbe fatto un’esperienza dotata di qualità estetica, innanzitutto perché non si è limitata a soltanto
pensare tutto il suo cammino, ma lo ha effettivamente compiuto. Dewey
sottolinea il carattere pratico di tale vicenda, non tanto per opporsi a
quelle estetiche che attribuiscono all’arte una funzione solo conoscitiva,
ma per separare l’esperienza estetica dalle prospettive meramente edonistiche. Perché l’esperienza arrivi alla sua dimensione estetica è necessaria
una lotta che comporta per lo più sofferenza e dolore: ciò consente a
Dewey di emancipare l’esperienza estetica dalla connessione col piacere,
che era stato l’oggetto della critica di Tolstoj. Dewey si muove in un una
direzione che rompe risolutamente con le estetiche edonistiche: «in ogni
129
esperienza c’è un elemento di patimento, di sofferenza in senso lato»
(There is […] an element of undergoing, of suffering in a large sense,
in every experience) 7. Il piacere e il dolore, come tutte le altre emozioni, d’altra parte, non devono essere considerate separatamente, ma
connesse col carattere processuale dell’esperienza, che si svolge come
la vicenda di un romanzo o di un dramma: l’emozione appartiene a
una entità che è impegnata in una lotta dalla quale essa acquista significato. La sospensione, che tante teorie considerano come un aspetto
essenziale dell’esperienza estetica, non deve essere intesa come distacco
dalla pratica, ma come attesa, incertezza sull’esito, tensione verso il perfezionamento dell’esperienza. La domanda sul “come va a finire” è un
fattore estetico determinante perché consente di intendere l’esperienza
come un’unità non immobile, ma articolata e dinamica, fatta di azioni
e passioni. Perciò Dewey preferisce parlare di “esperienza” anziché di
“azione” estetica: infatti l’agire e il subire si alternano e si compenetrano. Ogni azione è in realtà “interazione” col mondo esterno, mutuo
adattamento dell’individuo e dell’ambiente, interscambio di sensazioni
e di riflessioni. L’attivismo frenetico impedisce di accedere alla dimensione estetica, vale a dire ad una vera esperienza, perché non lascia
il tempo di pensare, di approfondire e rielaborare cognitivamente ed
emozionalmente ciò che si vive. Anche l’eccesso di ricettività costituisce
un ostacolo, perché deforma l’esperienza attraverso un accumulo di
fantasie e di impressioni passive, le quali fanno perdere il contatto con
la realtà del mondo e non portano a nessuna risoluzione.
La preoccupazione fondamentale da cui prende le mosse il discorso di Dewey è quella di collegare strettamente l’esperienza estetica
all’esperienza ordinaria: perciò egli critica quelle teorie che separano
l’arte dalla vita quotidiana e che la isolano collocandola in un regno
suo proprio; occorre invece ristabilire la continuità tra la dimensione
estetica e i fenomeni vitali normali che implicano processi di continua
lotta e interazione col mondo circostante. Non esiste, secondo Dewey,
una differenza radicale tra l’esperienza comune e quella estetica: ogni
esperienza può diventare estetica se essa, invece di essere interrotta e
abbandonata (come continuamente accade), viene proseguita e portata
a compimento. Ciò che caratterizza l’esperienza estetica è dunque il
compimento (fulfillment): l’azione diviene “bella” nella misura in cui
io mi impegno in essa, mi dedico ad essa, combatto per la sua piena
estrinsecazione. Il contrario di una esistenza estetica è una vita che va
alla deriva, che non ha né capo né coda, né inizio né termine; oppure
è un’esperienza che ha un cominciamento, ma che viene abbandonata
per ignavia, viltà, inclinazione al compromesso, desiderio di “quieto
vivere”, ossequio alle convenzioni.
5. The Rolling Stone – Tuttavia il fatto che Dewey trovi in una
pietra che rotoli il paragone più adatto per spiegare la sua idea di espe130
rienza estetica mi è sempre sembrato molto strano. Questa impressione
viene da lontano: Arte come esperienza è il primo libro di estetica che ho
letto in vita mia, quando avevo sedici anni, l’unico volume che ho fatto
rilegare facendo imprimere il nome dell’autore e il titolo con caratteri
d’oro sul dorso, nonché l’opera che mi ha accompagnato fino a oggi
attraverso il suo frequente inserimento nei programmi dei corsi tenuti
all’Università. Inoltre è stato una fonte essenziale per l’elaborazione
dell’estetica della formatività del mio maestro Luigi Pareyson 8. Col
senno di poi, vi vedo la formulazione archetipica della nozione di una
“cosa che sente”, la quale costituisce l’idea centrale intorno alla quale
ruota il mio libro Il sex appeal dell’inorganico 9.
Come molti sanno, l’espressione ritorna nel nome di un notissimo
gruppo musicale che ha rappresentato per decenni il modello alternativo del rock, quello che ha espresso nel modo più radicale la rivolta
giovanile a cominciare dagli anni Sessanta, The Rolling Stones appunto.
Tuttavia difficilmente si può immaginare che siano stati lettori di John
Dewey!
Probabilmente tanto Dewey quanto i Rolling Stones traggono spunto da una stessa fonte: un proverbio molto noto nel mondo anglosassone, ma di origine antica, commentato anche da Erasmo nei suoi
Adagia. Questo suona in latino Saxum volutum non obducitur musco,
in inglese suona A rolling stone gathers no moss, letteralmente “una
pietra che rotola non raccoglie muschio”. In siciliano si dice “petra
smossa non pigghia lippa”. Al proverbio vengono comunemente attribuiti due significati. Nel primo senso, vuol dire che persone che sono
sempre in movimento non riescono a piantare radici da nessuna parte;
in un secondo, senso si riferisce a persone che evitano di assumersi
incarichi gravosi.
6. Vivere coraggiosamente – Si è detto che la pietra che rotola, metafora dell’esperienza estetica, fa un’esperienza che ha un compimento. Ma che cosa vuol dire esperienza e compimento? Queste sono le
due nozioni chiave dell’estetica di Dewey, il cui senso è prima vista
tutt’altro che chiaro. Experience (come l’italiano esperienza e il francese expérience) viene dal latino experientia, parola che sta nello stesso
campo semantico-concettuale di periculum e di peritus. Si tratta di un
campo semantico molto ampio all’interno del quale sta tanto l’experimentum quanto il perire: esso rimanda quindi insieme all’idea di insicurezza e di rischio quanto a quella di competenza e di maestria. Allo
stesso ambito linguistico appartiene il greco peîra, che vuol dire prova,
tentativo, esperimento.
Il campo semantico-concettuale invece cambia completamente se
facciamo adoperiamo la parola tedesca Erfahrung, sulla quale Heidegger ha scritto uno testo fondamentale, Hegels Begriff der Erfahrung 10.
Secondo Heidegger, esiste una specie di coappartenenza essenziale
131
tra la nozione di Erfahrung e la dialettica hegeliana: l’esperienza è la
modalità propria dell’esser-presente, dell’auto-rappresentazione. Tale
connessione è implicita nella lingua. L’esperire (erfahren) implica un
fahren, cioè un procedere, uno studiare la via da prendere, un porsi in
cammino verso il sapere assoluto: il suo punto di arrivo è la scienza,
non il rotolare della pietra. L’esperienza è per Hegel inaccessibile al
sapere naturale: la continuità posta da Dewey tra la dimensione ordinaria dell’esistere e la dimensione estetica non appartiene alla dialettica
hegeliana, la quale mira ad un “sistema della scienza”, cioè ad una
organizzazione stabile dell’assoluto.
Se nelle parole di origine romanza è implicita l’idea del pericolo
e di un tentare pratico (quasi direi artigianale, tecnico, nel senso che
la tecnica è un procedere per tentativi anziché per deduzioni, come
nella nozione greca di metis) 11, l’Erfahrung è il cammino attraverso
il quale lo spirito si insedia completamente in tutto il regno della sua
verità. Erfahrung non è perciò una parola che appartiene al pensiero
heideggeriano. La traduzione in termini heideggeriani della nozione di
esperienza è piuttosto Gefahr, che è formato dallo stesso verbo fahren,
ma significa pericolo, e quindi sta nello stesso campo concettuale di
esperienza 12.
In altre parole, cosa vuol dire in primo luogo avere un’esperienza?
Lo aveva detto Nietzsche in una frase famosa: vivere pericolosamente
(gefährlich leben). Vivere senza mettere radici, cioè in transito. Non si
tratta tuttavia di andare alla deriva (non to drift, essere trascinato dalla
corrente), ma vivere con coraggio, secondo quella virtù cardinale che
molti secoli prima Tommaso d’Aquino aveva definito come magnanimità, magnificenza, pazienza e perseveranza 13.
7. Vivere coerentemente – Il proverbio A rolling stone gathers no
moss può essere interpretato anche in un altro senso: vivere senza assumere impegni ed essere coinvolti in responsabilità e impegni gravosi.
Qui tocchiamo la specificità dell’esperienza estetica rispetto all’esperienza in generale. Infatti il disinteresse costituisce un aspetto che a partire
da Kant viene attribuito molto spesso all’esperienza estetica. Non mi
sembra che Dewey accetti questa posizione. Per quanto affermi che
esiste continuità tra esperienza ordinaria ed esperienza estetica, tuttavia
sottolinea energicamente che una differenza esiste: la cosiddetta esperienza ordinaria non è una vera esperienza. La strategia concettuale che
sottende al pensiero di Dewey non va affatto in una direzione riduttiva
(come spesso viene erroneamente interpretato): l’accento non è posto
sulla nuda esperienza, ma sul fatto che solo l’esperienza è veramente
tale solo quando è estetica, cioè pericolosa e coerente.
Cosa vuol dire coerenza? Cohærens viene da hæreo essere attaccato,
dimorare fisso. A prima vista sarebbe tutto il contrario del rotolare.
Ma se si approfondisce l’indagine da un punto di viste etimologico si
132
scopre che la parola appartiene a un ceppo linguistico indoeuropeo da
cui proviene anche la parola lituana gaistu, il cui significato è esitare,
temporeggiare. La coerenza non è perciò separabile dalla esitazione,
dal temporeggiare, dal riflettere per avere il tempo di elaborare le
sensazioni e le impressioni ricevute dall’esterno.
Avere un’esperienza non è an exercise in bookkeeping, un esercizio
di contabilità: the experience is of material fraught with suspense and
moving toward its own consummation through connected series of varied
incidents 14⇢. Certo è che per Dewey perché l’esperienza sia tale, essa
deve essere coerente, cioè deve contenere uncertainty and suspense.
8. L’opera è il compimento dell’esperienza – Dewey inserisce nell’azione un parametro che è indipendente dalla riuscita o dal fallimento
pratico, senza tuttavia introdurvi delle istanze che sono estranee alla
natura dell’azione, quali la moralità. Egli fa saltare l’identità stabilita da
Kant tra ragion pratica e moralità: l’azione compiuta, cioè l’azione che
è pienamente e integralmente tale non è etica, ma estetica. Nello stesso
tempo egli sottrae l’ambito dell’azione alla politica (e alla guerra), perché la mera efficacia non basta a compiere un’esperienza: il risultato
in se stesso non compie l’azione se è separato dal processo che porta
ad esso. Il vero uomo d’azione non è né l’uomo pio, né il politico (e
nemmeno il guerriero), ma l’artista! Certo anche le azioni di Cesare e
di Napoleone avevano una qualità estetica, ma questa non dipende dal
loro successo pratico, ma dalle loro qualità specifiche.
L’abisso posto da Tolstoj tra l’estetica e l’arte è colmato da Dewey
con un’idea geniale: l’esperienza è veramente completa (e perciò pienamente estetica) quando si materializza in un’opera d’arte! Non solo
perché il processo artistico costringe l’artista ad un continuo confronto
tra ciò che ha fatto e ciò che ha ancora da fare, obbligandolo a procedere coerentemente e unitariamente, ma soprattutto perché solo a
partire dal momento in cui l’esperienza si è concretizzata in un’opera,
essa diventa trasmissibile, comunicabile e socialmente rilevante. Dewey
fornisce così una soluzione molto acuta al potenziale conflitto tra la
ricerca individuale dell’eccellenza (che è implicita nel perseguimento di
un’esperienza compiuta) e la solidarietà sociale (che induce a spostare
l’asse della propria attenzione da se stessi verso gli altri): in realtà riesce
a comunicare con gli altri ed essere loro utile solo chi porta a termine
le proprie esperienze! Del resto si sa da sempre che riesce ad andare
d’accordo con gli altri soltanto chi va d’accordo con se stesso! L’esperienza resta incompleta se non diventa percepibile per gli altri attraverso il suo risultato. L’opera, secondo Dewey, è sempre virtualmente
di dominio pubblico; la sua appartenenza a un mondo comune non
dipende dal fatto della pubblicazione, dell’esposizione o della ricezione,
ma dalla sua esistenza fisica la quale sollecita un giudizio. Perciò ogni
tensione tra l’individuale e il sociale è superata nello stesso momento
133
in cui si coglie l’intima coappartenenza tra la dimensione estetica e
quella artistica. Nessuna esperienza potrà mai essere compiuta fintanto
che rimane estetica, cioè puramente prigioniera del sentire individuale,
come un sogno o una fantasia! Chi vuole portare la propria esperienza
a compimento deve dunque per forza entrare nella produzione letteraria o artistica? Una ricerca scientifica o filosofica oppure un’impresa
politica o industriale non sono esperienze veramente compiute? La
differenza tra queste ultime e l’esperienza artistica consiste, secondo
Dewey, nel fatto solo nell’opera d’arte il processo ha altrettanto importanza quanto la conclusione: mentre nelle esperienze non artistiche
è possibile estrarre una verità, una formula, un risultato, un esito che
presenta un valore autonomo indipendente dal cammino cui ad essi si
è giunti, nell’arte invece la compiutezza riguarda non solo la fine ma
anche lo svolgimento, non solo il termine ma anche l’inizio.
Ciò non vuol dire però che per Dewey la dinamica dell’esperienza
abbia, come in Hegel, un andamento circolare, tale che il punto di arrivo si congiunga in qualche modo col cominciamento. L’azione estetica
corre verso un compimento effettivo e si conclude nel perfezionamento
dell’opera. Le esperienze estetiche sono le uniche sulle quali è possibile con buona coscienza scrivere la parola “fine”, perché esse sono
anche in tutte le loro parti comunicabili e trasmissibili. L’essenziale dell’azione sembra in Dewey consistere in questa possibilità di chiusura,
di conclusione. Sotto questo aspetto l’estetica e l’arte offrono di più
di tutte le altre attività pratiche, alle quali sembra mancare qualcosa
di importante: la vittoria o la sconfitta non sono determinanti per se
stesse; importa altrettanto come si è vinto o come si è perso. La lotta
conta quanto il risultato; la pacificazione estetica non proviene tanto
dalla soluzione dei conflitti, quanto dalla coscienza di avercela messa
tutta nel portare a termine l’impresa iniziata.
M. Perniola, L’estetica del Novecento, Bologna, Il Mulinom, 1997.
M. Kelly, Encyclopedia of Aesthetics, New York - Oxford, Oxford University Press,
1998, 4 voll.
3
K. Barck (a cura di), Aesthetische Grundbegriffe, Stuttgart-Weimar, J. B. Metzler,
2000-06, 7 voll.
4
B. Cassin (a cura di), Vocabulaire Européen des Philosophies. Dictionnaire des
Intraduisibles, Paris, Éditions du Seuil, 2004.
5
M. Perniola, Del sentire, Torino, Einaudi 2002; Il sex appeal dell’inorganico, Torino, Einaudi 2004; L’arte e la sua ombra, Torino, Einaudi 2004.
6
J. Dewey, Art as experience [1934], New York, Perigee, 2005, p. 41; tr. it di Giovanni Matteucci, Palermo, Aesthetica Edizioni, 2007, p. 65. Questa nuova traduzione è
stata preceduta da quella di Corrado Maltese, Firenze, La Nuova Italia, 1951.
7 Ivi, p. 41; tr. it. p. 66.
8 M. Perniola, Arte e interpretazione, in “Rivista di Estetica”, 1972, n. 2.
9 Cit.
1
2
134
10
M. Heidegger, Hegels Begriff der Erfahrung, in Holzwege, Frankfurt an Main,
Klosterman, 1957, pp. 105-92.
11
Per questa concezione della tecnica rimando a M. Detienne & J.-P. Vernant, Les
ruses de l’intelligence: la Metis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974.
12
M. Heidegger, Bremer und Freiburger Vorträge, Frankfurt an Main, Klosterman,
1994.
13
R.-A. Gauthier, Magnanimité. L’idéal de la grandeur dans la philosophie païenne
et dans la théologie chrétienne, Paris, Vrin, 1951. Cfr. anche S. F. Maclaren, La magnificenza e il suo doppio. Il pensiero estetico di Giovanni Battista Piranesi, Milano, Mimesis,
2005.
14
J. Dewey, cit., p. 44. Riporto le due traduzioni italiane: Corrado Maltese traduce:
«L’esperienza è esperienza di un materiale carico di sospensione che muove verso la
propria perfezione attraverso una serie coordinata di incidenti diversi» (cit., p. 54).
Giovanni Matteucci traduce invece: «L’esperienza è di un materiale carico di tensione
che va verso il suo perfezionamenro per una serie connessa di episodi».
135
Esperienza estetica e interattività
di Roberto Diodato
1. Propongo semplicemente di prendere nel senso più forte possibile il titolo dell’opera di Dewey, per cui Art as experience vuol dire
l’Arte quale esperienza 1: l’opera d’arte è esperienza estetica compiuta
e viceversa, e ciò comporta pensare l’opera d’arte non soltanto e primariamente come oggetto, ma come evento, o meglio pensarla come
oggetto-evento. Abbiamo così una convergenza stretta e determinata
tra estetica e ontologia, per la quale appunto convergono in unità l’arte
come questa opera e l’arte come questa esperienza. Ciò vale a due livelli,
particolare e generale, in quanto il singolare intreccio tra opera d’arte
ed esperienza estetica è in Dewey inteso come caso esemplare che svela
il senso dell’esperienza in genere. Dewey esplicita con precisione la
questione nel terzo capitolo di Art as experience, dove scrive: «l’estetico
[…] è lo sviluppo chiarificato e intensificato di tratti che appartengono
a ogni esperienza normalmente compiuta. Considero questo fatto la sola
base sicura su cui poter costruire una teoria estetica» 2; e proprio su
tale affermazione 3 Dewey innesta immediatamente un problema: «Nella
lingua inglese non c’è una parola che comprenda senza ambiguità ciò
che è designato dalle due parole “artistico” ed “estetico”. Dal momento
che “artistico” si riferisce anzitutto all’atto della produzione ed “estetico” a quello della percezione e della fruizione, è un peccato che manchi
un termine per designare i due processi presi insieme» 4. Nella sua
inesausta lotta contro ogni forma di dualismo, Dewey indica nell’arte
quale esperienza il luogo in cui le polarità di passività e di attività, di
costituzione e fruizione si intersecano esemplarmente dando vita alla
concretezza esistenziale dell’opera, concretezza che è oltre le differenze
tra mente e corpo, sensi e intelletto, spirito e materia. Sotto questo
aspetto l’opera d’arte è una struttura dinamica densa, leggibile come
realtà solo negli strati genetici dell’esperienza in cui consiste a livello sia
costitutivo sia fruitivo, come oggetto-evento pensabile soltanto nella sua
complessa struttura antropo-ontologica. È da questo punto di vista che
intendo il tema del compimento o perfezionamento dell’esperienza che
caratterizza per Dewey l’esperienza estetico-artistica: non come piacere
o godimento per quanto complesso che il soggetto dell’esperienza estetica proverebbe quale contrassegno della compiutezza dell’esperienza
stessa, quasi fosse possibile una risonanza e una traduzione nell’ambito
137
dei flussi di interessi esistenziali del piacere disinteressato di kantiana
memoria, ma come perfezionamento e quindi comprensione vissuta insieme intelligente e sensibile del senso dell’esperienza.
Che quanto nell’arte quale esperienza estetica peculiarmente si disvela sia estendibile come senso dell’esperienza in genere e quindi dell’essere stesso del mondo credo venga in chiaro nell’analisi della funzione
della copula nella costruzione del giudizio predicativo che Dewey compie nella sua Logica, teoria dell’indagine, dove scrive: «Etimologicamente
la parola è deriva da una radice che significa stare o soggiornare. Il
rimanere e perdurare è un modo d’azione. Quanto meno, esso indica
un temporaneo equilibrio d’interazioni. Ogni mutamento temporale è
di natura esistenziale. Di conseguenza la copula nel giudizio, sia essa
un verbo transitivo o intransitivo, o l’ambigua forma “è”, ha di per
se stessa riferimento alla realtà» 5. Ora la copula può anche, a livello
riflessivo-esplicativo, essere segno di una relazione puramente logica,
ma «La situazione alla quale la frase si riferisce determina senza ambiguità se “è” ha una forza attiva, che esprime un cambiamento in atto o
potenziale, o se esprime una relazione fra significazioni o idee […] La
copula di un giudizio esprime di conseguenza, a differenza del termine
della relazione formale, la trasformazione effettiva della materia trattata
da situazione indeterminata a situazione determinata. Lungi dall’essere
un elemento isolabile, la copula può essere addirittura considerata come
ciò che mette in opera i contenuti soggetto-e-predicato» 6. Dewey vede
insomma addirittura nei giudizi predicativi la forza esplosiva del plesso
essere-esperienza, la sua dinamicità, che viene prima delle oggettualità
isolabili, bensì le costituisce come reti relazionali, come distribuzione di
fattori attivi, come cooperazioni regolate, come progetti di lavoro solo
successivamente rappresentabili in proposizioni, a loro volta leggibili, a
questo livello, come cartografie definite dalle loro funzioni 7. È quanto
con sempre maggiore chiarezza emerge dal passaggio, nel lessico che
Dewey finalmente adotta in Knowing and the Know, dal concetto di
interazione a quello di transazione: «Se l’interazione suppone che l’organismo e gli oggetti del suo ambiente siano presenti come esistenze o
forme di esistenza essenzialmente separate, antecedenti al loro sottoporsi
congiuntamente ad esame, la transazione non ritiene adeguata alcuna
preconoscenza né del solo organismo né del solo ambiente […] ma
esige che essi si accettino prima di tutto in un sistema comune» 8.
Cio, a me pare, è semplicemente esplicativo di quanto già Dewey
scriveva in Esperienza e natura, rammentando i Saggi sull’empirismo
radicale di James: esperienza «è una parola “a due facciate” in quanto
nella sua primaria integrità non riconosce alcuna divisione tra atto e
materiale, soggetto e oggetto, ma li contiene entrambi in una totalità
non analizzata» 9. In altri termini la materia dell’esperienza consiste
in processi di adattamento tra azioni, abiti, funzioni attive tra fare e
subire, cioè materia dell’esperienza non sono innanzi tutto oggetti di
138
cui un soggetto farebbe esperienza: abbiamo cosi immediatamente la
destrutturazione di un rapporto meramente naturalistico tra oggetto
e soggetto, tra interno ed esterno. L’esperienza è piuttosto sintesi di
materia e atto, e tale sintesi è interazione; ma se il termine interazione
implica azione “tra” polarità, si dovrà allora dire che l’esperienza accade nel suo senso perfetto o compiuto quando tali polarità non si relazionano come poli in sé costituiti ma si coordinano in unità di senso,
come avviene appunto esemplarmente nell’esperienza estetico-artistica,
che non è né emotiva, né pratica, né intellettuale, ma realizza in unità
questi fattori: «L’arte rappresenta così l’evento culminante della natura
e nello stesso tempo il grado più elevato di esperienza» 10.
2. Ora si intende procedere allo sfruttamento del risultato di Dewey.
Com’è noto infatti Dewey intende la nozione capitale di esperienza in
genere come «l’interazione tra organismo e ambiente dalla quale risulta
un adattamento che garantisce un utilizzo del secondo» 11. Ma, possiamo domandarci, cosa accade quando l’ambiente non è più soltanto
e forse principalmente quello, ascrivibile a dinamiche biologico-vitali
quali motori originari di rapporti e istituzioni sociali, a cui Dewey poteva riferirsi? La mia risposta, che ora cercherò di giustificare, è che in
tale nuova situazione la relazione arte-esperienza come esemplare del
senso dell’esperienza pensata da Dewey acquista un significato peculiare
e radicale.
Il nostro attuale, comune “ambiente”, in cui costantemente cerchiamo adattamento e riequilibrio, ha oggi i tratti dell’immaginario mediale
e del relativo regime del desiderio proprio dell’epoca del marketing
emozionale; è l’ambiente dell’esteticità diffusa (dalla moda al design,
dalla pubblicità al videoclip, dal packaging alla progettazione ambientale
ecc.) di cui gusti, sentimenti, emozioni e propensioni grazie a complessi
processi di mediazione configurano l’apparente immediatezza. È certamente tanto complesso quanto necessario tener conto di tutto ciò
per riscoprire l’eventuale pregnanza del messaggio di Dewey, ma qui
mi permetto di isolare, per dir così, un aspetto dell’ambiente contemporaneo che mi pare consenta la ripresa e il ripensamento del nostro
modello. Da questa limitata prospettiva ciò che chiamiamo “ambiente”
è l’ambiente in senso lato virtuale, reso possibile da dispositivi tecnologici che interagiscono non sempre ma per lo più con organismi
proteseizzati, organismi non più soltanto biologici ma biotecnologici.
Ci si chiede allora che ne sia, in tali ambienti, dell’esperienza in genere
e dell’esperienza estetico-artistica.
Le nuove tecnologie di natura fondamentalmente numerica consentono un’uscita dal duplice paradigma che ha di fatto orientato le
riflessioni sulla tecnica: la tecnica come strumento di supplenza delle carenze adattive tipicamente umane (tesi classicamente esposta da
Gehlen 12 e da molti altri) oppure la tecnica come protesi “naturale”,
139
cioè originariamente connessa alla “natura umana”, in sé stessa ibridata
con l’artificiale (nota tesi di Leroi-Gourhan 13). Le nuove tecnologie
si collocano oltre l’esperienza adattiva di controllo, riequilibrio ed
espansione, poiché l’esperienza si riconfigura non attraverso di esse
ma sostanzialmente in esse, come intorno a un centro gravitazionale
mutevole e plurale. Radicalizzata secondo l’ormai classica metafora della deterritorializzazione, questa idea si ritrova in Baudrillard: «invece
di gravitare intorno a lui in ordine concentrico, tutte le parti del corpo
dell’uomo, ivi compreso il suo cervello, si sono satellizzate intorno a
lui in ordine eccentrico, si sono messe in orbita per se stesse e, di
colpo, in rapporto a questa estroversione delle sue stesse tecnologie, a
questa moltiplicazione orbitale delle sue funzioni, è l’uomo che diviene
esorbitato, è l’uomo che diviene eccentrico. Rispetto ai satelliti che ha
creato e messo in orbita è l’uomo che oggi, con il suo corpo, il suo
pensiero, il suo territorio, è divenuto esorbitante» 14. Baudrillard elabora al proposito il concetto di “videosfera” come senso complessivo
delle nuove tecnologie digitali, ipermediali e telematiche, un concetto
tutto sommato riduttivo e potenzialmente fuorviante poiché le nuove
tecnologie informatiche non sono soltanto e forse essenzialmente processi di analisi e sintesi dell’apparenza, in qualche modo soltanto televisivi. Ma al di là dei termini il messaggio è chiaro: le nuove tecnologie
più che essere strumenti o esplicazioni della “natura” per dir così,
“umana”, sembrano costituirsi come flussi autonomi, forse espressioni
di un aspetto prima celato della physis, che implicano, cioè strutturano e destrutturato, l’umano (le modalità percettive, le emozioni e
i desideri, gli scambi sociali, in generale il plesso corporeo-mentale)
all’interno dei loro processi, l’autonomia sempre maggiore dei quali
rende l’umano eccentrico rispetto a essi, e quindi non li sottopone più
alla presa della volontà e del progetto, per quanto gettato. Forse ciò
costringe a pensare in modo nuovo la sintesi physis-techne come luogo
proprio dell’ethos, dell’abitare umano, e se fino a ora la polis è stata
l’espressione più articolata di questa sintesi, adesso la dimensione del
politico non appare più sufficiente. Ora per comprendere la relazione
tra arte e nuove tecnologie a mio avviso la prospettiva “telematica”,
intesa come attenzione rivolta alle nuove tecnologie nella loro qualità
nuovi media, non è sufficiente e forse non coglie l’essenziale; è infatti
necessario esaminare i concetti di virtuale e di corpo-ambiente virtuale,
i quali da un lato sono alla base delle nuove tecnologie informatiche e
digitali in senso generale, e d’altro canto sono alla base di produzioni
artistiche non immediatamente mediali o che non hanno una finalità
specificamente comunicativa, se non nel senso che l’aspetto comunicativo può eventualmente competere a qualsiasi produzione artistica 15.
3. Con l’espressione “corpo-ambiente virtuale” possiamo intendere
in primo luogo e in senso ampio un’immagine digitale interattiva, il
140
fenomenizzarsi di un algoritmo in formato binario nell’interazione con
un utente-fruitore. Si tratta di qualcosa di preciso, su cui da anni la
sperimentazione estetica internazionale lavora, vale a dire a tutti quegli oggetti-ambienti informatici con i quali un fruitore può interagire
attraverso le periferiche di un computer, le quali possono assumere la
forma protesi bio-robotiche atte a consentire gradi di immersività molto
elevati. Con tali ambienti informatici, elaborati per lo più non da un
individuale singolo autore-(eventualmente)artista ma da una mente collettiva, talvolta l’utente interagisce attraverso i suoi avatar, gli alter-ego
virtuali che gli appaiono agire all’interno di tali ambienti, producendovi
delle trasformazioni, altre volte la sua funzione spettatoriale coincide
con l’essere attore della situazione. Ora, le trasformazioni o modificazioni “estetiche” prodotte dagli utenti negli ambienti informatici o virtuali
sono possibili in quanto le percezioni sensibili (visive, uditive, tattili ecc.)
che essi percepiscono/producono non sono altro che differenti fenomenizzazioni di una matrice algoritmica, non sono altro che le differenti
possibili attualizzazioni estetiche permesse dal programma. Tuttavia, si
noti, il grado di interattività di tali oggetti informatici muta a seconda
che l’interazione avvenga sulla base di matrici algoritmiche “rigide”
– che preordinano le possibili interazioni – oppure sulla base di matrici
“flessibili” che “apprendono” e si modificano attraverso l’interazione.
Quando l’interazione implica esperienza estetica in senso deweyano,
cioè un perfezionamento dell’esperienza che assume caratteri tipici ai
quali accennerò, ed è tale da costruire il senso dell’oggetto-evento, del
corpo-immagine o ambiente virtuale qualificandolo come opera d’arte,
allora l’interazione è propriamente interattività.
Sarebbe a questo punto necessaria una descrizione del campo, una
fenomenologia dei corpi virtuali che qui interessano la quale li distingua
in base al grado di immersività e di interattività che consentono. Questo
è quanto, certamente, qui non è possibile fare; mi limito al proposito a
notare che attualmente le tecnologie stabiliscono almeno una differenza
di rilievo, tra ambiente “virtuale” nello schermo (schermo informatico,
che non è ovviamente quello televisivo) e quindi anche, ma non necessariamente, nella rete (web) così come può fenomenizzarsi sullo schermo, e quello che chiamerei ambiente virtuale in senso proprio. Si tratta
di una differenza essenziale, che consente la produzione di sperimentazioni artistiche e di poetiche molto, quasi completamente, diverse. Per
quanto concerne l’esperienza mediata dallo schermo troviamo, divisi in
due campi che si intersecano, da un lato gli ipertesti narrativi costruiti
specificamente per la rete, tra i quali assumono ora un rilievo specifico
i blog che sviluppano narrazioni 16, dall’altro la cosiddetta net-art 17 con
altre forme che potranno essere inventate in second life. Questi campi
si distinguono per il prevalere di linguaggio verbale, in genere alfabetico, oppure di immagini e suoni, ma sono entrambi caratterizzati dall’essere sempre apparire di scritture ipertestuali, le quali si fenomenizzano
141
nei limiti delle possibilità intrinseche dello schermo. Ciò implica forme specifiche di programmazione dell’interattività, dove con il termine
interattività si intende «sia l’azione dell’utente che le retroazioni che
comportano queste azioni sull’interfaccia (principalmente automatismi
e azioni di feedback)» 18. Si tratta di operazioni di scrittura informatica
intesa essenzialmente come montaggio di oggetti-scrittura che derivano
da un’idea fondamentale di ipertesto come «documento elettronico che
prevede un accesso interattivo ai suoi contenuti e alle unità discontinue
riunite dal montaggio [in cui] rispetto agli altri documenti elettronici,
l’interattività è strutturata nelle sue componenti» 19, le quali in ultima
analisi sono i punti di intervento o bottoni di collegamento o link, che
consentono forme di interattività differenti e trasformano il fruitore in
fruitore-utente. Perciò 20 la specificità estetica dell’ipertesto, eccedente
rispetto a una qualsiasi forma testuale anche digitale, consiste nella
qualità dei nessi e quindi nell’esperienza interattiva resa possibile dai
collegamenti. Un’estetica della rete, e quindi dell’ipertesto in quanto in
rete, implica probabilmente una revisione della nozione di schema corporeo, della relazione Körper-Leib e del rapporto percezione-immaginazione, cioè di quelle dimensioni strategiche del rapporto uomo-mondo
che abbiamo assorbito, e ormai pensiamo come ovvie, dalla tradizione
fenomenologica: ciò che costituisce una difficoltà quasi insormontabile
per i programmatori, far vivere l’avatar sullo schermo e farlo navigare
nella rete come se avesse un corpo vivo, e quindi in modo da trasmettere in tempo reale all’abitante dell’avatar i processi estetico-noetici di
presenza, costituisce probabilmente una sfida per il pensiero che si vede
costretto a elaborare nuove categorie per render conto della relativa
in-esperibilità della rete 21.
Oltre questo aspetto genericamente ipertestuale della scrittura elettronica esiste com’è noto una linea di ricerca che procede dalle sculture immateriali agli ambienti sensibili con interfacce naturali, ai corpi
proteseizzati in ambienti telematici, fino alle prime sperimentazioni
di ambienti virtuali propriamente detti. E un discorso ancora a parte
meriterebbero le sperimentazioni artistiche nell’ambito della bioestetica
telematica 22 e quelle che tentano una connessione o con-vivenza tra
corpo proteseizzato e reti telematiche 23.
4. Per quanto invece concerne il corpo virtuale in senso proprio,
possiamo intenderlo come ambiente strutturalmente relazionale ed essenzialmente interattivo; ispezioniamo quindi per sommi capi l’ontologia del corpo-ambiente virtuale. Per descriverla in massima sintesi
possiamo enunciarne le caratteristiche essenziali: l’intermediarietà e la
virtualità – caratteristiche tra loro strettamente connesse. I corpi virtuali
sono realtà intermediarie 24 a mio avviso per due ragioni fondamentali:
il corpo ambiente-virtuale in quanto si fenomenizza nell’interattività
sfugge alla dicotomia tra “interno” ed “esterno”: non è né un prodot142
to cognitivo della coscienza, non è immagine della mente – in quanto
l’utente è consapevole di esperire una realtà altra anche nel senso di un
paradossale raddoppiamento sintetico della percezione – né è “esterno”
a essa – in quanto è pur sempre dipendente dall’azione del fruitore.
Il corpo-ambiente virtuale è quindi esterno-interno (di questo, che è
un punto che ritengo essenziale, ovviamente si può discutere. Prego
soltanto di non ritenere che i termini “interno” ed “esterno” siano
presi qui in modo ingenuo o “naturalistico” o che siano privi di “senso
fenomenologico”). Ciò significa che i corpi virtuali non devono essere
propriamente intesi come rapprentazioni della realtà, ma come realtà
costruite in modo essenzialmente differente da quelle costituite dalla
partecipazione circolare del corpo vivo con il mondo, il quale grazie alla
percezione-visione attraversa il corpo e diviene gesto, movimento del
corpo, eventualmente mediato da strumenti di riproduzione analogica,
e quindi immagine. I corpi-ambienti virtuali sono piuttosto “finestre
artificiali che danno accesso a un mondo intermediario” 25 nel quale lo
spazio stesso è il risultato di un’interattività, il mondo non accade al
modo della presa di distanza, bensì del senso-sentimento dell’immersione, e il corpo, in quanto percepito come altro, assume il senso della sua
realtà, della sua effettualità, come incisione patica e immaginaria, come
produzione di emozione e di desiderio, al punto che la sensazione di
realtà trasmessa dall’ambiente virtuale dipende in gran parte dall’efficacia con cui provoca emozioni all’utente 26. Da questo punto di vista
«la realtà virtuale può produrre un’esperienza capace di autenticarsi
da sola» 27, ma appunto in quanto realtà, cioè come alterità rispetto
all’utente, come ambiente nel quale può agire, come corpi che può
manipolare. Dunque il corpo-ambiente virtuale è intermediario non
soltanto come mediazione tra modello informatico e immagine sensibile,
ma primariamente intermediario tra interno e esterno come facce dello
stesso fenomeno, strano luogo in cui il confine diventa territorio. Quindi corpi-ambienti virtuali non sono né semplici immagini, né semplici
corpi, ma corpi-immagini i quali sfuggono alla distinzione ontologica
tra “oggetti” ed “eventi”, perché, così come gli “oggetti”, hanno una
relativa stabilità e permangono nel tempo, ma, così come gli “eventi”,
esistono solo nell’accadere dell’interattività. L’individuo che ne risulta è
sì concreto, in quanto percepibile e soggetto-oggetto di azioni, ma “peculiarmente sottile”, proprio perché è interattivo. Si tratta di un ibrido
dallo statuto ontologico incerto; possiamo anche chiamarlo corpo sottile
di un mondo non continuo, composto di punti-dati che si manifestano
come fluidità e densità e saturano la percezione: un corpo reso leggero
dalla digitalizzazione, che ha l’interattività come condizione di manifestazione. Possono qui tornare alla mente i corpi derivanti da processi
biotecnologici che popolano il mondo creato da William Gibson in
Neuromante e la sua definizione del cyberspazio come “allucinazione
consensuale”: un “ambiente” che per certi aspetti include l’utente stesso
143
nella misura in cui questo si trova trasfigurato nel proprio avatar, e
partecipa all’ambiente virtuale come un “quasi-cyborg”.
5. Ora da un lato le stesse possibilità artistiche dell’opera virtuale
sono (come sempre per l’arte, ma come viene bene in chiaro nelle
esperienze di produzioni tecnologiche in grado operazioni precise di
simulazione) connesse alle operazioni di scarto rispetto alla riproduzione come simulazione di esperienza “reale” o di “realtà”: le operazioni
di simulazione virtuale possono riguardare aspetti ludici e commerciali,
mentre l’operazione artistica implica quelle possibilità di realizzazione
dell’immaginario che è sempre irrealtà e apertura di faglia nell’esistente.
D’altro lato però la questione della riproducibilità dell’opera è connessa
alla relazione tra opera ed esperienza: e qui, come si diceva, siamo di
fronte a una sostanziale novità, in quanto l’opera d’arte virtuale non
è intrinsecamente riproducibile, perché incorpora, in quanto interattiva, in modo inedito l’azione del fruitore. Ciò perché interattività in
questo caso non è propriamente (soltanto) interazione, o azione tra,
ma intervento e modificazione della matrice che permette all’opera
stessa di esistere, oltre che ovviamente incidenza nel divenire esteticonoetico del corpo ibridato tecnologicamente del fruitore 28. Questo
aspetto “fondamentale” dell’interattività introduce sia nell’opera sia
nella fruizione dell’opera (distinguibili solo rationis) un elemento di
imponderabilità tale da far sì che proprio l’essenza digitale, cioè numerica, e quindi “programmatica” dell’opera, introduca una componente di indeterminismo. Credo che questa nozione di interattività sia
rilevante anche per definire le possibilità in senso lato etiche dell’arte
virtuale, ma intanto implica non una sottrazione bensì un’accentuazione
dei caratteri di irripetibilità e unicità dell’opera (non più “oggetto” o
“evento” ma “oggetto-evento”), e rende più complesse la nozioni di
autenticità. Infatti la specifica virtualità del corpo virtuale mette in evidenza il fatto, implicito nella definizione iniziale di corpo virtuale, che
il corpo-immagine digitale interattivo non attualizza mai completamente
la virtualità della sua matrice algoritmica 29. Il virtuale si configura insomma come complesso problematico, nodo di tendenze che si sviluppa
in un imprevedibile processo di attualizzazione formale. Se supponiamo
di considerare a questo livello l’esperienza estetica come relazione con
ciò che un certo sistema di prassi e di valori indica essere opere d’arte,
e quindi all’interno di una variegata ma riconoscibile tradizione, allora dovremmo pensare l’esperienza estetica privandola della distanza,
che è stata condizione di possibilità di una forma rilevante del valore
artistico, e di pensarla piuttosto nella dimensione del risucchio, dell’ingresso da parte del fruitore nel corpo dell’opera e insieme dell’opera
nel proprio corpo, o immaginario. Ciò comporta l’accentuazione della
dimensione patica e panica della relazione: fare corpo con l’opera, la
quale subisce l’effetto della mia presenza, e che attraverso il mutamento
144
prodotto da questo subire, modifica il mio sentire. Da questo punto di
vista l’esperienza estetica è relazione empatica sui generis, in quanto
espone compiutamente l’ambiguità fondamentale tra internamento e
unificazione tipico dell’empatia, poiché il movimento proiettivo che
annulla l’alterità non presuppone semplicemente una dualità polare
che viene superata, ma è esso stesso condizione di possibilità per quel
minimo di polarizzazione che consente la proiezione. Quindi, da questo punto di vista ciò che un tempo avremmo chiamato soggettivo, lo
stesso processo di trasferimento di sé nell’altro è insieme processo di
costituzione dell’altro; d’altro canto però tale processo di costituzione
è consentito dall’essenza virtuale dell’ambiente, ed è limitato dal suo
schematismo nascosto, dalla sua natura informatica e digitale, la quale
può essere processata empaticamente solo al livello del suo fenomenizzarsi. E ciò implica comunque procedure di eterodirezione, strategie
di modellizzazione seppure plastiche e fluide. (Tra parentesi ciò conduce, tra l’altro, a un’esperienza inedita: il corpo-ambiente virtuale
viene per dir così attratto nell’orizzonte della percezione, rendendo
possibile quello che è impossibile in ambiente non virtuale, lo sdoppiamento della percezione in se stessa: almeno tendenzialmente, per
quanto concerne i processi primari sui quali si innestano poi modalità
complesse di azione-fruizione 30, nell’ambiente virtuale ad alto grado
di immersività l’utente “percepisce” di percepire). Tutto ciò costringe
a pensare la struttura del corpo-ambiente virtuale come essenzialmente
relazionale, o come luogo che esiste solo nell’incontro. E ciò implica
che quanto possiamo, vogliamo o intendiamo chiamare opera d’arte
nell’epoca dei dispositivi virtuali sia, per la sua natura interattiva, una
forma irriproducibile di esperienza, o la messa in forma di un’esperienza irriproducibile (così che potremmo tranquillamente intitolare un
saggio su questi temi: L’opera d’arte nell’epoca della sua irriproducibilità
tecnologica). Dunque oggi, come mai prima d’ora, è possibile in senso
stretto dire, in linea di principio, che l’arte sia esperienza.
6. Forse opere d’arte che siano corpi-ambienti virtuali nel senso
sopra descritto non ne sono ancora comparse, se non come progetti e
sperimentazioni. Sono comunque da seguire con interesse quelle ricerche che sfruttano la qualità interattiva della fruizione estetica consentita
dai processi di digitalizzazione. Per esempio rispetto alla sostanza patica
dell’arte interattiva, accentuata dall’uso di interfacce naturali e quindi
dall’assenza di protesi tecnologiche innestate nel corpo del fruitore, e
dalla relativa maggiore immediatezza dell’esperienza, notevoli sono gli
“ambienti sensibili” di Studio Azzurro, a partire da Tavoli (perché queste
mani mi toccano?) del 1995, fino almeno a Le zattere dei sentimenti del
2002. Le zattere dei sentimenti sono poi, come afferma Studio Azzurro 31, un “journey of feelings” nel quale gli spettatori possono, toccando
in diversi modi tavole alle quali naufraghi disperati tentano di aggrap145
parsi, aiutare o ostacolare la salvezza delle immagini interattive. A partire da questi esperimenti Studio Azzurro ha da un lato sviluppato una
riflessione sul senso dell’interattività per l’operazione artistica, dall’altro
recentemente avviato un nuovo spazio di sperimentazione artistica che
mi sembra tra i più promettenti proprio per la sua potenziale rilevanza
etica. Relativamente al primo punto, scrive Paolo Rosa: «per interattività
intendo quella relazione “intercettata” sotto forma di dati informativi,
che la distingue in modo netto dalla semplice definizione di interazione,
in quanto risulta essere una relazione diretta e in qualche modo più
intima. Vale a dire che grazie alle nuove tecnologie si rende possibile
interferire sui processi relazionali, raccogliendo attraverso interfacce i
più svariati dati sensibili, per trasferirli in uno dei tanti database. Se al
posto di utilizzarli, come avviene, per scopi di marketing o di sorveglianza, riuscissimo virtuosamente a renderli tracce vive e partecipative,
avremmo un mezzo straordinario per accrescere il senso di condivisione,
di elaborazione costante, che alla fine sono validi strumenti di costruzione d’identità, di unicità, di appartenenza» 32. Se questa definizione
di interattività ancora non esplica propriamente le potenzialità del senso
tecno-ontologico che sopra ho delineato, certamente si muove nella
direzione, a mio avviso valida e ricca di futuro, di un’estetica delle
relazioni, accentuando l’aspetto collettivo e socializzante di costituzione
dell’opera come costruzione dello spazio pubblico partecipativo. È impegnata in questo senso l’attuale ricerca di Studio Azzurro, per esempio
attraverso la elaborazione di musei tematici del territorio, da intendersi
come spazi interattivi di identità e di memoria: «Non ragioniamo più nel
senso strettamente museale, ma in termini di luoghi di “condensazione”
in cui la memoria del passato si confronta con una partecipazione nel
presente […] Partiamo da elementi caratteristici di tipo storico o produttivo […] Raccogliamo immagini e testimonianze e le immergiamo
nei nostri sistemi interattivi. Così lo scenario — oltre che raccontare di
un passato, di una storia — racconta qualcosa dei linguaggi stessi con
cui è messa in scena» 33. A mio avviso questa tendenza, che si pone non
certo come alternativa a una “etica della forma”, ma come complemento
se si vuole “in minore”, promette qualcosa, quanto più assumerà valore
estetico, nella direzione di quanto, negli stessi anni di Art as experience, Benjamin avrebbe chiamato “politicizzazione dell’estetica” e anche
rispetto al compito che Dewey, noto nemico dei “musei”, ci affidava, il
compito di «ripristinare la continuità tra quelle forme raffinate e intense
d’esperienza che sono le opere d’arte e gli eventi, i fatti e i patimenti
di ogni giorno che, com’è riconosciuto universalmente, costituiscono
l’esperienza» 34. Innestare l’anima dei luoghi, la memoria delle persone e
la cultura che gli spazi abitati esprimono, nelle tecnologie d’avanguardia
in modo da farla parlare “nuovamente”, in modo inedito e produttivo;
unire il ricordo e il racconto della tradizione con forme di interattività
che contaminandoli li rendano fecondi di esperienza: quanto più la
146
sperimentazione artistica saprà interagire con la nuova cultura museale,
capace di pensare l’arte come occasione di esperienza collettiva e partecipativa orientata al futuro, a forme e linguaggi non standardizzati che
invitano al superamento dei cliché percettivi e cognitivi, e soprattutto
quanto più saprà dialogare con quelle tendenze aperte e spregiudicate della progettazione urbanistica e territoriale 35 che oggi tentano di
superare una cultura astratta di “piano regolatore” riconsiderando le
dimensioni della temporalità e dell’invisibile che la logica cartografica
aveva costretto ad abbandonare, tanto più sarà possibile lavorare nella
direzione di un ethos estetico di qualche utilità.
1 “As” significa per me qui “in the same way that”. Penso che questo senso risulti
complessivamente anche dall’introduzione di Giovanni Matteucci alla nuova, ottima
edizione di Art as experience (Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica,
Palermo 2007, pp. 7-26). Si tratta ovviamente di un “modo figurato” dove il termine
“quale” indica “qualità”; cfr. Arte come esperienza, cit., p. 311.
2 Arte come esperienza, cit., p. 70. Nel cap. 12, significativamente intitolato “La sfida
alla filosofia”, Dewey, p. 267, ribadisce: «L’esperienza estetica è esperienza pura. Essa
è infatti esperienza liberata dalle forme che ostacolano e confondono il suo sviluppo in
quanto esperienza [...] È all’esperienza estetica, dunque, che deve rifarsi il filosofo per
comprendere cos’è l’esperienza».
3 Che certamente può essere, ed è stata acutamente criticata. Sull’«indebito enjambement, che opera il Dewey, fra esperienza comune ed esperienza estetico-artistica» si
veda L. Russo, La polemica fra Croce e Dewey e l’arte come esperienza, “Rivista di studi
crociani”, 5, 1968, soprattutto pp. 212-13.
4 Arte come esperienza, cit., p. 70.
5 Logica, teoria dell’indagine, trad. it. A. Visalberghi, Einaudi, Torino 1973, vol. i,
p. 170.
6
Ivi, p. 171.
7
Come aveva ben compreso Enzo Paci, Dewey e l’interrelazione universale, in Tempo e relazione, Taylor, Torino 1954, p. 155: «Il riconoscimento della interdipendenza
e della relazione di tutti gli eventi è una caratteristica fondamentale della filosofia di
Dewey. Tutto è esperienza, tutto ciò che è nell’esperienza è relazione reciproca; l’universo stesso può presentarsi ai nostri occhi come una grande società di fatti ed eventi».
8
J. Dewey - A. F. Bentley, Conoscenza e transazione, trad. it. E. Mistretta, La Nuova
Italia, Firenze 1974, p. 146.
9
Esperienza e natura, a cura di P. Bairati, Mursia, Milano 1973, p. 27.
10
Ivi, p. 18.
11
Rifare la filosofia, trad. it. S. Coyaud, Donzelli, Roma 1998, p. 70.
12
Cfr. A. Gehlen, L’uomo nell’era della tecnica, Sugar Editore, Milano 1967, pp.
10-11. Gehlen cita Sombart, Alsberg e Ortega y Gasset a appoggio di questa tesi.
13
Cfr. A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, Einaudi, Torino 1977, pp. 283-84.
14
J. Baudrillard, Videosfera e soggetto frattale, in L. Anceschi (a cura di), Videoculture di fine secolo, Liguori, Napoli 1989, p. 30. Per uno sviluppo di questo tema
in direzione del virtuale cfr. Baudrillard, Il delitto perfetto, postfazione di G. Piana,
Cortina, Milano, 1996.
15 Per una panoramica generale sull’arte digitale cfr. L. Taiuti Corpi sognanti. L’arte
nell’epoca delle tecnologie digitali, Feltrinelli, Milano, 2001; Ch. Paul, Digital Art, Thames & Hudson, London 2003; F. De Meredieu, Arts et nouvelles technologies. Art vidéo
Art numérique, Larousse/VUEF 2003; sugli aspetti specificamente multimediali cfr. L.
147
Taiuti, Multimedia. L’incrocio dei linguaggi comunicativi, Meltemi, Roma 2005; in particolare sull’arte virtuale cfr. O. Grau, Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge
(Mass.)-London, MIT Press 2003. Per un’analisi accurate delle opere e delle poetiche E.
Couchot- N. Hillaire, L’art numérique, Flammarion, Paris, 2003; A-M Duguet, Déjouer
l’image. Créations électroniques et numériques, Jacqueline Chambon, Nimes, 2002.
16 Cfr. per approfondire questo punto A. Tursi, Estetica dei nuovi media. Forme
espressive e network society, costa & nolan, Genova 2007, pp. 116-36.
17 Per lo studio accurato di un caso ormai storicizzabile cfr. D. Quaranta, NET ART
1994-1998. La vicenda di Äda’web, Vita e Pensiero, Milano 2004.
18 A. Zinna, Le interfacce degli oggetti di scrittura: Teoria del linguaggio e ipertesti,
Meltemi, Roma 2004, p. 219.
19 Ivi, p. 220.
20 Come già sostenevo in questa sede all’epoca del convegno La nuova estetica
italiana.
21 Ha avviato un’interessante riflessione sull’estetica del web Vincenzo Cuomo nel
volume Al di là della casa dell’essere. Una cartografia della vita estetica a venire, Aracne,
Roma, 2007. Concordo con Cuomo quando, p. 76, scrive: «ritengo sia un errore fenomenologico (e ontologico) confondere l’ambiente-corpo digitale con il data-space, con il
flusso tele-presente dei dati (e del software-data) nel web. Lo spazio interattivo del web
non può essere ridotto all’ambiente virtuale, pena la riduzione della sua problematicità»;
e ciò vale anche viceversa: si tratta in effetti di due ambienti strutturalmente differenti.
22 Per esempio le ormai celebri opere di Edoardo Kac; per una riflessione sulla
responsabilità etica della bioarte cfr. la conversazione tra Maurizio Bolognini e Edoardo
Kac in http://www.ekac.org/luxflux2005.html
23 Si pensi al progetto MOVATAR di Stelarc che comprende un esoscheletro in parte
eterodiretto dagli utenti della rete Internet: «Si tratta di un avatar dotato di un’intelligenza artificiale che lo rende in un certo senso autonomo e operativo. Sarà in grado
di essere attivo nel mondo reale collegandosi a un corpo fisico. Quindi se qualcuno
indosserà l’attrezzatura e si connetterà all’avatar, diventerà l’ospite di un’entità virtuale
intelligente — un mezzo attraverso il quale il movimento dell’avatar può attualizzarsi. Un
fantasma che possiede un corpo e agisce nel mondo fisico […] L’esperienza sarebbe allo
stesso tempo quella di un corpo posseduto e di un corpo agente […] La questione non è
tanto chi controlla l’altro, quanto piuttosto l’idea di un sistema di rappresentazione più
complesso, di interazione tra corpi reali e virtuali», cfr. STELARC, L’involontario, l’alieno
e l’automatizzato. Coreografie per corpi, robot e fantasmi, in La scena digitale. Nuovi media
per la danza, a cura di A. Menicacci e E. Quinz, Marsilio, Venezia 2001, pp. 268-69.
24 Cfr. soprattutto Ph. Queau, Metaxu. Théorie de l’art intermédiaire, Seyssel, Champ
Vallon/INA 1989.
25 Ph. Queau, Metaxu, cit., p. 18. Non seguo però la teoria degli enti intermediari
di Queau ed elaboro la questione a modo mio.
26 Si pensi al proposito agli esperimenti di acrofobia virtuale condotti al Georgia Institute of Technology: i malati di acrofobia utenti di questi ambienti virtuali, ambienti che
non sono simulazioni particolarmente persuasive dal punto di vista percettivo, mostrano
gli stessi sintomi che accuserebbero in ambienti “reali”. L’ambiente virtuale consente lai
pazienti di provare e quindi controllare le loro reazioni in assenza di pericolo.
27 J. D. Bolter - R. Grusin, Remediation. Competizione e integrazione tra media vecchi
e nuovi, a cura di A. Marinelli, Guerini e Associati, Milano 2002, p. 195.
28
L’esposizione dei problemi logico-fisici impliciti in questa nozione di interattività
non è qui possibile, ed è un luogo di ricerca interessante e impegnativo.
29
Cfr. P. Levy, Il virtuale, Cortina, Milano, 1997, pp. 130-31; cfr. anche M. Heim,
The Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, New York-Oxford 1993,
p. 132.
30 Per quanto riguarda le modalità dell’esperienza estetica in ambienti virtuali mi
permetto di rinviare al mio Estetica del virtuale, Bruno Mondadori, Milano 2005.
31 Come si legge nel loro sito www.studioazzurro.com
148
32
Oltre i confini delle immagini: l’estetica delle relazioni. Conversazione con Paolo
Rosa a cura di B. Di Martino, in Studio Azzurro, Tracce, sguardi e altri pensieri, a cura
di B. Di Martino, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 49.
33
Ivi, pp. 48-49. Primi esperimenti il museo della Resistenza a Fosdinovo e il museo
della ruota nel biellese, sulla cultura del tessile.
34
Arte come esperienza, cit., p. 31.
35
Nell’ambito disciplinare della Pianificazione territoriale va in questa direzione il
notevole contributo teorico di Lidia Decandia, e in particolare i volumi: Dell’identità.
Saggio sui luoghi. Per una critica della razionalità urbanistica, Rubettino, Soveria Mannelli, 2000, e Anime di luoghi, FrancoAngeli, Milano, 2004.
149
Patologie dell’esperienza estetica contemporanea
di Fabrizio Desideri
Patologia nel suo senso esteso indica normalmente il malfunzionamento di un organismo, una qualche anomalia. In maniera più sbrigativa e più consuetudinaria potremmo anche dire che quando usiamo il
termine “patologia” implichiamo che “qualcosa non va”. Il difficile in
questi casi è dire quando qualche cosa “va” ossia e più precisamente
quando un organismo (non necessariamente biologico, anche sociale
oppure istituzionale) funziona normalmente, non è soggetto ad anomalie. Il normale funzionamento di un organismo o di un sistema, di
cui l’organismo (vivente) costituisce senza dubbio un sottogenere (nel
senso appunto che ogni organismo è un sistema, ma non viceversa), è
più facilmente definibile ex negativo (in opposizione alle sue manifestazioni patologiche) che in via direttamente positiva. Senza con questo
dover affatto concludere in un apofatismo puro semplice. Non sostengo
infatti che il normale funzionamento di un sistema o di un organismo
sia ineffabile: le sue patologie delimitano già in positivo alcuni tratti
significativi della condizione di normalità funzionale. Ovviamente, rispetto all’effettività di sistemi-organismi la norma esprime una sorta di
media ideale che possiamo esprimere nella forma di un modello. Da
una parte, tale modello dipende da una serie di osservazioni empiriche,
tanto più significative quanto più si presentano in forma patologica;
dall’altra, queste osservazioni sono influenzate dal modello e dai criteri
di interrogazione-analisi che fornisce. A questo proposito un modello,
nella fattispecie un modello relativo ad una funzionalità sistemica, sarà
tanto più potente quanto più sarà permeabile a degli aggiustamenti e a
delle correzioni e quindi quanto più sarà flessibile.
Sulla base di questa premessa generale mi propongo di analizzare
il problema delle patologie dell’esperienza estetica contemporanea. Un
aspetto non secondario del mio proponimento, anzi strettamente congiunto con esso, è dato dall’intenzione di contrastare la tesi abbastanza
diffusa circa l’estetizzazione o, come suo rovescio speculare, circa l’anestetizzazione quale chiave interpretativa di certi caratteri salienti della
contemporaneità quanto al problema estetico. Dico subito che a me
questa tesi , nel suo carattere di attribuzione generalizzante, pare inconsistente. Non solo per la sua scarsa efficacia descrittiva, ma anche – e
forse ancor più decisamente – per il modello teoricamente normativo da
151
cui consapevolmente o inconsapevolmente deriva. Riprendendo a questo
proposito una tesi di Jean Marie Schaeffer 1, senza doverla abbracciare
in toto sia nella sua articolazione analitica sia nel suo sviluppo successivo 2, identifico questo modello come direttamente derivante da una
concezione speculativa dell’estetica, dove quest’ultima – abbandonando
progressivamente il terreno aisthetico (e dunque percettivo-sensoriale)
del sentire – si risolve sostanzialmente in una filosofia dell’arte, conferendo a quest’ultima la prerogativa di un accesso privilegiato alla verità.
Con qualche approssimazione si può individuare la genesi di questo
modello speculativo dell’estetica nell’ambito della filosofia romantica e
idealista (segnatamente in Schelling ed Hegel) e vederne lo sviluppo e
la prosecuzione nel corso del Novecento in autori come Heidegger e
Gadamer. La conseguenza più macroscopica di un’identificazione dell’estetica con una filosofia dell’arte (di cui, ad esempio, la risoluzione
gadameriana dell’estetica in ermeneutica è una diretta conseguenza) è
che qualora venga ammessa una qualche specificità e pertinenza della
nozione di esperienza estetica (in Heidegger, ad esempio, essa è esplicitamente esclusa, fino a convertire l’Estetica in una Poietica ossia nel
considerare l’origine dell’arte in una messa in opera della verità), essa
viene comunque assorbita nella sfera dell’artistico. E molto spesso non
nell’artistico in genere, bensì in una sfera dell’arte da scriversi con la
maiuscola. Solo quest’ultima, infatti, in quanto costituita da opere-eventi eccezionali rende possibili esperienze estetiche altrettanto eccezionali.
L’esperienza estetica si fa così sinonimo di esperienza autentica, mentre
è proprio della possibilità di quest’ultima e dell’esperienza in generale
ciò di cui, nella diagnostica oscillatoria di estetizzazione e anestetizzazione, si lamenta la perdita. In questi casi non ci si accorge, però, che
il leit-motiv diagnostico è una conseguenza del modello speculativo soggiacente. Quel modello, di cui appunto estetizzazione e anestetizzazione
rappresentano rispettivamente l’esplosione e l’implosione. Il modello
esplode o implode per un sovraccarico di investimenti teorico-speculativi nei suoi confronti e di conseguenti attese nei confronti della realtà.
Siamo forse di fronte – analogamente a quanto avviene nei mercati
finanziari – all’esplosione o all’implosione di una bolla speculativa alimentata dalla forza d’inerzia delle tradizioni filosofiche e dall’eccesso di
previsioni negative. Un primo passo critico (che non può essere svolto
qui) consisterebbe nel riconoscere la relatività e la problematicità di
questo punto di vista che, a partire da un lettura ipersemplificata della
contemporaneità (ad esempio nella forma di un circolo infernale tra
globalizzazione, accelerazione tecnologica, post-humano e dominio di
un fantomatico pensiero unico) evoca miticamente un senso autentico
dell’identità umana di cui l’esperienza estetica in relazione all’Arte (con
la maiuscola) significherebbe e l’espressione e il compimento. Anche
una versione più moderata di questa lettura mitica della modernità e
della ipermodernità quale quella di Marquard (esplicitamente collegata
152
all’estetica della ricezione jaussiana) ne condivide i difetti di fondo: alla
perdita di esperienza tipica del Moderno (alla sua «trasformazione in
un puro e semplice mondo d’attesa» 3) «il mondo dell’esperienza viene
conservato nella dimensione estetica» a condizione, certo, che l’estetico
sia inteso come «regno poetico-ermeneutico» e che, di conseguenza,
l’esperienza estetica sia identificata come esperienza dell’arte da trasformarsi in «arte dell’esperienza». Non casualmente Marquard, nel
saggio cui ho finora fatto particolare riferimento, attacca in maniera
esplicita le tesi di Dewey contenute in Arte come esperienza: «L’attuale
situazione congiunturale dell’esperienza estetica compensa quindi […]
la crisi dell’esperienza della vita che caratterizza la modernità e il nostro
tempo. […] Infatti, a poco serve scoprire, come Dewey, ciò che vi è di
estetico nell’esperienza della vita quotidiana, se poi si vive in un’epoca
che, all’opposto, deve ancora trarre in salvo l’esperienza della vita quotidiana nella dimensione estetica pur di poterla conservare. Un’operazione che, invece, riesce […] unicamente quando la dimensione estetica
(l’arte e la sua ricezione) vuole e concepisce se stessa, appunto, come
esperienza» 4.
Contrariamente a quanto intende Marquard, a me pare invece che
il metodo scelto da Dewey, ossia quello di spiegare il senso dell’arte
per la vita umana a partire dalla primarietà dell’esperienza come «commercio attivo e vigile con il mondo» 5, sia l’unico corretto e sensato.
Innanzitutto perché muove da una nozione di esperienza come medium implicativo della continua interazione tra la «creatura vivente»
(il sistema-organismo) e le condizioni ambientali, anziché come «remedium contro l’estraneità al mondo» 6. Rispetto al criptognosticismo di
Marquard, che suppone un soggetto già in sé definito in opposizione
all’estraneità mondana, la prospettiva naturalistica, ma non riduzionistica, di Dewey offre la possibilità metodica di intendere l’esperienza
come un continuum geneticamente anteriore al costituirsi di una soggettività autoriflessiva. E ciò permette di disporre, relativamente alla
stessa definizione di “esperienza estetica”, le tre nozioni cardine della
teoria della ricezione jaussiana – poiesis, aisthesis, katharsis – nella loro
giusta sequenza sia dal punto di vista genetico-evolutivo sia da quello
logico-concettuale, mettendo al primo posto l’aisthesis. L’arte nella sua
significatività estetica la si comprende, infatti, a partire dalle dinamiche
percettive che costituiscono ogni esperienza del mondo. Sono queste,
nella loro intrinseca e non aggiuntiva esteticità, a costituire il germe
dell’arte 7 e non solo dell’arte cosiddetta bella, ma di ogni arte, anche
di quella che Dewey chiama «tecnologica» 8. Di conseguenza l’estetico,
in quanto qualità «valutativa, percettiva e fruitiva» dell’esperienza, è
più ampio del fatto artistico, seppur stia con esso in una relazione di
continuità genetica e di discontinuità logica.
Sulla base di questo chiarimento preliminare, relativo all’ampiezza
153
e alla costitutività dell’estetico in opposizione al suo carattere speciale
e compensativo, possiamo anche tentare un’approssimazione analitica
a quelle che ho chiamato patologie dell’esperienza estetica contemporanea. Con tre precisazioni, e conseguenti limitazioni, aggiuntive. La
prima riguarda il vigere di una qualche connessione, stretta o remota
non importa, tra determinate patologie e la tesi dell’estetizzazione/
anestetizzazione. Ciò non fa altro che confermare il fatto che le teorie
estetiche non solo implicano credenze e atteggiamenti nei confronti
del mondo, ma spesso li influenzano, facendo leva su disagi effettivi
e propensioni nei suoi confronti. La seconda precisazione è relativa
all’esclusione dalla mia analisi di patologie per così dire sistemiche,
riguardanti il Sé come sintesi biologico-culturale, limitandomi a quelle
che riguardano l’esercizio di quella che chiamerei meta- funzione estetica. La terza precisazione concerne il metodo di rilevamento: escluderò qualsiasi approccio direttamente fenomenologico, assumendo come
terreno d’analisi atteggiamenti e correlativi contenuti proposizionali
(nel presupposto che quest’ultimi dicono sempre qualcosa circa il paesaggio interno di cui sono espressione). Come si capirà, il mio scopo
non è tanto quello di opporre una versione corretta dell’esperienza
estetica (ciò significherebbe ancora difendere il mito dell’esperienza
estetica come “esperienza autentica”), quanto piuttosto di verificare,
a partire dall’interpretazione di alcuni fenomeni sintomatici (e degli
atteggiamenti che implicano), se, in che misura e a quali condizioni
possiamo delineare un modello antropologicamente costante e quindi
transculturale della (meta)funzione estetica nella costituzione mediale
dell’esperienza (nel suo essere un medium prima ancora che un remedium). Per ragioni di economia mi limiterò a tre fenomeni-credenze
esemplari anche per la loro diffusione: lo psichismo, l’estetismo e l’esotismo. Nella convinzione, a quest’ultimo proposito, che sia giunto il
momento di affrontare il problema estetico non solo a partire da casi
per così dire estremi, che eccedono la media degli atteggiamenti estetici, ma anche da considerazioni circa quel che avviene “innanzitutto
e per lo più”. La prospettiva, insomma, è quella di un’estetica capace
di cogliere la qualità nella quantità (un’estetica quantitativa se volete)
indagando lo stabilizzarsi di preferenze, valutazioni, giudizi e rifiuti
estetici di lungo periodo. Nell’ipotesi che il gusto non possa esser
considerato del tutto e radicalmente artificiale (frutto, cioè, soltanto
di dispositivi culturali e, dunque, privo di una qualche base biologica) e che, comunque, debba esser rivista in senso concettualmente
accorto la linea di confine tra naturale e artificiale. In tale direzione
ritengo necessario ripensare – anche contro quanto da me sostenuto
in precedenza – la definizione kantiana di arte in senso generico come
«produzione mediante libertà» 9. Forse dovremmo sostituire “libertà”
con “intenzionalità” e prepararci a riconoscere che noi umani a questo
riguardo non siamo soli (questo ovviamente non c’entra niente con le
154
fantasie intorno ai primati che fanno simil-Picasso o simil-Pollock: in
merito condivido pienamente quanto sostenuto in maniera esemplare
da Lucia Pizzo Russo 10).
Prima di impegnarmi in una pur breve analisi di psichismo, estetismo e esotismo ho però l’obbligo di esplicitare cosa intenda qui per
“contemporaneità” o almeno quali tratti salienti del presente ritenga
significativi sotto il profilo dell’esperienza estetica. Quanto dirò potrà sembrare ovvio, ma preferisco l’ovvietà all’oscurità. I tratti salienti
sono: (1) il globalismo ovvero l’unificazione sistemica del mondo, (2)
lo sviluppo pervasivo di una infosfera e delle relative interfacce intelligenti di accesso ad essa, (3) la modellizzazione ipertecnologica dell’ambiente e della vita quotidiana, (4) la revisione da parte della ricerca
scientifica di alcuni tradizionali confini tra natura e cultura, (5) l’intreccio pluralistico tra culture e visioni del mondo e il relativismo de
facto che ne consegue 11. Rispetto a questo elenco, aggiungo un’unica
osservazione. Se il globalismo, che corre sul filo immateriale-concreto
del sapere tecnologico-informatico e su quello materiale-astratto dell’economia finanziaria, unifica il mondo e più precisamente i mondi
vitali e di senso, di cui il mondo costituisce l’unità differenziale, tale
unificazione riguarda solo la sfera comunicativa (caratterizzata dalla
velocità e dall’ubiquità dei processi di produzione e di accesso all’informazione), trasformandola in vettore di ogni altro processo e di ogni
altra trasformazione. Ciò significa anche che l’attuale pervasività della
sfera comunicativa non produce identità, ma rivela differenze: differenze di forme di vita, di tradizioni culturali e di modi e tempi nell’adeguarsi e nell’interagire con la facies tecnologica dell’ambiente e con
l’interfaccia di accesso all’infosfera. Non siamo insomma di fronte ad
una omogeneizzazione del paesaggio umano. Semmai di fronte al fatto
che tradizioni culturali e forme di vita remote e distanti si sono fatte
estremamente prossime, in un intreccio da cui non è assente il conflitto
(in tutte le sue versioni). Di qui la questione pratica ed etica, ancor
prima che teorica, del pluralismo e del relativismo in relazione al problema dell’identità umana e delle sfide scientifiche e tecnologiche cui
è esposta. Sotto il profilo dell’esperienza estetica ciò dovrebbe invitare
a relativizzare alcuni assunti generalizzanti e ad abbandonare alcune
chiavi interpretative (ad esempio quelle che identificano la dimensione
estetica dell’esperienza con l’arte, anzi con il mondo dell’arte nel suo
senso istituzionale, e con la fruizione delle opere). Da questo punto di
vista l’esperienza estetica di uno spettacolo nel teatro parrocchiale ha
un grado di significatività pari alla partecipazione alle performances
più trendy. Sono infatti convinto che proprio oggi abbiamo bisogno
di una teoria che miri a spiegare tanto la prima esperienza quanto la
seconda, senza la pretesa di ordinarle in una gerarchia di valore. Quest’ultimo è il compito di una critica e non di un’estetica.
Sulla base di queste precisazioni possiamo ora, pur brevemente,
155
caratterizzare le tre patologie dell’esperienza estetica enumerate innanzi. Per psichismo intendo tutti quegli atteggiamenti estetici che fanno
precipitare la relativa esperienza nell’orbita del vissuto. Di conseguenza
la misura della verità dell’Erfahrung estetica è offerta essenzialmente
dall’Erlebnis. Anzi: l’esperienza estetica non è, alfondo, altro che Erlebnis. E ciò nel presupposto che il senso dell’identità umana sia definibile
in maniera puramente intrapsichica. La manifestazione più evidente
dello psichismo si può così individuare in una difficoltà ad orientarsi
in ambienti poco familiari, non riscaldati dal tepore della consuetudine
e non confortati dai legami della tradizione. Riducendo il simbolico,
di cui l’esperienza estetica è grembo fecondo, a contrassegno e/o congiungimento con l’originario, lo psichismo manifesta un acuto disagio,
fino al disadattamento, nei confronti della modellizzazione tecnologica
dell’ambiente. Psiche diviene l’antitesi di techne: la techne è vista come
un ingombrante complesso protesico che complica inutilmente, quando
addirittura non impedisce, il ritorno in sé. Degradato a mezzo o feticizzato a destino il medium tecnologico si trasforma nell’altro rispetto
all’umano: nell’antitesi della sua dimensione miticamente “naturale” o
“autentica”. Più che svilupparsi come un’effettiva relazione l’esperienza
estetica tende qui a invilupparsi sul confine di una regressione interiore. Lo psichismo conseguente tende perciò a consegnare l’estetico in
quanto vissuto all’ineffabile, il senso al sentimento. Caricando l’atteggiamento nei confronti dell’esterno dell’aspettiva di una rassicurante
conferma rispetto alla dimensione soggettiva del vissuto, lo psichismo
vive sempre negativamente le dinamiche trans-formative dell’esperienza.
Così nei confronti del presente si sente sempre in perdita, investendolo
di un eccesso di negatività e di catastrofismo. E perciò tale ateggiamento genera nevrosi e talvolta depressione, oscillando appunto tra la
«fatica di essere se stessi» 12 e l’impossibilità di un bilancio attivo nel
commercio estetico con l’ambiente. Unica requie, in questa nevrotica
oscillazione, è offerta dalla poesia. Qui l’arte può ancora difendersi,
seppur residualmente, ed offrirsi come un dialogo interpsichico tra io
e tu. Alla barbarie dei linguaggi artistici contemporanei lo psichismo
oppone un senso ‘poetico-sentimentale’ dell’arte e dell’esperienza estetica, dove il conoscere e il sentire stanno in perpetuo disaccordo.
Simmetricamente antitetico allo psichismo è l’esotismo. In questo
caso la dinamica della relazione estetica è tutta consegnata ad un puro
“fuori” 13: a un’esteriorità assoluta. Quanto più l’oggetto è percepito
come astratto dalla “prospettiva del mondo” ed estraneo alla cerchia
delle relazioni e degli abiti che definiscono la mia forma di vita, tanto
più è prediletto esteticamente. Mentre per lo psichismo la misura del
valore estetico è una prossimità dove il familiare scivola insensibilmente
nell’intimo, per l’esotismo il valore è dettato dalla distanza. Perciò l’oggetto estetico è desiderato in quanto “assolutamente” distante e, quindi, sigillato in se stesso. Non importa che la sua distanza sia geografica
156
o culturale, basta che opponga resistenza a rivelare i fili e le relazioni
che lo connettono al mio mondo. Bloccato nella sfera del desiderio, il
senso dell’estetico implica qui la chiusura al cognitivo. Nell’esotismo
si persegue, così, l’utopia di un oggetto “in sé”, perfetto nel suo isolamento e distante perfino dal proprio ambiente da cui emerge, appunto,
come fosse un’isola. In quanto emergenza assoluta l’oggetto esotico è
dunque indifferente al problema del confine tra physis e techne, tra
vita e artificio. Chi insegue l’insula felix dell’oggetto esotico trascura
che, al fondo, ogni isola è tale, ma solo relativamente.
Sempre in balia della pulsione a fare della vita stessa un’opera d’arte l’estetismo 14 tende invece a rimuovere i confini tra esperienza in
generale (quella che con Paolo D’Angelo potremmo anche chiamare
«esperienza quotidiana» 15) ed esperienza estetica. Il motivo sta nel
fatto che surroga la (meta)funzione estetica, e l’esperienza che la pone
in esercizio, nel suo input iniziale: la sensazione. Trascurando la differenza (pur micro-logica e micro-temporale) 16 che intercorre tra la
pluralità tendenzialmente caotica degli input sensoriali e le selezioni
percettive, l’estetismo persegue una rotondità e una definitezza della
sensazione, dove la significatività precipiti ad un grado zero. Ricercando una fantasmatica sensazione pura, l’estetismo riduce la qualità in
gioco nella dinamica percettiva dell’esperienza estetica in una qualità
della sensazione che si traduca in un senso senza significati. Per questo
il modo in cui la sensazione si presenta nell’estetismo si fissa spesso
nella forma dello choc. È un aspetto quest’ultimo ben colto da Dewey
e proprio nel suo carattere patologico:
La connessione tra qualità e oggetti – scrive in Arte come esperienza
– è intrinseca in ogni esperienza dotata di significatività. Se si elimina
questa connessione non rimane che una successione di fremiti transitori
priva di senso e non identificabile. Quando facciamo “pure” esperienze
di sensazioni esse ci capitano attirando d’improvviso e violentemente
l’attenzione; sono shock, e perfino gli shock servono normalmente a suscitare la curiosità di indagare la natura della situazione che ha improvvisamente interrotto la nostra occupazione precedente. Se la condizione
persiste senza cambiamenti e senza che si sappia calare ciò che si sente
in una proprietà dell’oggetto, il risultato è pura esasperazione – una cosa
assolutamente distante dal godimento estetico. E non è promettente fare
della patologia della sensazione la base del godimento estetico 17.
Trasformando e trans-valutando l’esperienza estetica in un ethos
vero e proprio, se non addirittura in un’etica, l’estetismo traduce l’attitudine attenzionale nell’intenzionalità (in senso forte) di un’attesa:
attesa che la sensazione si faccia forma. Ma l’eidos è una promessa
che la pura sensazione non può mai mantenere. Di qui l’esasperata
tensione meta-eidetica dell’estetismo, talvolta nella ricerca dell’informe
fino alla regressione materica. Quando non incontra thanatos come la
157
vera perfezione di eros (il volto in-significante di cui è in cerca) l’estetismo non può far altro che rimettersi ad attendere il prossimo shock,
innalzando progressivamente l’asticella che misura il grado della sua
intensità. E poiché l’asticella che sposta ha il colore grigio dell’abitudine, spesso l’estetismo finisce per consegnarsi alla noia ovvero al suo
nemico mortale.
Rispetto a queste tre patologie dell’esperienza estetica mi guardo
bene dal proporre una qualsiasi versione corretta o “sana” di esperienza estetica, opponendo un dover essere al loro essere. Mi si potrebbe
anche obiettare che l’essere di queste patologie riguarda la possibilità
più che l’effettività. La caratterizzazione di ogni patologia, in forma di
breve schizzo, ha certamente il valore di un modello, con tutte le semplificazioni e le astrazioni che comporta. Tutto sta nel vedere se questo
modello funziona e ci aiuta a capire alcuni aspetti diffusi e salienti
dell’esperienza estetica contemporanea e se, tornando al mio proposito
iniziale, non lasci anche scorgere un modello di esperienza estetica nel
suo funzionamento per così dire “normale”. Laddove normale sta ad
indicare l’approssimazione descrittiva ad una funzione o meta-funzione
che ho definito in termini di costante antropologica transculturale.
Così intesa, la dimensione estetica dell’esperienza perderebbe il suo
carattere speciale e il suo valore puramente regionale nel panorama
delle pratiche umane, per acquisire il senso di un primo orientamento
nei confronti del mondo, di una prima capacità di organizzare sensatamente, nel commercio percettivo, le informazioni dell’ambiente: di
organizzarle in una maniera gratificante (e dunque con un effetto di
rinforzo) per il sistema o l’organismo in gioco. In quella che Schaeffer
chiama «un’attivazione ludica del discernimento cognitivo» 18 e che
Kant definisce nella famosa formula dell’anticipazione della forma di
una conoscenza in generale, il piacere si configura infatti come una
sintesi densa tra l’elemento emotivo e quello cognitivo della percezione. Una sintesi che unifica, nella forza performativa di un giudizio, la
dimensione percettiva, quella valutativa e quella fruitiva 19.
Se poi assumiamo con una valenza dinamica il termine “anticipazione” usato da Kant, e lo assumiamo così proprio in rapporto al carattere rafforzante e gratificante del piacere che lo contraddistingue,
allora “anticipa”, in quanto congiunge il livello temporale con quello
logico, può qui tradursi in: orienta attivamente, costituendo un significativo assaggio di una relazione sensata (densa di senso) con il mondo.
L’assaggio tipico dell’esteticità di ogni comprensione, dove il gusto del
sapere, la sintesi densa di un “sapere come” (di un know how) è sempre in anticipo, precedendo le articolazioni e le categorizzazioni di un
“sapere che”. Una tesi, quest’ultima, forse in sintonia con lo spirito,
se non con tutta la lettera dell’analitica kantiana del bello e condivisa
per altri versi da Stuart Kaufmann nelle sue Esplorazioni evolutive,
laddove sostiene: «I fatti sono enunciati dal sapere che. Ma il sapere
158
come ha preceduto il sapere che. Io – continua Kaufmann -, anche se
pienamente consapevole dell’ingiunzione di Hume [a separare l’è dal
dev’essere] credo che nella prospettiva dell’agente autonomo la dicotomia disgustoso-delizioso sia primaria, inevitabile e, per quell’agente,
della massima importanza» 20.
In questo passo Kaufmann non intende però riferirsi all’estetico
come anticipazione del cognitivo. La precedenza dell’estetico, comunque prefigurata nella coppia oppositiva disgustoso-delizioso e caratterizzata nel senso di un “sapere come”, riguarda piuttosto la base biologica dell’atteggiamento etico. Convinzione di Kaufmann è, infatti, che
“rudimenti di semantica, di intenzionalità, di valore e di etica nascano
con gli agenti autonomi”, ossia con tutti i sistemi viventi capaci di autorganizzazione. Senza dover condividere del tutto la tesi di Kaufmann,
si tratta ora di capire se anche, e in che misura, alcuni “rudimenti”
di estetica siano ravvisabili prima dell’emergenza dell’umano. Possiamo, in altri termini, parlare di presupposti naturali e quindi evolutivi
dell’emergenza dell’estetico nella trasmissione linguistico-culturale che
contraddistingue, differenzialmente, l’uomo in quanto specie? Per tentare una risposta positiva possiamo prendere in seria considerazione
le osservazioni che Darwin dedica al problema estetico in una chiave
evolutiva nella sua seconda grande opera: The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Queste osservazioni sono state recentemente
discusse e analizzate non solo da un punto di vista psico e sociobiologico 21, ma anche da un punto di vista filosofico e segnatamente estetico,
in particolare da Winfried Menninghaus nel libro Das Versprechen der
Schönheit 22 e da Wolfgang Welsch nel saggio Animal Aesthetics 23. Di
particolare interesse per il nostro discorso mi sembrano le tesi avanzate
da quest’ultimo.
Riprendendo alcune osservazioni autocritiche dello stesso Darwin,
relative appunto all’aver attribuito troppa importanza «all’azione della
selezione naturale o alla sopravvivenza del più adatto», Welsch mira
infatti a contestare una posizione abbastanza diffusa in ambito sociobiologico, ossia che i criteri estetici della scelta del compagno per la
riproduzione siano definibili in termini di semplici indicatori di fitness. Contro questa posizione parlano alcune osservazioni dello stesso
Darwin. Lo sviluppo di alcune parti del corpo (quali la coda nei pavoni
o le corna dei cervi) come attrattiva estetica per la scelta del partner
sessuale da parte della femmina ha un costo troppo elevato dal punto
di vista della sopravvivenza del più adatto. D’altra parte un analogo dispendio energetico riguarda lo sviluppo coevolutivo di un senso capace
di distinzione estetica implicato nella selezione sessuale. Tra selezione
naturale e selezione sessuale si apre così una forbice (gli ornamenti
maschili designati al successo nella lotta sessuale sono spesso controproducenti nella lotta per la vita); una forbice, ai cui estremi stanno
159
la competizione estetica (tra maschi della stessa specie) e l’apertura di
un ventaglio di possibilità nella scelta estetica del partner. La conseguenza che da ciò ne trae Welsch, coerentemente con le osservazioni
di Darwin, è che qui assistiamo alla prima emergenza di una funzione
estetica nell’ambito della vita animale. Una funzione di cui certo non si
può misconoscere la piega utilitaria e cioè il suo emergere in rapporto
al problema della selezione sessuale. Questo però non impedisce di
cogliere come la funzionalità emergente, proprio per i suoi costi elevati
e per il dispendio energetico che implica, sia più ampia del contesto
di utilità in cui sorge. Un’ampiezza che potremmo anche interpretare come tendenzialmente meta-funzionale e quindi come nucleo di
un’auto-elevazione semantica all’interno di una funzione naturale. Si
potrebbe anche ipotizzare, a questo proposito, che la funzione estetica
specificamente umana non stia in un rapporto di assoluta discontinuità
con quella animale: in qualche modo (tutto da pensare e da verificare)
emerge da essa. Il punto critico dell’emergenza, oltre che ovviamente
nello sviluppo su basi biologiche di un’intelligenza plastica, potrebbe
essere colto – come sembra suggerire lo stesso Welsch – in uno svincolarsi del desiderio dal suo originario legame con l’impulso sessuale
e in una correlativa indeterminazione dell’ambiente in cui esercitare la
preferenza estetica. In questa inedita connessione, rispetto a cui la tesi
freudiana della sublimazione appare riduttiva, una funzione di vettore
potrebbe essere rappresentato proprio dall’emergere nella specie umana
di un’attitudine estetica nei confronti del mondo. Accettare questa ipotesi ci induce a correggere il modello kantiano di esperienza estetica,
quale è delineato nella Terza critica, in un punto significativo, quello
relativo al primo momento del giudizio di gusto e cioè al disinteresse
che ne definisce la qualità 24. Se verso la forma dell’oggetto il disinteresse del giudizio di gusto, in quanto “contemplativo”, è indifferente
alla sua esistenza e, quindi, nel caso della differenziazione tra piacevole
e buono, al suo stesso concetto, dal lato del soggetto esso implica la
libertà dal desiderio e dalla sfera degli impulsi da cui muove. E questa
è la condizione perché l’esperienza estetica implicata nel giudizio abbia
un carattere di autofinalità, secondo quanto Kant sostiene nel terzo
momento, quello relativo alla relazione, dove si parla appunto di una
finalità senza scopo. Anche qui, come nel caso della dimensione quasi
cognitiva del giudizio di gusto, vale la categoria del “come se”: come
se, appunto, la forma dell’oggetto venisse incontro all’esigenza di un
buon accordo tra le facoltà cognitive, configurando, perciò, nel giudizio
estetico la possibilità di un’anticipazione ludica (il libero gioco delle
facoltà!) di una conoscenza in generale. Il problema, a questo punto,
è se la modalità del “come se” possa estendersi anche all’esigenza di
accordo tra le facoltà cognitive (immaginazione e intelletto) o se, piuttosto, proprio questa estensione sia improponibile e non si debba ammettere che laddove vi è un’esigenza, e dunque, una mancanza, là vi è
160
un qualche tipo di desiderio, non necessariamente determinato quanto
all’oggetto della sua soddisfazione. Si tratta perciò di “salvare” o forse
di “trasformare” la staticità della nozione kantiana di “disinteresse”
nella dinamica del formarsi di esigenze ed aspettative nei confronti del
mondo alimentate da una progressiva indeterminazione del desiderio e
quindi di una corrispettiva estensione dell’ambito di esercizio di preferenze estetiche. Una dinamica in cui il piacere (la possibilità fruitiva)
avrebbe il ruolo di confermare e rafforzare le capacità valutative e selettive dell’esperienza percettiva. Si tratta, in ultima analisi, di ascoltare
bene il dialogo tra Socrate e Diotima nel Simposio platonico e, quindi,
di includere nel libero gioco kantiano delle facoltà anche quella di desiderare. Così, la virtù anticipante dell’estetico non apparirà più limitata
alla sfera cognitiva, ma includerà anche quella etica. Abbandonando
il mito di un “giudizio estetico puro”, potremmo finalmente pensare
il vincolo estetico 25 come uno nodo che stringe insieme l’anticipazione della conoscenza e la promessa di una vita buona (quella che noi
moderni chiamiamo felicità). Senza, naturalmente, essere né ciò che
anticipa né ciò che promette. E a questo punto avremo capito in che
senso la funzione estetica può dirsi una meta-funzione.
1 Si veda per questo. J.-M. Schaeffer, Les célibataires de l’art, Gallimard, Paris 1996
e Id., Adieu à l’esthétique [tr. it., Addio all’estetica, Sellerio, Plaermo 2002], PUF, Paris
2000.
2 Il cui frutto più recente è il volume La fin de l’exception humaine, Gallimard,
Paris 2007.
3
O. Marquard, Crisi dell’attesa – Ora dell’esperienza. Sulla compensazione estetica
della perdita moderna dell’esperienza, in Id., Compensazioni: antropologia ed estetica, a
cura di T. Griffero, Armando, Roma 2007 (il saggio cui ci riferiamo è del 1981).
4
Ivi, p. 127.
5
J. Dewey, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Aesthetica, Palermo 2007,
p. 45.
6
O. Marquard, Crisi dell’attesa, cit., p. 123.
7
«In quanto soddisfazione di un organismo nelle sue lotte e nei suoi successi in
un mondo di cose – scrive Dewey in conclusione al primo capitolo di Arte come esperienza -, l’esperienza è arte in germe. Anche nelle sue forme rudimentali essa contiene
la premessa di quella percezione piacevole che è l’esperienza estetica» (J. Dewey, Arte
come esperienza, cit., p. 45).
8
Ivi, p. 71.
9
È quanto appunto Kant sostiene nel § 43 della Critica della facoltà di giudizio.
A tale proposito rimando ai miei seguenti lavori: Il passaggio estetico. Saggi kantiani, il
Melangolo, Genova 2003, pp. 129-68, e Forme dell’estetica. Dall’esperienza del bello al
problema dell’arte, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 83-90.
10 Si veda in proposito Lucia Pizzo Russo, Al di qua dell’immagine, in “Fieri”, 4,
dicembre 2006, pp. 311-36.
11 A questo proposito rimando al saggio Uno sguardo sul presente. Pluralismo, relativismo e identità umana, di prossima pubblicazione su “Atque” e disponibile in forma
di pre-print sul sito <www.seminariodestetica.it>.
161
12
Cfr. in proposito Alain Ehrenberg, La fatica di essere se stessi. Depressione e
società, Einaudi, Torino 1999.
13
A questo proposito il rimando d’obbligo è a Victor Segalen, Saggio sull’esotismo.
Un’estetica del diverso, a cura di V. Petrucci, ESI, Napoli 2001. Ma ho tratto liberamente spunto anche da quanto osserva Emmanuel Lévinas in Dall’esistenza all’esistente,
a cura di P. A. Rovatti, Marietti, Casale Monferrato 1986, p. 45 ss. Sulla nozione di
“esotismo” in Lévinas si veda il saggio di F. Armengaud, Etica ed estetica nel pensiero di
Lévinas: a proposito delle Obliterazioni di Sacha Sosno, in “Studi di estetica”, 22/2000,
a. xxviii, fasc. ii.
14 Per l’estetismo il rimando d’obbligo è al libro di Paolo D’Angelo, Estetismo, il
Mulino, Bologna 2003.
15 Ivi, p. 33.
16 Tale differenza riguarda anche il ritardo temporale della consapevolezza. Si veda
al riguardo B. Libet, Mind Time. Il fattore temporale nella coscienza, a cura di E. Boncinelli, Cortina, Milano 2007.
17 J. Dewey, Arte come esperienza, cit., pp. 137-38.
18 J.-M. Schaeffer, Addio all’estetica, cit., p. 34
19 Come unità di esperienza «valutativa, percettiva e fruitiva» Dewey definisce appunto l’estetico; cfr. per questo J. Dewey, Arte come esperienza, cit., p. 71.
20 S. Kaufmann, Esplorazioni evolutive, a cura di T. Pievani, Einaudi, Torino 2005,
pp. 153-54.
21 Penso qui ad esempio al volume di Ellen Dissanayake, Homo Aestheticus: Where
art comes from and why, The Free Press, New York 1992, e al saggio di Geoffrey F.
Miller, Aesthetic fitness: How sexual selection shaped artistic vituosity as a fitness indicator and aesthetic preference as mate choice criteria, in “Bulletin of Psychology and the
Arts”, 2(1), 2001, pp. 20-25.
22 W. Menninghaus, Das Versprechen der Schönheit, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
2003.
23 W. Welsch, Animal Aesthetics, in “Contemporary Aesthetics”, vol. 2 (2004):
<www.contempaesthetics.org/newvolume/pages/journal.php?volume=2>.
24 A tale proposito le obiezioni mosse da Dewey a Kant proprio in relazione al nesso
tra disinteresse, contemplazione e lontananza dal desiderio del giudizio estetico sono
meno ingenue di quanto può sembrare a prima vita (cfr. in merito J. Dewey, Arte come
esperienza, cit., pp. 249 e 284, dove la critica è estesa a Schopenhauer). Nella sua critica
a Kant Dewey mostra di aver ben presente quella mossagli da Schiller (cfr. ivi, p. 342,
nota 219). La proposta di Dewey è appunto quella di non scindere il senso del disinteresse e della distanza dalla sfera del desiderio e degli impulsi da cui muovono e questa
sarebbe appunto la condizione per considerare la distinzione tra “qualità sensoriale” e
“significato” come secondaria e metodica rispetto alla loro effettiva unità nell’esperienza
estetica (cfr. ivi, pp. 254-55).
25 Sul tema del vincolo estetico rimando al saggio Il nodo percettivo e la meta-funzionalità dell’estetico, in F. Desideri e G. Matteucci (a cura di), Estetiche della percezione,
Firenze University Press, Firenze 2007, pp. 13-23.
162
Esperienza estetica e anestesie dell’esperienza
di Pietro Montani
1. Tra le grandi estetiche filosofiche della modernità, quella di John
Dewey si caratterizza per un’opzione teorica di fondo che, insieme ad
alcune implicazioni che ne derivano, la rende particolarmente idonea,
almeno dal punto di vista che adotterò in questo contributo, a fungere da termine di confronto per alcuni rilevanti eventi estetici del
nostro tempo. Preciso subito che questi eventi non riguardano tanto
la prassi artistica contemporanea – la cui sostanziale irriducibilità al
quadro categoriale deweyano è sotto gli occhi di chiunque – quanto le
trasformazioni che sono intervenute nella nostra comprensione comune
di che cosa significhi fare e condividere esperienze e il processo, forse
ancor più significativo, per cui l’esperienza è diventata per certi aspetti
una merce che si può acquistare.
Ho usato l’espressione “opzione teorica” a ragion veduta. Il pragmatismo di Dewey è infatti una filosofia militante, che non si sottrae
alla responsabilità di definire ciò che appare più meritevole di essere
elevato a dignità di oggetto di riflessione. Ciò vale innanzitutto per
il suo concetto di “esperienza”, che riposa su un’assiologia, del tutto
esplicita, relativa alle specifiche condizioni di sussistenza e di autocomprensione della vita biologica dell’uomo, a cominciare dalle modalità,
non generalizzabili, del suo adattamento tipicamente contrassegnato
da espansione e trasformazione. È sotto questo profilo per così dire
“darwiniano”, del resto, che Dewey può arrivare a determinare i connotati di un’esperienza genuina, contrapponendoli a quelli di un esperire inautentico.
Bisognerà dunque convenire sul fatto che quella di Dewey è innanzitutto un’estetica fisiologica che pone al centro della riflessione il rapporto determinante tra organismo e ambiente. Per essere più precisi: si
tratta di un’estetica che prende le mosse dall’interazione tra la peculiare
sensibilità del corpo umano – pulsionalità, percezione, immaginazione, emozioni, senso del possibile, bisogno di condivisione – e ciò che
questa sensibilità riceve, elabora e trasforma. Il carattere interattivo in
senso pieno di questa relazione richiede di essere accuratamente sottolineato, e ci tornerò più volte: ciò che la sensibilità umana riconosce
nell’ambiente non è tanto una semplice materia da mettere in forma
(cognitivamente e operativamente) o un territorio neutrale in cui espan163
dersi; è, piuttosto, una indeterminata e ricca molteplicità di stimoli da
cui estrapolare di volta in volta alcuni “tratti capitali” (avrebbe detto
Nietzsche): le “affordancies” o proprietà sopravvenienti – diremmo forse oggi – che fanno dell’ambiente reale un’ambiente che appare “disponibile” proprio in quanto non è immediatamente sotto-mano ma
oppone resistenza, che coopera con le esigenze della vita solo in forza
di continue riorganizzazioni del rapporto interattivo. Ma che preserva,
e questo punto come si vedrà più avanti è decisivo, ampie zone di irriducibilità all’azione organizzante dell’uomo. Se così non fossse, del
resto, l’esperienza perderebbe ogni autentica creatività.
Ho descritto l’opzione teorica di fondo dell’estetica di Dewey ricorrendo a una terminologia e, più in generale, a una Stimmung filosofica
che rinvia intenzionalmente a Nietzsche, cioè a un autore che in Arte
come esperienza (d’ora in avanti AE) non viene mai preso in considerazione. Ma l’attinenza, che non è diretta, si potrebbe facilmente
dimostrare lavorando sul testo. Come, per altri versi, sarebbe facile
emendare la singolare incomprensione che Dewey dimostra per Kant,
la cui estetica filosofica presenta invece larghissime e decisive convergenze con l’oggetto essenziale del suo pensiero. Che è, ad evidenza,
l’idea di una condizione (in senso rigoroso) estetica dell’esperienza in
genere.
Anche l’estetica di Kant, come quella di Dewey, è una «filosofia non
speciale» – per usare la felice formulazione di Emilio Garroni ridiscussa, in questo libro, da Leonardo Amoroso – solo che, a differenza di
quella di Dewey (e di Nietzsche), non è riferita a un orizzonte assiologico. E, soprattutto, non è interessata alla questione della vita nel senso
sopra indicato. Ciò conforta l’osservazione da cui ho preso le mosse
e mi consente di enunciare una prima precisazione. Quando ho detto
che l’apertura filosofica dell’estetica di Dewey è particolarmente idonea
a fungere da termine di confronto rispetto ad alcuni eventi estetici che
caratterizzano il nostro tempo, pensavo innanzitutto al suo interesse per
la «creatura vivente» (che dà il titolo al primo capitolo del libro), e a
come quest’ultima sia diventata, da qualche decennio in qua, oggetto
di profonde trasformazioni che hanno comportato il profilarsi di nuovi
paradigmi concettuali e disciplinari (dalla bioetica alla biopolitica, per
fare solo due esempi). Ora, il punto per me decisivo è il seguente: sebbene in modo largamente inavvertito, è accaduto che nell’epoca della
bioetica e della biopolitica anche la sensibilità della creatura vivente si
sia modificata, in modo tanto rilevante quanto irriducibile ai modelli
teorici con cui in genere abbiamo fin qui registrato e interpretato queste
modificazioni. È in atto, in altri termini, una trasformazione nel “sentire” del vivente che aspetta ancora di essere adeguatamente esplorata.
Ci tornerò, naturalmente. Non prima, però, di aver brevemente
discusso due conseguenze dell’opzione deweyana per l’interazione tra
organismo e ambiente che mi sembrano interessanti per misurare la
164
portata delle trasformazioni intervenute nell’esperienza estetica – e dunque nell’esperienza in genere – nel nostro tempo.
La prima conseguenza riguarda la questione della tecnica. È del tutto significativo, mi pare, che nelle battute iniziali del suo libro Dewey
dichiari che «per comprendere l’estetico nelle sue forme fondamentali
e riconosciute, si deve cominciare dal considerarlo allo stato grezzo»
(AE, 32). E che esemplifichi questa presenza diffusa dell’estetico nella
vita quotidiana con una serie di immagini che sottolineano il rapporto
dell’uomo con la tecnica: «l’auto dei pompieri che passa; le macchine
che scavano enormi buchi nel terreno; l’uomo mosca che si arrampica
sul fianco del campanile; le persone appollaiate su alte travi sospese
mentre lanciano e afferrano bulloni incandescenti» (ibid). Ciò che ci
attrae e ci procura piacere in questi spettacoli non è solo il naturale
prolungamento della vita dell’uomo in artefatti tecnici – ciò, dopotutto,
caratterizza l’uomo fin dalla sua comparsa – ma anche e soprattutto
il fatto che in questo genere di prolungamenti il «senso della vita immediata» risulti intensificato (AE, 34).
L’estetico allo stato grezzo, dunque, è una qualità che traspare dall’operare tecnico dell’uomo e dai suoi artefatti quando questi si mostrino dotati della capacità di far sentire l’espansione della vita in forme di
organizzazione dotate di coerenza e di unità. Una capacità che, secondo
la tesi centrale e caratterizzante del libro di Dewey, si manifesta nelle
opere d’arte in modo sviluppato, accentuato (AE, 38) e fine a se stesso,
cioè provvisto di una tale congruenza da portare in sé il proprio significato. Da questo punto di vista, l’arte è, eminentemente, una modalità
di esperienza “ben formata” che si mostra, senza altri scopi, nel suo
organico procedere verso una «consummation», una sanzione di compimento che non coincide con la conclusione del processo esperienziale perché, piuttosto, è incorporata nell’opera stessa, è l’opera stessa in
quanto modello di un “buon” esperire. Ma non bisogna dimenticare
– anche se Dewey è spesso incline a farlo – che un “buon” esperire è,
innazitutto, un modo di accertare che l’espansione della vita umana si
avvale “naturalmente” di artefatti tecnici.
Questo punto fa problema nell’estetica di Dewey e nella sua stessa
concezione dell’esperienza. Da un lato, infatti, egli sembra pensare la
tecnica come un elemento costitutivo della vita umana. L’interazione
dell’organismo umano con l’ambiente, in altri termini, gli appare indissociabile da mediazioni di carattere tecnico. Di più: è proprio in virtù
della tecnica che l’adattamento specifico dell’uomo assume la forma
caratteristica dell’espansione creativa. Dall’altro lato, tuttavia, e proprio
quando il suo discorso transita dall’estetico allo stato grezzo all’estetico
raffinato in arte, la sua concezione della tecnica sembra attestarsi sul
piano, assai più convenzionale, di un’interpretazione puramente strumentale. Come se l’estetico tendesse a ritirarsi dall’operare tecnico per
concentrarsi esclusivamente in quello artistico. Ciò rende conto tra l’al165
tro – ma non intendo soffermarmi su questo aspetto – della confusione
tra esteticità e artisticità che spesso danneggia il testo deweyano, e
della discutibilissima intercambiabilità tra i due termini che altrettanto
spesso ne oscura le formulazioni. Dewey non potrebbe mai scrivere,
per fare un solo esempio, che «L’arte è una qualità che permea l’esperienza» (AE, 311), se questa oscillazione non restasse sostanzialmente
irrisolta. Ciò che permea l’esperienza, infatti – ed è proprio Dewey
ad avercelo fatto vedere – non è l’arte ma la qualità estetica. Tornerò
anche su questo punto. Per ora mi limito a sottolineare che l’estetica
di Dewey è intimamente, anche se problematicamente, connessa con
la questione del rapporto tra vita e tecnica.
Ciò mi consente di passare alla seconda conseguenza dell’opzione teorica di fondo dell’estetica filosofia deweyana. La presenterò in
questo modo. Il fatto che l’adattamento della creatura vivente umana
sia caratterizzato da espansione e trasformazione non garantisce che
la sensibilità dell’uomo sia sempre all’altezza della prestazione creativa
che è connaturata al suo esperire. È vero, piuttosto, che può capitare
all’uomo di volersi sottrarre alla ricchezza e alla complessità della stimolazione sensibile cui è aperto e che il suo modo di interagire con
l’ambiente si indebolisca, si contragga e si irrigidisca in schemi ripetitivi, cioè perda, in ultima analisi, proprio il suo carattere interattivo.
È anche questo, ad evidenza, un tema che ricorda Nietzsche e che
Dewey esprime, per esempio, in questa notevole riflessione: «L’esperienza è il risultato, il segno e la ricompensa di quella interazione tra
organismo e ambiente che, quando raggiunge la pienezza, si trasforma
in partecipazione e comunicazione. Poiché gli organi sensoriali, con il
relativo apparato motorio che vi è connesso, sono i mezzi di questa
partecipazione, ogni e qualsiasi loro indebolimento, sia pratico che teorico, è al tempo stesso effetto e causa di un’esperienza di vita ridotta e
offuscata. Le opposizioni tra mente e corpo, anima e materia, spirito e
carne hanno tutte origine fondamentalmente nella paura di ciò che la
vita può produrre. Sono segni di contrazione e di arretramento» (AE,
49, corsivo mio).
Altrove (AE, 65) Dewey parla, a questo proposito, di «esperienze
anestetiche», e le caratterizza da un lato come esperienze frammentate e inconcludenti, incapaci di legarsi organicamente in un tutto,
dall’altro come esperienze congelate e irrigidite, incapaci di rompere
il sicuro protocollo di una connessione puramente meccanica. Bisogna
qui aggiungere una considerazione, che non è tematica nel testo deweyano (mentre lo è, per esempio, in Nietzsche). Il punto è che senza
una qualche parziale anestetizzazione l’esperienza dell’uomo, proprio
in forza del suo peculiare radicamento in una sensibilità “aperta”, risulterebbe, per così dire, sovraesposta, frastornata e disorientata dalla
molteplicità delle stimolazioni ricevute. Cosicché una delle funzioni
dell’arte potrebbe essere proprio quella di costituirsi come una zona
166
franca in cui a questa pluralità si potesse dare libero corso, con l’obiettivo di esibire il lavoro – certo particolarmente complesso – con cui
essa riesce comunque ad accedere alla sanzione di una forma compiente. O addirittura (ma qui siamo già oltre Dewey: ci tornerò nelle
battute conclusive) a mancarla, mostrandone tuttavia – cioè mettendole
in forma – le motivazioni.
Vorrei trarre almeno una conclusione da questa rapida ricognizione
dell’estetica fisiologica di Dewey, di cui ho posto in evidenza la centralità
della questione della vita biologica e del corpo senziente, il rapporto
necessario, anche se assai problematico, con i prolungamenti tecnici di
questo corpo (con le sue protesi sensibili, si potrebbe dire) e infine il
risvolto regressivo e, alla lettera, “an-estetico” che affligge, altrettanto
necessariamente, l’esperienza umana nella forma di una singolare paura
per le sue stesse potenzialità creative e di un potente desiderio di assicurazione e di stabilità. La conclusione è che la riflessione di Dewey sulla
condizione estetica dell’esperienza in genere e sull’arte come modello
di un’esperienza autentica deve indurci a porre sotto osservazione il
dosaggio tra quanto di estetico e quanto di anestetico è necessario che
intervenga nella relazione tra organismo e ambiente affinché questa salvaguardi il suo genuino carattere interattivo e a domandarci se nella determinazione di questo dosaggio i dipositivi tecnici a cui la creatura vivente
umana delega parti crescenti della sua sensibilità non rivestano un ruolo
particolarmente incisivo. Ci si può chiedere, in altri termini – ed è ciò
che farò nella seconda parte del mio contributo – se un eccesso di delega
nei confronti dei dispositivi tecnici nei quali si prolunga la sensibilità
umana non comporti anche un’interruzione del carattere genuinamente
interattivo della nostra relazione con l’ambiente trasformandola in una
relazione tendenzialmente autoreferenziale, nella quale ciò che definiamo
“ambiente” avrebbe perduto precisamente il tratto dell’imprevedibilità
e della contingenza e dunque non presenterebbe più, tendenzialmente,
alcuna affordancy. Perché, se così fosse, esso avrebbe perduto proprio
quella capacità di opporre resistenza nella quale risiede la motivazione
principale dei processi di elaborazione e riorganizzazione creativa nei
quali Dewey vede, a buon diritto, le premesse necessarie di un esperire
autentico in quanto adattamento per espansione.
2. Bisogna dunque porre sotto osservazione i processi di tecnicizzazione della vita che, da sempre attivi, hanno assunto nel nostro tempo
connotati particolarmente vistosi, anche se ancora inadeguatamente
chiarificati. Mi riferisco in particolare ai processi di progettazione tecnica della sensibilità, che oggi si servono di protesi mediali sempre più
pervasive, performative ed economicamente accessibili.
Non c’è dubbio che questi dispositivi protesici si costituiscano come
i veicoli di una peculiare esperienza estetica; ma si tratta di capire se, e
a che condizioni, quest’ultima risponda ai requisiti interattivi di esten167
sione e riorganizzazione indicati da Dewey. E che genere di “consummation” esperienziale vi sia connessa.
Ebbene, è difficile sottrarsi alla conclusione che l’orientamento complessivo della progettazione tecnica della sensibilità vada oggi esattamente nella direzione opposta al concetto deweyano di esperienza estetica, e cioè lavori a un livellamento, a una contrazione e a una potente
canalizzazione del sentire.
Dewey, come molti prima e dopo di lui, aveva ben chiari i rischi di
una trasformazione antropologica connessa con l’età della razionalità
tecnica. Ma oggi dobbiamo fare i conti con un elemento nuovo, e ancora non sufficienemente chiarito, su cui vorrei richiamare l’attenzione:
mi riferisco al fatto che la progettazione tecnica della sensibilità ha un
rapporto tanto significativo quanto profondo con la forma biopolitica del potere, di cui costituisce anzi una decisiva infrastruttura, una
sorta di “bioestetica” come mi è capitato di chiamarla. Ora, il punto
che mi sembra davvero importante è che la giuntura delle due linee
– quella biopolitica e quella “bioestetica” – si verifica precisamente
sotto il segno di quell’istanza assicurativa nella quale Dewey vedeva il
contrassegno certo di un’anestetizzazione dell’esperienza.
Assicurare la vita materiale è il progetto razionale, semplice e onnipervasivo, del biopotere. Ma è anche il progetto essenziale della razionalità tecnica, intesa nel senso ampio con cui un pensatore come
Heidegger ci ha insegnato a interpretarla. Ora, uno dei tratti distintivi
di questa convergenza consiste precisamente in un innesto diretto della
razionalità tecnica su un corpo pulsionale sempre più vistosamente
delegato a protesi tecniche. Ciò significa che una bioestetica tende a
costituire le sue forme di vita a monte di ogni elaborazione del sentire. Che essa è, tendenzialmente, un’estetica della sensazione e non
ancora un’estetica del senso. Che la sua direzione non è amancipativa
ma regressiva. Insomma, più che un’estetica è, si potrebbe dire, una
modalità an-estetica del governo della vita: l’esercizio di una ricettività tecnicizzata, contratta e inelaborata, cui corrisponde un’esperienza
sempre più incapace di autoregolarsi perché sempre più incapace di
espandersi nel campo di un’autentica interazione con l’ambiente. Del
resto, è precisamente a queste condizioni che l’esperienza, come ho
osservato all’inizio, può entrare in un processo di reificazione tale da
trasformarla in oggetto di compravendita.
Credo che se ne debba trarre questa conclusione: l’estensione del
campo di influenza delle protesi tecniche della sensibilità in funzione
vicaria non coincide affatto, come riteneva almeno in parte Dewey,
con un dispiegamento e un’intensificazione dell’aisthesis, né coincide,
come vuole una tesi speculare molto fortunata, con un «delitto perfetto» (Baudrillard) di cui sarebbe stata vittima la realtà, e si presenta,
invece, come una vasta operazione anestetica che seleziona e mantiene
attivi solo quei segmenti di sensibilità che possono essere canalizzati su
168
oggetti particolari (proprio come nel caso esemplare dei videogiochi,
delle mappe interattive montate sugli autoveicoli o delle operazioni
militari eseguite su ambienti reali riprodotti in simulazione elettronica).
Per cui, in definitiva, il compimento, la “consommation” dell’esperienza
può arrivare a coincidere con la sua ottimizzazione: che si tratti di una
destinazione raggiunta col minimo dispendio di tempo e di esitazioni,
o di un bombardamento “chirurgico”, o di un nuovo record da iscrivere nella lista degli score di un videogame.
Se è vero, come credo, che la giuntura tra biopotere e protesi tecniche della sensibilità si apre sul campo delle esperienze ottimizzabili,
reificabili e mercificabili, allora la bioestetica è la forma attuale, e incomparabilmente più pervasiva, dell’estetizzazione della politica di cui
parlava Benjamin proprio negli stessi anni in cui Dewey scriveva il suo
saggio. Resta da domandarsi se, in queste condizioni, una “politicizzazione dell’arte” possa ancora candidarsi a indicare le strade che si
aprirebbero per il recupero di un’esperire autentico. E se quest’ultimo
possa ancora avvalersi dei tratti distintivi con cui lo pensava Dewey.
Proverò, in conclusione, ad affrontare questa domanda limitandomi
a disegnare, a grandi linee, il campo nel quale essa può aspettarsi di
trovare delle risposte adeguate.
3. I concetti che dobbiamo riprendere da Dewey, per riesaminarli,
sono due: l’interazione tra organismo e ambiente e l’idea di un compimento unitario e armonico del processo esperienziale esemplarmente
esibito dall’opera d’arte.
Ho già detto all’inizio che il concetto di interazione va preso sul
serio. Si tratta, cioè, di un rapporto in cui i cooperanti sono due, e che
comporta, come sottolinea spesso Dewey, non solo attività e passività
ma anche il pieno coinvolgimento dei due contraenti – l’organismo e
l’ambiente – in un movimento che li trascende entrambi e che non può
mai essere interamente dominato né dall’uno né dall’altro. In fondo
Heidegger diceva più o meno la stessa cosa quando – di nuovo in quegli
stessi anni, evidentemente cruciali – parlava dell’opera d’arte come lotta
tra terra e mondo.
Com’è noto, le arti contemporanee, e soprattutto quelle che si avvalgono di nuove tecnologie, hanno enormemente enfatizzato l’idea di
interattività. Il punto che è rimasto fin qui non sufficientemente chiarificato, tuttavia, riguarda proprio il carattere duplice dell’interazione,
su cui ho appena richiamato l’attenzione. Ci si potrebbe chiedere, in
altri termini se gli oggetti tecnoestetici con cui si interagisce siano a
tutti gli effetti assimilabili alle proprietà di un ambiente (contingenza,
imprevedibilità, resistenza, relativa irriducibilità), o se non si tratti piuttosto, perfino nei casi più complessi, di artefatti interamente gestiti da
un programma e dunque tendenzialmente anestetici nel senso indicato
da Dewey. La risposta potrebbe prospettare interessanti gradazioni,
169
da un massimo a un minimo di autentica “ambientalità” registrabili,
per esempio, nelle simulazioni elettroniche immersive che sempre più
spesso mirano ad accreditarsi come proposte di esperienza estetica
tecnicizzata (e si veda su questo punto la precisa presa di posizione
illustrata in questo libro da Roberto Diodato). Ma, più radicalmente,
ci si dovrebbe chiedere se le arti contemporanee interessate alle tecnologie abbiano prospettato con sufficiente chiarezza il progetto di
riqualificare specificamente l’orizzonte esperienziale di una sensibilità
tecnicizzata. Un progetto che comporta da un lato la verifica del grado
di apertura e di indeterminatezza estetica accessibile alle protesi tecniche della sensibilità, dall’altro – e in modo che mi sembra ancor più
determinante – l’esplorazione del tipo di contingenza, imprevedibilità,
resistenza e relativa irriducibilità virtualmente presenti negli ambienti
tecnici di riferimento, per esempio nelle simulazioni digitali complesse.
Insomma: che l’ambiente immersivo delle simulazioni elettroniche sia
davvero un ambiente, e non la semplice performance autoreferenziale
di un programma, è una tesi tutt’altro che evidente che le arti avrebbero il compito di dimostrare.
Il secondo punto è connesso a quanto ho appena detto. Ci si deve
chiedere cioè se l’esperienza estetica di una sensibilità tecnicizzata possa ancora presentarsi nella modalità di un processo coeso nel corso del
quale, come scrive Dewey, «il materiale esperito porta a compimento
il proprio percorso» (AE, 61), un processo di cui l’arte non sarebbe
altro che una messa in forma intesificata ed esemplare.
Non intendo opporre a questa domanda la mera constatazione che
le strade seguite dalle arti moderne, almeno dalle avanguardie in poi, si
sono orientante in una direzione molto diversa. Se lo hanno fatto, ciò
significa, tra le altre cose, che l’incompibile e la lacunosità, il disorientamento e la frammentazione sono stati avvertiti dalla sensibilità moderna
come fenomeni inerenti a ciò che chiamiano “fare esperienza”. Questo
punto, su cui tornerò nelle battute finali, mi interessa meno, per il
momento, di una domanda che suonerebbe così: se fossimo ancora disposti a considerare l’interpretazione deweyana dell’esperienza come un
modello dotato di adeguatezza empirica, in quali esperienze particolari
ci aspetteremmo di poterlo trovare? E in che modo queste esperienze
particolari dovrebbero farsi carico dell’elemento critico introdotto dalle
arti contemporanee nel concetto di un compimento armonico?
Credo che questa domanda meriti di essere posta sullo sfondo della questione della vita, che ho indicato fin dalle prime battute come
l’opzione decisiva. Ho detto prima, sviluppando un pensiero di Dewey,
che una vita delegata ai protocolli assicurativi della tecnica sarebbe una
vita anestetizzata, assoggettata ai dispositivi di controllo del biopotere e
così indigente da rendere possibile il fenomeno della compravendita di
segmenti di esperienza. È la versione regressiva di ciò che ho definito
bioestetica. Ma ne esiste anche una versione emancipativa?
170
Sono convinto che la risposta debba essere affermativa. Ma a che
condizioni? La prima, che ho già indicato, è la seguente: che agli ambienti tecnici vengano restituite le proprietà che fanno di un ambiente
qualcosa di non calcolabile e di non programmabile. Solo in questo
modo, come ho già detto, una sensibilità delegata a protesi tecniche
potrebbe autenticamente interagire con un ambiente simulato (ma
anche, ovviamente, con l’ambiente reale che in via di principio lo include) e dar luogo a esperienze autentiche. In questo quadro è facile
concludere non solo che il concetto di esperienza elaborato da Dewey
resterebbe del tutto valido, ma anche che le forme specifiche di cui
si potrebbe avvalere per lasciarsi esibire sono ancora ben lontane dall’essere state esplorate e chiarificate. Il che significa che il lavoro delle
arti, intese nel senso della continuità con la tradizione a cui pensava
Dewey, qui è appena agli inizi (faccio solo due esempi che vanno nel
senso di un’autentica riqualificazione esperienziale del mondo delle
immagini elettroniche: Bill Viola e Studio Azzurro).
La seconda condizione mette l’accento sulla discontinuità e sulle
differenze (ma vorrei insistere sul fatto che l’elemento della continuità
è ancora tutt’altro che elaborato). Per restare nell’universo della multimedialità, che oggi è di certo quello più sensibile alle forme (regressive
ma anche emancipative) di una bioestetica, credo che sia indispensabile
porre di nuovo il problema antichissimo della veridicità delle immagini,
o meglio, come preferisco dire, della loro capacità di testimoniare forme
di vita. Che la producibilità tecnica delle immagini abbia logorato questa capacità fino a renderla del tutto ineffettuale è cosa ben nota. Non
si è riflettuto abbastanza, invece, sul fatto che questo logoramento si
dispone lungo due vettori. Il primo, che definisco ipermediale, riguarda
la progettazione puramente sensazionale dell’immagine, la sua totale indifferenza per la veridicità che si scarica integralmente in potenza delle
sensazioni (si pensi al recente e peraltro notevole Beowulf di Robert
Zemeckis). Il secondo, che definisco ipomediale, è sicuramente meno
appariscente ma, a mio giudizio, molto più incisivo e sempre più pervasivo. È il caso, per più versi paradigmatico, dei materiali condivisi in siti
come You Tube o My Space, nei quali chiunque può riversare frammenti
di vita configurati grazie alla tecnologia digitale dei telefonini cellulari
o delle webcam. Si tratta di dispositivi tecnici al tempo stesso straordinariamente maneggevoli e molto sofisticati, in grado di garantire la più
alta sensibilità al contingente, la più ampia capacità di intercettarne le
pieghe cogliendo la vita nella sua flagranza. Ma allora perché questi
dispositivi non sembrano saper incontrare, della vita, null’altro che il
corpo inelaborato, di volta in volta pulsionale o esibizionistico, violento
o feroce? La risposta dev’essere cercata proprio nella contrazione di
ciò che viene sentito come un’esperienza meritevole di condivisione e
di apprezzamento, nel suo tendenziale orientarsi verso il dominio delle
sensazioni elementari che per essere ricevute non hanno bisogno di
171
alcuna elaborazione e anzi debbono disattivare i processi elaborativi
connessi con la ricchezza della nostra percezione ritagliando nei dispositivi tecnici utilizzati precisamente quelle funzioni, appunto, ipomediali
– la rapidità, l’incuria per la qualità delle riprese, la maneggevolezza, gli
automatismi di default – che garantiscono la neutralizzazione di ogni
sconfinamento dell’immagine sulla capacità di incorporare pensiero e
riflessione.
L’intuizione del mondo iscritta nei dispositivi ipomediali che inducono a schematizzare la realtà, ogni realtà, come l’oggetto di uno show
potenziale è dunque un fondamentale evento anestetico e biocratico in
cui ne va dell’atrofia e del prosciugamento dei processi – emotivi e cognitivi – che differenziano la percezione dalla sensazione, le esperienze
autentiche da quelle contratte e irrigidite nel senso di Dewey.
Sono convinto, tuttavia, che al movimento anestetico di quest’ultimo vettore regressivo dell’immagine prodotta tecnicamente – che è
il più interessante proprio perché è il più contiguo alla vita e alle sue
forme – si possa e si debba contrapporre un lavoro mirato precisamente alla rigenerazione del potere testimoniale dell’immagine, e che
questo lavoro – ecco l’elemento di decisiva discontinuità col concetto
deweyano di esperienza – non possa che avvalersi di una natura che
definisco intermediale, intendendo con questo che per restituire all’immagine la capacità di farsi testimonianza di una forma di vita bisogna
farla lavorare sulle differenze tra i diversi formati della rappresentazione (a cominciare dalla differenza capitale tra l’ottico e il digitale).
I modi dell’intermedialità possono essere i più diversi: quando per
es. Michael Moore, nel suo film sull’11 settembre, decide di mettere
in immagine la testimonianza di quell’evento escludendolo dal campo
visivo – cioè non facendolo vedere ma solo ascoltare, su un fondo
nero, e immediatamente dopo mostrandocelo solo attraverso i volti e
gli sguardi di chi era presente – non fa opera di iconofobia ma fa precisamente un lavoro intermediale. Quando Spike Lee, nel suo Requiem
in four acts, ricostruisce il disastro dell’uragano Katrina attraverso un
complesso montaggio di immagini che intreccia diversi regimi della
rappresentazione – archivio, televisione, documento, commento – ci
fa vedere che la testimonianza non avrebbe efficacia senza questo intreccio. Marco Bellocchio ha costruito il suo film sul sequestro Moro
nello stesso modo, cioè mescolando e ibridando diverse forme della
rappresentazione: quella tradizionalmente diegetica, quella televisiva,
quella dell’archivio, ma anche una completamente visionaria. Brian
de Palma, in Redacted, ha mostrato che la verità di un episodio della
guerra in Iraq non poteva sorgere se non da un gioco intermediale.
E così via.
L’elemento di discontinuità con Dewey, in definitiva, consiste in un
passaggio obbligato dalla pregnanza dell’immagine – che ha perduto
credo definitivamente il tratto della veridicità – al gioco delle differenze
172
tra le immagini. Un passaggio a cui non si potrebbe attribuire il requsito essenziale del compimento estetico perché l’accento si è spostato
sul luogo dell’apertura e della differenza, che è incompibile in via di
principio. Vorrei ricordare che fu Dziga Vertov, il grande cineasta degli
anni venti del secolo scorso, il primo ad aver capito che questo gioco
di differenze non è solo costitutivo dell’immagine in quanto tale, ma è
anche la condizione di possibilità del suo carattere veridico, della sua
capacità di «cogliere la vita in flagrante», come suona un suo slogan.
Non ci sono immagini presuntivamente dirette e immediate del mondo
e delle cose, c’è piuttosto un montaggio interminabile che sdoppia e
differenzia l’immagine in cosa vista e atto della visione, proprio come
l’occhio è al tempo stesso un occhio che vede e che è visto: soggetto
e oggetto della visione. L’immagine veridica, l’immagine che attesta è
dunque un’immagine che sconfina oltre ogni presuntiva immediatezza
e pregnanza: è immagine sdoppiata e plurale, disseminata e interminabile (si pensi alle Histoire(s) du cinéma di Godard). Un’immagine
che non si compie in se stessa, che non provvede un’esperienza dotata
di compimento, ma che, per contro, mira precisamente a reintegrare
il lacunoso, il differente e l’incompibile nell’atto esperienziale, che in
tal modo si lascia spiegare solo uscendo dal paradigma conciliato di
Dewey senza tuttavia abbandonare quella che all’inizio ho definito la
sua opzione teorica di fondo, vale a dire la sua estetica fisiologica.
Vorrei chiudere sottolineando che sono proprio le modificazioni registrabili, oggi, nelle forme di un’interazione tra organismo e ambiente
a indirizzarci risolutamente in questa direzione. Ma l’ultima parola (o
forse bisognerebbe dire: la prima, la parola che apre, che mostra, che
fa vedere) spetta qui alle arti che sappiano mantenersi all’altezza di
questi cambiamenti.
173
Arte ed esperienza. Dopo Dewey
di Fulvio Carmagnola
Essere giusti con Dewey
Che significa “dopo”? Qualcuno (De Duve) ha scritto per esempio
che ci sarebbe un Kant “dopo Duchamp”. Ci sarebbe un evento dell’ordine dell’arte che in qualche modo ha plasmato o influenzato con
la sua portata il proprio futuro e insieme il proprio passato teorico. Ma
il “dopo Dewey” in fondo lo possiamo vedere in una prima accezione
abbastanza facilmente: basta guardare pellicole recenti come Good night
and good luck o il più recente Michael Clayton per constatare l’influenza
duratura del pensiero e dell’atteggiamento laico-progressista e sinceramente democratico – con la sua critica alle ingiustizie e l’ideale di una
società migliore – radicato nei liberal americani, e di cui Dewey è stato
certamente un insigne rappresentante.
E tuttavia, “dopo” può implicare anche una domanda scomoda:
dove ci troviamo oggi? Siamo ancora lì? La mia impressione generale
di sorvolo, dopo la lettura di Art as Experience, è che Dewey guardi
all’indietro come l’angelo di Benjamin. Mi spiego: forse nelle arti figurative (prendiamo la pittura come pietra di paragone) possiamo leggere
Dewey tenendo presenti artisti come Grant Wood o Wyeth. Forse
Giorgia O’Keeffe, forse Hopper, e cosi via. È possibile che una figura
emblematica sia quella dei due anziani coniugi che si trova in American
Gothic (1930), non a caso un’immagine che ritroviamo sulla copertina
di un’edizione italiana dell’Antologia di Spoon River, celebrazione dello
spirito della comunità originaria dei pionieri del Nuovo Mondo…
Non è una critica ma una constatazione. Eppure, mentre Dewey
sviluppa le sue riflessioni sull’arte come punto più alto dell’esperienza
umana, è già avvenuta la rivoluzione duchampiana: la posizione rispetto all’oggetto-opera è già cambiata in modo irreversibile e la nozione di
bellezza come equilibrio è già tramontata, l’arte “retinica” è in discussione e in letteratura la “rutilante gioielleria barbara” della scrittura di
Joyce ha già compromesso l’idea del linguaggio come rappresentazione
del mondo là fuori. Che ne è di Dewey d’aprés Duchamp, o d’aprés
Joyce, forse si potrebbe chiedere allora.
Naturalmente la spocchiosa domanda su “ciò che è vivo e ciò che
è morto” è del tutto ingiustificata perché presuppone che, seduti sulle
spalle del gigante, noi lo possiamo giudicare da lì, con una certa como175
dità di posizione. Tuttavia più giustificata, a mio avviso, sarebbe una
domanda alla Foucault, voglio dire una domanda in stile archeologico
o genealogico: a quale “formazione discorsiva” appartiene Dewey? Che
cosa, restando immanenti alle sue categorie, possiamo o non possiamo
vedere del suo stesso presente – piuttosto che misurarlo anacronisticamente con il nostro? Occorre insomma misurare una distanza e insieme farlo generosamente. Al “dopo” dell’influenza e della continuità
accoppiare un “dopo” che misura delle discontinuità. Ma una distanza
c’è e va presa in considerazione.
La prima domanda
Proverò allora a formulare una prima domanda: di quale formazione
discorsiva fa parte la parola “esperienza” nel pensiero di Dewey? Con
che cosa si combina, a che cosa la si può opporre o commisurare – per
esempio, al dibattito sulla perdita dell’esperienza che anima le pagine, di poco posteriori, della Dialettica dell’illuminismo (1947) o quelle,
contemporanee all’opera di Dewey, di Walter Benjamin? E perché, nel
suo sistema di pensiero, la nozione di “arte” diventa necessariamente
il punto apicale dell’esperienza umana? Una domanda complessa alla
quale non so se sarò in grado di dare risposta, ma almeno resterà formulata. Eccone lo schema:
– che cosa significa “esperienza” per Dewey;
– a quale formazione discorsiva o concettuale appartiene;
– perché la nozione di “arte”, così come Dewey la formula, ne è
necessariamente il punto apicale;
– quali parentele rivela e quali altre costellazioni di pensiero le
possiamo ragionevolmente opporre.
Si tratta insomma di riflettere sulla coerenza del testo e di chiarirne i
presupposti. Solo in seguito potrà essere formulata la seconda domanda:
che ne è di noi ora, “dopo Dewey”, anche nel senso banale che ci troviamo in un punto differente dell’asse del tempo storico. Solo un’analisi
immanente ci metterebbe al sicuro dalla presunzione, poniamo, di avere
ragione “contro” di lui o di essergli semplicemente estranei come se
il suo tempo non fosse più il nostro… presunzione alla quale farebbe
eco una speculare: di poter dare giudizi sul nostro presente (sull’arte e
l’esperienza estetica in particolare) usando le categorie di Dewey come
un metro normativo. Insomma usare Dewey per dire, magari: questa è
“arte”, questa no – oggi.
Comunità
La mia ipotesi è che la parola chiave per capire Dewey sia la parola “comunità”. La usa parecchie volte nel testo. Proverò a ricordare
sommariamente lo spazio concettuale circoscritto dalla terminologia,
dal lessico. Questo spazio è delimitato da alcune parole chiave. Troviamo da un lato la costellazione che chiamerei ascendente: movimenti
176
dell’animale vivente/esperienza strutturata/arte – e dall’altra la costellazione critica: separatezza/astrazione/squilibrio.
Nella prima, la forma diventa allora il punto apicale di una continuità, di una sequenza naturalistica che parte dall’impulso, “stadio iniziale
di ogni esperienza compiuta”. È qualcosa di simile forse al Trieb freudiano o più indietro al conatus di Spinoza. È questo elemento primario
che spinge l’esperienza verso la sua definizione.
Ma alla base naturalistica si accoppia strutturalmente un vertice dove
intorno alla forma si accumulano i caratteri di una semantica classica:
compimento, equilibrio, realizzazione, ordine, totalità. Così «l’esperienza estetica è esperienza nella sua integrità» (Dewey, p. 266) o al suo
grado più alto, e naturalmente in questa luce l’arte può rappresentare
ancora, come nella tradizione occidentale, «la più grande realizzazione
intellettuale della storia dell’umanità» (p. 51).
Se ora ci domandiamo dove collocare questa costruzione, dovremmo parlare di una versione naturalizzata e critica dell’umanesimo, la
cui comprensione dei fenomeni specifici dell’arte si spinge (solo) fino
a un certo punto della contemporaneità. Fino al punto, direi, in cui
qualcosa come un’“opera”, con i caratteri tradizionali appena elencati:
chiusura formale, equilibrio, bellezza, carattere intuitivo o «presentazionale» (S. Langer) è ancora individuabile. La bellezza, scrive Dewey,
«denota la presenza evidente di relazioni di adeguatezza e reciproco
adattamento tra i membri dell’intero […] manifestazione di una proporzione armonica tra parti» (p. 141).
Cerco di ricostruire sommariamente quel che mi pare uno schema
generale molto chiaro:
– l’essere vivente ha un rapporto primario con il mondo, costituito
dalla genesi senso-motoria dell’esperienza nel vissuto pre-linguistico
(es. p. 243: «l’esperienza è una questione di interazione dell’organismo
con l’ambiente circostante»);
– questa è la base dell’universalismo o della “costituzione comune”:
diremmo il lato naturalistico della nozione di “comunità” il cui altro
lato complementare è il sociale, l’interazione sociale;
– l’esperienza appare come il progressivo perfezionamento dei processi vitali elementari, la sua organizzazione sistematica: «un’unione
integrale di qualità sensoriale e significato in una sola tessitura compatta» (p. 254);
– l’arte che ha la capacità di «rendere intensa e concentrata l’esperienza» (p. 255) è il culmine questo processo, non il distacco da esso:
è una qualità specifica dell’esperienza, che si caratterizza non per la
discontinuità ma per l’intensificazione – così, da un lato la forma è
«un movimento ordinato della materia dell’esperienza verso un compimento» e dall’altro l’arte porta a realizzare compiutamente l’esperienza
della vita-in-comune: «la continuità della cultura […] è determinata
dall’arte più che da qualsiasi altra cosa» (p. 312).
177
Posta in questo modo la questione, si potrebbe pensare a una pura
positivizzazione – e tuttavia l’altro lato è rappresentato da un’istanza
critica: alla condivisione si oppone la “separazione” indotta dalle condizioni sociali specifiche (Dewey non usa il termine marxiano alienazione):
«arte e vita della comunità» sono in contrasto con «le attuali condizioni
[…] il fatto significativo è la diffusa disgregazione […] (si tratta di)
restituire un posto organico all’arte all’interno della civiltà […] in una
unione immaginativa coesa e integrata» (p. 320).
Proprio perché l’arte è il punto culminante dell’esperienza, a essa
va restituito un posto “organico” nella vita sociale. Non c’è arte senza il movimento del vivente, ma nemmeno senza vita della comunità
sociale. Il punto di originalità di Dewey mi pare proprio questo, la
congiunzione o la continuità esperienziale tra i due lati del vivente e
del sociale, come stadi di un unico processo. Ecco allora la doppia
posizione dell’arte: critica della separatezza e dimostrazione delle possibilità di unificazione, sotto forma di prefigurazione «ideale» (p. 271)
– o forse si potrebbe dire “idealtipica” – di una condizione liberata
dell’esperienza: «i valori che portano a produrre l’arte e a goderne in
maniera intelligente devono essere assimilati nel sistema delle relazioni
sociali […] possibilità che sono irrealizzate e che potrebbero realizzarsi
[…] l’arte è un tipo di predizione […] e delinea possibilità di relazioni
umane» (pp. 326-30).
Segnalo la contrapposizione frontale: “unificazione” (dell’esperienza) versus “separazione”: una società libera è, per cosi dire, una comunità sociale estetizzata.
Vorrei anche ricordare alcune analogie o derive di pensiero che
traspaiono dal testo: lo Schiller delle Lettere e il Marx dei Manoscritti
sembrano le più immediatamente visibili. Più interessanti, sul versante
“naturalistico”, è l’analogia con concezioni che troveremo molto tempo
dopo in una corrente innovativa del pensiero della complessità rappresentata in particolare da Maturana e Varela: la cognizione è intimamente legata allo sviluppo dei processi sensomotori del vivente.
Colpisce poi l’analogia con le posizioni sistemiche di un pensatore
eclettico e eterodosso come Gregory Bateson. Quando Dewey parla
dell’intelligenza come «percezione di una relazione» (p. 70), o afferma
che «è il modo in cui la cosa è connessa che conta» (p. 178), viene alla
mente la definizione di comportamento estetico che si trova in Bateson:
«per estetico intendo sensibile alla struttura che connette» (pattern
which connects) (Bateson, 1979, tr. it. 1984 p. 22; cfr. anche Manghi,
2007, p. 74). E quando Dewey ricorda che «la mente» non deve essere sostanzializzata metafisicamente ma trattata come «un verbo», o
«uno sfondo costituito dalle modificazioni del sé […] dagli scambi con
il mondo […] uno sfondo esperienziale […] di cui la coscienza è il
primo piano» (pp. 258-260) non si può non ricordare la definizione di
mente sistemica che si trova nei saggi di Steps to an Ecology of Mind.
178
Dunque da un lato la naturalizzazione dell’esperienza valica il ristretto orizzonte antropomorfo, è il riconoscimento dell’appartenenza
dell’umano alla natura. Ma dall’altro l’esperienza culmina comunque
nell’umano, e connette il singolo alla comunità come forma di sentire
comune, in una sorta di religione laica, civica.
Natura e comunità civile sono i due estremi di un continuum, nel
quale l’arte diventa la forma più alta della dimora, dell’appaesamento. Noi “in-abitiamo il mondo” e l’arte è apparizione nelle opere di
un mondo possibile liberato dalla “separazione”: «[…] in-abitiamo il
mondo. Esso diventa una dimora […] l’arte toglie il velo che nasconde
l’espressività delle cose esperite; li distoglie dall’indolenza della routine
[…] le opere d’arte sono i soli media capaci di una comunicazione
completa e non ostacolata tra uomo e uomo […] in un mondo pieno
di abissi e pareti che limitano la condivisione dell’esperienza» (pp.
119-20).
Ripeto: l’originalità di Dewey mi pare quella di aver coniugato un
asse genetico di continuità (la matrice naturalistica dell’esperienza nell’organismo o nella creatura: termini che verranno non a caso usati
appunto da Bateson e che ricordano «l’animal vivente» di Galileo) con
un asse critico-ideale: il compimento estetico dell’esperienza nell’opera che si presenta come Idealtypus di una possibilità contenuta nella
natura umana e frenata dalle condizioni sociali. Ne deriva, ripeto, il
carattere tradizionale della forma estetica implicata da questa coniugazione: compimento, senso intensificato, bellezza percettiva evidente. Naturalismo e umanesimo compaiono insomma come le premesse
complementari del terzo asse, quello fondamentale.
Due versanti della critica?
Sarebbe qui il caso di toccare il quarto punto della mia domanda:
con quale altra teoria estetica possiamo ragionevolmente confrontare
questo sistema di pensiero? Viene in mente immediatamente la Teoria
critica almeno nelle versioni di Benjamin e poi di Adorno, perché anche qui si sviluppa un ragionamento sull’esperienza.
Vorrei tornarci sopra alla fine, e anticipo solo un’osservazione. Se
l’esperienza per Dewey è, per cosi dire, il bagaglio naturale del vivente e viene vista nel modo della continuità, al contrario per la Teoria critica c’è una grande faglia che non permette alcuna continuità:
l’esperienza è, diremmo, la promessa non mantenuta della modernità
e dell’illuminismo. Questa differenza si manifesta in due teorie della
forma artistica radicalmente differenti: per la prima, la forma sta in
continuità con la classicità e con il primo moderno – per la seconda la
bellezza e l’intero devono cedere il posto all’espressione della frattura
e al valore testimoniale dell’arte.
Potrei azzardare che in un certo senso Dewey e Adorno (o Ben����
jamin�������������������������������������������������������������������
) si fronteggiano come i due versanti di un’estetica critica: anti179
cipatrice o dialettico-negativa. Ma anche: la nozione di esperienza di
Dewey “vede meglio”, per cosi dire, fino a un certo punto dell’evoluzione delle arti. Basta consultare l’indice dei nomi del suo libro per
rendersene conto. Mentre Adorno (e Benjamin) si trovano al centro di
quella fase dello sviluppo delle arti dove più radicale appare la negazione della “buona forma”. Un presente che era già quello di Dewey
ma che nella sua teoria non viene pienamente raccolto.
La realizzazione ironica
La condizione culturale alla quale Dewey appartiene, e che ho cercato rozzamente di richiamare, è ancora la nostra? Dove ci troviamo
oggi rispetto a questa costellazione di pensiero? Che valore critico ha
oggi l’umanesimo di Dewey? Ma soprattutto: che cosa vediamo, ma
anche, che cosa non riusciamo a vedere, se guardiamo con gli occhi di
Dewey? Vorrei solo toccare due punti specifici che chiamerei “realizzazione ironica” e “eteronomia sistemica”.
È stata recentemente sollevata la questione doppiamente problematica della universalità e dell’esemplarità dell’arte – questione che
tocca da vicino i temi di Dewey. Secondo questo punto di vista l’arte
non sarebbe «un termine primitivo, dotato di uno statuto sostanziale».
La sua origine deve essere identificata in «un insieme di artefatti ed
esperienze determinate a cui, dal xviii secolo in poi, si è convenuto di
dare il nome di arte». Dunque non sarebbe garantita la conservazione
della sua esemplarità in condizioni storiche mutate, in quanto essa va
intesa come «un nome che appartiene al vocabolario della modernità» (Montani, 2007, pp. 10-11). Concordo con questa impostazione
e vorrei riprendere la questione da un punto di vista differente ma,
credo, complementare.
In primo luogo, a mio parere è avvenuta (riprendo qui osservazioni
che si possono già trovare in Baudrillard) una sorta di realizzazione
ironica dei teoremi critici modernisti enunciati da Dewey, che dunque
vedono sfocarsi il loro valore ideale critico e anticipativo. Ne consegue
che l’esperienza non è più un definiens ma un elemento problematico,
e che l’arte non è più di per sé il valore da contrapporre, la sporgenza
rispetto al mondo della “separazione” – anzi si è pienamente realizzata, in maniera ironica, la sua profonda “integrazione” con il mondo
mercificato. Come tale oggi l’arte non è più il centro o il punto apicale
dell’esperienza ma semmai il punto (locale o regionale) di un complesso che si potrebbe definire come “immaginario mediale” connesso
inestricabilmente al mondo delle merci e non contrapponibile a questo.
Chiamo “ironica” questa realizzazione perché a mio parere cambia il
segno delle affermazioni di Dewey se le rileggiamo alla luce di ciò che
sta accadendo.
Senza alcuna acrimonia, si potrebbe osservare infatti che in un certo senso gran parte dei valori che in Dewey assumono la posizione di
180
ideale critico si sarebbero realizzati con il segno cambiato, nella cultura
del “terzo capitalismo”. Che non è più la società dell’omogeneità standardizzata e della macchina seriale ma della smart machine (The Age of
the Smart Machine, suona appunto il titolo di un best seller di qualche
anno fa). Alcuni esempi con riferimento al testo deweyano possono
illustrare questa circostanza:
– la cultura come «espressione naturale della vita collettiva» (p.
36) si realizza nei profili di «vita artistica» di cui si adornano i manager creativi (Perniola, 2002) e nella popolarizzazione attuata nello stile
para-televisivo dell’orgia di festival. C’è un festival per tutto – dalla
scienza alla formazione aziendale – e davvero l’alta cultura pare fare a
gara per popolarizzarsi e presentarsi in modo agibile, agevole, fruibile, non distaccato. La divulgazione è il modello vincente della cultura
attuale;
– la «connessione sociale» e la fine della scissione tra produttore e
consumatore che doveva ripristinare la continuità dell’esperienza estetica con i processi naturali del vivere (p. 37) si realizza nella figura del
consumatore come nuovo produttore inconsapevole – un lavoratore
che non sa di lavorare, come recitavano i Situazionisti – nell’ambiente
pervasivo del nuovo marketing virale;
– l’esperienza estetica pare realizzarsi in una pratica di consumo
che poco ha a che vedere con la pura funzionalità strumentale o funzionalità rispetto allo scopo (Weber), come voleva Dewey. Proprio nel
consumo postindustriale la forma dell’oggetto «viene svincolata dall’essere limitata a un fine specifico e serve anche agli scopi di un’esperienza immediata» (Dewey, p. 130); proprio qui e pienamente all’interno delle regole del marketing “esperienziale” appunto, l’esperienza
estetica si quotidianizza, e smette di essere «il salone di bellezza della
civiltà» (p. 325);
– l’esperienza come un “questo”, una singolarità, per la quale Dewey
ha espressioni precise e pregnanti – quel pasto, quella tempesta (p.
62) – non si realizza forse ironicamente nelle pretese del marketing
esperienziale (Ferraresi, Schmidt, 2006) che punta precisamente su una
sorta di intensificazione del valore d’uso nella declinazione estetica postindustriale del “piacere”? “The Ardbeg Experience” si legge appunto
nel claim di una nota (e peraltro eccellente) marca di Malt scozzese;
– e la concezione tradizionale della separatezza tra «lavoro» e «piacere» (p. 258) non viene forse smantellata dall’insistenza attuale sulle
nuove dimensioni lavorative ad alta densità creativa e cognitiva nell’ambiente del terzo capitalismo (Boltanski-Chiapello, 1999)? La liberazione
del lavoro, scriveva Dewey, è il «prerequistito essenziale della soddisfazione estetica» (p. 325). Proprio questo oggi il capitalismo richiede tanto al lavoratore cognitivo quanto al consumatore creativo, sotto forma
di ingiunzione performativa: sii creativo! Sii felice!
– e infine, si potrebbe dire: l’apertura all’esperienza dell’altro cul181
turale (p. 317 ) non è forse oggi diventata effettivamente, come Dewey
auspicava, «parte intrinseca della creazione artistica» (p. 317)? Certo,
ma lo è diventata in qualche modo con il segno cambiato dal momento
che la «unione immaginativa coesa e integrata» (p. 320) pare essersi
realizzata nella globalizazzione etnico-commerciale e nella forma dell’immaginario melting pot.
Dunque si direbbe che al posto di parlare di «isolamento dell’arte»
(p. 317) sia necessario parlare oggi di una crescente e forse definitiva
integrazione dell’arte nel sistema della comunicazione mediale. Ne consegue che l’arte deve cercare, come sta facendo, altre forme.
In particolare, per quanto riguarda le poetiche, mi pare che l’estetizzazione della vita comune sia rispecchiata (ancora una volta ironicamente) da certe correnti dell’arte contemporanea che espone la quotidianità nella sua sconcertante vacuità informe. Sembra che la componente critica dell’arte abbia preso sempre più spesso l’apparenza del
rovesciamento dei teoremi modernisti: non l’organicità ma l’informe (la
vita quotidiana come tale: Nan Goldin, Sophie Calle, Philip Lorca Di
Corcia e molti altri); non la comprensibilità immediata ma la negazione
del senso (Lynch per esempio); non l’originalità ma la virtù della cover
secondo la direzione indicata dal celebre racconto di Borges, Pierre
Menard, autore del Don Chisciotte (Senaldi, 2003).
L’eteronomia sistemica
In secondo luogo, il paesaggio attuale dell’arte è eteronomo e non
più definibile con la classica nozione di “forma”. L’innovazione rivendicata dal pensatore americano consisteva, abbiamo visto, nel combattere la separatezza con la continuità: la forma artistica deriva dai
processi vitali della creatura. In questo modo, osservavo, Dewey svolge
una efficace critica dell’antropomorfismo.
Resta tuttavia il fatto che la forma ha nel suo pensiero i tratti tradizionali: compiutezza, equilibrio. E che l’opera deve, proprio per la
funzione che Dewey le assegna, essere ancora riconoscibile ictu oculi, deve insomma stagliarsi con nettezza nel panorama dei prodotti
dell’esperienza, non separata ma, per cosi dire, separabile, prodotto
ultimo e più alto dei processi vitali. La non-autonomia genetica della
forma artistica non incide insomma sulla sua evidenza o autonomia
percettiva.
Ora, io non credo che questo sia tuttora il panorama dell’arte contemporanea – e per la verità credo che non lo fosse già più ai tempi
di Dewey. Per comprendere lo scenario attuale credo sia necessario
spostarsi al di fuori del predominio del sistema coerente percezione
diretta / forma “buona”, che sta al centro del pensiero di Dewey, e
di parte dell’estetica del secolo scorso. Ritengo in altre parole che
l’artefatto “opera” non sia più definibile con le coordinate immanenti
della forma ma in base a una sorta di eteronomia che definisco come
182
“posizione di enunciazione” (cfr. ad es. Goodman, 1968). All’opera
come auto-presentazione di una forma che si offre alla percezione immediata, portatrice di «significati che si presentano direttamente come
proprietà di oggetti di cui si fa esperienza […] non c’è bisogno di un
codice […] il significato è intrinseco all’esperienza immediata» (Dewey,
p. 102), si contrappone nella tarda modernità la presenza dell’opera
come artefatto non evidente, definibile solo in termini di contesto istituzionale o “dispositivo” o sistema.
Un esempio straordinario a mio avviso è costituito dal caso ArtaudRiviére (1923) oltre a tutto perfettamente contemporaneo al periodo
in cui Dewey sviluppa le sue considerazioni. Lo riassumo qui brevemente.
La vicenda letteraria di Artaud comincia con un rifiuto: Jacques
Riviére, il direttore della “Nouvelle Revue Française” alla quale Artaud
aveva spedito alcune poesie, si rifiuta di pubblicarle. Riviére motiva
il suo rifiuto parlando di una insufficiente «unità di impressione», di
«immagini a tratti divergenti», di «informità di realizzazione», di un
«funzionamento immediato e animale dello spirito». Uno “spirito” disorganizzato e diremmo selvaggio, produce una forma (letteraria) insufficiente nella quale, scrive Riviére, «tutto si disgrega in un’immensa
contingenza» (cfr. Artaud, Al paese dei Tarahumara, tr. it. p. 18). Non
pare di sentire Dewey?: «in casi estremi l’emozione crea disordine […]
un’emozione eccessiva ostacola la necessaria elaborazione e definizione
di parti» (Dewey, p. 72).
In realtà Artaud otterrà il riconoscimento, la certificazione di autore letterario di prima grandezza, quando è ancora in vita, quando
cioè il più importante editore francese, Gallimard, deciderà di pubblicare l’edizione delle sue Opere complete. Quindi evidentemente si
tratterebbe di un completo capovolgimento della situazione iniziale.
Dovremmo chiederci allora: che cosa è accaduto “nel frattempo”?
C’è un’altra circostanza rilevante. Dopo più di un anno di scambi
di lettere tra il poeta e l’editore della rivista Riviére fa una proposta
sorprendente: «perché non pubblicare la o le lettere che mi ha scritto?» (Al paese…, p. 21). Insomma, semplificando al massimo: le poesie
non avrebbero valore letterario (difetti di forma) ma le lettere sì. Come
mai? Che cosa decide che uno scritto – o una pittura, o in genere un
artefatto – sia un’“opera” (letteraria o artistica in genere)? Che cosa
distingue, e chi è in grado di distinguere la “contingenza” del sintomo
dalla consapevolezza della forma compiuta?
Riviére pare rispondere: la condizione perché ci sia opera è un certo livello di chiusura formale. Diremmo: di buona forma. E quindi,
nello stesso ordine, rifiuta lo statuto di opera a ciò che Artaud scrive.
In questo rifiuto c’è evidentemente un implicito: è possibile distinguere, guardando l’oggetto stesso, il suo status.
La vicenda di Artaud mostra però che la condizione “formale” non
183
è sufficiente, occorre aggiungere quella che si potrebbe chiamare una
condizione “istituzionale”. Questa circostanza è messa in luce proprio
dall’evoluzione del carteggio con Riviére. Allora, che cosa definisce il
campo di validità della scrittura letteraria o dell’opera? A prima vista
si tratta della forma-di-opera. Ma chi definisce la forma-di-opera? Si
può azzardare una risposta: la forma-di-opera dipende non dalla forma
stessa (la forma non è più autonoma, non si presenta più da sé) ma
dalla posizione di enunciazione o dal sistema che conferisce lo statuto
alle opere stesse.
L’opera stessa non ha più una propria essenza. Il gesto di Riviére
che accetta/rifiuta – per la precisione rifiuta una “forma” specifica, la
poesia, e ne accetta o ne legittima un’altra, le lettere – è ciò che decide
dell’appartenenza o meno di uno specifico artefatto, e dunque di uno
specifico “autore” al sistema-letteratura. E il gesto istituzionale dell’editore Gallimard decide, con la decisione di pubblicare le Opere complete
– della presunta ontologia artistica dell’opera di Artaud.
Dire il vero, essere nel vero
Dunque ci si potrebbe chiedere: Dewey dice il vero quando parla
dell’arte come culmine dell’esperienza? È nel vero? Ho usato di proposito due locuzioni che richiamano alcune considerazioni pertinenti
di Michel Foucault: dire il vero e essere nel vero non sono la stessa
cosa. La teoria dell’evoluzione di Mendel, notava Foucault, diceva il
vero ma non era nel vero, dal momento che «è sempre possibile dire
il vero nello spazio di un’esteriorità selvaggia; ma non si è nel vero se
non ottemperando alle regole di una ‘polizia’ discorsiva» (L’ordine del
discorso, tr. it. p. 28).
Credo che la “polizia discorsiva” abbia a che vedere con la posizione di enunciazione che definisce l’opera nel contemporaneo. C’è una
posizione, e solo stando al suo interno si può essere accettati nella propria verità, «la disciplina è una posizione di controllo della produzione
discorsiva» afferma ancora Foucault.
Cerchiamo allora di proiettare queste osservazioni sul discorso di
Dewey. Potremmo osservare che rispetto alla disciplina (o formazione
discorsiva) chiamata “arte” è forse cambiato il modo di essere-nel-vero.
Potremmo aggiungere che il vero che Dewey dice è segnato da una
storia, quella della proto-modernità. Ma forse anche che il punto in
cui Dewey si trova è un punto o uno spazio storico di biforcazione,
uno spazio o un luogo in cui il dire-il-vero della tradizione moderna
e quello delle Avanguardie si intersecano, si sovrappongono – e il secondo, Joyce o Duchamp, tanto per fare due nomi, sta ancora sul bordo dell’essere-nel-vero. Come Mendel, forse ai tempi di Dewey anche
Duchamp, o Joyce, era «un mostro vero […] la scienza non poteva
parlarne» (Foucault, ib.).
E tuttavia forse questa posizione storicizzante non basta perché il
184
ragionamento di Foucault può essere spinto oltre. La genealogia ha
bisogno della storia, osservava Foucault riprendendo Nietzsche. Ma
che cos’è la genealogia? Una posizione critica sospettosa, che sfascia
le continuità apparenti per restituire i fatti nella loro reale “dispersione”. È notevole il fatto che negli anni settanta Foucault immaginasse
possibile una genealogia anche di quel terreno che lui, con una curiosa
riduzione, definisce “pittura” (Archeologia del sapere, tr. it, p. 220).
Forse “pittura” può essere generalizzato in “arte”. Forse si può tentare
una genealogia del sistema “arte”, nella quale dovrebbe apparire la
distinzione tra forma e posizione di enunciazione.
Si tratterebbe della descrizione di uno spazio o di un campo entro
il quale si possa di volta in volta dire il vero stando nel vero. Sarebbe
la descrizione dello spazio-di-verità che permette la produzione di artefatti riconoscibili come “veri” (nella fattispecie: vere opere d’arte).
La percezione diretta della forma come criterio o canone (per rispettare il lessico di Dewey) fa parte di questo spazio e questo spazio è
variabile (non universale, diciamo). Non è l’esperienza “umana” ma un
campo storico, e non è descrivibile solo con le coordinate immanenti
dell’opera ma con quelle eteronome dell’archivio, del dispositivo, della formazione discorsiva, della posizione di enunciazione. È animato
o abitato da una pluralità di attori o agenti la cui interazione decide
sull’appartenenza di qualsiasi artefatto al sistema-arte: ecco che cosa a
mio avviso si può intendere con “eteronomia”.
Ora, se esaminiamo il campo dell’arte contemporanea, questa mi
pare la caratteristica prevalente: ciò che decide dell’appartenenza legittima non è la percezione diretta ma piuttosto la posizione (eteronoma)
di enunciazione. È questa che decide del gusto, del piacere e della
legittima appartenenza dell’artefatto – insomma del suo essere-nel-vero
e di conseguenza del suo valore di verità (dire-il-vero o “esprimere
significati” per usare il lessico deweyano).
Nella parte finale del suo libro, Dewey prende in considerazione
una circostanza rilevante dell’arte contemporanea del suo tempo, l’utilizzazione da parte dell’avanguardia dei modelli formali delle culture
dei cosiddetti popoli senza scrittura (l’«arte negra», p. 317): «l’influenza delle arti di culture distanti è diventata parte intrinseca della
creazione artistica». Ma qual è la motivazione che muoverebbe questa
appropriazione? «La forza motrice è la partecipazione autentica», nota
Dewey. Grazie a questa “le barriere si dissolvono” e l’arte mostra di
essere «una modalità di linguaggio più universale di quanto non sia il
discorso» (p. 318).
Non è forse questo un esempio di quanto l’essere-nel-vero sia a
sua volta una posizione prospettica? Se applichiamo all’universalismo
umanistico deweyano la lezione della scuola del sospetto, dovremmo
piuttosto dire che i manufatti etnici diventano arte solo nel “per noi”
che appartiene alla nostra “formazione discorsiva” – ovvero, quando
185
sono importati o fruiti alla luce della posizione di enunciazione entro la
quale ci troviamo senza discuterla. La posizione caratteristica di quella
specifica formazione discorsiva, occidentale e moderna, chiamata convenzionalmente “arte”. Un importante saggio di James Clifford (On
Collecting Art and Culture, tr. it. 1999) chiarisce in proposito molte cose.
In particolare, chiarisce come gli stessi artefatti, in condizioni di percezione (sociale, storica) mutate, vengano inclusi in differenti orizzonti
di senso e collocati in differenti posizioni nel sistema di cui l’“arte” fa
parte. A mio parere questa è una condizione nella quale si trova tutta
l’arte contemporanea.
La triste scienza
L’insieme di questi punti mi sembra di fatto comporre una mappa
coerente. Al posto di un’apicalità, culmine di un percorso ascendente,
abbiamo una regionalizzazione dell’arte come parte dell’immaginario
mediale. Al posto della posizione idealtipica abbiamo la crescente integrazione in una comunicazione in cui la stessa estetizzazione appare iperfinalizzata e normata. Al posto della buona forma abbiamo la trasgressione generalizzata della forma in varie direzioni (Perniola, 2000). Al posto
della posizione autonoma e autosufficiente della percezione abbiamo
una profonda eteronomia dove la legittimazione dell’artefatto artistico
è decisa da un sistema relazionale e da una pluralità di agenti.
Resta da decidere allora come valutare la teoria di Dewey: questi
mutamenti sono il prodotto di una fase ulteriore, imprevedibile ai suoi
tempi – oppure già nella sua dimensione storica erano presenti e lui
non li voleva vedere perché ancora impegnato a difendere l’eredità dell’illuminismo umanistico dagli assalti della modernizzazione? In fondo,
anche per Dewey si potrebbe forse ripetere a questo proposito ciò che
Blanchot osservava su Freud: la sua opera mostra «una commovente
fiducia […] nei poteri della coscienza e dell’espressione» (Blanchot,
tr. it. 1969, p. 216).
Ma il rischio è anche che questa fiducia si trasformi in qualcosa di
simile all’ideologia quando venga assunta come tale – è il rischio che
motiva il punto chiave della teoria estetica adorniana, ben prima dello
sviluppo delle teorie post-strutturaliste alla Foucault. Non occorre essere necessariamente anti-umanisti come la generazione dei pensatori
francesi fioriti al seguito di Kojéve, di Hyppolite o di Lévi-Strauss per
notare come Adorno che “il Tutto è il falso” e che “non si dà vera
vita nella falsa”.
Torniamo così ancora al confronto tra la versione di Dewey e quella
di una critica governata dalla concezione della dialettica negativa. È
una posizione che eredita la “potenza del negativo” hegeliana per far
emergere la verità – e la verità è appunto che il tutto, la totalità, nelle
condizioni concrete della società capitalistica si è trasformata nel falso
dell’universale reificazione. E tale è appunto la condizione alla quale
186
reagiscono criticamente l’arte e la letteratura degne di questo nome
rifiutando persino l’anticipazione di un intero – come la tipizzazione
ideale di Dewey proponeva.
Parlando di Kafka, Adorno scrive che il narratore non espone la
totalità nell’opera ma piuttosto espone la ferita, cioè la condizione “reificata” al suo massimo grado: diventare-cosa, diventare-animale, disumanizzarsi. La naturalizzazione genetica di Dewey assume allora una
tonalità differente, diventa “la salutare rassomiglianza dell’uomo con la
bestia”. E questa è la ferita che l’umanesimo non vede, e la cui esposizione diventa “la cifra” dell’arte. Ovvero, è il “dire il vero” sulla nonverità sociale. Potremmo dirlo in termini psicoanalitici: la traversata del
fantasma si effettua esponendo il fantasma in tutta la sua portata e non
contrapponendovi un’immagine della vera vita che potrebbe esserci.
Il «momento dello scatto» scrive Adorno, si ha «quando gli uomini
si rendono conto di non essere un’ipseità – di essere anch’essi cose» o
animali, come accade al protagonista della Metamorfosi. Invece di anticipare l’intero, la forma pacificata, ogni «conoscenza», osserva Adorno
– ogni forma di consapevolezza – deve mimare la condizione del falso
per poter «diventare tale» ovvero: per poter essere conoscenza. La
mimesi dell’accecamento è anche insieme l’estrema difesa dall’accecamento e la sua critica. Credo che nell’arte contemporanea, almeno
in una fase della sua storia, sia stata questa una forma potente – alla
quale l’irenismo di fondo di Dewey, malgrado la sua sincera attitudine
democratica, non permette di accedere.
Palinodia
Avremmo in ogni caso due differenti forme di critica. Una anticipatrice, l’altra negatrice. Una idealizzante, necessariamente; l’altra dialettica. Una che eredita il tono della bellezza tradizionale, l’altra che vi si
rifiuta in nome della qualità testimoniale. Una, in fondo, gioiosa, l’altra
sofferente. E tuttavia… Non potremmo recuperare le virtù di Dewey
proprio facendo leva un’ultima volta sulla chiave ironica? Tenterò in
questa chiave una sorta di parziale ritrattazione.
Che ne è di Dewey dopo Duchamp? Ho cercato di mostrare come
Dewey in un certo senso abbia paradossalmente (ironicamente) ragione
contro se stesso – dal momento che la realizzazione dei suoi teoremi
ne cambierebbe il valore rispetto a quanto egli voleva. Ciò che si riteneva patrimonio critico è stato infatti tranquillamente assorbito dal
sistema arte-cultura attuale. Così, Dewey avrebbe in fondo il valore
di una testimonianza storica, di ciò che non possiamo più essere né
pensare. Eppure si potrebbe capovolgere anche la domanda iniziale:
che ne è di Duchamp dopo Dewey? Si potrebbe in fondo mostrare
che proprio il culmine della realizzazione ironica indica una vicinanza
letterale tra Dewey, Duchamp e l’arte attuale, almeno in alcune delle
sue declinazioni.
187
Sì, è vero: Dewey e Duchamp potrebbero ben condividere – da
opposti versanti – le stesse affermazioni. “Qualunque cosa può essere
arte”, e come è noto, “sono gli spettatori che fanno il quadro”. Ma non
ritroviamo più o meno le stesse affermazioni nel libro del pensatore
americano?
– «l’artista incarna in se stesso l’atteggiamento del percipiente»
(Dewey, p. 72):
– il materiale dell’arte non è distinto dal «mondo comune» (p.
122);
– occorre «indebolire la soggezione moralistica che spinge le menti
a rifuggire da certi materiali […] fino a comprendere (potenzialmente)
ogni e qualsiasi cosa» (pp. 193-94).
E così via. Siamo disorientati e cerchiamo la differenza specifica
che ci faccia capire dove stiamo. Queste due serie di affermazioni, ci
domandiamo ancora una volta, fanno parte della stessa “formazione
discorsiva” o sono incommensurabili?
A seconda di dove ci poniamo possiamo rispondere affermativamente o negativamente. Rispondere “sì” implicherebbe una continuità delle
parole (esperienza, arte, forma) che continuerebbero a indicare le stesse
“cose” nel corso della storia. La risposta negativa implica invece ciò che
Foucault chiamerebbe una “dispersione” – o addirittura una faglia che
ci separa per sempre da quella modernità di cui tanto Dewey quanto
Adorno fanno parte pur nella loro radicale contrapposizione. Il punto
su cui ragionare è proprio il termine “esperienza”. Entrambi – l’idealista e il dialettico – in fondo ne condividono il significato profondo.
Ma «le arti al volgere del millennio» (Riemschneider, Grosenik,
1999) hanno perduto a quanto pare sia il pathos ideale di Dewey che la
potenza del negativo adorniano – proprio a causa, credo, del loro status
integrato di cui ho cercato di parlare prima. La loro ironica presenza
è intrisa di un pervasivo cinismo, di indifferenza an-estetica. Probabilmente sia Adorno che Dewey rifiuterebbero i furbi ammiccamenti di
Cattelan o di Matthew Barney, di Damien Hirst o di Jeff Koons, il loro
sapiente e perverso gioco con i media, la loro capacità di apparire in
quanto figure, personaggi, star.
L’arte oggi, mi pare, non mostra la bellezza per contrapporla alla
separazione, né esibisce in modo critico-testimoniale la condizione del
falso come index sui et veri. Più semplicemente, ripete, o meglio, nelle sue migliori apparizioni mostra il falso come il vero-del-vero (ecco
perché la cover a mio avviso è cosi importante). Forma drammatica
prevista da Adorno, che guardava i grandi modelli di Beckett e Kafka,
ma appunto in una forma minore, nella tonalità del trick. Non nella
regione alta dell’“Arte” ma nella regione bassa dello Spettacolo. Non
in forme direttamente identificabili ma in forme ambigue. Non si tiene
al sicuro nella moralità della Cultura, ma rasenta ogni volta la regione
compromettente del kitsch…
188
L’arte, o almeno una sua parte, mostra insomma che l’esperienza
non può essere idealizzata come ciò che da sempre il vivente accumula
fino al suo apice artistico, perché è un fatto sociale e l’umano può regredire e perderla. Ma nemmeno che essa è ciò che abbiamo perduto
una volta per tutte: sarebbe ancora un universale. “Da sempre” o “una
volta per tutte” sono due varianti compatibili, stanno sui due bordi
opposti di una faglia segnata da due accezioni dell’esperienza: acquisizione perenne o eredità per sempre perduta: «il midollo dell’esperienza
è tutto succhiato – scrive Adorno – non c’è più alcuna esperienza,
neanche quella immediatamente sottratta al commercio, che non sia
intaccata» (Teoria estetica, tr. it. p. 54).
Potrebbe dunque esserci un’altra declinazione del pragmatismo.
Questa in fondo ci dice che l’esperienza è «ciò che si fa e si può perdere» (Senaldi), di volta in volta. Né ciò che è per sempre perduto né
il frutto inevitabile di un cammino ascendente della specie. Piuttosto,
qualcosa che va cautamente sorvegliato perché i suoi esiti sono indeterminabili e sottoposti a un continuo pericolo – ma anche occasioni
che di volta in volta un soggetto riflessivo può cogliere. Si tratterebbe
però di sostituire all’umanesimo di Dewey quella strana versione del
pragmatismo che si trova in Deleuze: non il Soggetto ma la molteplicità dispersa, il «muro di pietre a secco» (Deleuze, tr. it. 1995, pp. 80
e 114).
Che cos’è “il muro di pietre a secco” in cui Deleuze vede inaspettatamente la virtù del pragmatismo? Potremmo dire che si tratta di
una terza figura dell’esperienza estetica: dopo quella dell’opera come
organicità (Dewey) e quella dell’opera come frammento che sarebbe
«quella parte della totalità dell’opera che resiste alla totalità stessa»
(Adorno), il muro di pietre a secco riguarda l’esperienza post-umanistica di una molteplicità dispersa, plurale, anonima. Dopo la “comunità” di Dewey, una figura del farne-a-meno: corpuscoli, gruppuscoli,
molteplicità o “comunità che viene”.
Referenze bibliografiche
Adorno, T. W., 1955, tr. it. 1972, “Appunti su Kafka”, in Prismi. Saggi sulla critica
della cultura, Torino, Einaudi, p. 249 ss.
Id., 1970, a cura di G. Adorno e R. Tiedemann, tr. it. 1975, Teoria estetica, Torino,
Einaudi
Id., 1947, tr. it. 1966, Dialettica dell’illuminismo, Torino, Einaudi.
Artaud, A., 1956, tr. it. 1966, Al paese dei Tarahumara e altri scritti, a cura di H. J.
Maxwell e C. Rugafiori, Milano, Adelphi.
Bateson, G., 1972, tr. it. 1976, Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.
Id., 1979, tr. it. 1984, Mente e natura, Milano, Adelphi.
Blanchot, M., 1959, tr. it. 1969, Il libro a venire, Torino, Einaudi.
Boltanski, L., Chiapello, E., 1999, Le nouveau esprit du capitalisme, Paris, Gallimard.
189
Clifford, J., 1988 , tr. it. 1999, I frutti puri impazziscono. Etnografia letteratura e arte
nel secolo xx, Torino, Boringhieri.
Deleuze, G., 1993, tr. it. 1995, Critica e clinica, Milano, Raffaello Cortina.
Dewey, J., 1934, tr. it. 2007, Arte come esperienza, a cura di G. Matteucci, Palermo,
Aesthetica.
Ferraresi, M., Schmidt, B. H., 2002, Marketing esperienziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo, Milano, Franco Angeli.
Foucault, M., 1969, tr. it.1971, L’archeologia del sapere, Milano, Rizzoli.
Id., 1970, tr. it. 1972, L’ordine del discorso, Torino, Einaudi.
Goodman, N., 1969, tr. it. 1991, I linguaggi dell’arte, a cura di F. Brioschi, Milano,
Il Saggiatore.
Maturana, H., Varela, F., 1970, tr. it. 2004, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione
del vivente, a cura di G. De Michelis, Venezia, Marsilio.
Montani, P., 2007, Bioestetica. Senso comune, tecnica e arte nell’età della globalizzazione, Roma, Carocci.
Perniola, M., 2000, L’arte e la sua ombra, Torino, Einaudi.
Id., 2002, Prova di forza o prova di grandezza? Considerazioni sull‘àgalma, “Agalma”,
3, p. 62 ss.
Riemschneider, B., Grosenitz, U., 1999, Art at the Turn of the Millennium, Koeln,
Taschen.
Schiller, Fr., 1795, tr. it. 2005, L’educazione estetica, a cura di G. Pinna, Palermo,
Aesthetica.
Senaldi, M., a cura di, 2003, Cover Theory. L’arte contemporanea come re-interpretazione, Milano, Scheiwiller.
190
Appendice
a cura di Alfonso Ottobre
Sul finire del 1949 il “Journal of Aesthetics and Art Criticism” pubblicava
un articolo di Patrick Romanell dal titolo A Comment on Croce’s and Dewey’s
Aesthetics 1. Il titolo dell’articolo era abbastanza fuorviante perché in realtà
l’estetica di Croce non veniva presa in considerazione, se non per evidenziare,
nonostante Dewey si fosse fortemente impegnato sulle pagine di quella stessa
rivista a negare qualsivoglia somiglianza tra il suo pensiero e quello del filosofo
italiano 2, come in fin dei conti permanesse almeno una comune assunzione di
fondo, tutt’altro che irrilevante: quella cioè di considerare l’esperienza estetica
come l’oggetto proprio della filosofia dell’arte. Nell’articolo di Romanell vi era
però ben altro; a suo parere Dewey condivideva con Croce il raggiungimento
di un obiettivo decisamente poco invidiabile, quello cioè di aver dato vita a una
filosofia dell’arte contraddittoria, tentando di sviluppare nel contempo anche
una differente concezione di quale dovesse essere l’oggetto proprio dell’estetica,
senza rendersi conto che tale mossa conduceva a due filosofie dell’esperienza
contrapposte. Il nome di Croce, il cui pensiero non era minimamente analizzato,
veniva quindi speso in modo strumentale, solo per rendere più deciso l’attacco
contro il pensiero estetico di Dewey, che agli occhi di Romanell smentiva nei
fatti le pur promettenti dichiarazioni d’intenti contenute in Art as Experience.
Il breve testo che qui presentiamo, pubblicato sulla stessa rivista nel settembre del 1950 3, è la risposta di Dewey a quelle accuse; il suo valore prescinde
ovviamente dall’occasione, ma è bene spendere ancora qualche parola sull’analisi
filosofica condotta da Romanell, poiché essa ci offre una doppia opportunità:
comprendere il senso della risposta di Dewey e al tempo stesso fare luce su
una tensione presente nel suo pensiero che ha prestato il fianco a una serie di
equivoci.
L’articolo di Romanell è incentrato, come si è detto, sull’ipotetica incoerenza della visione deweyana, che nascerebbe da una tensione non risolta tra
due distinte filosofie dell’esperienza; una pluralista e «sostantivale», che vede
l’esperienza estetica come un tipo particolare di esperienza, e una monista e
«aggettivale», che interpreta l’esperienza estetica come uno degli aspetti dell’esperienza 4. Delle due, la prima sembra a Romanell non in sintonia non solo
con un pensiero schiettamente pragmatista, ma anche con la posizione che ad
esempio lo stesso Dewey aveva assunto in un libro coevo a quello sull’arte, A
Common Faith, nei confronti dell’esperienza religiosa, quando aveva fermamente
respinto l’idea che si potesse parlare di una esperienza religiosa come di un tipo
particolare di esperienza, per ciò stesso separata da altri tipi di esperienza in
virtù di un particolare contenuto. Ma allora, spiega Romanell nel suo articolo,
«se non esiste una cosa come “l’esperienza religiosa”, seguendo lo stesso tipo
di logica non esisterà nemmeno una cosa come “l’esperienza estetica” […] Se
la condizione per l’esistenza di una buona teoria delle religione è che il suo
191
oggetto debba essere concepito in modo aggettivale, cioè come “la fase religiosa
dell’esperienza”, allora allo stesso modo una teoria dell’arte adeguata dovrebbe
essere limitata alla “fase estetica dell’esperienza vitale”» 5. Romanell dunque non
nega che in Art as Experience vi sia anche un’analisi aggettivale del fenomeno artistico (l’arte come artistico), tuttavia si lamenta del fatto che questa si combina
con un’analisi sostantivale dell’arte «come esperienza estetica», visione che, a suo
parere, «conduce inevitabilmente all’erronea concezione dell’arte come “regno
separato”, una conseguenza contraria alla morale principale del libro» 6. Dewey
insomma, per usare la formula dello stesso Romanell, finirebbe con il mostrarsi
più anti-chiesa che non anti-museo.
La critica di Romanell non è perfettamente centrata. La visione deweyana
non sottintende affatto due filosofie dell’esperienza non conciliabili, e Dewey
nella sua risposta ha infatti gioco facile nel rimandare al mittente «l’onere della
prova», presentando in modo molto semplice e chiaro la sua idea di continuità
dell’esperienza. Le perplessità di Romanell possono tuttavia essere interpretate
come il sintomo di qualcosa di poco chiaro nella proposta deweyana, qualcosa
che lo stesso Romanell non sembra afferrare in pieno, e che ha a che fare con
un troppo disinvolto “gioco al rimbalzo” tra artistico ed estetico. Non è un caso
infatti che in chiusura della sua risposta, Dewey parli esplicitamente di due modi
dell’estetico: uno «primario», quello riscontrabile in una qualsiasi esperienza
completa, l’altro invece, quello che dovrebbe contraddistinguere uno stato evoluto, definito «artistico». Nel primo caso l’accento sembra posto sulla qualità
dell’esperienza, mentre nel secondo l’accento sembra posto sul suo contenuto.
Dico sembra, perché se le cose stessero veramente così, allora la maggior parte
delle riflessioni contenute in Art as Experience sarebbero prive di senso.
“Arte” per Dewey designa infatti una qualità (estetica) dell’esperienza, una
qualità del fare (che comprende anche il percepire) che può essere riscontrata in
qualsiasi attività umana, e non solo in via ipotetica. Su questo punto l’opera del
’34 è effettivamente piena di esempi, e Dewey non è sprezzante quando rimanda
senza tanti complimenti a quanto lì ampiamente esposto. Al tempo stesso però
l’arte è anche una qualità di ciò che viene fatto e percepito; e l’esperienza estetica
può essere considerata completa soltanto a condizione che “prenda corpo” in un
oggetto. Anche questo aspetto è assai ben sviluppato in Art as Experience: i riferimenti alla necessità dell’embodiment al fine di rendere completa una esperienza
sono continui e Dewey afferma chiaramente che non si può fare un’esperienza
estetica in assenza di un oggetto (interpretando ovviamente il termine “oggetto”
in senso ampio).
Vi è una qualche contraddizione in tutto ciò? Non è forse vero che nella
nostra lingua vi sono termini come “opera”, “lavoro”, “costruzione”, ma anche
come “storia”, “vita” e, soprattutto, “esperienza”, che designano sia un processo
che il suo risultato? L’incoerenza dunque, argomenta Dewey nel suo articolo, la
vede solo chi si avvicina alla teoria estetica con quei pregiudizi filosofici tipici di
un pensiero dualista che crea separazione laddove invece vi è continuità.
Che poi in Art as Experience gli oggetti in cui le qualità estetiche dell’esperienza “prendono corpo” siano quasi invariabilmente le opere dell’arte bella, e
che Dewey sia intimamente convinto che queste ultime rappresentino, allo stato
attuale dei fatti, il più alto raggiungimento possibile del processo esperienziale,
è un altro discorso. Si può certamente discutere su quanto Dewey sia effettivamente rivoluzionario nella sua proposta estetica o su come in alcune parti del
suo libro egli dia l’impressione di non voler portare sino in fondo le sue stesse
intuizioni sull’arte e sul ruolo che essa è chiamata a recitare nella società e nell’esperienza umana. Ma che la sua filosofia dell’esperienza, sfondo e base del
192
suo pensiero estetico, possa essere considerata causa di separazioni e dualismi
concettuali sembra essere effettivamente un’ipotesi priva di fondamento.
È d’altronde opportuno, se si vuole tentare di comprendere l’accento riformista della filosofia dell’arte di Dewey, tenere presente il carattere di apertura
verso il futuro di molte considerazioni contenute nell’opera del ’34. Che l’artistico in quanto qualità dell’esperienza, sebbene per il momento realizzato quasi
esclusivamente nelle opere dell’arte bella, possa un giorno diffondersi ben oltre i
limiti dell’arte istituzionalmente intesa è qualcosa di più di una semplice speranza
nella visione deweyana: è una possibilità insita nella natura stessa dell’esperienza
umana. Questo è ciò che Dewey ha sempre voluto dire; e purtroppo è anche ciò
che quasi nessuno ha voluto capire.
Vol. 8, n. 2, December 1949, pp. 125-28.
Nel 1948, com’è noto, la stessa rivista aveva pubblicato un articolo di Benedetto
Croce, sostanzialmente una recensione di Art as Experience, nella quale il filosofo italiano
discuteva quelli che, a suo parere, erano i numerosi punti di contatto tra l’estetica di Dewey
e la propria (“On the Aesthetics of Dewey”, vol. 6, n. 3, Mar. 1948, pp. 203-07). In coda
all’articolo di Croce era possibile leggere la brevissima replica di Dewey (“A Comment on
the Foregoing Criticism”, pp. 207-09) nella quale il filosofo americano respingeva, ancor
prima che le critiche, qualsiasi parentela filosofica. La controreplica di Croce, sempre sulla
stessa rivista (“Dewey’s Aesthetics and Theory of Knowledge”, vol. 11, n. 1, Sep. 1952, pp.
1-6) fu pubblicata qualche mese dopo la morte di Dewey. Sulla questione si vedano almeno
G. H. Douglas, A Reconsideration of the Dewey-Croce Exchange, “The Journal of Aesthetics
and Art Criticism”, 28, 1970, pp. 497-504, e, in italiano, L. Russo, La polemica fra Croce e
Dewey e l’arte come esperienza, “Rivista di studi crociani”, 5, 1968, pp. 201-16.
3 Aesthetic Experience as a Primary Phase and as an Artistic Development,“The Journal
of Aesthetics and Art Criticism”, vol. 9, n. 1, September, 1950, pp. 56-58. �����������������
L’articolo di Dewey, preceduto da quello di Romanell, è stato pubblicato nell’edizione critica integrale delle
sue opere (vedi The Later Works: 1925-1953, vol. 16, ed. by Jo Ann Boydston, Southern
Illinois University Press, Carbondale, 1989), e ha già conosciuto due traduzioni nella nostra
lingua: una di L. Bellatalla, apparsa nel volume antologico Educazione e Arte (La Nuova
Italia, Firenze 1977), l’altra di A. Granese, in J. Dewey, Arte come esperienza e altri scritti,
La Nuova Italia, Firenze, 1995. Quella che qui presentiamo si differenzia da entrambe in
più di un punto.
4
Sulla distinzione tra concezione sostantivale e aggettivale dell’arte e sui riflessi che essa
può avere su una filosofia dell’esperienza si veda P. Romanell, Prolegomeni a ogni estetica
naturalista, “Rivista di Filosofia”, li, ottobre 1960, 4, pp. 391-98.
5
Romanell, cit., p. 466.
6 Ivi, p. 467.
1
2
193
L’esperienza estetica come fase primaria
e come sviluppo artistico
di John Dewey
In un recente numero di questa rivista, il dottor Romanell ha sostenuto che, nel mio Arte come Esperienza, io parlo di due forme o
specie di esperienza estetica. Senza dubbio è vero; il dottor Romanell,
tuttavia, ha deciso che nel far ciò vi sia una qualche sorta di incoerenza. Non mi sembra però che egli sia stato in grado di dimostrare
che il mio riconoscere le due forme le abbia anche rese talmente incompatibili da spezzare in due la mia estetica, a meno di non voler
considerare una prova il fatto che io parlo sia di esperienza “estetica”
che di «fase estetica dell’esperienza». Dal momento che la spina dorsale, e invero la linfa vitale della mia teoria estetica, così come essa
è effettivamente, è costituita dal fatto che ogni ordinaria esperienza
completa, ognuna che compia interamente il suo corso, è estetica nella
sua fase consumatoria; e dal momento che la mia teoria afferma anche
che le arti e le esperienze estetiche che le riguardano sono sviluppi
intenzionalmente coltivati di quella fase estetica primaria, l’accusa di
incoerenza dell’intenzione principale, e irrinunciabile, della teoria dovrebbe essere accompagnata dalla presentazione di prove. Poiché, per
quanto mi è dato di vedere, nessuna prova è fornita a parte l’uso, fatto
di proposito al fine di evidenziare mediante due differenti espressioni
la forma primaria e quella intenzionalmente sviluppata dell’esperienza
estetica, e visto che non vi è nemmeno il più remoto riferimento al
ruolo giocato nella mia teoria estetica dalla questione dello sviluppo
artistico che scaturisce dalla fase primaria, non penso vi siano degli
elementi rispetto ai quali dovrei articolare una replica.
Fornire prova del fatto che il tema dello sviluppo della forma o
del modo artistico a partire dalla fase estetica primaria costituisca “il
cuore, l’anima e la mente” (l’intenzione) dell’intero libro, equivarrebbe
a scriverne una sinossi completa. Visto che il libro è a disposizione di
chiunque voglia leggerlo, tale operazione sarebbe tanto superflua quanto impossibile da compiere in un articolo di rivista. Di conseguenza, in
questa occasione mi limito a richiamare l’attenzione, per quanto concerne la fase primaria dell’estetico, sui primi due capitoli. I loro titoli,
“la creatura vivente” e “fare una esperienza” (con l’accento su “una”),
sembrerebbero piuttosto espliciti, senza che si avverta la necessità di
molti altri riferimenti al loro contenuto; quindi faccio appena men195
zione qui del fatto che la maggior parte del resto del libro è dedicata
alla discussione delle arti in quanto sviluppi di aspetti estetici primari.
Aggiungo anche che un considerevole spazio è utilizzato per mostrare
che le “opere d’arte” non derivanti dallo sviluppo di una fase delle
esperienze primarie sono artificiali più che artistiche; un fatto che in sé
più che mostrare l’incoerenza della mia posizione, prova l’irrilevanza
della critica del dottor Romanell verso di essa.
Vi è tuttavia un’affermazione nel suo articolo che, sebbene non richieda una replica, mi offre l’opportunità, della quale lo ringrazio, di
dire qualcosa riguardo la filosofia generale dell’esperienza, di cui la
discussione dell’estetico non è che una varietà.
La frase in questione è quella in cui il dottor Romanell asserisce
che sviluppare, ciascuno per proprio conto, quanto sostengo riguardo
l’esperienza estetica «darebbe luogo a due filosofie dell’esperienza tra
loro incompatibili». Dal momento che ho parecchi motivi per pensare
che il dottor. Romanell non sia l’unico a non aver afferrato pienamente
questa teoria generale, sono ben lieto di cogliere l’occasione per dire
qualcosa su questo tema.
Si tratta in buona sostanza di questo: il caso dell’esperienza estetica
con il suo sviluppo coltivato di tipo artistico a partire da ciò che è naturale e spontaneo nell’esperienza primaria fornisce, con ogni probabilità,
il modo più semplice e diretto di chiarire ciò che vi è di fondamentale
in tutte quelle forme di esperienza che vengono tradizionalmente (ma
in modo erroneo) considerate come tante partizioni differenti, isolate
e indipendenti dell’oggetto in esame. L’abitudine tradizionale, tuttora
in voga, di dividere l’uno dall’altro argomenti che sono rispettivamente
politici, economici, morali, religiosi, educativi, cognitivi (con il nome di
epistemologici) e cosmologici, trattandoli di conseguenza come se fossero auto-costituiti, intrinsecamente differenti, è un esempio di ciò che
io rifiuto nel caso dell’estetico. Gli antropologi hanno mostrato come le
comunità relativamente primitive facciano tutto ciò che è in loro potere
per rivestire quelle attività che sono necessarie per la sopravvivenza del
gruppo con l’abito dell’immediatezza, dell’esteticamente piacevole – trascurando perfino di coltivare ciò che è “utile” ma prosaico in se stesso.
Tali fatti forniscono – lo ripeto – la maniera più semplice di presentare e comprendere cosa è accaduto nel caso di tutti quegli argomenti
che le filosofie non curanti dell’esperienza, o contro di essa, hanno
costruito come tanti compartimenti isolati, indipendenti e strettamente
chiusi in se stessi, nobilitati poi con nomi altisonanti come domini, reami, sfere, dell’Essere. È difficile trovare alcunché di misterioso nelle arti
della danza, del canto, del dramma, della narrazione, che prolungano e
perpetuano la fase immediatamente soddisfacente dell’esperienza primaria. Il dipingere, lo scolpire, le costruzioni architettoniche, portano
avanti lo stesso tipo di sviluppo, solo che lo fanno in modi indiretti,
più complessi e quindi più mascherati.
196
L’influenza di questi fatti su una filosofia che è decisa a fare tutto
ciò che è in suo potere per restare fedele, nelle sue posizioni teoretiche, ai fatti che riguardano l’origine e lo sviluppo di forme differenti
di contenuti di cui si fa esperienza, non è così difficile da capire nei
termini che le sono propri. Ciò che costituisce un ostacolo, ciò che intralcia, arresta e rende irriconoscibile, proviene da quelle filosofie nelle
quali gli sviluppi funzionali della fase soddisfacente delle esperienze
primarie sono stati pietrificati, congelati e reificati in una moltitudine
di generi dell’Essere e della Conoscenza, costitutivamente separati all’origine.
Non vedo quindi modo migliore per terminare questo mio breve
articolo che non sia quello di riportare un passo da un mio scritto composto e pubblicato indipendentemente e qualche anno prima di Arte
come esperienza. Il passo ha il merito non solo di esporre la versione
corretta della mia posizione circa i due modi dell’estetico, il primario
e l’artistico, ma illustra anche quel principio dello sviluppo che circola
universalmente nella mia teoria della varietà di fasi dell’esperienza, siano
esse quelle della morale, della politica, della religione, della scienza,
della filosofia stessa, così come dell’arte bella, in modo da rispondere
anticipatamente a quelle critiche che trasformano la distinzione tra gli
aspetti primari e quelli artisticamente sviluppati di un unico argomento
in due materie incompatibili. Il passo recita: «Ci sono sostanzialmente
due alternative. O l’arte è una continuazione, per mezzo di una combinazione e di una selezione intelligenti, di naturali tendenze di eventi
naturali, oppure l’arte è un’aggiunta peculiare alla natura, che sboccia
da qualcosa che alberga in seno all’uomo, comunque la si voglia chiamare. Nel primo caso, la percezione piacevolmente intensificata ha la
stessa natura del godimento di qualsiasi oggetto consumatorio. È il risultato di un’abile e intelligente arte di trattare le cose naturali al fine di
intensificare, purificare, prolungare e approfondire quelle soddisfazioni
che esse (le cose delle esperienze primarie quotidiane) spontaneamente
ci offrono».
Sembra quasi inutile aggiungere che, qualunque possano essere i
meriti e i demeriti di una tale teoria, c’è una differenza radicale tra
continuità di sviluppo e incompatibilità intrinseca; in particolare quando la natura della differenza riguarda in modo fondamentale ciascuna
e ogni varietà di temi trattati dal punto di vista di una filosofia dell’esperienza generale e comprensiva.
197
Aesthetica Preprint
Supplementa
1 Breitinger e l’estetica dell’Illuminismo tedesco, di S. Tedesco
2 Il corpo dello stile: Storia dell’arte come storia dell’estetica a partire da Semper, Riegl,
Wölfflin, di A. Pinotti
3 Georges Bataille e l’estetica del male, di M. B. Ponti
4 L’altro sapere: Bello, Arte, Immagine in Leon Battista Alberti, di E. Di Stefano
5 Tre saggi di estetica, di E. Migliorini
6 L’estetica di Baumgarten, di S. Tedesco
7 Le forme dell’apparire: Estetica, ermeneutica ed umanesimo nel pensiero di Ernesto
Grassi, di R. Messori
8 Gian Vincenzo Gravina e l’estetica del delirio, di R. Lo Bianco
9 La nuova estetica italiana, a cura di L. Russo
10 Husserl e l’immagine, di C. Calì
11 Il Gusto nell’estetica del Settecento, di G. Morpurgo-Tagliabue
12 Arte e Idea: Francisco de Hollanda e l’estetica del Cinquecento, di E. Di Stefano
13 Pœta quasi creator: Estetica e poesia in Mathias Casimir Sarbiewski, di A. Li Vigni
14 Rudolf Arnheim: Arte e percezione visiva, a cura di L. Pizzo Russo
15 Jean-Bapiste Du Bos e l’estetica dello spettatore, a cura di L. Russo
16 Il metodo e la storia, di S. Tedesco
17 Implexe, fare, vedere: L’estetica nei Cahiers di Paul Valéry, di E. Crescimanno
18 Arte ed estetica in Nelson Goodman, di L. Marchetti
19 Attraverso l’immagine: In ricordo di Cesare Brandi, a cura di L. Russo
20 Prima dell’età dell’arte: Hans Belting e l’immagine medievale, di L. Vargiu
21 Esperienza estetica: A partire da John Dewey, a cura di L. Russo
©
Aesthetica Preprint
Supplementa
Collana editoriale del Centro Internazionale Studi di Estetica
Presso il Dipartimento Fieri dell’Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze, Edificio 12, I-90128 Palermo
Fono +39 91 6560274 – Fax +39 91 6560287
E-Mail <[email protected]> – Web Address <http://unipa.it/~estetica>
Progetto Grafico di Ino Chisesi & Associati, Milano
Stampato in Palermo dalla Tipolitografia Luxograph s.r.l.
Registrato presso il Tribunale di Palermo il 27 gennaio 1984, n. 3
Iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione il 29 agosto 2001, n. 6868
Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
issn 0393-8522
Direttore responsabile Luigi Russo
Aesthetic Experience
Starting from John Dewey
The International Centre for the Study of Aesthetics celebrated
the publication of the Italian edition of John Dewey’s seminal
Arts as Experience (Palermo: Aesthetica Edizioni, 2007) by organizing a seminar entitled “Aesthetic Experience: Starting from
John Dewey”, which took place in Palermo on November 23-24,
2007.
The present volume, edited by Luigi Russo, collects the papers
presented at that conference, and more specifically: Giovanni
Matteucci’s “Dewey and the Anthropology of Aesthetic Experience”, Roberta Dreon’s “Emotions and Subjects in Artistic Expression: Dewey’s Contribution”, Simona Chiodo’s “Empiricist
Aesthetics”, Marco Senaldi’s “Art as Experience and Contemporary Art”, Stefano Velotti’s “Is an Aesthetic Experience Still
Possible?”, Salvatore Tedesco’s “The Anthropological Model of
Aesthetic Experience: Dewey, Gehlen, and Plessner”, Elio Franzini’s “Phenomenology and Aesthetic Experience”, Leonardo
Amoroso’s “Aesthetics as a Philosophy of Experience: Re-reading Dewey through Garroni“, Paolo D’Angelo’s “The Critique of
Aesthetic Experience in Anglo-American Analytical Philosophy”,
Mario Perniola’s “How Can We Interpret Art as experience in
the Present Aesthetic Context?”, Roberto Diodato’s “Aesthetic
Experience and Interactivity”, Fabrizio Desideri’s “Pathologies of
Contemporary Aesthetic Experience”, Pietro Montani’s “Aesthetic
Experience and Experiential Anesthesias”, Fulvio Carmagnola’s
“Art and Experience: After Dewey”.
The Appendix, edited by Alfonso Ottobre, presents a short text
by Dewey (“Aesthetic Experience as a Primary Phase and as an
Artistic Development”) that lends important insight into his aesthetic theory.
Centro Internazionale Studi di Estetica, Viale delle Scienze, I-90128 Palermo